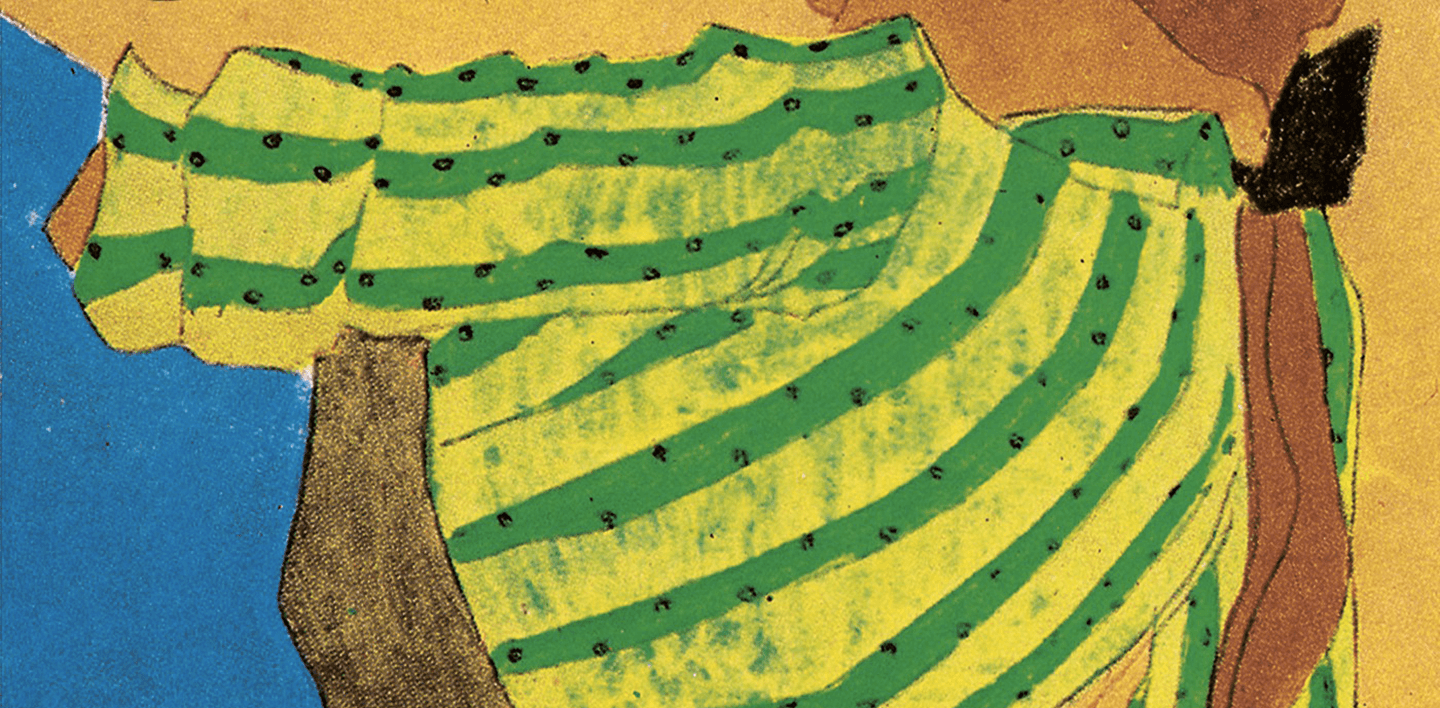
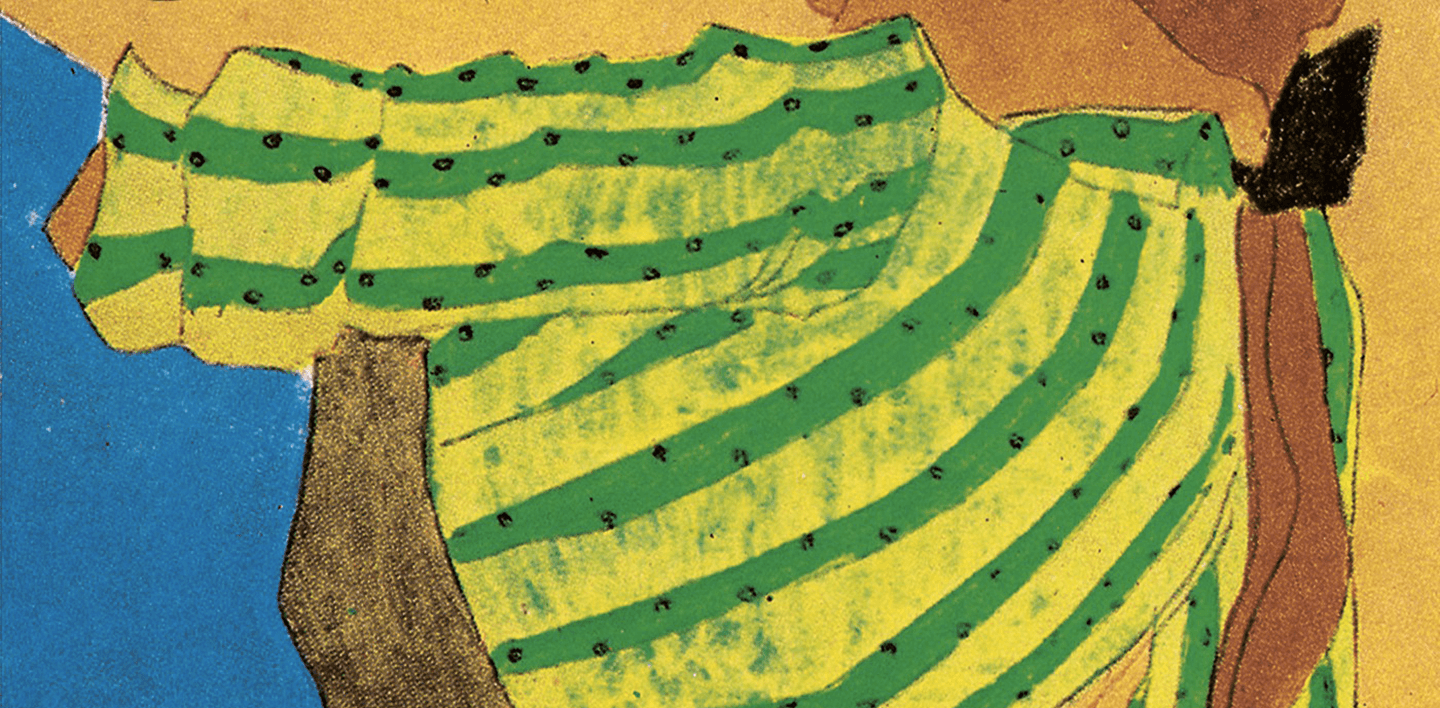
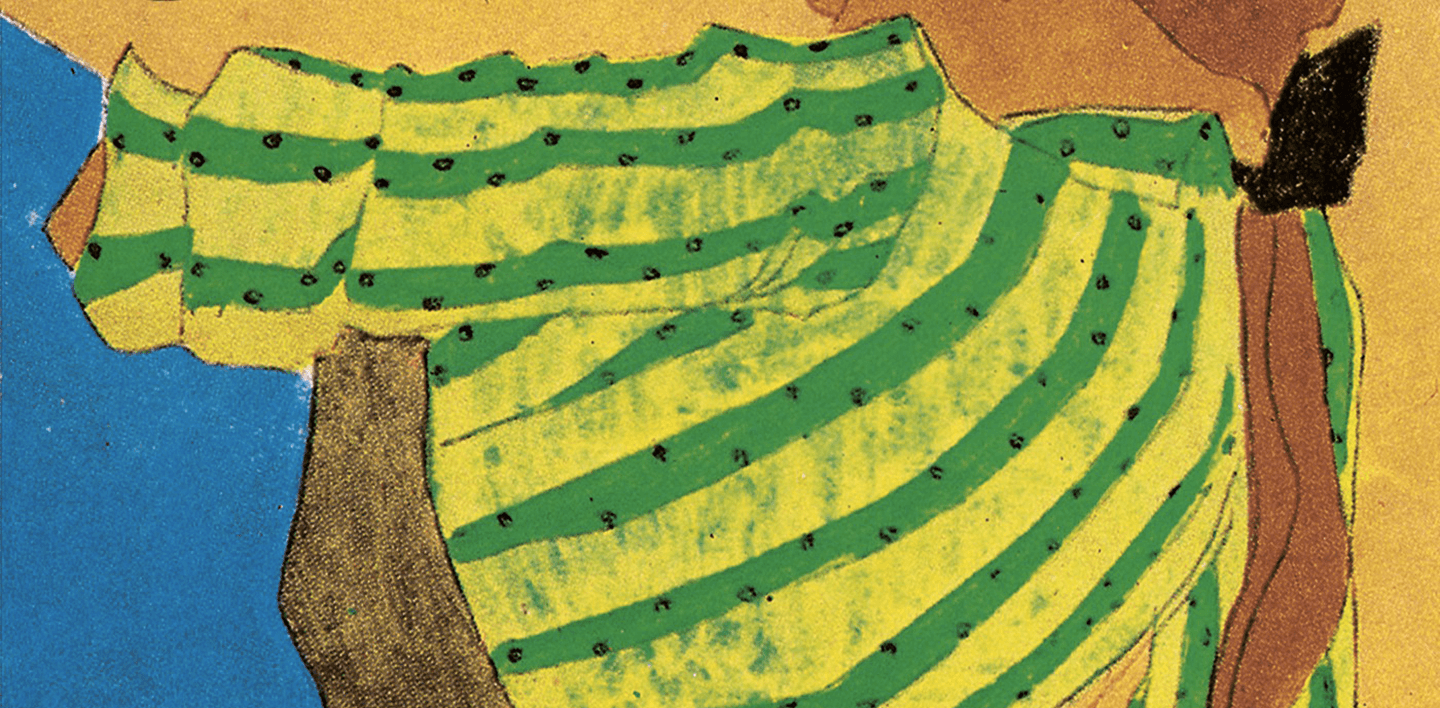
“L’ ultima donna rimasta sulla terra”: così l’aveva definita Calvino nel 1947 sull’Unità. “Tutti gli altri” – proseguiva nell’articolo uscito in occasione della pubblicazione del secondo romanzo della Ginzburg, È stato così – “sono uomini”. A quel tempo Italo Calvino aveva ventiquattro anni, Natalia Ginzburg trentuno. Non era ancora la scrittrice affermata che sarebbe diventata, ma lavorava già per Einaudi, aveva pubblicato due romanzi (il primo, nel 1942, era stato La strada che va in città) e aveva tradotto il primo volume della Recherche di Proust. Si era sposata con Leone Ginzburg e da lui aveva avuto tre figli, si era nascosta in Abruzzo durante la guerra, era rimasta vedova, aveva cambiato dieci case, si era iscritta al Partito Comunista, aveva tentato il suicidio, provato e abbandonato la psicanalisi per poi tornare finalmente a scrivere.
Non era di certo l’ultima donna rimasta sulla terra: quello che Calvino intendeva dire era che le donne simili a lei potevano essere molte, anzi erano di certo moltissime, ma Natalia con la sua scrittura era l’unica a essere in grado di dar loro un volto e una voce. Le sue novelle, i suoi articoli e romanzi avevano inventato un nuovo modo di essere donna e di raccontarlo: profondamente femminile senza essere a tutti costi femminista, domestico ma non casalingo, letterario ma non lirico, sofisticato e disadorno, personale e riservato (citando Garboli: “sembra un paradosso che Natalia Ginzburg la quale nei suoi libri ha tanto parlato di sé, non ci abbia mai raccontato niente di sé stessa. Che cosa sappiamo di lei? Tutto e nulla”). Chi ama Natalia Ginzburg la ama, credo, per queste sue abilità solo apparentemente opposte: per la rapida esattezza con cui salva minuscoli e luminosi dettagli del mondo e li strappa agli abissi dell’abitudine e alla noie della vita borghese e, al tempo stesso, per la totale arrendevolezza con cui si abbandona alla malinconia del vivere, sprofondando in una pacata tristezza e sguazzandoci dentro come se non esistesse altro, come se di quei dettagli luminosi sulla terra non ci fosse più traccia.
I suoi romanzi, le sue opere teatrali, i suoi articoli sono così: deprimenti e salvifici, disperati e coraggiosi, gelidi e intimi, spartani e delicati, bruschi e fragilissimi. Allo stesso tempo però, lo stile della Ginzburg non rimbalza mai da un registro all’altro: è un unico e tenace fiume tranquillo, che va avanti per la sua rotta, senza conoscere clamori ma nemmeno arresti. Non esiste un’altra scrittrice che abbia viaggiato su questo doppio binario con la stessa costanza, e la maestria della sua prosa deve molto alla naturalezza con cui diluisce uno con l’altro aspetti del vivere in apparenza inconciliabili, e li distilla insieme sulla pagina come se uniti fossero nati.
Se il binario è doppio l’universo è composito, e tiene insieme un mucchio di galassie differenti: città e case (nata a Palermo, Natalia Ginzburg è cresciuta a Torino, si è rifugiata a Pizzoli durante la guerra, ha vissuto a Roma, a Londra, poi di nuovo a Roma) oggetti e ideali, periodi ed epoche della storia d’Italia, persone e personaggi. Eppure, come spesso accade coi grandi, la luce in cui si finisce quando si ha a che fare con lei non cambia mai davvero. Quelli i colori, i tessuti, gli accenti e i gesti. Non importa di cosa scriva o da dove, o in quale epoca si torni a leggerla: la prosa della Ginzburg rimane. Nonostante i tanti anni a Roma, le estati a Sperlonga e l’infanzia palermitana il tratto sabaudo è quello che più le resta attaccato addosso: l’educazione squisita e il fiero riserbo, la capacità di asserire cose terribili senza mai alzare la voce, il coraggio pacato, invincibile proprio grazie alla sua apparente fragilità, che non smette di fare il suo dovere anche quando, puntuale come sempre, la malinconia ritorna e tutto sembra pronto a smarrirsi per sempre. “Mai letta una cosa così piemontese”, le dirà nel ’61 Calvino parlando de Le voci della sera. “Piemontese da far piangere. Anche il linguaggio (…) Triste, triste da morire”.
Raccontare l’universo della Ginzburg rimanendo fedele alla sua luce è quello che è riuscita a fare Sandra Petrignani nella biografia La corsara, in libreria per Neri Pozza dal 22 gennaio. 460 pagine per 75 anni, quelli della vita di Natalia e dell’Italia che intorno a lei si muove: quella degli Einaudi e degli Olivetti, di Pavese e Calvino, di Quasimodo e Casorati, di Cesare Garboli e Felice Balbo, di Leone Ginzurg e Gabriele Baldini e di Elsa Morante, altra grande unica donna sulla terra, così diversa da Natalia in tutto e per tutto, eppure a lei in qualche modo legata come a nessun altra.
Costruito come un affresco panoramico e minuzioso al tempo stesso, il libro ripercorre tutta la vita della Ginzburg e si chiude con una serie di istantanee di poche righe strappate a suoi amici, colleghi e conoscenti. Elio Pecora di lei dice: “Una sera che si parlava del morire lei si disse sicura che sarebbe rinata. E che sarebbe rinata identica.” L’agente letterario Agnese Incisa: “Quando s’arrabbiava con Giulio Einaudi lo chiamava Arsenio Lupin.” La traduttrice Ludovica Nagel: “Quando per strada la gente la riconosceva, si stupiva. Si girava a chiedermi: “Ma, salutano me?”. Ugo Leonzio: “Elsa [Morante] pensava che Natalia fosse una “gran maschilista”. Mi disse proprio così, una volta: “Una maschilista tremenda!” I loro rapporti (…) erano divertentissimi! C’era una cosa decisiva a separarle: a Natalia piaceva il sesso, a Elsa no.”
“Sono importanti le biografie, ma bisogna accendere le luci e saperle spegnere al momento giusto”, aveva detto la Ginzburg un giorno a un giovane Silvio Perrella che stava preparando proprio quella di Calvino (e che a quanto pare, dopo l’incontro con lei, a quell’impresa rinunciò). Nella Corsara non soltanto gli interruttori scattano al momento giusto, ma è il tipo di luce, la grana del racconto a essere impeccabile. Impossibile, per chi ama Natalia Ginzburg, non ritrovarla sin dalle prime pagine, il braccio lungo il bracciolo del divano di quel salotto romano di campo Marzio in cui, nella metà degli anni Ottanta, riceve una giovane e un po’ intimidita Petrignani alle prese con un “abbozzo caotico di romanzo” e con la consueta, spietata sincerità le dice: “Io questo libro non l’ho capito. Siccome non l’ho capito non mi piace. Ma siccome non l’ho capito non posso dare un giudizio”.
Sandra Petrignani Natalia Ginzburg l’ha conosciuta, abbastanza bene per non raccontarla come si racconta una statua su un piedistallo, e non così da vicino da cadere nella tentazione di tracciare il ritratto della sua versione, della Natalia con cui lei nel corso degli anni ha avuto a che fare. E forse l’equilibrio di questo ritratto, devoto e coraggioso insieme, nasce anche dalla giusta distanza da cui è stato composto. Altro elemento essenziale del libro è il linguaggio con cui è stato scritto. L’universo Ginzburg deve tantissimo alla lingua e al ritmo inconfondibile della sua prosa. Quel piglio narrativo che Pavese, parafrasando la “cantilena Duras”, aveva definito “lagna Ginzburg” e Cesare Garboli, con altrettanta devota ironia, chiamerà “un fraseggio monocorde come la pioggia”. Oltre che al ritmo, la bellezza dello stile della Ginzburg sta nelle singole parole scelte, che si affermano fin dai primi racconti e in oltre cinquant’anni di scrittura torneranno ciclicamente. Parole a prima vista quasi banali nella loro semplicità, ma in realtà pesate e pescate tra mille. Parole-mondo dirette e “oneste” (memorabile l’intervento dell’89 su La Stampa in cui la Ginzburg se la prendeva con le “parole-cadaveri”, non vedente al posto di cieco, anziano al posto di vecchio, operatore ecologico, male incurabile e persona di colore). Regine e sentinelle poetiche e insieme colloquiali, squisitamente italiane, nel senso migliore del termine, quello che sa di sartoria e spontaneità. Ne La corsara le ritroviamo intatte, scolpite come personaggi e impegnate come testimoni a comporre il ritratto della donna che nel Lessico famigliare ha trovato una chiave di accesso al mondo e alla sua memoria.
“Mi pettino e mi spettino”
“Scrivo le novelle, corro a scuola coi libri, perdo il tempo, mi pettino e mi spettino”, scrive in una lettera Natalia al fratello Mario nel 1935. Natalia Levi ha appena vent’anni allora, ha da poco conosciuto Leone Ginzburg, suo futuro marito, e lui nel frattempo è finito in prigione per le iniziative politiche che porta avanti con Giustizia e Libertà, il gruppo antifascista di cui fa parte. In carcere Leone resterà due anni; è già innamorato di Natalia (“sono sano di te”, le dirà un giorno) e le scrive regolarmente. Lei tentenna, si cerca, non sa. Si è già affezionata a Leone ma non sa ancora cosa vuole dalla vita o da se stessa; è curiosa di tutto, e di nulla le importa davvero. Arriva con fatica agli esami di maturità, passeggia per Torino con Mario Soldati, si fa crescere i capelli e sogna di giocare a tennis, si annoia, pubblica sulla rivista Solaria il racconto “I bambini” e con quei soldi si compra un vestito nuovo. Si pettina e si spettina, appunto, come una giovane Penelope che non si accorge nemmeno di aspettare, solo per il gusto e il capriccio di farlo, tra gesti e giorni che sembrano inutili ma che sono invece l’inizio di tutto.
La verità
“Dire la verità. Solo così nasce l’opera d’arte”. Natalia lo scrive a diciassette anni ne Il Gallo, un giornaletto letterario che ha fondato con l’amica Bianca Debenedetti. Lo ripeterà a Enzo Biagi molti anni dopo, nel 1975, quando di anni ne ha quasi sessanta, e resterà fedele a quell’intuizione per tutta la vita. Se fin dai primi racconti le cose che scrive sono ispirati a cose reali – persone che conosce, eventi che ha vissuto, case in cui ha abitato – sarà la guerra – e senza dubbio la scomparsa di Leone, che alle torture della guerra non sopravvive – a spingerla ancora più lontano, a esasperare questa esigenza in modo radicale: “Non guariremo più da questa guerra. Noi non possiamo mentire nei libri e non possiamo mentire in nessuna delle cose che facciamo […] Non mentire e non tollerare che ci mentano gli altri.”
In È stato così, scritto subito dopo la morte del marito, la ricerca della verità nei rapporti umani si farà brutale, e suonerà come un grido di aiuto: “Gli ho detto: – Dimmi la verità, – e ha detto: – Quale verità, – e disegnava in fretta qualcosa sul taccuino e m’ha mostrato cos’era, era un treno lungo lungo con una grossa nuvola di fumo nero e lui che si sporgeva dal finestrino e salutava col fazzoletto. Gli ho sparato negli occhi”.
Ecco che da un certo punto in poi, la verità per la Ginzburg non sarà più solo un fine, ma un mezzo per esprimersi e un modo di stare al mondo. La raccolta di saggi Le Piccole virtù (1962) e Lessico Famigliare (1963) rappresentano l’apice di questa poetica, e l’avvertenza in apertura di Lessico suona come un monito e una confessione: “Luoghi, fatti e persone sono, in questo libro, reali. Non ho inventato niente: e ogni volta che, sulle tracce del mio vecchio costume di romanziera, inventavo, mi sentivo subito spinta a distruggere quanto avevo inventato”.
Anche la resistenza per anni opposta dalla Ginzburg al mondo del teatro nasceva proprio dal non capire come si potessero far andare in scena dei personaggi imprigionati loro malgrado dentro esclamazioni forzate e poco veritiere, o in situazioni poco realistiche. Il teatro per Natalia era in qualche modo il culmine della menzogna: “Ogni volta che ha provato a scrivere su una pagina: «Piero: Dov’è il mio cappello?»” scrive la Petrignani, “si è vergognata fino al ribrezzo. «Perché in quel Piero, in quei due punti, in quel “dov’è il mio cappello” si proiettavano tutte le brutte commedie che ho letto e che ho sentito in vita mia».
Sarà Pier Paolo Pasolini, all’inizio degli anni ’60, a spiegarle come aggirare il fastidio di quel tipo di finzione e, presentandole l’attrice Adriana Asti, ad aprirle la porta di accesso a un mondo dal quale lei stessa per tanto tempo si era sentita esclusa per definizione: da allora scrivere commedie non soltanto non sarà più impensabile, ma diventerà un altro modo di nominare la verità, e di specchiarvisi dentro.
Lo specchio
Da “Il mestiere di scrivere”, in Piccole virtù:
Ho capito che non esiste il risparmio in questo mestiere. Se uno pensa “questo particolare è bello e non voglio sciuparlo nel racconto che sto scrivendo ora, qui c’è già molta roba bella, lo tengo in serbo per un altro racconto che scriverò”, allora quel particolare si cristallizza dentro di lui e non può più servirsene. (…) In quell’epoca che scrivevo i miei racconti brevi (…) ho visto una volta passare per strada uno specchio, un grande specchio dalla cornice dorata. Vi era riflesso il cielo verde della sera, e io mi son fermata a guardarlo mentre passava, con una grande felicità e il senso che avveniva qualcosa d’importante. Mi sentivo molto felice anche prima di vedere lo specchio, e a un tratto m’era sembrato che passasse l’immagine della mia felicità stessa, lo specchio verde e splendente nella sua cornice dorata. Per molto tempo ho pensato che l’avrei messo in qualche racconto, per molto tempo ricordare il carretto con sopra lo specchio mi dava la voglia di scrivere. Ma non m’è mai riuscito di metterlo in nessun luogo e a un certo punto mi sono accorta che era morto in me.
I romanzi di Natalia Ginzburg sono romanzi di oggetti; sono pieni di scarpe, armadi e cassetti, di borse e cappotti, tende e maglioni. E di specchi. Nella corsara gli specchi sono dappertutto. C’è Pavese che passandoci davanti grida “Come sono bello!”, c’è Lidia Tanzi, la madre di Natalia, che vedendosi riflessa esclama “Mamma che vegia sono diventata!”, c’è Paola, la sorella più grande bionda e bella di Natalia, che davanti allo specchio si dispera, perché a forza di camminare in montagna dietro al padre, dice, le si sono ingrossati irrimediabilmente i polpacci. C’è Valentino, il protagonista dell’omonimo racconto che la Ginzburg scrisse nel ’51 su richiesta di Bassani, che davanti allo specchio “fa lo scimmiotto” vestito da sciatore, e c’è la donna senza nome di È stato così, che allo specchio si osserva e si chiede se ha davvero “l’aria da brava teresina”. È agli specchi che i tedeschi sparano, “quando devastano la casa di Anna e Cenzo” in Tutti i nostri ieri, e se non è infranto è cupo all’inverosimile l’altro specchio di Cesare Pavese, quello del Mestiere di vivere, che in una delle sue frasi di impossibile solitudine dice: “Passavo le sere davanti allo specchio per tenermi compagnia”.
Di casa Ginzburg lo specchio, con o senza cielo dentro, intero o a pezzi, è uno dei simboli centrali: della scrittura e dell’integrità, di quel “cercare la verità” che per Natalia è il senso stesso del suo mestiere. Simbolo e amuleto insieme, della bugia dello stare al mondo, e delle immagini riflesse – oggetti, gesti, persone – che compongono la nostra vita e i libri che la scandiscono. I tempi dello specchio sul carretto sono ormai lontani quando, nel 1984, per presentare La città e la casa, la Ginzburg scriverà: “scrivendo romanzi, ho sempre avuto la sensazione d’avere in mano degli specchi rotti, e tuttavia sempre speravo di poter ricomporre finalmente uno specchio intiero. Ma non mi è mai successo e via via che andavo avanti a scrivere la speranza s’allontanava. Questa volta però, fin dal principio, non speravo nulla. Lo specchio era rotto e io sapevo che ricomporne i pezzi mi sarebbe stato impossibile. Non avrei avuto mai il bene di avere davanti a me uno specchio intiero”.
La catramonaccia; cascare nel pozzo
Potevano arrivare invitati, pietanze buone in tavola, potevo avere un vestito nuovo, un libro nuovo, potevo vedere bauli, pensare ai treni, alla campagna, all’estate: la malinconia mi avrebbe seguito dovunque. Essa era sempre là, immobile, sconfinata, incomprensibile, inesplicabile, come un cielo altissimo, nero, incombente e deserto.
Senza la malinconia l’opera di Natalia Ginzburg non esisterebbe. Dalla malinconia nasce tutto quello che scrive, e alla melanconia torna, in un circolo che si chiude ed é inevitabilmente alimentato da se stesso. La “catramonaccia” forse Natalia l’ha ereditata da sua madre Lidia Tanzi: è una parola del dialetto bergamasco, e indica un misto di malinconia, misantropismo e solitudine. La Ginzburg ne parla in Lessico Familiare:
Mia madre delle amiche della Paola era sempre un po’ gelosa; e quando la Paola aveva una nuova amica, lei diventava di cattivo umore, sentendosi messa in disparte. Si alzava allora al mattino con un viso grigio, con le palpebre tutte pestate; e diceva: – Ho la catramonaccia –. Quell’insieme di tetraggine e di senso di solitudine, mescolato anche di solito a un’indigestione, mia madre lo chiamava la “catramonaccia”. Con la “catramonaccia” stava rintanata in salotto, e aveva freddo, e si avviluppava negli scialli di lana; e pensava che la Paola non le voleva più bene, non veniva a trovarla, e andava con le sue amiche a spasso.
Ma se la catramonaccia di Lidia Tanzi nasceva da cause ben precise – senso di abbandono per l’assenza della figlia o cattiva digestione – la malinconia di Natalia pervade tutto a prescindere, senza bisogno di una ragione per venir fuori e appropriarsi di tutto. È parte integrante della vita al punto che è impossibile separarla dal resto, e forse – come la Ginzburg azzarda nel Discorso sulle donne del 1948 – nasce semplicemente dell’essere donna:
Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle donne […] a me non è mai successo d’incontrare una donna senza scoprire dopo un poco in lei qualcosa di dolente e di pietoso che non c’è negli uomini (…) Le donne sono una stirpe disgraziata e infelice con tanti secoli di schiavitù sulle spalle e quello che devono fare è difendersi con le unghie e coi denti dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno più libero. Così devo imparare a fare anch’io per prima perché se no certo non potrò combinare niente di serio.
Al tempo stesso però, quando vive e quando scrive è indispensabile per lei non lasciarla mai trionfare del tutto, non dimenticare mai il doppio movimento di abbandono e resurrezione, quel salvare e lasciare andare sul quale tutto si fonda. Quando uno dei due gesti prevale sull’altro qualcosa non funziona: “Forse in quel libro c’è qualcosa di troppo malinconico”, confesserà a Marino Sinibaldi in un’intervista parlando di È stato così, che considera un libro non del tutto riuscito. E ancora, in una lettera alla Morante del 1948, che scrive mentre è in villeggiatura in montagna coi figli: “Ero terribilmente malinconica e non mi riusciva di far niente, ora mi è passato. I bambini stanno bene, e giocano con dei ragazzotti”. Dalla malinconia si parte e alla malinconia si torna, e spesso si cade nel pozzo, ma si scrive per altre ragioni, e per altre ragioni si lotta.
Il kibitzer
Da Mai devi domandarmi:
È come un essere umano, irrequieto e niente affatto paziente. Con quelli che scrivono, egli è invece dotato di un’estrema pazienza. Ha inoltre lo strano dono di animare e stimolare, nel prossimo, pensieri e desiderio di scrivere. Dirò che, forse, basta vederlo in una stanza per proporsi di scrivere.
In Yiddish un kibitzer, scrive la Petrignani, “è qualcuno che seduto da spettatore accanto a chi gioca, senza essere della partita, offre in modo importuno consigli o commenti”. Uno dei grandi kibitzer della narrativa italiana della seconda metà del ‘900 fu senza dubbio Cesare Garboli. A chiamare così Garboli non sarà Natalia, ma Domenico Scarpa, che riassume in questa parola l’essenza di quest’uomo “dall’irascibile, generosa pazienza” che passò la vita a “suggerire, correggere, riscrivere i libri degli altri senza mai essersi misurato direttamente con un suo proprio romanzo, pur avendo le stimmate e il genio del narratore”.
ll suo rapporto con la Ginzburg fu leggendario, diverso da quello più classico e formale che Garboli intratteneva con gli altri scrittori. “Lui le s’imponeva in continuazione, ma lei non si ribellava, sembrava non farci caso, era molto paziente. Garboli – racconta Salvatore Mannuzzu – si ergeva a Maestro con tutti, intelligentissimo, divertente. Con Natalia, però aveva una speciale delicatezza, si capiva che le voleva bene, potrei dire che la corteggiasse, ma non è la parola giusta.”
I due si erano conosciuti nel 1948 al caffè Greco. Garboli allora non aveva ancora vent’anni, e a presentarli era stata Paola Olivetti, la sorella di Natalia. Si sarebbero ritrovati quindici anni più tardi, sempre a Roma, lui critico affermato e lei sposata a Gabriele Baldini, amico comune: da allora non si persero più di vista. Nel 1986, quando la Ginzburg aveva superato i settanta e Garboli ne aveva sessantuno, in una delle sue tante lettere “lui le rimprovera una serie di “cantonate” anche antiche, da quella per Garcia Marquez a quella per il film Anonimo veneziano, concludendo che la ama pure per le sue cantonate”.
Le biografie sono anche fatte di numeri, e basta gettare uno sguardo alle pagine a lui riservate nell’indice dei nomi della Corsara per immaginare il peso e l’influenza che il loro incontro ebbe nella vita di entrambi. Senza Natalia Cesare non sarebbe stato lo stesso critico, e senza il suo kibitzer anche lei sarebbe stata una scrittrice diversa. Nessuno come lui ha saputo leggerla e raccontare le sue opere, al pubblico e forse soprattutto a Natalia stessa: “Mi ha illuminata, mi ha fatto capire cose di me che ignoravo”, dirà lei più di una volta quando qualcuno, sapendola schiva e a tratti forastica, le chiedeva come potesse accettare le ingerenze di Garboli. E lui, nel risvolto del 1974 di Vita immaginaria, di Natalia Ginzburg darà una definizione fulminante, la cui potenza ancora una volta è racchiusa in un equilibrio binario: “Il primo scandalo della Ginzburg è l’innocenza separata dall’ingenuità.” L’ultima donna sulla terra aveva trovato uno dei pochi uomini in grado di capirla davvero.
“Impiastro per sempre”
Spero di essere uno scrittore davvero (…) Non ho mai fatto un vaglia e spero che non ci sia nessun pasticcio.(lettera all’editore Carocci, 1937)
Suo padre quando era piccola la chiamava “impiastro per sempre”, “perché non sapeva vestirsi da sola, né allacciarsi le scarpe e lasciava tutto in giro e non era sportiva né studiosa e aveva paura di andare a scuola da sola.” E proprio su tutto quello che non sa fare, che non è in grado di capire, che non è buona a gestire Natalia Ginzburg ha costruito la sua forza narrativa. Quello che scrive suona spesso ai limiti dell’understatement, dell’ammissione di colpa, di un’ironia e autoironia che se non arrivano mai al cinismo sono sempre spietate nella loro sincerità. I giovani della Ginzburg non si sa come debbano invecchiare, le donne non hanno dove andare, gli uomini sono senza memoria e senza futuro, distrutti per sempre da cose di cui non importa a nessun altro che a loro: sono impiastri per sempre anche loro, intrappolati da se stessi e dalla vita che gli sta intorno. Alcuni si lasciano cadere, altri spariscono nel vuoto, ma tutti gli altri, proprio come lei, finiscono per correre lungo un doppio binario, e se non hanno una meta non gli manca l’orgoglio, se di futuro non ne vedono si attaccano al presente, e si salvano grazie a un gioco perpetuo di equilibrismi e bilanciamenti tra il vuoto e qualcosa che, malgrado tutto, un peso ce l’ha. Di quelli troppo sicuri, felici, certi del loro andare non soltanto la Ginzburg diffida, ma fa addirittura a meno.
Per lei, forse, sentirsi ed essere un impiastro in una vita “affollata di pasticci” è stato il prezzo da pagare per arrivare a scrivere come nessun altro, e a dedicare alla scrittura tutta se stessa. Una piuma di Dumbo al contrario, che l’ha convinta a credere in quello che sapeva fare per sottrazione rispetto a tutto quello che non sapeva e – come scrive in Il mio mestiere – che credeva non le sarebbe mai riuscito:
Quando mi metto a scrivere, mi sento straordinariamente a mio agio e mi muovo in un elemento che mi par di conoscere straordinariamente bene: adopero degli strumenti che mi sono noti e familiari e li sento ben fermi nelle mie mani. Se faccio qualunque altra cosa, se studio una lingua straniera, se mi provo a imparare la storia o la geografia o la stenografia o se mi provo a parlare in pubblico o a lavorare a maglia o a viaggiare, soffro e mi chiedo di continuo come gli altri facciano queste stesse cose, mi pare sempre che ci debba essere un modo giusto di fare queste stesse cose che è noto agli altri e sconosciuto a me.