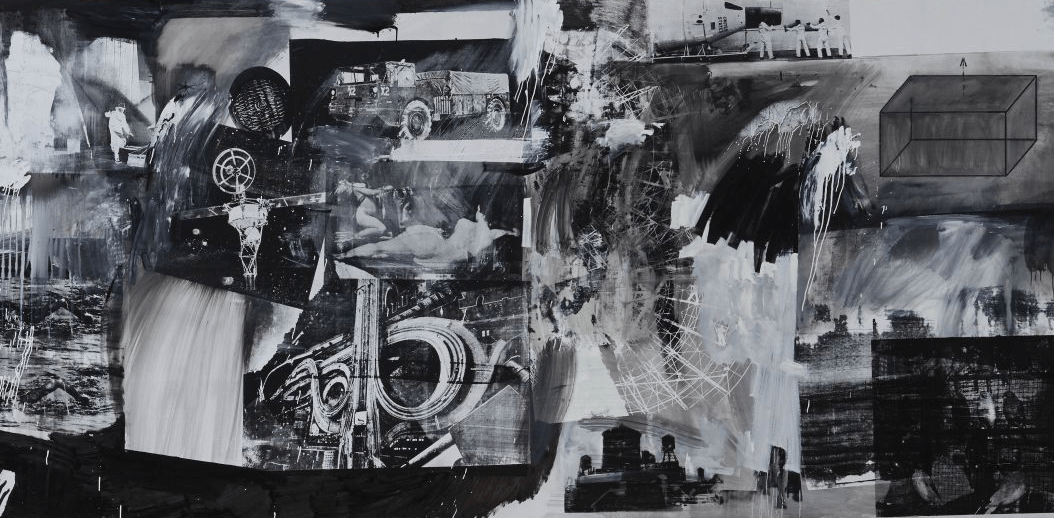
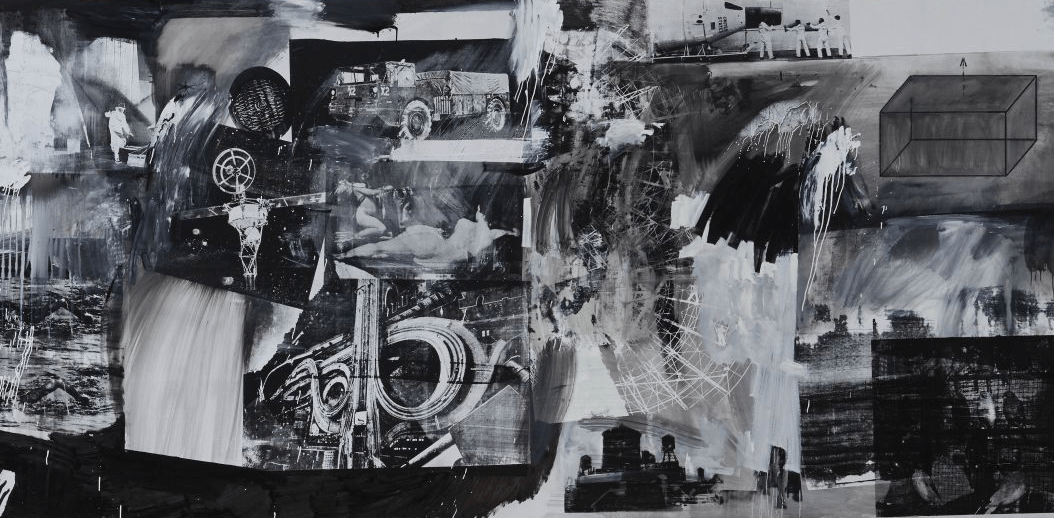
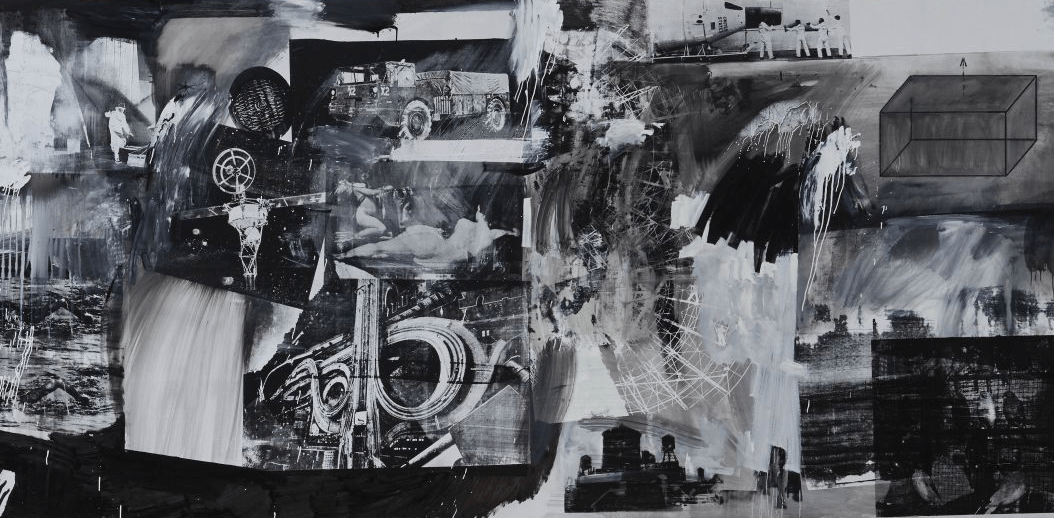
E sule, iconoclasta, provocatore, eternamente scisso tra i poli della Maturità e della Giovinezza, della Forma e del Caos. È difficile immaginare, tra i grandi narratori del Novecento, un autore che più di Witold Gombrowicz sia riuscito a portare a galla le aporie e i cortocircuiti del discorso letterario. Avverso a ogni stilizzazione, dottrina e metodo, lo scrittore polacco si è sempre contrapposto, nelle parole di Bruno Schulz, “alla basilare corrente culturale che consiste nel fatto che l’uomo si sfoga sempre a spese di parti, ideologie, frasi fatte e forme da lui stesso forgiate invece di vivere di se stesso”. Un uomo che, nel tentativo di legittimarsi, “si è sempre considerato un’imperfetta, irrilevante appendice ai propri contenuti culturali”.
Oltre alle ossessioni che puntellano la sua produzione artistica, anche la biografia di Gombrowicz si presenta come inscindibile da questo gioco di spoliazioni e fughe dall’identità. Egli stesso si dimostrò particolarmente refrattario all’annosa questione dell’intreccio tra letteratura e vita, come dimostrato dalla sua storica rivalità con Borges: se la poetica dell’argentino era infatti profondamente radicata nella letteratura e nei suoi infiniti rimandi potenziali, quella del polacco lo era nella vita e nell’intensità dell’esperienza. Gombrowicz stesso soleva definirsi, con un certo orgoglio, un individuo “anti-letteratura”.
Nato a Małoszyce nel 1904 in una famiglia di ascendenza nobile, si trasferì a Varsavia nel 1916, ma dopo la laurea in legge e una breve parentesi di praticantato decise di dedicarsi alla scrittura. Con la pubblicazione delle sue Memorie del periodo dell’immaturità, poi raccolte sotto il titolo Bacacay, e con la stesura di testi teatrali come Ivona, principessa di Borgogna si guadagnò (non senza critiche e stroncature) una certa nomea negli ambienti letterari della capitale polacca, fino alla consacrazione definitiva con l’uscita di Ferdydurke nel 1937. Negli anni della formazione compaiono già in forma embrionale alcune delle idiosincrasie che tormenteranno la sua riflessione negli anni successivi: gli attriti con la famiglia e la sua impostazione aristocratico- borghese, il difficile rapporto con la polskość, la “polonità”, la cieca sottomissione ai diktat del canone culturale e la costante sensazione di tensione e indeterminatezza tra poli inconciliabili. Ma, come ricordato nelle Conversazioni con Dominique Roux, una tensione soggiacente è necessaria a ogni atto creativo, perché per Gombrowicz l’arte nasce soltanto dalla contraddizione.
È proprio sulla contraddizione che si innesta Ferdydurke, grottesca e sprezzante risposta al Bildungsroman e al concetto stesso di formazione, dove il protagonista Józio, ormai trentenne, regredisce all’adolescenza, torna a scuola e diviene testimone delle pieghe grottesche dell’accademia, dei paradossi del sistema educativo e della cultura, ma soprattutto di un mondo adulto che soccombe ineluttabilmente al fascino della gioventù.
Gombrowicz stesso soleva definirsi, con un certo orgoglio, un individuo “anti-letteratura”.
Nella sua prefazione all’edizione inglese del romanzo, Susan Sontag descrive Gombrowicz come uno scrittore che fuggendo nella gioventù rigetta il destino che ci si aspetta dagli adulti, e che grazie a questa sottrazione riesce ad assaporare appieno la rinuncia all’identità e i privilegi che ne conseguono. La questione identitaria, declinata in chiave esclusivamente individualista, è sempre stata centrale per l’autore: era necessario far coincidere la scrittura con l’unica realtà possibile, quella “personale e privata, non quella generale e obiettiva”. Eppure, in Testamento osserva come lo sforzo creativo nel perseguire una scrittura egoistica l’abbia portato alla scoperta del problema universale della Forma, la dolorosa lotta dell’individuo con i suoi modelli, i suoi metodi, la sua cultura: tutto ciò attraverso cui l’uomo, un agglomerato di mondi diversi, si manifesta all’esterno.
Questo lungo processo di diffidenza e scomposizione, portato avanti nella narrativa come nel Diario, ebbe uno sviluppo decisivo negli anni dell’esilio. Partito per l’Argentina nel 1939 come giornalista a bordo del transatlantico Chrobry, decise di restare a Buenos Aires dopo la notizia dell’invasione nazista della Polonia, restandoci anche dopo l’instaurazione della PRL. Rimasto “completamente solo, privo di qualsiasi retroterra e per giunta interiormente lacerato”, Gombrowicz trascorse il periodo argentino in povertà, tra precarietà lavorativa al Banco Polaco, frequentazione degli ambienti intellettuali del caffè Rex e battuage nel quartiere gay del Retiro, facendo del disorientamento esistenziale una virtù. “Farla finita una volta per tutte con la mistificazione”, ricorda nel Testamento, “era una questione d’onestà, di dignità, di razionalità e soprattutto di vitalità”. Questa distanza dalla patria e dalle sue consuetudini si rivelò cruciale per la nascita di Witold Gombrowicz, l’individuo “amputato da se stesso”, che affrancatosi dal proprio nome e dalla propria identità passata riuscì a crearsi nella degradazione, nell’indeterminatezza e nell’abominio: in tutto ciò che rendeva possibile una fuga liberatoria dalla Forma.
La riflessione su una specie particolarmente insidiosa di Forma, quella polskość da cui si era definitivamente distaccato, divenne un altro degli snodi centrali del periodo argentino. I manierismi affettati degli ambienti dell’emigrazione polacca, il malcelato senso d’inferiorità identitaria e culturale nei confronti dell’Europa occidentale e l’attaccamento ai vecchi valori della patria perduta condussero presto Gombrowicz a una critica tout court dell’artificiosità di qualsiasi teoria, ideologia o fede. L’indeterminatezza che tanto affliggeva i polacchi (e gli uomini tutti) era anche apertura alla possibilità di costruirsi una propria libertà individuale affrancandosi dal fardello della Forma, di “essere se stessi molto di più”, nelle parole di Arbasino, o quantomeno di ristabilire, con il culto dell’Immaturità, una sovranità sulla propria creazione. La scrittura, l’arte verbale della manipolazione, diventa il mezzo privilegiato per far emergere un sé vitale e autentico dalla tensione tra il desiderio abietto e l’imperativo formale che cerca di imbrigliarlo.
L’atteggiamento dell’autore nei confronti della critica letteraria, al meglio scettico e al peggio apertamente sprezzante, viene spesso ribadito nelle conversazioni del Testamento. È con il discorso sulla polonità e sui codici condivisi dell’emigrazione e dei microcosmi sociali, sapientemente ridicolizzati in Trans-Atlantico, che si apre una serie di meditazioni più ampie sulla tendenza ad affidarsi tout court a una scuola di pensiero, un metodo o un’ideologia, a loro modo una specie di patria. Gombrowicz ne rovesciò la necessità: le teorie erano per lui meri “setacci attraverso i quali scorreva la vita”, devozione a una forma che impedisce un accesso autentico all’ingenuità e all’immediatezza dell’esistenza. Deprecava “quelle analisi abissali, quegli scrupoli troppo drammatici” di un lusso ben lontano dalla santità e dalla ragione della vita – le stesse analisi che Marcoaldi definì tranchant, nel suo contributo a Riga 7, “tutte le forme di onanismo mentale mascherato; […] che discendono dall’autocompiacimento linguistico […] e dai deliri interpretativi che ne discendono”. La devozione al metodo come delirio onanistico, dunque. Come avvicinarsi a Gombrowicz fuori da questa impasse?
Le “macchine infernali” di Gombrowicz, così definiva i suoi romanzi, avevano la peculiarità di autodistruggersi nel momento stesso della loro creazione, vanificando qualsiasi sforzo di incasellarle entro un’ideologia o un metodo.
Nel dedalo della critica del Novecento, scissa tra metodologie rigorose, ermeneutica orientata al lettore, decostruzionismo disilluso e appelli ai valori umanistici contro il caos della postmodernità, è forse Susan Sontag ad avvicinarsi di più all’approccio auspicato dallo scrittore polacco. Anche lei pensatrice eclettica, paladina della sensibilità lowbrow e con lo sguardo sempre attento alle soluzioni delle avanguardie, nei suoi scritti critici rivendica l’importanza dell’esperienza estetica e della fruizione dell’opera nella sua immediatezza sensuale, contro una critica intellettualistica sempre più depauperante che rende l’arte “gestibile e malleabile”. Una critica, citando il Gombrowicz del Testamento, ormai votata all’ingrato compito di “tradurre la poesia in diagrammi”. È curioso osservare anche come i due intellettuali fossero egualmente ossessionati dalla questione della forma, seppur con accezioni diverse: se la Forma è per l’uno un dramma interumano della massima urgenza metafisica, le tesi dell’altra si snodano nel solco dell’annosa querelle sulla dicotomia tra forma e contenuto, dove ad avere la meglio è quasi sempre il secondo.
Per Sontag il problema dell’interpretazione è, essenzialmente, un problema di giustificazione. Se dai tempi di Platone e Aristotele, in cui l’arte era innanzitutto imitazione, si ricercavano motivazioni da addurre a favore dell’utilità dell’opera d’arte, la coscienza occidentale non è mai riuscita ad affrancarsi dalla priorità e dall’egemonia del contenuto. Il modello interpretativo – da non intendersi come valore assoluto bensì come atto cosciente – si è fatto strada nel corso delle epoche passando da un’interpretazione dei testi antichi secondo i bisogni moderni a sistemi ermeneutici ben più rigorosi, come quello marxista o quello freudiano, in grado di riformulare un fenomeno e inquadrarlo in una visione storica. Senza derubricare in toto la validità dei metodi critici, resta indubbio che il piacere dell’opera risieda anche al di là del significato latente o manifesto. Lo stesso Gombrowicz, del resto, non era estraneo alla filosofia, pur intrattenendo con essa un rapporto “scettico-utilitarista”. Sartre elogiò le conoscenze teoriche del polacco in fatto di marxismo, psicoanalisi e strutturalismo, ma le “macchine infernali” di Gombrowicz – così definì i suoi romanzi – avevano la peculiarità di autodistruggersi nel momento stesso della loro creazione, vanificando qualsiasi sforzo di incasellarle entro un’ideologia o un metodo. La vitalità di Gombrowicz sembrava eludere ogni rigore, nella lettera come nella critica, e ci era arrivato non per speculazioni teoriche, ma “attraverso la sua personale patologia”.
Nell’enumerare antidoti validi all’eccesso di interpretazione, Sontag ricorda la parodia e il manierismo, cari a Gombrowicz, la fuga dal contenuto – è il caso dell’arte astratta, che ci risulta oscura per difetto, oppure della Pop Art, ininterpretabile nella sua evidenza –, o ancora la rivoluzione del gusto poetico. L’avanguardismo programmatico risultava tuttavia impraticabile, perché alla lunga avrebbe costretto le arti a un perpetuo movimento di fuga. È opportuno (nonché ironico) notare come in Gombrowicz la fuga dalla Forma porti al crocevia ineliminabile tra il Caos e la creazione di nuove forme altrettanto soffocanti. Per sottrarsi a tali aporie viene invocato il valore liberatorio della trasparenza, una rappresentazione della vita che tenga conto dell’esperienza sensoriale delle cose, della gioiosa esuberanza degli eccessi oltre metodi, temi e convenzioni.
Per entrambi gli autori la partita si gioca sul terreno dello stile, che da appendice irrilevante del contenuto può finalmente venire riconosciuto come espressione privilegiata della totalità dell’opera. Wojciech Karpiński ricorda come il problema fondamentale di Gombrowicz, scrittore “dionisiaco-cerebrale”, fosse proprio la ricerca dello stile, il tentativo di ritagliarsi una propria identità espressiva operando una sintesi tra “il gelido sorriso di Nietzsche” e “la voluttà delle eruzioni verbali di Rabelais”. Del resto, sono molte le citazioni d’autore sulla fisionomia delle scelte formali, dal “Lo stile è l’uomo stesso” di Buffon, poi parodiato da Lacan, al quasi fatalistico “Lo stile è l’anima, che per nostra sfortuna assume le forme del corpo” di Cocteau, ripreso da Sontag. In Gombrowicz la questione era altrettanto incontrovertibile, ma si trattava di un fatto – o meglio, un atto – di volontà: “Che la mia opera divenga me stesso”. In questa ricerca spasmodica di un vitalismo capace di crearsi ex novo attraverso la lettera, la teoria veniva esclusa dalle competenze dell’artista e acquisiva valore solo quando “immessa nel sangue”. Inutile allora affidarsi al principio di realtà, alla verosimiglianza o alla sincerità: in letteratura, afferma Gombrowicz, “non serve assolutamente a nulla. È un’altra delle antinomie dinamiche dell’arte: più si è artificiali, e più si può essere sinceri. […] E poi, la sincerità è una tale barba! Non sa di niente”.
La vitalità di Gombrowicz sembrava eludere ogni rigore, nella lettera come nella critica, un risultato raggiunto non per speculazioni teoriche, ma “attraverso la sua personale patologia”.
Simili diatribe su stile e artificialità non sono recenti. Dietro alle discussioni sulla distinzione tra forma e manierismo, sulla consapevolezza storica delle scelte stilistiche o sulla rivendicazione del rapporto organico tra contenuto e stile, per Sontag si cela il dilemma sempre aperto “della storica confusione occidentale sul rapporto tra arte e morale, tra estetica ed etica”. Se la distinzione cerca di difendere l’autonomia dell’estetico, il rovescio sta nella velata ammissione dell’esistenza di due tipi diversi di risposta all’arte. Eppure per Sontag il piacere estetico è un piacere morale: la moralità nell’arte è un problema di risveglio della sensibilità etica attraverso l’estetica – una posizione che verrà ripresa e ampliata da Brodskij nel suo discorso di accettazione del Nobel qualche anno più tardi. Lungi dall’essere confinata alla sola teoria, in Sontag la coscienza eccede la contemplazione, “si nutre di arte e di pensiero speculativo, attività […] non bisognose di giustificazione”, perché la sensualità è una giustificazione sufficiente. E in un mondo di forme sempre mutevoli, volatili e in costante tensione, la morale è indispensabile. “Senza morale non esiste letteratura. La morale è il sex-appeal dello scrittore”, diceva Gombrowicz a Roux. Si può parlare di stile nei termini di principio di decisione o messa in scena della volontà, come fa Sontag, ma il risultato finale resta sempre quello visibile in superficie: se l’arte più grande sembra una secrezione, un’arte autenticamente morale si sviluppa dall’interno verso l’esterno. I movimenti di etica e desiderio hanno la marca della convessità.
Proprio l’intreccio tra etica e desiderio è stato uno dei punti nevralgici della produzione letteraria di Gombrowicz e della sua critica – è il caso, ad esempio, dell’interpretazione lacaniana di Berressem, nata da un fortuito accidente linguistico in corso di una traduzione precedente (una tensione divenuta desiderio) menzionato da Borchard nella sua nota all’edizione inglese di Pornografia. La posizione di Gombrowicz, radicale e profondamente etica, era volta alla scoperta della propria moralità di uomo e artista fuori da ogni sofisma. Il termine moralità, del resto, ricorre spesso nelle sue riflessioni: “In mancanza di meglio, bisognava semplicemente recuperare la morale insita dentro di noi senza pretendere motivazioni di sorta”, confidò a Roux. Sia nelle riflessioni di Gombrowicz che in quelle di Sontag, le tortuosità di etica e stile si dipartono e si intrecciano continuamente. Numerosi sono gli appelli al ruolo dell’arbitrario e dell’ingiustificabile, il sigillo più attendibile della soggettività insostituibile del creatore: lo stile è il criterio linguistico con cui, per Sontag, “l’artista dispiega le forme della sua arte”. Non esiste grado zero, non esistono neutralità né autenticità, non esiste nulla all’infuori delle parole che erompono dalla necessità interiore: stile e morale coincidono nella descrizione inevitabilmente personale di ogni esperienza e dello sguardo da cui viene filtrata, nell’intensità della sua focalizzazione, nella devianza dalla norma – o dalla Forma.
Per funzionare, allora, la letteratura deve sfuggire all’interpretazione sgusciando via come un’anguilla, dichiara Gombrowicz nel Testamento. Non nel perpetuo rinvio dei significanti caro alle interpretazioni che tanto vituperava, bensì nella necessità che l’arte si svolga sempre “da tutt’altra parte”. Nel puro piacere della fruizione, ad esempio, o in una risata liberatoria che dimostra tutto l’amore per la commovente impotenza umana, come voleva Schulz. La sensibilità quasi camp di Gombrowicz, che prevede il trionfo dell’ironia, dello stile e della leggerezza, ci rivela l’importanza di affrancare i piaceri della vita e della lettura dalla severità concettuale, di abbracciare il non senso come antidoto all’atrofia dei sensi, di apprezzare innanzitutto l’ingiustificabile. Questa “follia del godersi l’assurdo”, per citare una pagina del Diario, risiede proprio nell’assurdo del godimento al di là di ogni tentativo intellettuale di legittimarlo, e la produzione di Gombrowicz è il perfetto antidoto a quella letteratura nera di cui deplora “il tono demoniaco-apocalittico oggi quasi obbligatorio”, alla seriosità stantia dei drammi interiori del tardo modernismo e alle tendenze catastrofiste dei suoi contemporanei. La fruizione dell’arte è uno dei temi centrali della sua produzione non solo sul piano letterario con la critica alla venerazione passiva della cultura, ammirata e studiata ormai non per i suoi meriti ma per la sua appartenenza a un canone o un gusto condiviso, ma anche e soprattutto sul piano concreto della lettura, intesa come rapporto tra vita e testo, spesso accantonato a favore di un’interpretazione puramente cerebrale.
Dopo la morte di Gombrowicz, Miłosz ha riflettuto sulla necessità “di prendere il partito di quelli che hanno sempre confessato di non capire Gombrowicz, piuttosto che di quegli spiriti desti per il quale tutto è chiaro in lui. Gombrowicz aveva messo il dito su questioni per noi, nel nostro secolo, e forse in generale, incomprensibili”. Forse, allora, se ogni interpretazione è il prodotto retroattivo di una teoria o di una forma già stabilite e trasforma il presente dell’esperienza nel passato della comprensione, è arrivato il momento di pensarlo di meno e sentirlo di più. E se con l’avvento della cultura dell’intrattenimento di massa, permeata dall’ideale americano di eterna giovinezza (non a caso, Ferdydurke è una delle opere di narrativa più menzionate dai Tiqqun nella Theory of the Young Girl), Gombrowicz non è più in grado di provocarci con il contenuto, il fascino, la stravaganza e l’intransigenza dello stile sono ancora intatti. “Lunga vita al suo scherno sublime di tutti i tentativi di addomesticare il desiderio… o la portata della grande letteratura”, recita la prefazione inglese a Ferdydurke. Possiamo ancora addentrarci nel piacere del testo e scoprire come nel punto di resistenza a ogni rigore, nell’assoluta refrattarietà a ogni interpretazione, risieda la più liberatoria delle gioie, quella di arrendersi. E se alla fine dei giochi sembrano restare solo le incomprensioni o le antinomie irrisolvibili, possiamo appellarci a quanto auspicato da Sontag in chiusura a Contro l’interpretazione: anziché di un’ermeneutica, abbiamo bisogno di un’erotica di Gombrowicz.