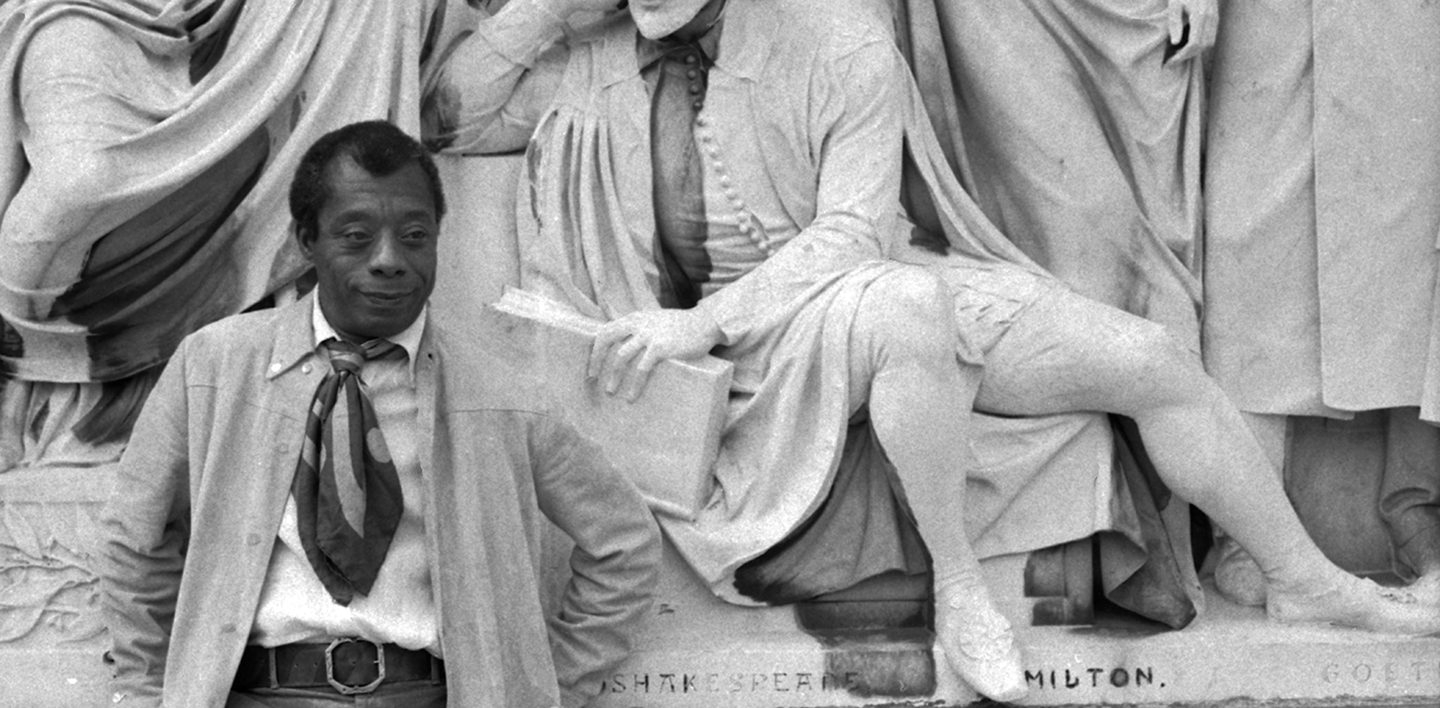
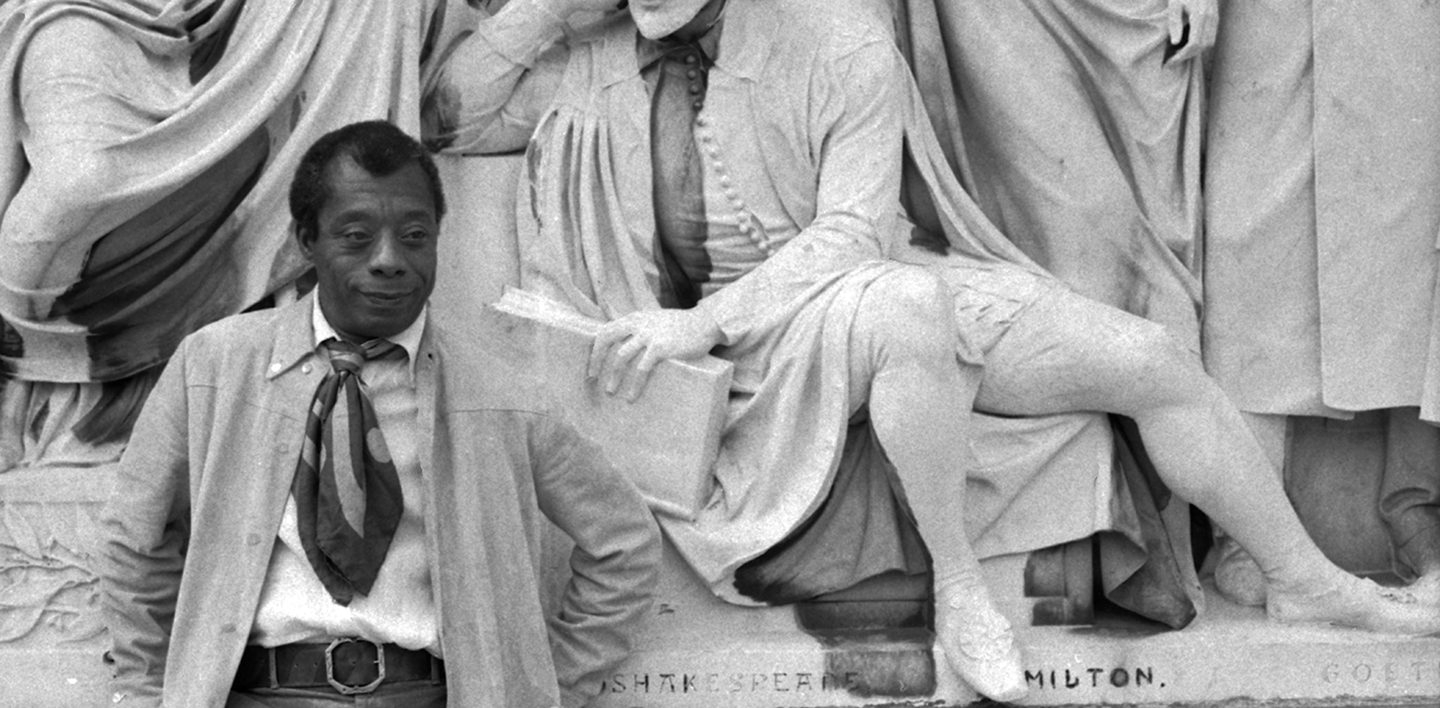
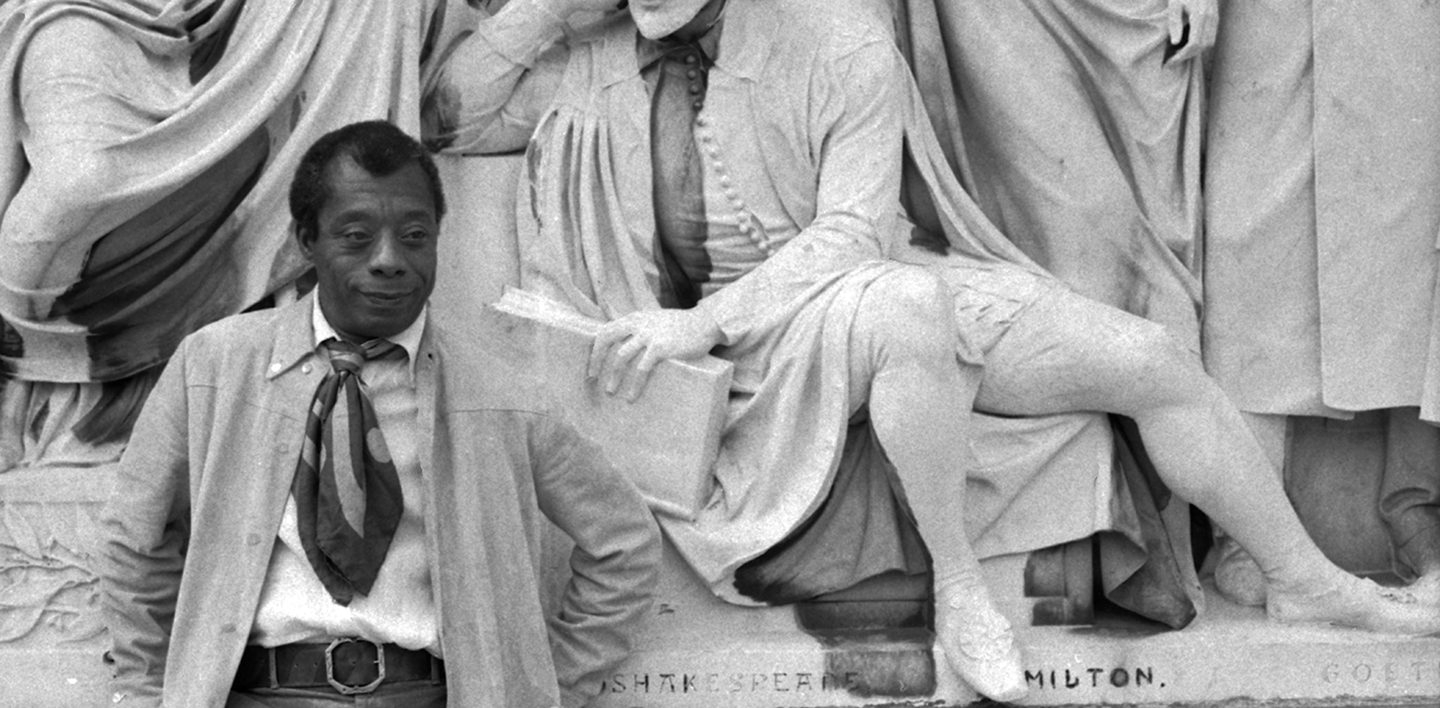
I l faldone su James Baldwin messo insieme dall’FBI tra il 1960 e il 1974 conta quasi duemila pagine. Una di queste è stata annotata a margine, in matita, dal direttore stesso, J. Edgar Hoover: “Isn’t Baldwin a well known pervert?”, è un omosessuale, allude. L’agente che compila il report di risposta sceglie la cautela: non è possibile stabilire l’orientamento sessuale di Baldwin – se sia un pervert o no – ma è vero che ha espresso pareri positivi sull’omosessualità, e il tema compare in due dei suoi tre romanzi pubblicati. Sebbene l’FBI sorvegliasse Baldwin per tracciarne il coinvolgimento con le organizzazioni impegnate nella lotta per i diritti civili, gli archivi rivelano piuttosto curiosaggine per la condotta privata di Baldwin, alle volte anche per le vite sentimentali dei personaggi dei suoi romanzi. La saggistica di Baldwin, invece, non pare disturbare l’FBI: The Fire Next Time (La prossima volta il fuoco), un lungo saggio del 1963, è riassunto in cinque righe. Eppure è un testo in cui Baldwin si domanda “Davvero voglio essere integrato in una casa che brucia?”. Il dettame “separati ma uguali” divide la vita civile statunitense fino al 1964, i primi quarant’anni della vita di Baldwin trascorrono permeati dagli effetti della segregazione razziale regolamentata dalle leggi Jim Crow.
Se nei romanzi Baldwin dedica ampio spazio alle relazioni omoerotiche e gli amori interrazziali che scandalizzano l’FBI, è nella saggistica prodotta in parallelo, durante il suo esilio volontario in Europa, che Baldwin descrive strategie di sopravvivenza e convivenza degli americani divisi dal colore, ed elabora nel lungo corso il suo concetto di amore. Si tratta di articoli, recensioni e longform per riviste poi pubblicati in raccolte indipendenti durante tutta la sua carriera, testi in cui Baldwin espone le sue idee più brillanti, per esempio “the Negro problem” – un problema dei bianchi che “non esiste se non nel buio delle menti” – o l’identità del singolo unica “pietra di paragone” con la realtà. Sono testi costruiti dando l’impressione che chi legge sia invitato ad aggiungersi alle speculazioni di Baldwin, e a comporre insieme a lui l’equazione che spiega i perché delle storie personali che racconta. Notes of a Native Son (Questo mondo non è più bianco), ad oggi la sua raccolta più celebre e purtroppo l’unica oggi reperibile in italiano, esce nel 1955, il suo seguito, Nobody Knows My Name, compare nel 1961. The Devil Finds Work (1976) raccoglie scritti di critica cinematografica, No Name in the Street (1972) è una raccolta di profili di figure storiche contemporanee. Per il best-seller The Fire Next Time (1963) Baldwin riceve un biglietto di apprezzamento da Hannah Arendt, la quale si dichiara “spaventata dal vangelo d’amore che inizia a predicare sul finale”.
The Fire Next Time è un dittico in cui Baldwin concentra le sue considerazioni sulla tensione razziale, e per farlo sceglie di raccontarsi in prima persona, con una lettera a suo nipote James – “My Dungeon Shook”, il primo dei due saggi-manifesto – e sbrogliando – nel secondo saggio, “Down at the Cross” – le implicazioni religiose, oltre che culturali, al cuore della discriminazione. “My Dungeon Shook” è una lettera pensata in occasione del centenario del Proclama di emancipazione (l’ordine esecutivo con cui nel 1863 lo status legale degli schiavi neri passa a libero), con cui Baldwin intende rinfrancare il nipote: “l’uomo nero funge da stella fissa, pilastro immobile nel mondo dell’uomo bianco, se si sposta dal suo posto il cielo e la terra si scuotono alle fondamenta”. Lo invita anche, però, ad immedesimarsi in una simile sensazione di terrore e disorientamento, come “se svegliandosi una mattina vedesse il sole brillare e tutte le stelle in fiamme”. L’intenzione, tuttavia, non è affatto quella di spaventare, anzi, la responsabilità che Baldwin vuole suggerire al nipote si rifà a uno dei concetti fondamentali del suo pensiero: l’idea di affetto nell’azione politica.
Quella che emerge dal corpus dei suoi saggi è una forma di amore controintuitivo, un “hard loving” capace di ribaltare i termini dell’inclusione in gioco, un allargamento drastico della visuale attraverso il quale è il nero a poter accettare il bianco, e non il contrario. Quando è impegnato a decifrare le ripercussioni psicologiche del razzismo – sia su chi lo subisce e su chi lo pratica – e le forme culturali legate alla segregazione di stato, Baldwin si sforza di condividere il suo pensiero nella sua forma più pura, il che rende necessario accompagnare ai romanzi la saggistica. L’analisi descrive senza voler provocare una risposta di pancia, ripulisce i fatti e li raffina creando immagini nitide e spiegazioni lampanti. Baldwin sa che il paese sta “festeggiando cent’anni di libertà con cent’anni d’anticipo”, e in mancanza di un’autentica storia di integrazione, Baldwin fornisce – in “Down at the Cross” – una seconda lettera scritta “da un luogo nella mia mente” – le sue memorie di bambino nero nel ghetto di Harlem, figliastro di un pastore protestante, primogenito di una famiglia che fatica a dar da mangiare a tutti i suoi bambini. Il punto di vista biografico, eccezionalista nella misura in cui viene messo per iscritto, ma di fatto sovrapponibile a mille altre storie analoghe, diventa, in ogni saggio, la base più solida per generalizzare esperienze generazionali, dandogli la dignità di storia.
“Sto usando la parola ‘amore’ non semplicemente nel senso personale, ma come uno stato dell’essere, o uno stato di grazia – non nel senso americano, infantile dell’essere resi felici, ma nel senso universale e difficile della ricerca, dell’audacia e della crescita”: un’interruzione simile – in “Down at the Cross” – è una classica accortezza alla Baldwin. Gli appigli per guidare il lettore sparsi nei suoi saggi sono di vari tipo, alle immagini immediate – “una mosca nel latticello”, “la cultura non è un cesto intrecciato dalla comunità” – si sommano gli intervalli forzati per chiarire il significato a cui mira, che a volte prendono la forma di una specifica parola in isolamento, focalizzando il vero motivo per cui Baldwin sta accostando sequenze di ricordi. Per esempio, in “Freaks and American Ideal of Manhood” – esplorazione dell’ideale di sessualità americano, che Baldwin vede rapprendersi nel desiderio maschile – “Povertà” è una frase in isolamento, che funziona da perno. Prima, una scena di ingegnosità domestica:
mia madre friggeva il manzo in scatola, lo bolliva, lo cuoceva al forno, ci metteva delle patate, del riso, lo nascondeva nel pane di mais, lo bolliva nella zuppa(!), lo avvolgeva in uno strofinaccio, lo batteva con un martello, lo sbatteva contro il muro, lo lanciava contro il soffitto. Infine lasciava perdere, non c’era modo di farcelo mangiare ancora.
Dopo, un esterno giorno, Baldwin ragazzino in competizione con un quarantenne per una moneta caduta per terra. Harlem è il punto di partenza preferito per le sue divagazioni, sia teoriche che di osservazione sociale, e la resa minimalista del degrado del quartiere e dell’isolamento di chi lo abita azzera il potenziale patetico di una scrittura che resta, sempre, di denuncia. Baldwin infatti si assume ogni rischio legato all’usare il racconto personale come chiave di lettura sociale, è conscio della possibilità che la sua trasparenza sia scambiata per arroganza quando riepiloga un’intera generazione, o quartiere, o paese a partire dai suoi termini empirici. Eppure l’alternanza tra storie di vita comune – Baldwin bambino strattonato e perquisito da due poliziotti bianchi in “Down at the Cross” – ed episodi unici – Baldwin isolato in carcere, in balia della burocrazia francese fino all’essere riconosciuto come “Américain” in “Equal in Paris” – è fondamentale per raccontare l’eredità di sofferenza psichica causata dalla disuguaglianza storica sofferta dagli afroamericani.
Baldwin è anche capace di sfruttare il controllo inalienabile delle proprie memorie – sempre allo scopo di illustrare situazioni di sofferenza – a rischio di alimentare stereotipi degradanti, senza nascondere o annacquare la violenza nei propri stessi gesti. Nel 1948 Baldwin è nel New Jersey, impiegato che in pausa pranzo cerca un ristorante dove mangiare: nemmeno la tavola calda American Diner (Baldwin non manca di notare l’ironia nel nome) accetta di servire hamburger e caffè a un cliente nero. Quando la cameriera bianca di un ristorante pretenzioso (e per soli bianchi) si trova a dover ripetere la formula “non serviamo Negroes qui” al giovane nero seduto immobile al tavolo, si scansa appena in tempo dalla traiettoria di una caraffa d’acqua che si infrange contro la parete alle sue spalle. Baldwin racconta questo episodio, e l’esasperazione insopportabile da cui ha origine, in Notes of a Native Son, il saggio in cui elabora il lutto per il padre e ripercorre l’itinerario mentale che l’ha portato a capire quanto la sua vita “la vita vera, fosse in pericolo, e non per quello che le altre persone potessero farmi, ma per l’odio che mi portavo nel cuore”.
Eppure il Baldwin che rischia il linciaggio diventa, nel 1971, l’affermato intellettuale pubblico che sfiora la mano di Nikki Giovanni – all’epoca, promessa della poesia afroamericana – per calmarla e assicurarle la sua attenzione quando, durante un acceso dibattito televisivo, i due non riescono ad accordarsi. Insieme discutono sul livello di autonomia che è lecito aspettarsi da persone che hanno interiorizzato così a fondo i riflessi razzisti, si chiedono che tipo di amore possono dimostrarsi a vicenda, e come giudicare le situazioni che vengono a crearsi. “L’amore deve essere razionale, deve, è una situazione razionale” insiste Giovanni, e seppure Baldwin neghi vigorosamente, lo fa senza imporre il vantaggio dell’età e dell’esperienza sulla ragazza seduta accanto a lui. Giovanni lo critica senza remore per la sua propensione a considerare la coesistenza tra bianchi e neri nei suoi aspetti morali, invece che politici, ma Baldwin, invece che sanare le divergenze, ribatte seguendo i suoi schemi classici: portando un esempio tratto dalla sua vita, e capovolgendo le aspettative circa i ruoli e le azioni capaci di innescare cambiamenti.
“Un paese è forte solo quanto sono forti le persone che lo compongono e un paese diventa quello che le persone vogliono che diventi” scrive in “Notes for a Hypothetical Novel”. È un saggio in cui vaglia i limiti della prosa ancorata alla biografia, e in un certo senso spiega il suo metodo. D’altronde, nota, “c’è qualcosa di molto più importante e reale che produce la Cadillac, il frigorifero e la bomba atomica, qualcosa che a quanto pare non vogliamo vedere, ed è la persona”. La posizione minoritaria di Baldwin è di fatto il punto d’accesso più limpido per osservare l’immaginario americano, le forme culturali che lo propagano e registrare in prima persona gli effetti che causa. Nero, omosessuale, cresciuto in un ghetto, allontanatosi dalla fede: il “ritratto nazionale” che “suggerisce lavoro duro e sano divertimento e morigeratezza e devozione e successo” non lo riguarda, così come esclude “la maggior parte delle persone di questo paese, e la maggior parte dei fatti della vita”, scrive in “In Search of a Majority”. “Una delle ragioni per cui siamo così attaccati a inchieste sociologiche, ricerche e comitati d’indagine è perché nascondono qualcosa”: la realtà osservabile non è altro che un conflitto tra “modi di vivere”. E poi:
Finché possiamo trattare il Negro come un tipo di statistica o qualcosa da manipolare, o da cui scappare, o a cui dare qualcosa, è qualcosa che possiamo evitare, e quello che evitiamo è ciò che davvero significa per noi.
Baldwin vede una società resa immobile dal panico e dalla paranoia, che preferisce appendersi a categorie inventate per “negare bellezza, paura e potere” dell’essere umano, ma che allo stesso tempo ha creato un immaginario americano elastico abbastanza da pubblicare il genere della protest novel e apprezzare la musica jazz. Ma solo finché, indica Baldwin, i personaggi neri restino “icone operose”, e la comprensione della musica resti avvolta da un “sentimentalismo protettivo” che ne limita la lettura. In “Everybody’s Protest Novel”, saggio che distrugge il retaggio del canonico romanzo antischiavista La capanna dello Zio Tom (1852) di Harriet Beecher Stowe, Baldwin dà la sua definizione di “sentimentalismo”: “lo sfoggio vistoso di emozioni eccessive e fasulle è il segno della disonestà, dell’incapacità di provare sentimenti, l’occhio umido del sentimentalista tradisce la sua avversione all’esperienza, la sua paura di vivere, il suo cuore arido, ed è sempre, perciò, segnale di una segreta disumanità violenta, la maschera della crudeltà”.
Il lavoro di critica culturale portato avanti per tutta la vita – per esempio il lungo saggio di spietata critica cinematografica The Devil Find Work – evidenzia la capacità (e responsabilità) che certe modalità di narrazione hanno nel viziare percezioni e comportamenti anche al di là degli schermi e delle pagine: una sceneggiatura può essere “vuota come una buccia di banana, e altrettanto viscida”. Soprattutto, Baldwin non sopporta l’idea che un unico sguardo, quello compassionevole del bianco, sia diretto in maniera univoca al nero, e possa impunemente raccontarlo secondo le frequenze del paternalismo e del pietismo. In “In Search of a Majority” rovescia la direzione dello sguardo: “nessuno al mondo, in tutto il mondo, sa di più, e conosce gli americani meglio o, per quanto strano possa sembrare, li ama più del Negro americano. E questo è perché vi ha dovuti guardare, essere più furbo di voi, avere a che fare con voi, sopportarvi, e a volte anche sanguinare e morire con voi, da quando siamo arrivati qui, cioè, da quando entrambi, bianchi e neri, siamo arrivati qui, e questo è un matrimonio”.
Baldwin, perciò, vede il binarismo razziale americano come “un matrimonio”, un patto e non certo una convivenza le cui parti trovino il tempo per amarsi a vicenda. Nel suo appello all’amore e all’amarsi, di conseguenza, non c’è traccia di ingenuità o romanticismo, e quasi non c’è traccia di una controparte: “non possiamo discutere lo stato delle nostre minoranze finché non abbiamo un’idea di che cosa siamo, chi siamo, quali sono i nostri obiettivi e in che modo intendiamo la vita”, scrive in “In Search of a Majority”. È una questione di coscienza, individuale e collettiva, che trascende percentuali e colori, e continua: “la questione non è che cosa possiamo fare per il messicano ipotetico, o per il Negro ipotetico. La questione è che cosa vogliamo davvero dalla vita, per noi stessi, che cosa riteniamo sia reale”.
Baldwin incolpa “la preziosa innocenza” dei toni in cui l’America si racconta, l’idea che ci sia un’unica e spontanea via “naturale” di fare le cose, e in “The Preservation of Innocence” marca i legami che uniscono “orrendo romanticismo” e misoginia, l’infantilismo nella divisione tra i sessi e omofobia. “Che cosa succederà a tutta questa bellezza?” Baldwin ricorda essersi chiesto da ragazzino, in conclusione di “Down at the Cross”: la bellezza, intende, della particolare eredità di dolore condivisa dagli afroamericani, del carattere che ne è nato. Senza mai esplicitare una risposta, Baldwin tenta, con i suoi saggi, di intessere una storia sommersa e ignorata nel quadro politico di una nazione, senza diluirne le specificità, ma nemmeno celebrandone gli esiti. Invece di tradurre gli ideali in prassi, Baldwin suggerisce una linea morale. Lo stato di grazia che Baldwin auspica, l’amore come ricerca, audacia e crescita, che è sfuggito al vaglio dell’FBI e ha spaventato Hannah Arendt, è un antidoto al veleno che ognuno si porta dentro, un compito di coloro che, anche se a malapena consapevoli, “devono, come amanti, esigere, o creare, la coscienza degli altri”.