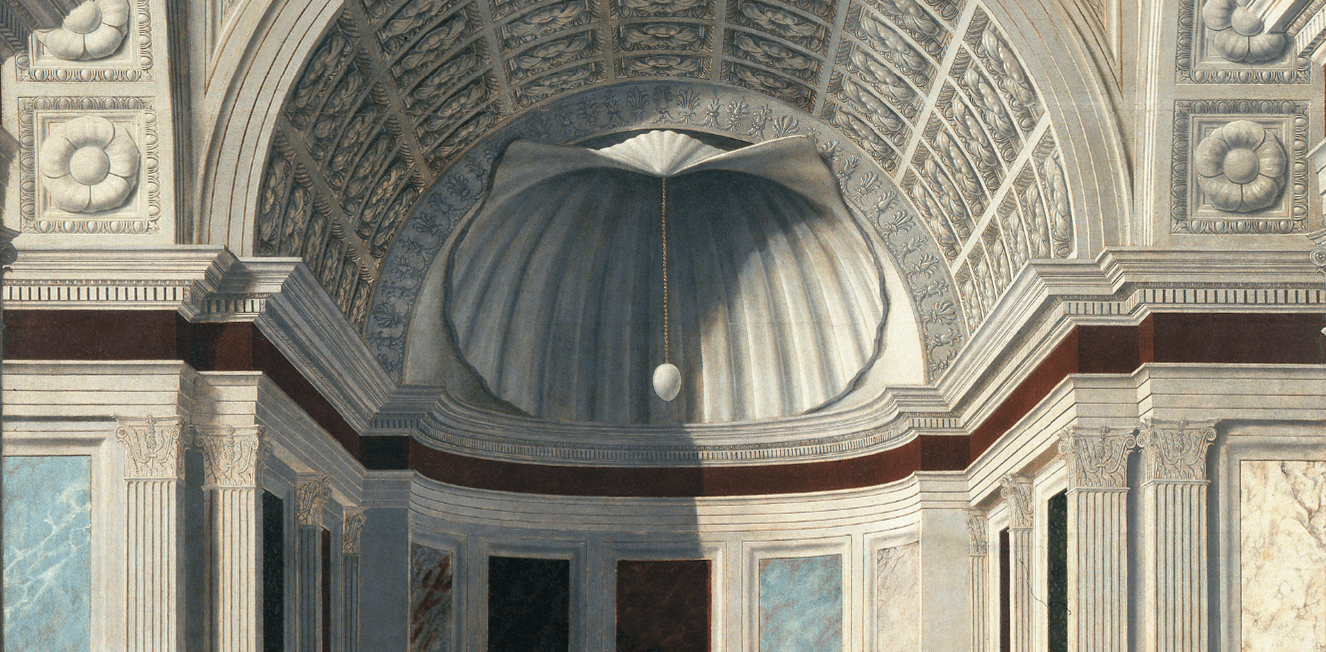
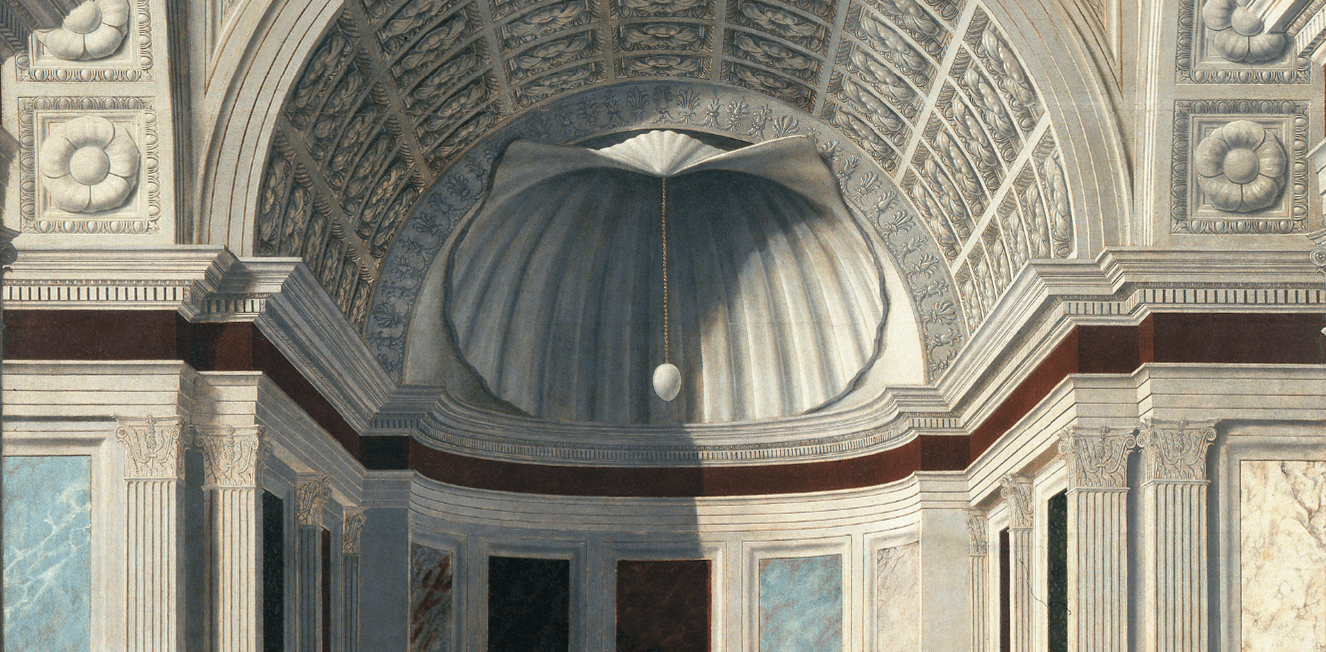
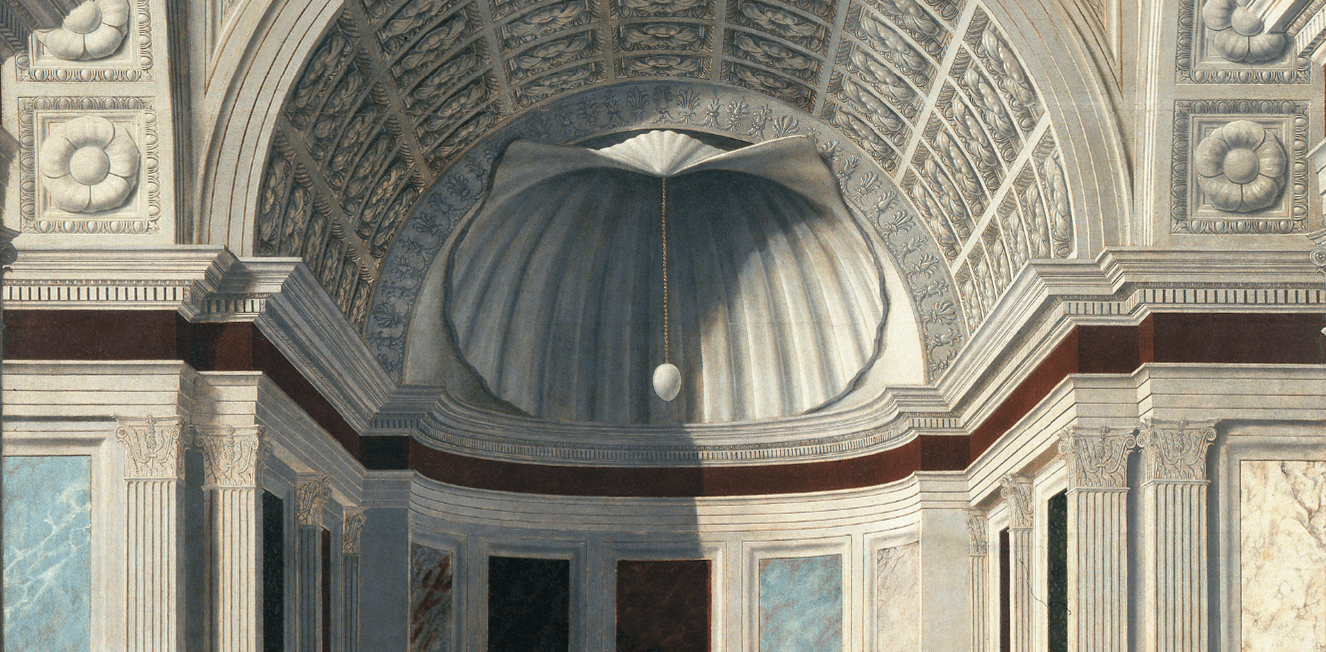
C ’erano una volta, in una terra tanto lontana, due fratellini di nome Kaele e Abino. Kaele era il maggiore, il Big Brother, diciamo, e lavorava nei campi; mentre Abino, il minore, preferiva occuparsi degli animali. Un giorno i due fratelli decisero di fare un’offerta agli dèi, così, per ringraziarli delle benedizioni ricevute in vita. Kaele raccolse i frutti del proprio sudore e donò quelli, mentre Abino scelse alcuni tra i suoi animali e li offrì in sacrificio. Gli dèi, chissà perché, furono soddisfatti dell’offerta di Abino, ma non gradirono troppo quella di Kaele. Questi, invidioso del fratello, andò su tutte le furie. Sapeva bene d’aver lavorato di più e meritare quindi un riconoscimento maggiore. Un bel giorno, la gelosia di Kaele gli fece nutrire pensieri oscuri. Doveva assolutamente fare del male al fratello. E allora – com’è, e come non è – mentre si trovavano nei campi, l’attaccò e l’uccise. Gli dèi seppero subito, neanche a dirlo, del pasticciaccio e bandirono Kaele da quella terra. Lui, tapino, vagolò per il mondo solo soletto e pieno di rimorsi, come una nube nera nel cielo infinito. Ma poi fondò una città e iniziò una nuova vita.
Morale? Ay, there’s the rub, direbbe Amleto. Questo è il punto. L’interpretazione. Perché interpretare a volte implica la necessità di tirare un po’ per la giacca questioni complesse; può voler dire, per farla semplice, tirare l’acqua al proprio mulino. La storia, che ho narrato, è evidente, è tratta di peso, ma con piccole varianti, da un racconto archetipico del Genesi. Quello sì che è stato interpretato autorevolmente negli scritti patristici o secondo l’antica esegesi ebraica. Il nostro non necessita di tanto: possiamo trattarlo né più né meno alla stregua di una sorta di fiaba macabra. In questa luce, sarebbe di certo troppo facile derubricare il fattaccio, ad esempio, suggerendo che questa storia insegni l’errore di essere invidiosi, e che l’invidia possa portare a conseguenze disastrose di cui ci si pentirà. Certi dettagli sembrerebbero suggerire possibilità più ardite.
Ogni tanto, per sondare nuove terre c’è bisogno di nuovi occhi, e anche di nuovi strumenti. Proviamo ad esempio a decontestualizzare il tutto, e iniziamo a porci domande strane. Ad esempio, perché gli dèi preferirono l’offerta carnivora di Abino a quella vegetariana di Kaele? Chissà, magari se Kaele se la prese a morte – ed è proprio il caso di dirlo – è perché sotto sotto sapeva d’aver fatto meno del male rispetto fratello; del male ad esseri viventi, intendo. E se gli dèi, giudici supremi, questo non l’avevano capito, che razza di divinità sono, verrebbe da dire? E poi, che genere di uomo è quello che si prende cura degli animali per poi sacrificarli sull’altare di personaggi invisibili che si autoproclamano superiori? Perché dovrebbe meritare riconoscimento e lodi?
Certo, niente giustifica la reazione francamente sproporzionata di Kaele, questo è vero. Poteva limitarsi a un rimprovero, magari a qualche schiaffo, ma arrivare a far fuori il fratello pare esagerato. Perché non tentare invece la via del dialogo e appellarsi all’uso della ragione? Non dico degli dèi, questo no, ma almeno del fedele Abino!
Ogni tanto, per sondare nuove terre c’è bisogno di nuovi occhi, e anche di nuovi strumenti.
Questioni complesse, bibliche, direi. Ma anche la Bibbia, è o non è pur sempre un insieme di storie? E le storie, non le possiamo forse interpretare all’infinito? A volte non le capiamo, o non le capiamo del tutto, ma ogni tanto ci aiutano a capire altro, a fare salti inattesi, a tentare connessioni ardite. Ad esempio, mi viene in mente: chissà se la storia di Kaele e Abino saprebbe per caso dirci qualcosa del comportamento, assai diverso per gran parte del dramma, del citato principe Amleto? Sono personaggi diversissimi, Kaele e Amleto, ma anche per certi versi fratelli: uniti, intendo, da qualcosa di profondo, qualcosa che possiamo chiamare ad esempio desiderio di vendetta. Mi sia consentito, allora, provare a ragionare su questo strano entanglement, su questo strambo affratellamento, ma sostituendo stavolta al nostro omicida inventato il suo vero modello, Caino, il non guardiano di suo fratello, maledetto da Dio ma da questi protetto contro ogni vendetta tramite un segno.
Iniziamo col dire che i due personaggi di Amleto e Caino condividono alcune somiglianze e anche delle differenze. Entrambi hanno un rapporto complicato con membri della propria famiglia, ed entrambi lottano con turbolenze e conflitti interiori irrisolti. Tuttavia, le differenze in termini di azioni, motivazioni e personalità sono davvero significative.
Il principe Amleto è il figlio del re Amleto (pochissima fantasia in casa) ossia il sovrano di Danimarca. È nipote di Claudio, ovvero l’assassino di suo padre, perché Claudio è il fratello di Amleto padre (una sorta di altro Caino, diciamo). La moglie prima dell’uno e poi dell’altro – di Re Amleto finché resta in vita, e poi di Claudio – è Gertrude (che nell’Ulisse di Joyce diventa Gerty). È lei infatti che, a babbo morto, o meglio, a consorte spacciato, ne sposa il fratello.
Il giovane Amleto lotta contro il dolore per la morte del padre, disgustato dalle frettolose nozze della madre, e combatte a lungo con la propria indecisione. Medita il suicidio, si finge pazzo, e diviene man mano ossessionato dalla vendetta. Caino, invece, è il figlio primogenito di Adamo ed Eva, figlio dunque di un’altra unione malata, se diamo per certa la vecchia storia della costola, per non parlare del frutto proibito. Uccide Abele per invidia e gelosia, ma anche lui, in un certo senso, si vendica di qualcosa. Differiscono significativamente, però, nelle azioni compiute. Mentre Amleto esita ad agire, Caino agisce impulsivamente e commette un omicidio. Amleto trascorre la maggior parte dell’opera contemplando la vendetta e cercando di confermare la colpevolezza dello zio, mentre Caino pare comportarsi come un bambino arrabbiato, e segue ciecamente le proprie emozioni senza riflettere sulle conseguenze.
Perché mischiare le carte senza alcuna remora, perché giocare con storie distanti e scollegate?
Hanno poi differenti motivazioni. Amleto cerca di vendicare l’omicidio del padre e di riportare la giustizia nella sua famiglia e nel suo Paese. Caino, invece, uccide il fratello per gelosia e risentimento. Ma, come abbiamo visto, anche lui potrebbe star perseguendo, a suo modo, un senso di giustizia, essendo stato “trattato male” in modo plateale e ingiustamente, e non certo dall’ultimo arrivato ma da Dio in persona, si fa per dire.
Siamo abituati, poi, a pensare ad Amleto come a un giovane intelligente e riflessivo, introspettivo, combattuto, e ci scordiamo che sarà autore di un bagno di sangue iniziato con l’uccisione del povero Polonio, padre di Ofelia, e quindi suo quasi suocero. Certo, Caino è rappresentato come impulsivo e violento: non perde, come Amleto, del tempo prezioso a riflettere; ma a pensarci bene, non potremmo semplicemente ritenerlo una persona in grado di prendere le proprie decisioni più in fretta, diciamo?
Infine, l’agire di entrambi sembrerebbe portare alla rovina, ma alla resa dei conti, inaugura invece un nuovo corso. E che Caino fu, in verità, più furbo di Amleto, lo dimostra il fatto che almeno lui sopravviverà e saprà farsi una vita. A questo punto ci si chiederà: a che serve ragionare così? Perché mischiare le carte senza alcuna remora, perché giocare con storie distanti e scollegate?
Risposta: entanglement, affratellamento, intreccio, correlazione. “Quello, dunque, che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”, leggiamo in Matteo 19, 6, e potrebbe essere un bel modo di spiegare quanto accade se proviamo a tradurre, ossia a trasportare, il concetto quantistico di entanglement su un piano di interpretazione letteraria. Detto in parole misere e senza le dovute equazioni, nella quantistica l’entanglement si basa sull’assunto che gli stati quantistici di due particelle microscopiche, una volta che tra loro si è avuta un’interazione iniziale, risultino poi legati in modo tale che, anche a enorme distanza, una modifica riguardante la prima particella avrà immediatamente un effetto misurabile sullo stato quantistico dell’altra.
Semplificando, e uscendo dal campo della quantistica, se tra due oggetti, persone, cose, opere, distanti e distaccate, vi è un’interazione in qualche modo significativa, quella stessa interazione farà sì che siano poi collegate per sempre. Immaginiamo di avere al posto delle due particelle due autori, apparentemente distanti. I primi che mi vengono in mente: Joyce e Gramsci; e immaginiamo che esista un motivo scatenante di interazione tra di loro. Credo di aver personalmente assistito a un evento del genere. Ecco la storia.
L’oscurità, sia di Joyce che di Gramsci, è una forma sublimata di spinta popolare verso il nostro elevarci come umanità.
Qualche anno fa, prima della pandemia, conobbi un “amico comune” sia di Joyce che di Gramsci. I suoi studenti, all’Università di Notre Dame, in Indiana, lo chiamavano il professor B. Parlo di Joseph Buttigieg, Joe per gli amici. È il traduttore dell’edizione quasi integrale dei Quaderni del carcere. Andò in pensione subito dopo il nostro ultimo incontro – nell’ottobre del 2017, a South Bend – felice di poter finire l’opera; ma poi scomparve poco più di un anno dopo per un male incurabile. Avremmo dovuto vederci per un convegno in Cile, ma già non aveva più la forza di fare dei viaggi lunghi.
Perché cito questo ricordo personale: perché la parabola del professor B è stata in grado di riunire le figure epocali di Joyce e Gramsci. Non solo. Negli anni Settanta quando si parlava di Buttigieg ci si riferiva a lui come joyciano, ma poi, a partire dagli inizi degli anni Novanta si è iniziato a parlare di lui come gramsciano.
Gli scritti di Joe su Joyce hanno sempre un piglio gramsciano, e quelli su Gramsci un temperamento assolutamente joyciano. Restano uno dei pochi caposaldi dello studio comparativo di due autori all’apparenza tanto dissimili, eppure anche tanto “affratellati”. Ci spiegano, quegli studi, quanto siano interrelate le cause (e quindi gli “stati”) di questi due autori, le loro opere, i loro intendimenti. Da quel punto in poi, da quando, ovvero, li si è fatti interagire con forza e in maniera convincente, i due autori sono entangled, correlati, intrecciati. Al punto che scoperte fatte su Gramsci, se applicate a Joyce, sono in grado di cambiare la prospettiva anche su quest’ultimo. E viceversa.
Ovviamente, ciò che è importante affinché l’entanglement interpretativo avvenga, è che l’interazione sia significativa, non un appaiamento causale come quello che ho tentato tra Caino e Amleto. L’impatto iniziale deve essere rilevante, e dopo di esso nulla sarà più come prima: i due fenomeni, seppur distanti, verranno considerati intrecciati, sia che accettiamo l’esistenza del nesso, sia che la deploriamo. Pensiamo all’interpretazione freudiana del mito di Edipo. Difficile scrollarsela di dosso; e anche volendo, una sua refutazione sarà comunque un continuo riaffermarla. Ovvero: se modifichiamo la lettura freudiana del complesso edipico, la nostra percezione della tragedia di Sofocle anch’essa muta. Certo, non muta il testo in sé, ma il suo comportamento. Il suo funzionare.
C’è bisogno di collegamenti arditi, di interpretazioni eretiche, di correlazioni pericolose, se vogliamo che la critica torni ad essere una forma di letteratura.
Allo stesso modo, grazie agli scritti del professor B, e al modo in cui ha parlato di Joyce e Gramsci quasi fossero due facce della stessa medaglia, esiste un entanglement letterario che nessuno potrà scindere. Questo apparentamento, ad esempio, ci consente di vedere come, pur lavorando su campi distanti, i due autori condividevano obiettivi di emancipazione, di liberazione. Ma anche come i rispettivi metodi appaiano congruenti. Mi viene in mente, primo fra tutti, la complicazione, l’oscurità, sia di Joyce che di Gramsci, un’oscurità che gli ingenui possono prendere per elitarismo, e invece sappiamo bene essere una forma sublimata di spinta popolare verso il nostro elevarci come umanità. È la complessità che tutti meritiamo, non la semplificazione che talvolta si regala per abbindolare le masse.
E poi, la loro relazione è tanto rilevante che, esattamente come l’entanglement in quantistica, non riusciamo a misurarla a occhio nudo. Sembra non esserci, e invece c’è; e agisce in silenzio nelle generazioni di lettori e critici. Così, grazie anche all’opera di tanti studiosi che si sono mossi sul solco tracciato da Joe, riusciamo oggi a cogliere tra Joyce e Gramsci delle affinità. Questo perché oramai le loro cause, i loro stati, sono correlati e possono illuminarsi a vicenda. Sulla base di questa interazione significativa che rende entangled i due autori, possiamo scorgere tante ulteriori affinità: l’interesse di Gramsci per l’Irlanda, ad esempio, o per Giordano Bruno, o per Ibsen, due tra i principali mentori anche dell’irlandesissimo Joyce. E uno studio comparativo di questi loro interessi comuni diverrebbe rivelatore sia nel caso dell’esegesi joyciana che di quella gramsciana.
Poi, capita che esistano persino incroci più ameni tra di loro. Sono affratellati ad esempio dal fattore tempo in maniera quasi speculare. L’ultima parola dell’Ulisse è un numero: 1921, l’anno in cui fu completato (sarebbe uscito nel 1922). Anche il partito comunista di Gramsci nasce nel 1921. Se fossimo superstiziosi – e Joyce lo era, ma magari Gramsci un po’ meno – persino certi giochi di date li unirebbero. L’Ulisse esce il 2.2.22, quarantesimo compleanno di Joyce (nato il 2 febbraio del 1882). Il partito comunista nasce il 21.1.21, giorno precedente il trentesimo compleanno di Gramsci (nato il 22 gennaio del 1891). Tutto ciò è curioso, anche se ovviamente non spiega niente. Si tratta, com’è ovvio, di coincidenze casuali (o forse acasuali, direbbe Jung). Le correlazioni vere e proprie sono altre, e hanno persino risvolti biografici, come il rapporto contrastato di entrambi con il padre. Ma quel che conta è il fatto di poter considerare collegate le loro opere, e simili i loro obiettivi, nella prospettiva della nostra fruizione degli stessi. Questo avviene grazie a una passata interazione significativa che li ha messi in relazione.
Poste in entanglement, le opere di Joyce, come quelle di Gramsci, non sono più scrigni di significato ma macchine generatrici di senso. Generano significati all’infinito, perché non riducono nulla a delle semplici formulette. Ci raccontano di un modo di ragionare, di pensare, che è libero da determinismi. La loro scrittura diviene un continuo farsi, un continuo crearsi a partire da connessioni, ricordi, intuizioni; e non è comprensibile nel senso geometrico e perimetrante del termine. Il loro entanglement letterario è esemplare e foriero di speranze per chi cerchi sempre nuovi nessi, nuove vie interpretative. Questo perché, come credeva Wilde (altro punto di incontro tra i due), il critico vero è “colui che sa tradurre in altra maniera o in nuova materia, la sua impressione di cose belle”. Sospetto che in genere i lettori, abituati talvolta a una critica esangue e paludata, possano non essere, per esperienza, troppo d’accordo con quest’ultimo assunto.
C’è sempre più bisogno di collegamenti arditi, di interpretazioni eretiche, di correlazioni pericolose, se vogliamo che la critica torni ad essere una forma di letteratura. E in questo, l’imponderabilità invisibile e silenziosa dell’entanglement interpretativo può aiutare non poco.