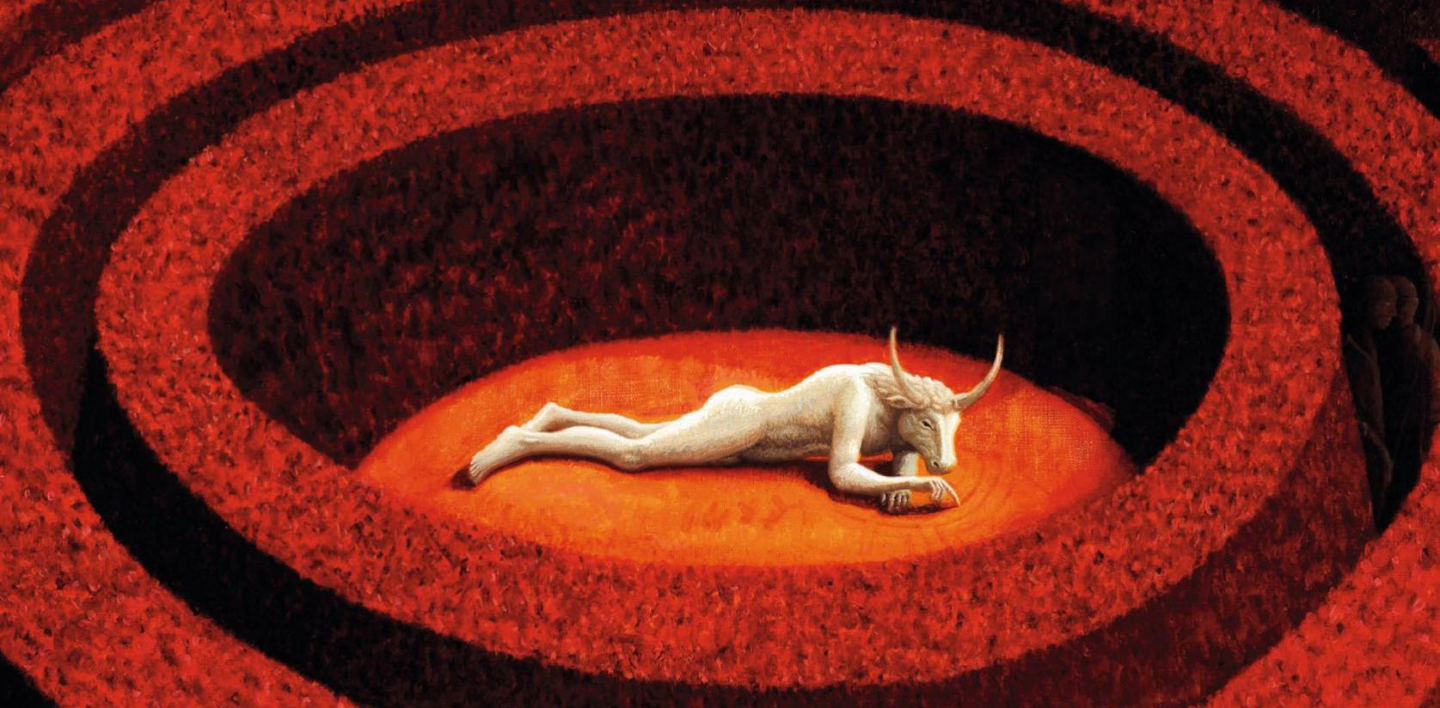
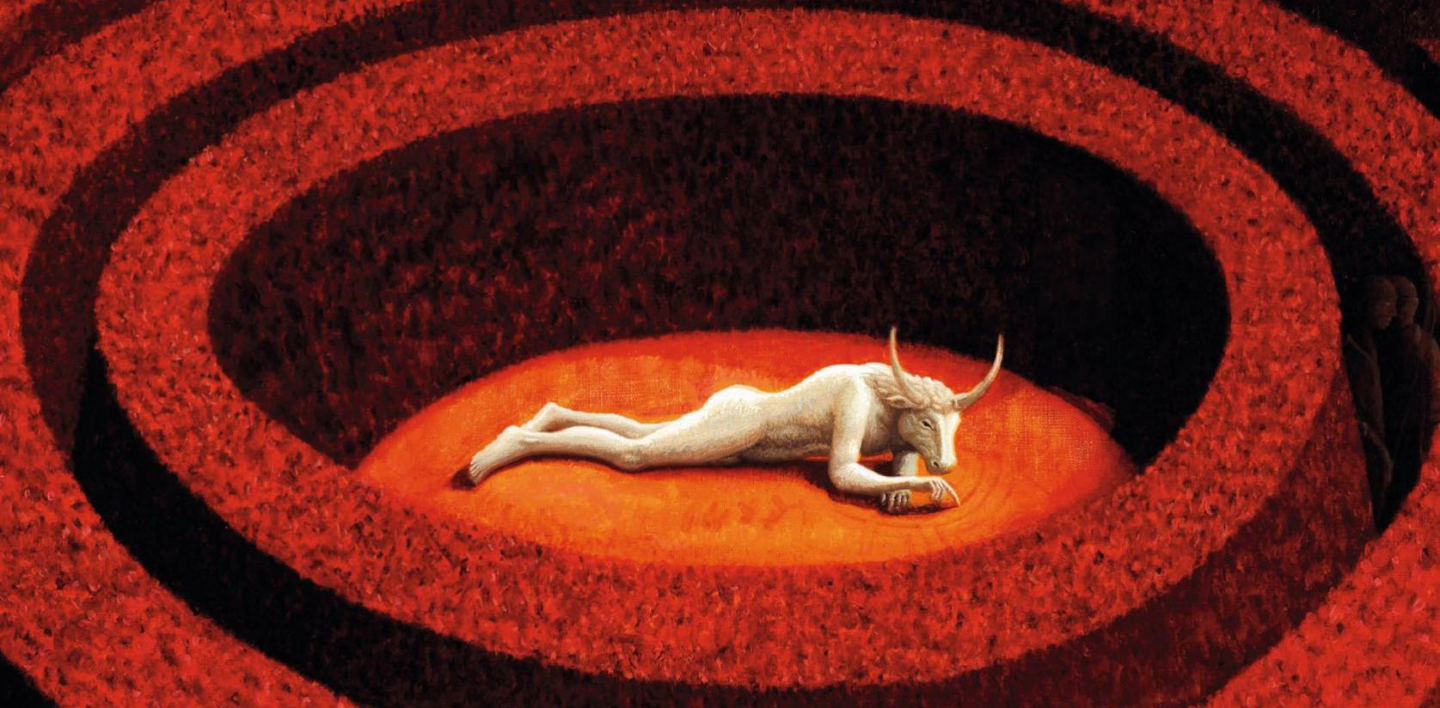
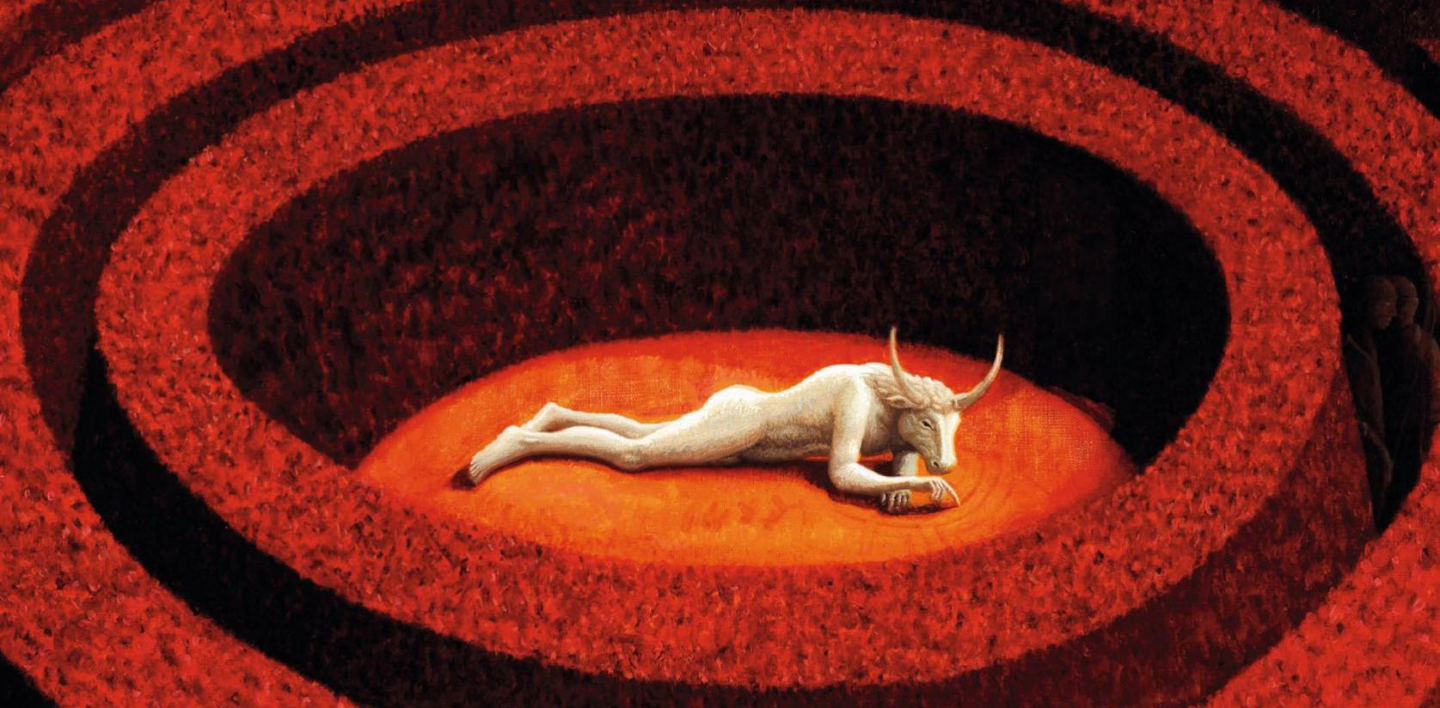
A una certa altezza della sua parabola, dopo Il contagio e con la fine del periodo romano, Siti ha orientato la propria poetica in una direzione più estroversa, con l’ambizione zoliana o balzacchiana di fornire un quadro composito della nostra società attraverso una serie di ritratti emblematici: il finanziere, il prete, il matricida. Adesso è la volta dell’adolescente, un giovanissimo transumanista che incontra un professore di liceo omosessuale in pensione, vedovo, trapianto di cuore (e con una protesi peniale). I due si riconoscono, diventano amici: questa, in estrema sintesi, la storia de I figli sono finiti.
Siti però non è Balzac, non è Zola: il professore è l’ennesimo avatar di un autore indiscreto che, non pago dell’alter ego, si affaccia di continuo da dietro le quinte per precisare, chiosare, influenzare il lettore. “Mi chiamo Walter Siti, come tutti” suonava l’incipit memorabile di Troppi paradisi: il mondo romanzesco di Siti è monistico, la coralità tende all’unisono: non soltanto nei duplicati dello scrittore, ma in quasi tutti i personaggi importanti riconosciamo l’incarnazione di uno stesso io. Contrario perfetto del narratore neutro, o presunto tale, quello sitiano “contagia” tutti.
È noto che molti autori non fanno che riscrivere lo stesso libro per tutta la vita e Siti, nelle note finali del romanzo, sembra ammettere di appartenere a questa categoria. Ammissione non del tutto pacifica, credo. Di certo lo abbiamo visto divincolarsi nello sforzo di liberarsi di sé, lo abbiamo sentito dichiarare questa intenzione, poi smentirla, dichiararla e ancora smentirla. Lo vediamo anche ne I figli sono finiti, dove “lo scriba” non smette di mettere le mani avanti, si scusa per l’invadenza, si scherma, forse perché il soggetto, il giovane borderline immerso nel sogno digitale, sembra domandare un maggiore riconoscimento. La gioventù, il grande enigma: il passato che non ricordiamo, il futuro che non vivremo.
Certo non manca ne I figli sono finiti l’intenzione di inquadrarla questa gioventù, di restituirla nella sua essenza se non esistenziale almeno sociologica. In particolare si nota, come sempre in Siti, un grande sforzo d’imitazione linguistica e quanto sia possibile, o quanto valga la pena, inseguire il socioletto giovanile è una domanda che sorge spontanea leggendo queste pagine. Ho l’impressione che afferrare l’universo linguistico degli adolescenti sia un’impresa estremamente difficile, se non forse dall’interno (dovrebbe cioè scrivere uno di loro, come facevano negli anni Ottanta i tondelliani e o nei Novanta la gioventù cannibale: oggi probabilmente bisognerebbe andare su WattPad), e comunque rispecchiandone uno stato estremamente provvisorio. I gerghi sono settorializzati e cambiano a una velocità tale che forse congelarli non serve ad altro che a mostrarne l’invecchiamento precoce.
Il suo narcisismo è il nostro, il suo monismo è il nostro.
A maggior ragione perciò, sotto la livrea sociologica del ragazzino, riconosciamo ancora una volta il profilo del vecchio scrittore. Acutissimo, caustico, ironico, letterato, cinico questo adolescente, lessico giovanilistico a parte, non parla da adolescente (“Del dopo discuteremo dopo, non sempre il solipsismo è la condizione peggiore.” “Le metafore mi diserotizzano”, “Se voi siete riusciti a liberarvi dalla fede in Dio, noi riusciremo a liberarci dalla fede nella realtà”). L'”eremitaggio digitale” dell’hikikomori diventa una sponda per approfondire le fantasie postumane del suo creatore (“Il tuo visitor ultra-erculeo non è ancora una macchina, ma ci va vicino” fa giustamente notare Astore al vecchio Augusto), accompagnandole a una più profonda e originaria misantropia.
Tutto questo è probabilmente da mettere in conto al laschiano narcisismo culturale di cui Siti stesso ha ragionato a suo modo in molte pagine (“Sono egoista, si rimprovera Augusto quando Bruno se n’è andato, con un pretesto o con un altro finisce che parliamo sempre di me”): persona al corrente dei fatti, reo confesso. La coscienza del limite non per forza implica il suo superamento, ma almeno (“In che mondo schifosamente sbagliato stiamo vivendo…” “Non abbiamo saputo farlo più giusto.”), offre un certo conforto morale. Potremmo chiederci se lo stesso meccanismo autofizionale, che questo autore ha contribuito a rendere popolare in Italia, non sia un modo di conferire dignità letteraria alla post-realtà, alla progressiva coincidenza di io e mondo, alla cancellazione del discrimine tra realtà empirica e stato d’animo, o simulacro.
Perfettamente sintonizzata sulla condizione antropologica della borghesia liberal occidentale, sui suoi tic, le sue ambizioni e meschinità, la voce di Siti rispecchia il nostro modo di essere. Il suo narcisismo è il nostro, il suo monismo è il nostro. Anche questo significa mi chiamo Walter Siti come tutti. Perciò non stanca quella voce, perché continua a illuminare i lati più oscuri della nostra vita, anche se confesso che il ritorno del culturista (il vecchio palestrato coatto, ripulito e padano, occupa buona parte di questo romanzo) è stato un po’ impegnativo.
Per inciso, il fatto di saper cogliere una qualche universalità attraverso figure di omosessuali e problematizzando l’empowerment del queer, per così dire (già vent’anni fa Siti parlava di “gayzzazione dell’occidente”), non è l’ultimo dei suoi meriti. Oggi questo libro aggiunge un tassello ulteriore: la decostruzione del genere, l’emancipazione del desiderio e il rifiuto della naturalità biologica collocano il progresso dei diritti LGBT+ nel solco di una evoluzione che riguarda tutti: “prima con le donne, poi si allargherà al sesso in generale e al concetto di umanità” dice Astore/Siti, pensando a un mondo di futuri cyborg. D’altronde i body builder pansessuali, o forse asessuali, dei primi romanzi (e di questo) già rappresentavano chiaramente una “umanità in transito”, o in transizione.
La forza espressiva della sua prosa torreggia sulla sciatteria del paesaggio letterario odierno.
La capacità di metterci davanti a uno specchio disturbante è l’ambigua ragione per cui ci sentiamo attratti da questo scrittore, un piacere non estraneo al masochismo attraverso cui la cattiva coscienza della borghesia occidentale cerca un riscatto, o un lenitivo. Ma la scrittura, lo stile di questo autore, è il motivo per cui lo consideriamo tra i massimi esponenti della letteratura italiana degli ultimi decenni.
La forza espressiva della sua prosa torreggia sulla sciatteria del paesaggio letterario odierno: ogni pagina di Siti mira alla compiutezza e all’equilibrio formale, quella “well composed page of prose” a cui si richiamava Sebald in una vecchia e splendida intervista. Non è qui la sede per un’analisi stilistica di una scrittura così finemente intessuta e piena d’inventiva: i giochi delle focalizzazioni, l’uso della punteggiatura, la micidiale precisione di certi aggettivi, il contrappunto dei registri (lirico/umoristico/triviale), il passaggio inopinato dal micro al macro (dal dettaglio sentimentale alla cronaca sociopolitica), eccetera.
Nel corso degli anni Siti ha perfezionato il suo strumento, e in queste pagine, che ha dichiarato essere le sue ultime (e speriamo di no), più ancora che in passato la scrittura e lo stile sembrano addensarsi, cercare la concentrazione della parola poetica. E allora eccole, le poesie, sbocciare tra le mani del giovane:
Il piedistallo è una bara / e viceversa: così il fiore / dei tigli respira da solo / di sera.
Nel suo primo romanzo-monstre del 1994 (Scuola di nudo) molti versi, e molto belli, interrompevano la linearità della prosa a testimonianza della precedente attività poetica dello scrittore. In seguito sono più o meno spariti, o assimilati da una prosa attraversata da una fortissima tensione lirica.
È uscita di recente per Quodlibet una raccolta di schede editoriali di Franco Fortini (Pareri editoriali, curato da Riccardo Deiana e Federico Masci) dove si trova un commento alle prime composizioni poetiche di Siti, che in quegli stessi anni collaborava con Fortini come consulente per Einaudi (insieme a Berardinelli e Mengaldo). È un parere poco esposto, con cui Fortini mette a fuoco il rapporto tra le poesie di Siti e l’ermetismo fiorentino. Già allora, alla fine degli anni Settanta, il fiuto del critico scorgeva nel giovane poeta un futuro romanziere: “qui perdura l’intento narrativo romanzesco” ha scritto,
ultima prova: la versificazione è poco più che un omaggio grafico, queste partiture fanno pensare a testi musicali d’altri secoli, cui mancano alcune indicazioni, come il tempo o la chiave; o testi recentissimi dove il compositore confida in un esecutore-ascoltatore complice e consenziente.
Complice e consenziente, il lettore di Siti può esserlo in molti modi. Con sguardo preveggente Fortini riconosce il narratore dietro il poeta: noi oggi possiamo tornare a guadare il poeta che si nasconde dietro al narratore, e che forse ne rappresenta l’identità più profonda, più dolente, la meno replicabile. Come ancora scriveva eloquentemente Fortini a proposito di quegli albori: “In questi versi ci sono visibili tracce di sangue. Siti ha deciso di giocarsi la vita o una sua parte in termini ‘poetici’, di scrittura; il più terribile ‘placebo’ inventato dall’età contemporanea.”. L’umanità da allora si è dotata di altri “placebo”, ma leggere Siti significa ancora oggi osservare quelle tracce.