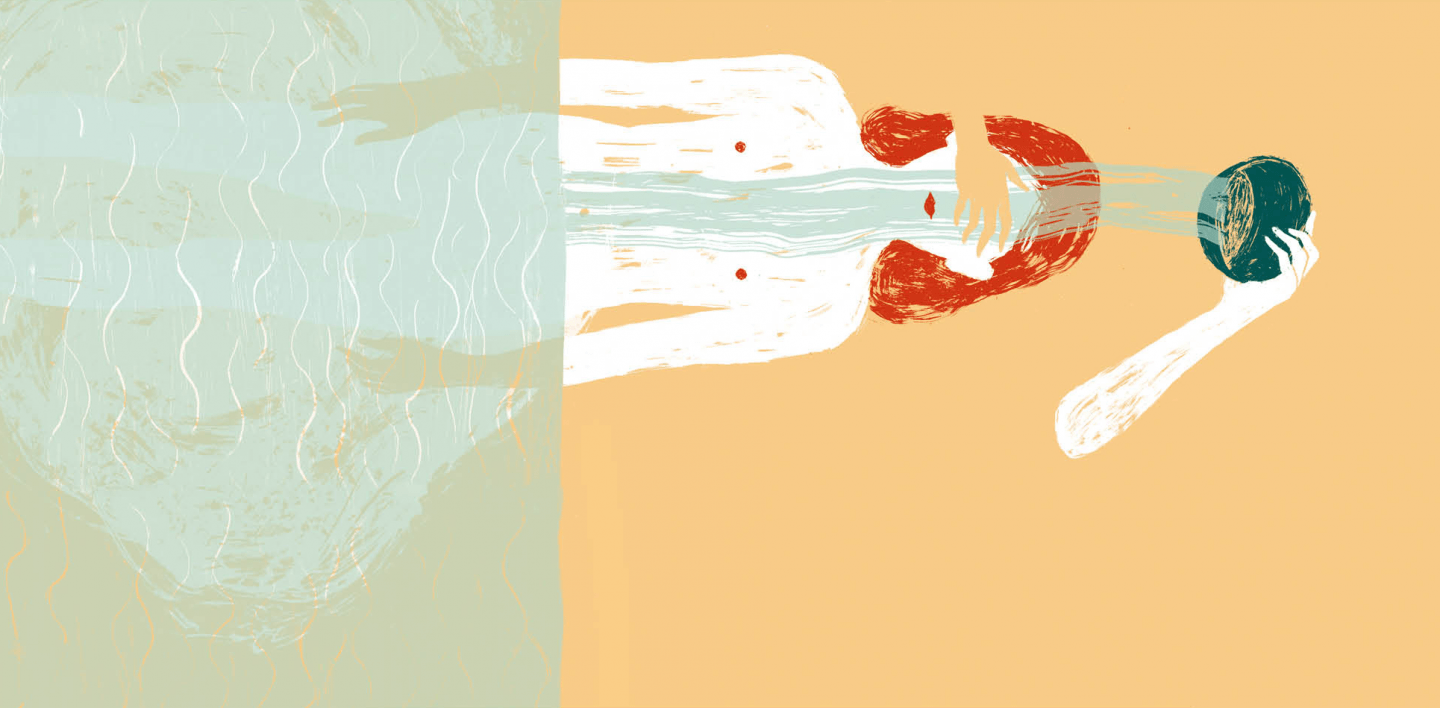
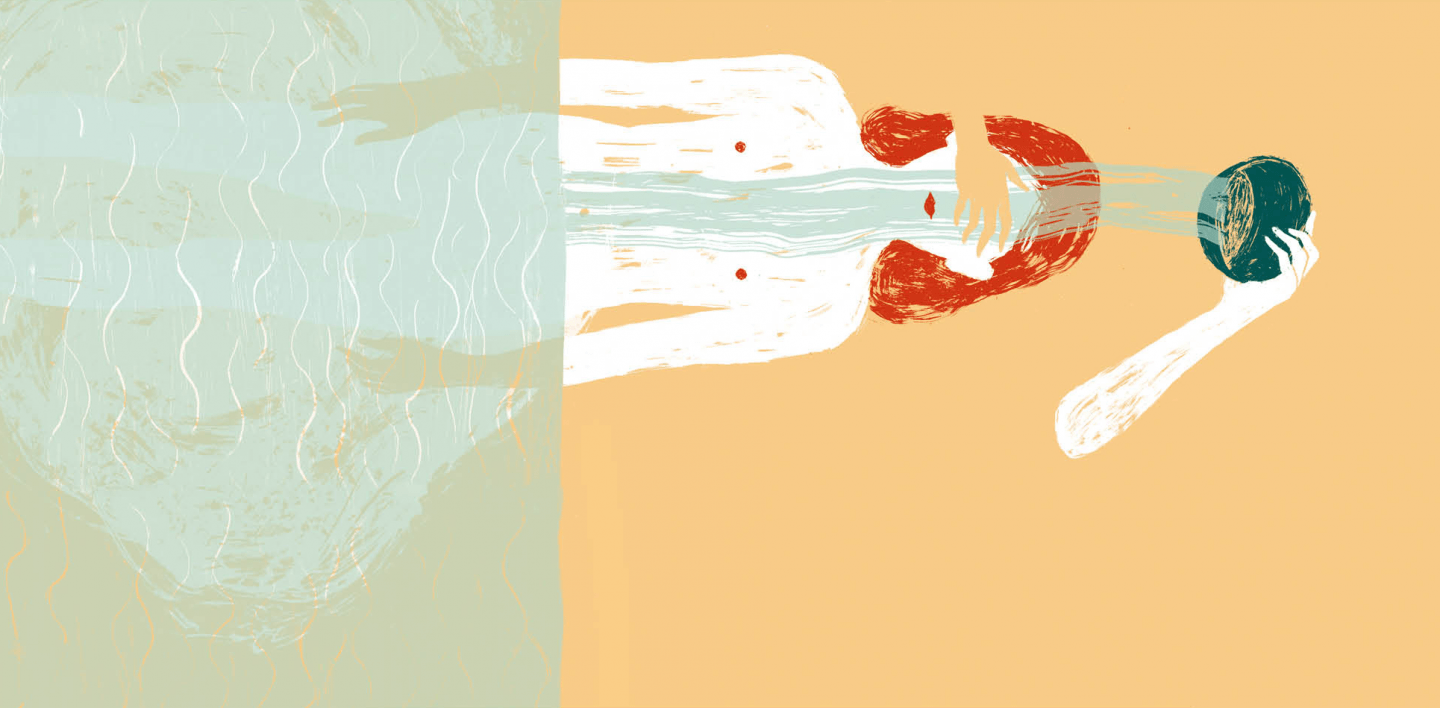
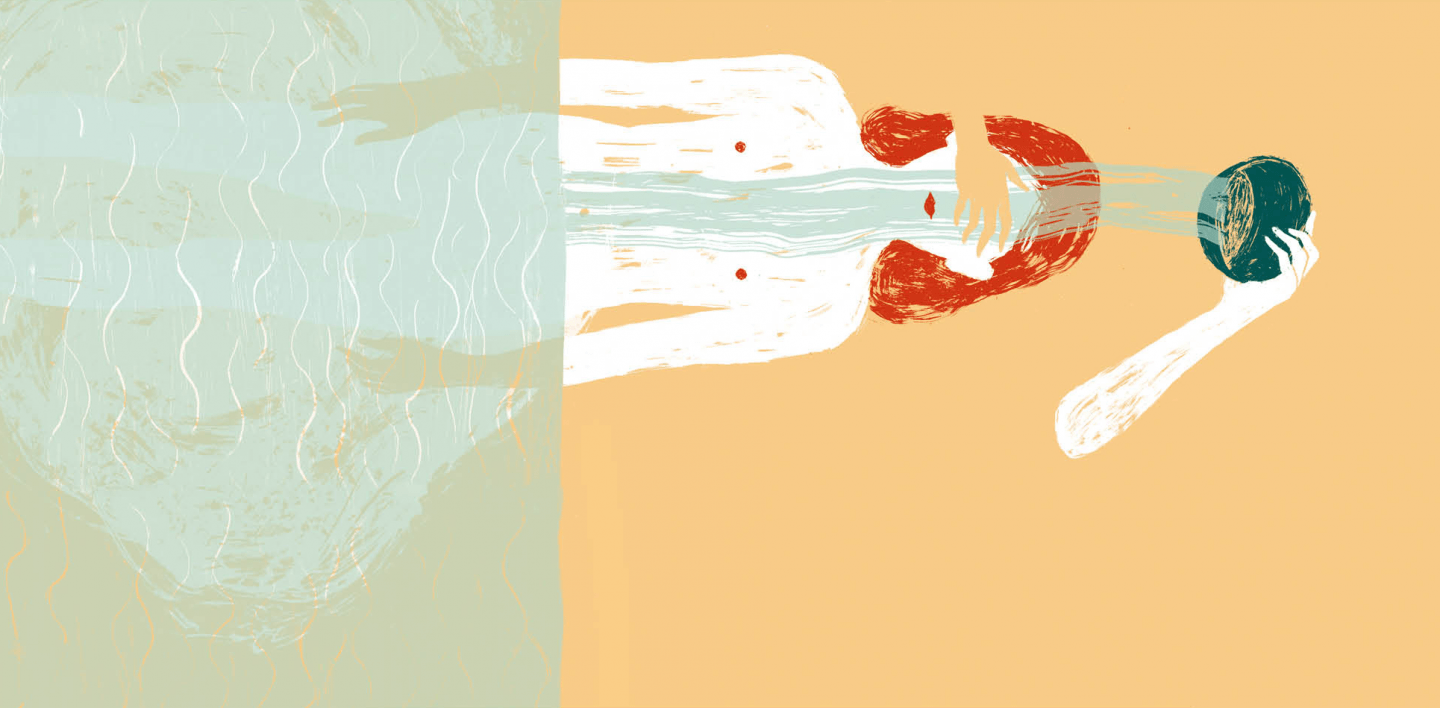
A ll’incirca cinque anni prima avevo avuto, per così dire, il mio momento di gloria, ero perfino apparsa sulle pagine del giornale di Milwaukee. Mi definivo un’artista emergente, creavo pericolanti assemblage di oggetti che trovavo in giro, e performer innovativi, scultori, scrittori, registi e produttori di film indipendenti mi si affollavano intorno, e c’era questo critico d’arte che lavorava per il settimanale locale che non la finiva più di scrivere di noi. Bel periodo, quello, con la gente che inaugurava gallerie d’arte nella soffitta di casa e ogni fine settimana c’era uno spettacolo da vedere, o magari una rappresentazione da teatro dell’assurdo con le donne che si spogliavano, anche donne brutte, fatte male, come me, e gli uomini che se ne andavano in giro brandendo erezioni come manganelli, i miei amici di un tempo! Dopo, tutte quelle persone alla moda e intellettualmente avanti, brutti compresi, si riversavano in un bar con due piste da bowling nel seminterrato. Nessuno sembrava aver niente da ridire contro i brutti, non era quello il punto. La mia fama era circoscritta a un gruppo specifico di gente che abitava in centro; in periferia di noi non importava a nessuno. Neppure la mia famiglia adottiva ne sapeva niente, in parte perché non leggeva mai il settimanale locale, e in parte perché la cosa era durata poco. Per un lasso di tempo pari a quello che impiega una candela accesa a consumarsi, la gente era stata attratta da me, mi cercava, voleva sapere dove fossi se non c’ero, e alcuni si erano perfino spinti a dire che ero una discreta bellezza. O forse solo discreta. Comunque. Ho sempre avuto un aspetto molto ordinario e piuttosto scialbo, a prescindere da tutto, quindi forse ero circondata da un’aura di pathos artistico, anche se al college non ci andavo per l’arte ma per ottenere un pratico diploma di laurea in Lettere, ché una laurea in Lettere ti apre tante porte, come mi disse un tutor. Avevo fatto di me un’artista, nello stile di vita e nell’abbigliamento. Il mio capo preferito all’epoca proveniva da un bidone della spazzatura all’incrocio tra Farwell e Pleasant, era una felpa turchese con un’applique che raffigurava un cane e un coniglio dentro il cesto di una mongolfiera. Il pallone era di tessuto scamosciato rosa. Sfido io che un tempo – un tempo molto lontano – ero circondata di persone.
Poi qualcosa era andato storto, qualcuno mi si era rivoltato contro, forse per gelosia, non lo saprò mai, e aveva fatto girare la voce che ero un’artista da strapazzo mettendo in discussione l’originalità del mio operato. Si cominciò a dire che i miei assemblage di oggetti e frammenti di testi ricordavano in maniera troppo smaccata i lavori di Joseph Cornell e Henry Darger. Qualche settimana più tardi sul settimanale era comparso un articolo, corredato da una foto mia e del mio lavoro accompagnata dalla seguente didascalia: appropriazione o furto: il fallimento dell’artista di milwaukee helen moran. Era stato un incubo; ovunque andassi la gente mi accusava alle spalle di plagio e truffa. Accostati a quelli di Cornell e Darger, i miei lavori mostravano accorgimenti tecnici e soluzioni simili, ma per quanto sfacciata e forse manchevole di spirito critico fosse la mia ammirazione, i miei frammenti di testi e assemblage non erano copie esatte, non volevo riprodurre qualcosa che era già stato prodotto, ma piuttosto prendere parte alla conversazione. Inizialmente ero precipitata in una spirale di sconforto, imbarazzo e vergogna, poi un giorno ero andata in biblioteca, avevo consultato The History of Art di H.W. Janson e mi ero resa conto che nell’arte non esistono immagini nuove, inedite. È tutto un palinsesto dietro l’altro. Ad ogni modo, quelle voci e quelle parole avevano scavato nella mente della gente, compromettendo la mia reputazione proprio mentre il nostro gruppo di artisti iniziava a stuzzicare l’interesse nazionale a Chicago e Minneapolis; nessuno mi invitava più nei seminterrati con le piste da bowling né nelle soffitte ammuffite o a performance di teatro dell’assurdo, o alle mostre collettive, alle biennali. Nel giro di un’estate ero stata espulsa dal gruppo, allontanata come una lebbrosa. Avevo una gran voglia di afferrare la gente per le spalle e scuoterla urlando, Tutto al mondo è un palinsesto, pezzi di merda! Ma nessuno voleva vedermi, nessuno mi richiamava mai. Mi ero rintanata nel mio tugurio, uno schifoso seminterrato situato in una zona fatiscente della città che nemmeno investitori stranieri multimilionari potevano salvare. Non mi vestivo né uscivo più, il che capitava a fagiolo dato che la mia acne tardiva era esplosa. La vita si vendicava di me. Ero rimasta chiusa in casa per circa un mese a escogitare, avvolta dalla penombra, un piano per evadere. Alla fine, da discreta bellezza mi ero trasformata in un’efficiente eremita con l’alitosi. Non mi comportavo più come se emanassi un’aura artistica. Se andavo da qualche parte, cosa che accadeva di rado, lo facevo accartocciata su me stessa. Ero una persona socievole, pensavo, finché la gente non ha più voluto avere niente a che fare con me.
Come si poteva vivere così?
Avevo deciso di ricominciare da capo. Mi ero trasferita a New York, una città in cui nessuno a Milwaukee si sarebbe volontariamente trasferito a) perché chiunque vivesse a Milwaukee non si sognava neanche di lasciarla, e b) perché il costo della vita a New York era alto, per non dire proibitivo. Ma io conducevo una vita modesta, alimentandomi a quinoa e riso. Frugale, forse è il termine più corretto. In quella città proibitivamente costosa conducevo una vita sana e frugale da contadina urbana. Avevo impiegato anni a raggiungere una situazione abitativa stabile, ma ero sana come mai prima di allora. Helen Moran, un’adulta sana ed efficiente a New York. Ma come? Come fare a mantenersi sani e allo stesso tempo vivere di briciole?
Lo vedrete, dissi a un pubblico immaginario. Ve lo farò vedere io. Qualcuno un giorno mi pagherà per raccontare della vita elegantemente frugale e sana che ho condotto in quell’enorme, scintillante inferno di immorale prosperità.
Un estratto dal romanzo Scusate il disturbo di Patty Yumi Cottrell (66thand2nd, traduzione di Sara Reggiani).