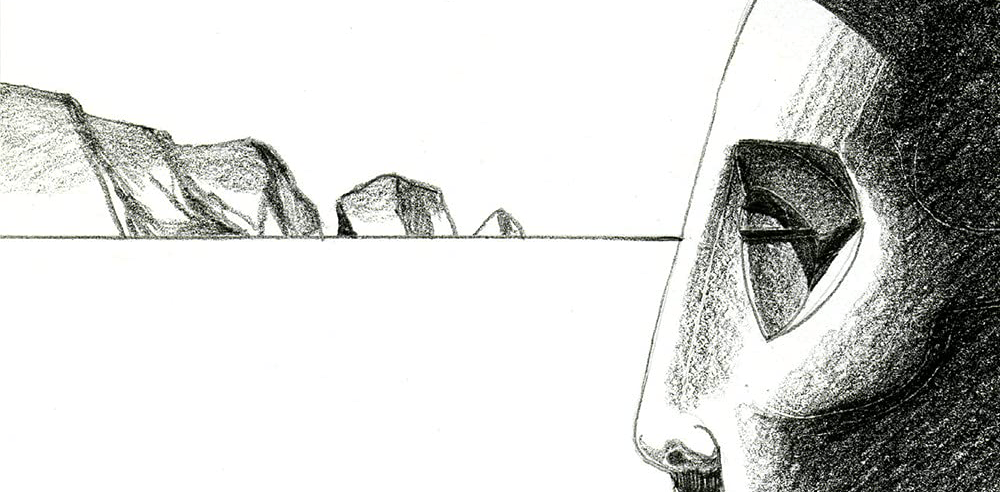
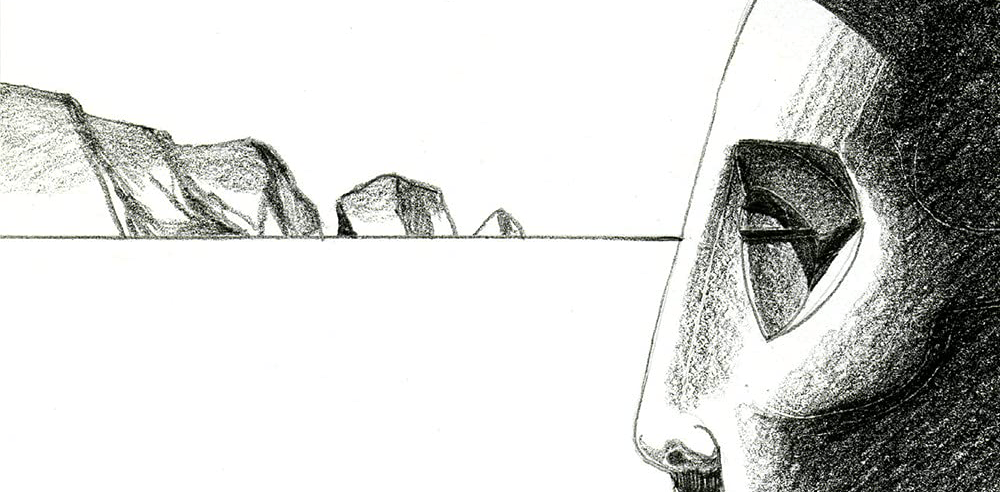
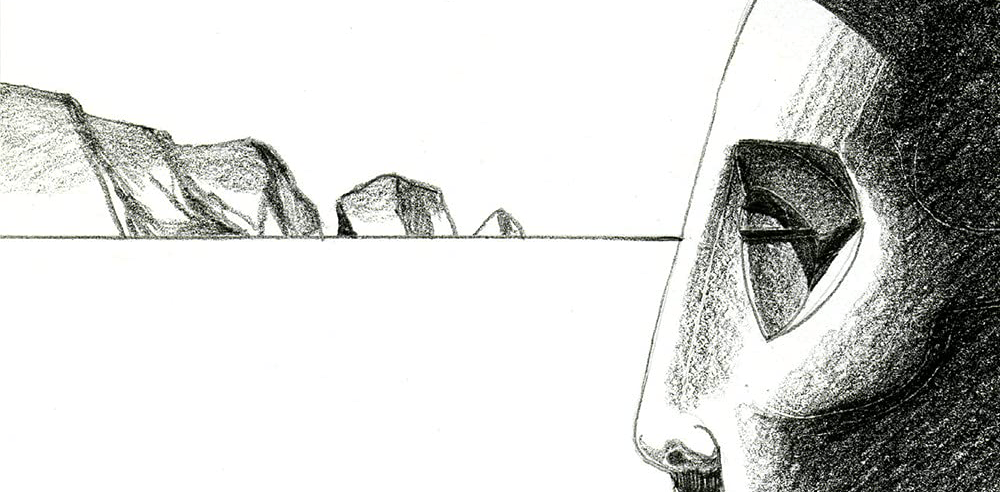
S chivo, ironico, intenso, improvvisamente brutale e altrettanto improvvisamente lirico, linguisticamente meticoloso e idiosincratico, capace di alternare affondi psicologici ad aeree mappature sociologiche, il Francesco Pecoraro che scopriamo (o ri-scopriamo) nei racconti di Camere e stanze (Ponte alla Grazie, 2021) è lo stesso che abbiamo amato nei suoi romanzi (La vita in tempo di pace e Lo Stradone). Con una significativa sorpresa però, e cioè la capacità abbastanza insospettabile conoscendo la natura erratica e “informale” delle sue prose lunghe (ma forse non estranea all’assidua frequentazione delle forme brevi e brevissime di internet: Pecoraro è stato molto attivo nelle multiformi declinazione della scrittura “webbica” come direbbe lui, anche se oggi credo sia meno interessato alla cosa) la capacità, dunque, di fare quello che dovrebbero fare tutti i racconti riusciti, cioè cogliere nel segno, mettere a fuoco nitidamente, compiutamente, anche nell’apparente neutralità fotografica della “fetta di vita”, un momento, un’emozione, un istante decisivo, il nocciolo duro e scarno della novella.
Ebbene, tutto questo la maggior parte dei racconti qui raccolti lo fa benissimo. Lo fanno tutti quelli compresi in Dove credi di andare, la raccolta pubblicata per Mondadori nel 2007 che apre il volume e contiene alcuni tra i pezzi più belli: per esempio l’eponimo “Camere e stanze”, storia di una festa finita male, o il conclusivo “Uno bravo”, racconto dagli echi pirandelliani, ma forse anche un po’ cheeveriani, di uno stimato professionista che prende una strana deriva.
L’impressione è che in un paese dove la narrativa breve è ormai poco considerata, e dove di conseguenza gli scrittori che si cimentano in questo genere sono rari, i racconti di Pecoraro possano ben considerarsi (come d’altronde i romanzi) tra quelli da non lasciarsi sfuggire. Un autore quasi interamente vocato alle forme brevi e recentemente scomparso come Antonio Debenedetti, che di raccolte di alto livello ne ha pubblicate diverse, potrebbe essere un buon termine di confronto, peraltro anche vicino a Pecoraro per temi e ambientazioni, per lo più borghesi e sentimentali. Se la prima raccolta ha ormai quindici anni, l’interesse per il racconto non sembra avere abbandonato lo scrittore anche mentre si cimentava in opere di più ampio respiro. La terza sezione raccoglie racconti più recenti, e alcuni di essi (come i durissimi “Il cormorano” e “Non so perché”, rispettivamente sulla fine di un amore e su un difficile rapporto padri-figli) sono da contare tra i migliori del libro, alcuni altri assomigliano invece a prove, sperimentazioni, quasi canovacci per opere a venire, hanno un aspetto interlocutorio e più occasionale.
I personaggi di Pecoraro sono quasi tutti in rotta col mondo: una poetica del fastidio sembra unire questi racconti.
Convince meno il lungo racconto, già pubblicato in ebook per Ponte alle grazie, intitolato “Tecnica mista” e che costituisce da solo la seconda parte del libro e dove l’autore, uscendo dai sentieri battuti, si cimenta nella storia di un terrorista islamico nato in Italia. La scrittura c’è, il racconto è ben costruito, ma forse la distanza dalla realtà e dai vissuti conferisce al testo un aspetto un po’ schematico e astratto, compresa quell’idea di atto-violento-come-opera-d’arte, pur piena di nobili predecessori (dall’Erostrato di Sartre ai nichilisti dostoevskiani), ma (oggi?) concettualmente discutibile e piuttosto inflazionata almeno dopo i filosofemi, spesso piuttosto corrivi, scaturiti dall’undici settembre.
I temi dominanti della raccolta, lo si è già accennato, sono quelli legati ai vissuti borghesi di uomini maturi e/o anziani professionisti, o artisti, che in certi casi molto felicemente deviano verso l’onirico e l’allucinatorio, in altri casi, altrettanto felicemente, si attengono a un piano puramente realistico. Anche l’infanzia, inevitabilmente sanguinosa, è ben rappresentata in questi racconti, la fanciullezza e la scuola (“l’inutile vuota scuola media, quando niente o quasi ti colpisce la mente, quando niente ti forma, quando niente ti resta, se non la ferocia dell’Iliade e Mazzeo che si faceva le seghe all’ultimo banco”), dove Pecoraro dimostra una notevole capacità di immedesimazione e recupero di quell’età lontana con i suoi fantasmi, la sua goffaggine, i suoi slanci.
A questo proposito si potrebbe notare che se la prima e l’ultima parte della vita sono raccontate dal di dentro, la giovinezza in senso stretto, quella dell’uomo nel pieno delle sue forze e della sua impulsiva accettazione del mondo, è rappresentata solo, e spesso, come alterità aliena e per lo più ostile. Il tema, ampiamente sviscerato anche nello Stradone, è quello del nuovo che si fa spazio a cannonate, lasciandosi alle spalle un passato di rovine insieme ai suoi ultimi disorientati abitanti. Su questo sfondo di scontri generazionali, rappresentato benissimo dal racconto di apertura dove un professore universitario si vede la casa invasa da giovani festanti, balenano nostalgiche immagini di fuga verso un altrove elegiaco, utopico, incarnato dalla madre, dal mare e dai profumi della marina, ma anche dalla compostezza formale, architettonica, di una ideale razionalità classica e mediterranea.
Quello di Pecoraro è un mondo denso, intenso, pienamente materiale.
I personaggi di Pecoraro sono quasi tutti in rotta col mondo. Una poetica del fastidio, per così dire, sembra unire questi racconti, ma il dispetto verso le cose è retroattivo: autodenigrazione e autosarcasmo sono il risvolto soggettivo della misantropia o del misoneismo dei protagonisti di queste novelle. Atteggiamento (non esclusivo, va detto) che si potrebbe moralisticamente additare ma che ho il sospetto costituisca un ottimo punto di partenza, e forse di arrivo, per chi cerca di proiettare uno sguardo critico sul mondo.
Tra le tante note che si potrebbero fare sullo stile, mi interessa sottolineare l’uso del lessico: molte le deviazioni dalla norma linguistica, a volte anche di interpunzione (che però mi sembrano le meno interessanti), qualche tendenza oralizzante (come il birignao della borghesia viziata e consumista “le solite cosine dell’happy hour”), e parole che assumono un significato nella ripetizione, nell’uso e nell’integrazione dentro una lingua d’autore (per esempio gli aggettivi “basico” o “muscolato”). A volte una ricercatezza greve, di per sé interessante, si materializza in parole come “sperdimento”, “pratazzi”, “attovagliato”, “improfumato”, altre volte i nomi puntano ad assumere un valore mitico, emblematico, nel qual caso si manifestano graficamente con la maiuscola (il “Chiesone”).
Sono tutti tratti, mi pare, che ritroviamo anche nei romanzi. Così come l’attenzione e la precisione assoluta delle descrizioni ambientali, che si tratti di evocare idilliache atmosfere naturali, o che l’autore metta a profitto le sue passate competenze professionali per indugiare in dettagli materiali, architettonici, ingegneristici. Così per esempio, davanti a un vano dell’ascensore, un personaggio osserva: “i molloni coperti di grasso del vano extra-corsa incassato in mezzo alle rampe della scala.”. Moltissime descrizioni di interni portano il segno della stessa pignoleria descrittiva:
Tutte uguali le scale e gli androni di questa città: i gradini di marmo bianco, consumati, il parapetto di ferro nero, il corrimano in legno, rigato e rovinato, lo zoccolo di smalto verde spento come l’alzata dei gradini, le pareti a calce, bianchissime, le plafoniere al neon, le finestrelle di riscontro d’aria sulle scale. Dappertutto lo stesso odore di strofinaccio, di varechina misto a cibo cucinato, di covaticcio domestico, non sgradevole in fondo.
Come se in quei molloni coperti di grasso o nel corrimano di legno rigato, o negli odori domestici, la scrittura trovasse un modo di compiersi, e riposare, assolvendo al suo ruolo allo stesso tempo classico e biblico di nominare le cose, facendole essere nella precisione assoluta di una visione lucida e ordinata che si contrappone a un universo caotico e irrazionale.
È un mondo denso, intenso, pienamente e direi goduriosamente materiale, quello di Pecoraro, dove le parole sono precisamente pesate sulla sostanza delle cose e dove chi parla sembra soffrire, patire, rimpiangere, ma solo perché spinto dal fortissimo desiderio vitale che le cose esistano infine così, piene vere disponibili, come nell’infanzia, o come sulla carta.