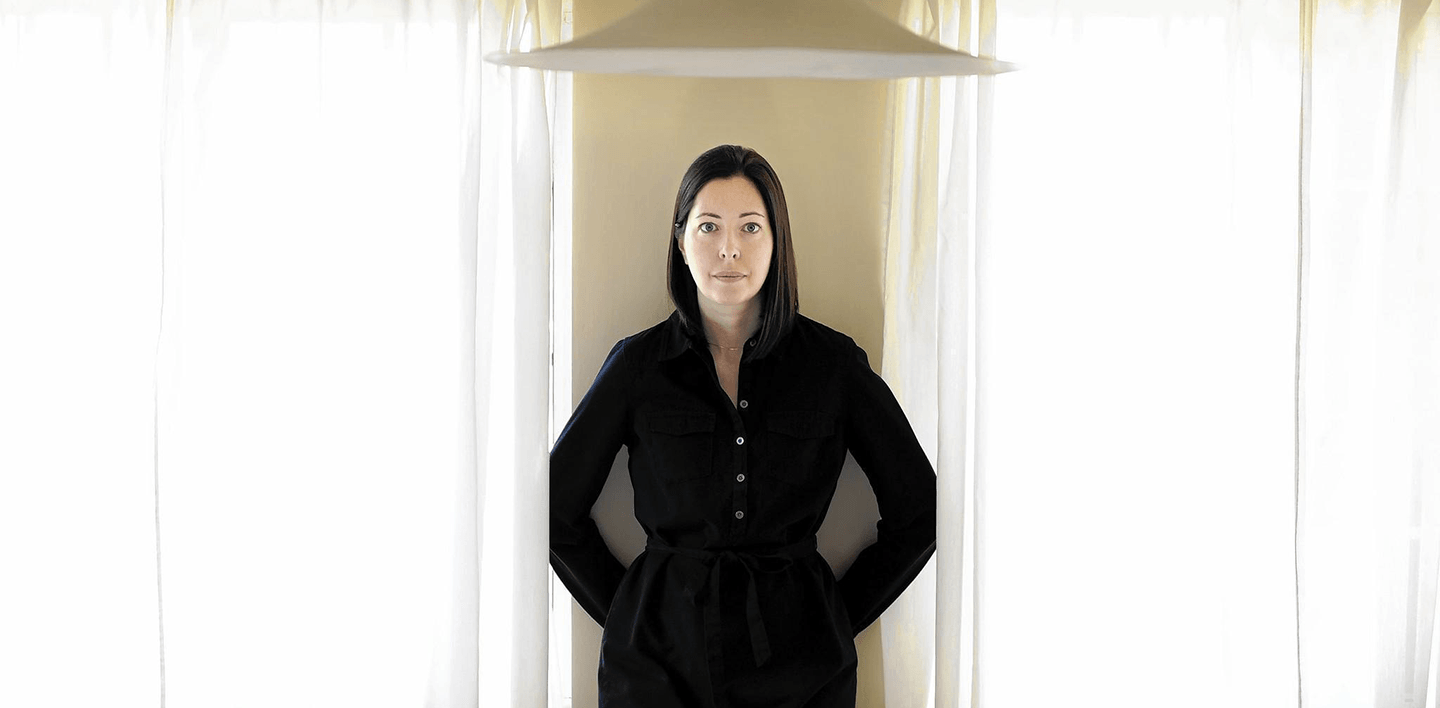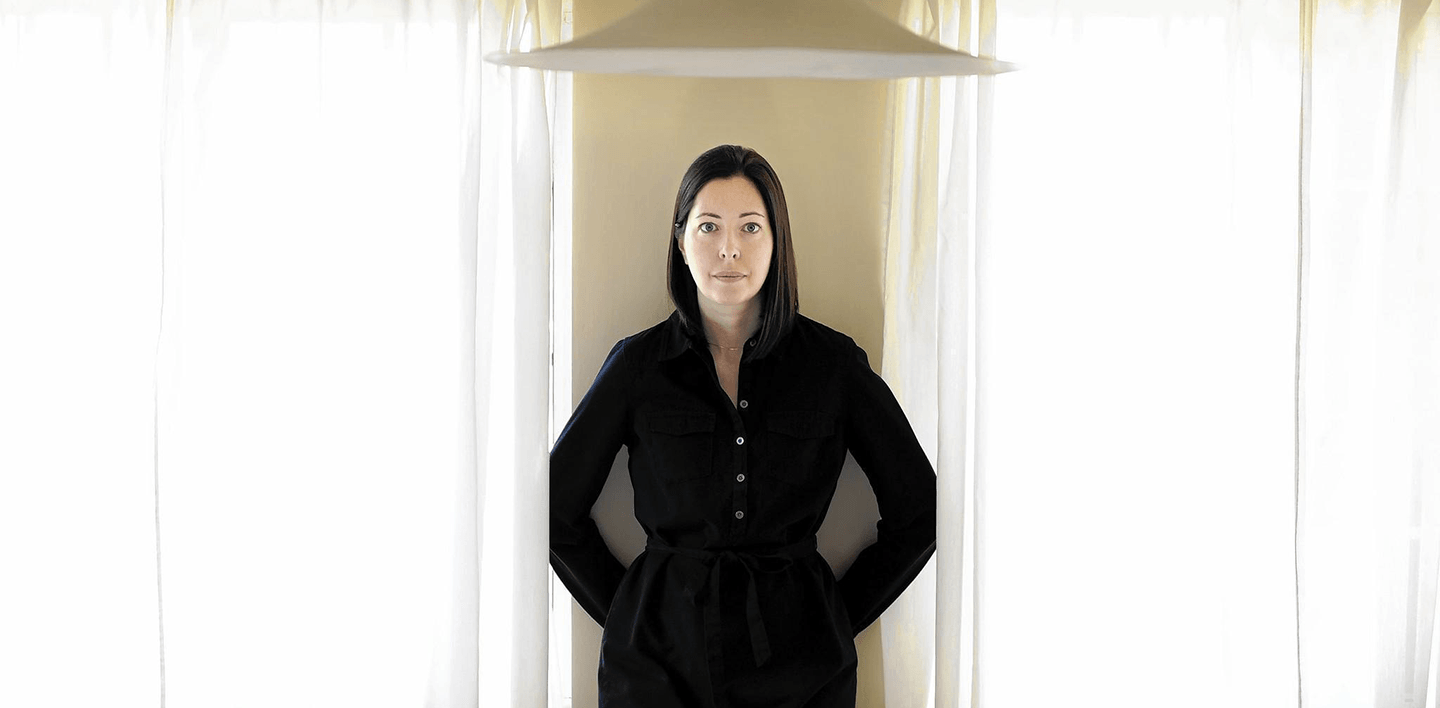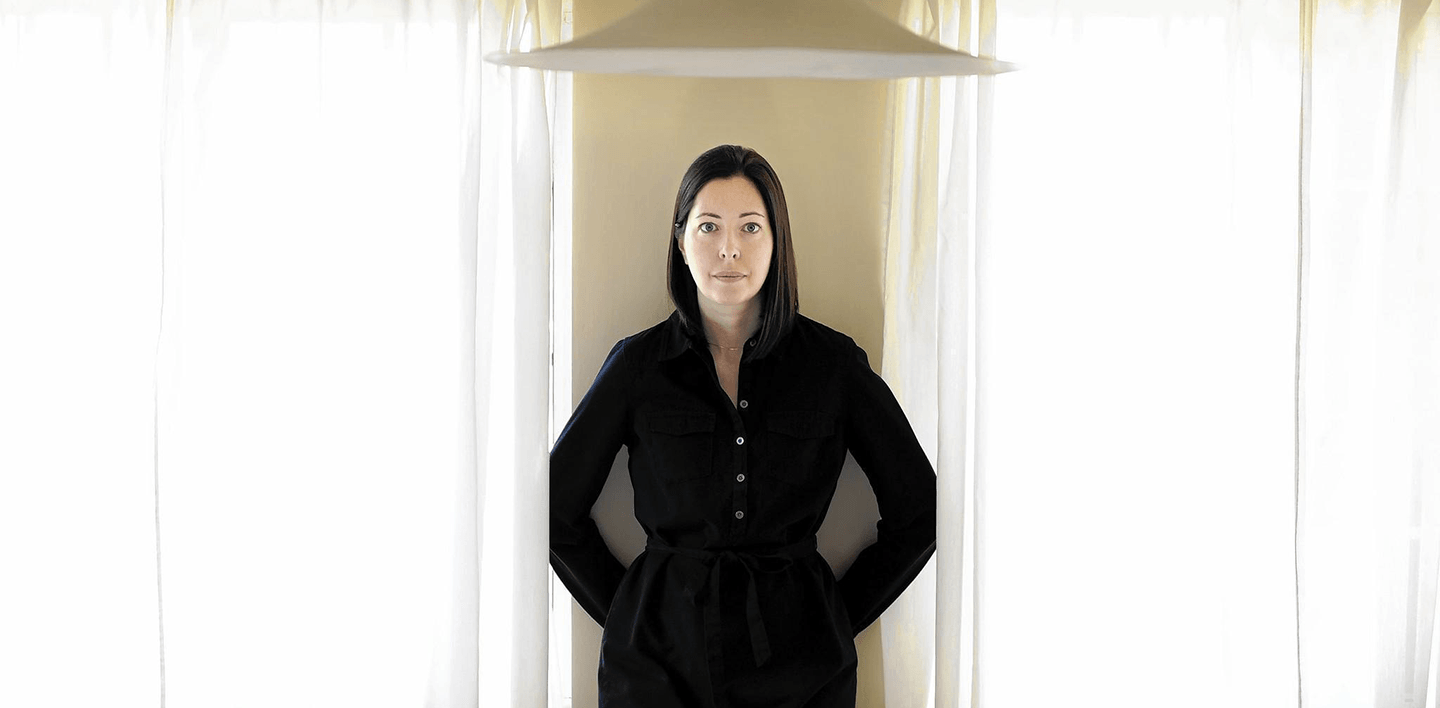“A
vrei voluto annotare ogni istante, ma il tempo non è fatto di istanti, li contiene. E nel tempo c’è molto altro. […] Volevo capire il mio posto nel tempo per fare in modo che la mia evoluzione fosse più completa e utile possibile.” Per venticinque anni, Sarah Manguso ha religiosamente tenuto un diario: “non volevo perdermi niente” confessa in Ongoingness. Tradotto da Gioia Guerzoni come Andanza (NN Editore), in questo memoir l’autrice americana racconta il suo desiderio di catturare l’andanza della vita, l’eterno susseguirsi di attimi che ne costituiscono la trama: “temevo che se mi fossi concessa di fluttuare per più di un giorno in un tempo non documentato sarei stata travolta”. Se non lo riesco a scrivere, si diceva, non è successo, se non vi riesco ad accedere col linguaggio, non avrà senso per me, sarà perso nel tempo.
Non volevo perdermi niente, era quello il mio problema. Non potevo affrontare la fine di una giornata senza annotare quello che era successo. Scrivevo di me stessa per non restare lì immobile a rimuginare – per smettere di pensare a quello che accadeva e a cosa farne. Ma soprattutto, scrivevo per poter dire che stavo prestando davvero attenzione. L’esperienza in sé non era sufficiente. Con il diario mi difendevo dalla paura di svegliarmi alla fine della vita accorgendomi che mi era sfuggita.
Nel 1958, alla galleria Iris Clert di Parigi, Yves Klein inaugura una mostra dal titolo Le vide: all’apertura lo spazio espositivo non contiene niente, non un singolo arredo, un singolo oggetto, niente, solo il vuoto. L’opera d’arte coincideva non tanto con la sua intangibilità, ma con la sua evaporazione, con la luce e l’aura che la presenza dell’artista aveva irradiato fino agli angoli della galleria: Yves Klein aveva pulito lo spazio, lo aveva reso elettrico. Due anni dopo, Arman avrebbe riempito lo stesso spazio ammassandovi di tutto, di fatto rendendo impossibile l’entrata ai visitatori. Nei miei ricordi le due mostre avvengono con cronologie inverse, per questo mi erano tornate in mente leggendo il libro di Manguso: perché quello dell’autrice è un lavoro di sottrazione, di pulizia, perché il sottotitolo di Andanza è la fine di un diario.
“L’arte di perdere non è una disciplina dura / tante cose sembrano volersi perdere / che la loro perdita non è una sciagura”, scrive Elisabeth Bishop in Un’arte: si fa un gran parlare del decluttering, di quel mantra che recita do I need it, does it spark joy?, ma quello che fa Sarah Manguso con Andanza assomiglia a quanto accade il giorno in cui porti via l’ultima scatola da una casa in cui hai vissuto per anni: non c’è più niente di tuo là dentro, eppure resta ancora qualcosa nell’ombra dei mobili, l’impronta di quello che è stato.
In questo volume sottile delle ottocentomila parole che contava il suo diario non se ne legge una, evaporate nel racconto della sua conclusione; Andanza è una riflessione sul desiderio e la mania che l’hanno portata a tenere un diario per quasi tutta la vita, a comporre migliaia di pagine e poi a farlo sempre meno: è una meditazione sulla scrittura, sul tempo e la sua testimonianza. In un giro di battuta, senza citarne una sola riga, Sarah Manguso cancella venticinque anni di annotazioni, perché non le servono più: “avevo vent’anni. E poi ventuno, ventidue e così via. Poi sono diventata madre e non ho più saputo distinguere tra ventuno e ventidue e tra trentotto e trentanove”. Al desiderio di tenere tutto, si sostituisce quello di permanere, di esistere come tempo, dentro al tempo.
Prima che mio figlio nascesse, il diario mi permetteva di continuare a esistere. Mi dava una forma, letteralmente. Se non lo scrivevo non ero nulla, ma poi il neonato è diventato un bambino che ha bisogno di me più di quanto io abbia bisogno di scrivere il diario. […] Prima di diventare madre pensavo di potermi chiedere, Come posso sopravvivere se dimentico così tanto? Poi ho capito che i momenti dimenticati sono il prezzo della partecipazione continua alla vita, una forza indifferente al tempo.
Se al blocco dello scrittore si contrappone la grafomania, se Mallarmé sta al lato opposto di Stephen King, Sarah Manguso abita uno spazio intermedio. Il salto, Andanza (entrambi pubblicati da NN Editore con traduzione di Gioia Guerzoni) e, poi ancora, Two kinds of decay (di prossima pubblicazione) e il recente 300 Arguments sono libri brevissimi, fatti di frammenti, riduzioni impossibili e accurate di universi infiniti, trattati tascabili sull’amore, la morte, la malattia.
Prima di intervistarla, ho riletto Il Salto e ho pensato a come questa scrittrice sia capace di trasformare il personale in universale: scrive “voglio sapere del mio dolore, che è inconoscibile, come quello di tutti” e poi continua “il sentimento d’amore non è per l’amato. È per chi ama. Quando mi dicono di amare tanto da non riuscire a respirare, non mi interessa. Sono loro a essere senza fiato”, per questo scrive che si vergogna del proprio dolore, per il lutto che porta per Harris, il suo amico che un giorno entra nella metropolitana di New York e si getta incontro a un treno: per questo ne scrive, “ormai i ricordi sono vaghi, erosi dal tempo, ricoperti dalla polvere di tutto quello che è accaduto poi. Ma ora voglio ricordarla, e impedire che mi tormenti”. Vuole fare i conti col suo dolore e poi lasciarlo finalmente libero.
Deve avere una sua bellezza, la fine. Lasciare che il vento ti soffi in faccia quando il treno entra sfrecciando in stazione. Immaginare che la vita ti venga incontro come un’onda. Cerco di credere che Harris abbia chiamato a raccolta tutta la bellezza della sua vita. Mi consola pensare che l’energia apparentemente perduta si è solo spostata altrove, è stata restituita al sistema del mondo.
Manguso scrive perché la sua vita è scrittura e perché di lei non rimanga traccia, per tornare ogni volta ad essere una tela bianca. Scrive perché tutto possa essere perduto, perché le parole possano smettere di significare senza che niente sia dimenticato e perché continuano a significare anche quando smettiamo di pronunciarle: “ora considero il diario come una serie di momenti che dimenticherò, trascritti in parole così come sono riuscita a farlo, vale a dire in modo imperfetto. Sto dimenticando tutto. Il mio obiettivo ora è dimenticare tutto, così da essere pulita per la morte. Rimarrà solo un vago ricordo di amore, di unione con il tutto.”
Maggie Nelson scrive, ne Gli Argonauti, di credere “all’idea wittgensteiniana secondo la quale l’indicibile farebbe – indicibilmente! – parte del detto”. Alla frase “Oh, che cosa ti direi, se solo le parole fossero sufficienti” risponde: “le parole sono sufficienti”. È per questo che scrive e per questo, mi pare, scrivi anche tu. La grafomania che ti imputi e che descrivi in Andanza non mi sembra altro che il tentativo di massimizzare le probabilità che tra tutte quelle parole, dietro a tutto quel materiale, sia contenuto anche l’indicibile.
Che le parole non siano sufficienti, che ci siano cose che non possono essere dette è una cosa che ho sentito dire spesso, forse non in Maggie Nelson, e la trovo frustrante. Non sono una studiosa di Wittgenstein e non so se voglio discutere il punto, ma quello che mi importa ottenere col mio lavoro è dire con accuratezza quello che fino a quel punto non sono riuscita a esprimere o che ancora non ho trovato nel lavoro di altri. Riuscire in questo intento assomiglia al sollievo che si prova quando ci si spoglia di un peso: c’è un preciso senso di soddisfazione nel leggere le parole di un autore che è stato capace di esprimere qualcosa con un grado di accuratezza maggiore. Non si tratta di un effetto mistico, ma piuttosto quantitativo, legato alla capacità di essere incisivi, aderenti a qualcosa che è accaduto. Penso a molti dei grandi temi – l’amore e il dolore e il desiderio e la morte, per esempio – e a come sono stati trattati di solito: e ogni volta trovo che non siano stati ancora trattati in maniera soddisfacente.
Ottocentomila parole, tanto misura il tuo diario nella sua interezza: invece di pubblicare un libro di migliaia di pagine, ne hai tirato fuori un volume imprevedibilmente sottile e frammentario. In un certo modo mi è sembrato il controcanto de La mia battaglia di Karl Ove Knausgaard: i sei volumi che ha scritto sembrano animati dallo stesso tipo di urgenza, che però si colloca dall’altro lato dello spettro.
Non appena un autore riesce a comprendere qual è la sua andatura naturale, il suo ritmo, impara anche quale sia la forma o il registro che gli sono più congeniali. Per me è la brevità: provo piacere – ed è una sorta di ossessione per me – nel ridurre le cose, nel sintetizzarle quanto più possibile, provando però a rimanere sempre accurata. La forma naturale per Knausgaard è la lunghezza: deve avere a che fare con il suono delle parole o con il modo in cui costruisce le frasi. Se pure scrivessi un libro di migliaia di pagine, questo non assomiglierebbe comunque per niente ai suoi libri; sarebbe strutturalmente diverso, perché scritto nella mia lingua: non parlo di traduzione, quanto del modo in cui uso il linguaggio perché significhi qualcosa.
Quando hai iniziato a riflettere sulla tua abitudine di tenere un diario? L’impressione è che questo sia avvenuto nel momento in cui continuare a scriverlo ha smesso di essere vitale per te.
Ho sempre difficoltà a rispondere a questa domanda, perché in un certo senso è una di quelle domande a cui è facile dare una risposta. E la risposta è che ho avuto un figlio, ma il mio rapporto con il diario non è cambiato per le ragioni che uno si aspetta, non perché fossi più impegnata, ma perché la presenza di un figlio ha trasformato il modo in cui vivo il tempo. Non avevo più l’impressione di essere solo una piccola particella che si muove libera nell’universo, ma c’era un’altra e nuova posizione che stavo occupando oltre a quella: ero diventata lo sfondo della vita di qualcun altro, ero diventata il tempo e l’universo per mio figlio. E occupare nello stesso momento le due posizioni ha ridotto il mio bisogno ossessivo di scrivere e non era come se non ne fossi più capace o perché c’era qualcosa che mi bloccava, ma perché quella necessità impellente e quell’urgenza si erano calmate: ed era un sollievo.
C’è una frase nel Dottor Zivago a cui non pensavo da molto e che mi è tornata in mente quando ho letto Andanza, è quella in cui a Lara si rivela il senso dell’esistenza: “era lì, sentiva, per cercare di capire la frenetica bellezza del mondo, per dare un nome alle cose e, se le sue forze non fossero bastate, per generare dei figli che l’avrebbero fatto in sua vece”. Mi sembra descrivere la tua relazione con la scrittura: la frenetica bellezza del mondo sembra appunto un’andanza. Ma come facciamo a nominare le cose se i nomi sono arbitrari? Tuo figlio, lo citi in Andanza, ad un certo punto impara a dire bambù e tutte le cose sono bambù, senza che la loro sostanza ne venga influenzata, tutto resta uguale.
Penso che nessuna tra le arti possa salvare o trattenere l’universo dal suo decadimento, in nessun modo. Quello che per me era interessante era vedere come questa piccola creatura avrebbe imparato a parlare, come avrebbe creato il suo rapporto con il linguaggio. Quello che nessuno ti dice, una cosa che non avevo mai letto prima, è che la maternità può essere molto stimolante dal punto di vista intellettuale. Mi aspettavo di imparare qualcosa sui sentimenti, sull’amore, e invece la maternità è stata un’esperienza affascinante e coinvolgente per la mia mente. È successo il contrario di quello che si dice di norma, cioè che da madre non hai più tempo per pensare. E a proposito del linguaggio, come possiamo dare nomi alle cose, è una domanda difficile. Da scrittori si crede che tutto quello che si scrive debba o essere pensato per il lettore, o qualcosa che puoi capire solo tu: penso invece che queste due categorie si sovrappongono per larga parte.
George Sauders ha detto una volta che non c’è differenza tra il primo amore nella Russia del diciannovesimo secolo, con le strade gelate dalla neve, e il primo amore nel Midwest degli anni ‘70, mentre ci si dà da fare sul sedile posteriore di un’auto e alla radio passano
Foghat, che si equivalgono: trovo che preoccuparsi della distanza tra ciò che è comprensibile per me e quello che lo è per un lettore non sia sempre un problema legittimo. Sono convinta che se quello che scrivo è sufficientemente accurato per me, allora, in generale, posso esser certa che anche il lettore capirà.
Il Salto è, da sottotitolo, un’elegia per un amico, una meditazione sulla vita e la morte di una persona. In quel libro racconti del tuo periodo a Roma: pensavi, scrivi “che se fossi mai andata in Italia sarei diventata subito italiana, che il mio nome mi avrebbe ancorato lì” ma scopri che il tuo cognome, nonostante suoni italiano, non vuol dire niente di preciso; ironicamente credo proprio che Manguso abbia a che fare con la radice di mancare. Forse le parole non riescono a portarci più vicino al nucleo della verità o a qualsiasi cosa siamo convinti che ci sia da qualche parte, ma perlomeno possono dare traccia di un’esistenza o anche solo la trama del tempo che passa. Forse, mi chiedo, le parole servono a portarci più vicino a questa mancanza, all’evanescenza delle cose, dei referenti.
Ho sentito infinite interpretazioni del mio cognome, come
mano chiusa, e mi chiedo se forse non dovrei chiedere a un linguista quale sia quella giusta, ma mi piace anche la lettura che ne fai tu, la trovo molto evocativa. Non ci pensavo da molto tempo, ma mi è tornato in mente questo passaggio di Charles Simic, il poeta di origine serba che dice che
“ogni oggetto è un’enciclopedia di archetipi” . Si trova nella raccolta
Il mostro ama il suo labirinto, che tra le altre cose ha un titolo stupendo; ecco lì parla dell’impossibilità di usare una parola senza dover rinunciare a tutti gli altri significati che quella parola potrebbe, anche inintenzionalmente, avere. Ogni volta che usi una parola, questa porta con sé una serie di riferimenti che forse non erano neppure intesi all’origine e di cui vorresti fare a meno, che magari non hanno a che fare con l’etimologia, ma che adesso sono lì e provengono dalla cultura, dalla società, dall’uso che se ne fa. Se ci pensi troppo, finisce che non scrivi più neanche una parola, schiacciata dalla paura e dal peso di fare una sola scelta, perché ogni parola vuol dire già troppo.
Ridurre le esperienze a libri così brevi ho la sensazione che abbia a che fare con l’idea di mettere in ordine il mondo, di dire le cose per assiomi e regole. Se non come Wittgenstein, almeno come L’amante di Wittgenstein, il romanzo di David Markson che procede per brevissimi frammenti. In quel libro il tentativo di mettere ordine in un mondo desolato finisce per produrre un’opera piena di buchi, di crepe, e proprio in queste fratture trovi tutto quello che il resto del libro non riesce ad esprimere. Forse quello che conta sta là.
Quelle fratture non sono assenza di struttura, ma parte della struttura stessa. Il silenzio può dire molte cose e ci sono molti modi di usarlo, per lasciare le cose fuori dall’inquadratura. Per anni ho fatto lezione sull’omissione in letteratura: mi piaceva farlo perché gli studenti sembrano portati naturalmente – direi proprio che sono attratti da questa forma – a scrivere cose brevi, perché in apparenza sembra più facile, no? È breve, è facile. Ma nel processo si rendono conto che sono infiniti i modi per non dire qualcosa, per omettere un dettaglio o una reazione; puoi usare una metafora vuota che non porta a niente, lasciare la pagina bianca – come scrittrice sono interessata agli strumenti formali per ottenere questo effetto. Potrei pensare al silenzio per sempre.
Quanto hanno pesato la filosofia o certi tipi di scrittura nella tua formazione letteraria? Vorrei capire quali sono le tue influenze.
Devo dire che rispetto al mio desiderio di scrivere, la spinta non arriva da ciò che leggo – farlo ovviamente è fonte di enorme piacere – ma piuttosto viene dalle esperienze, dal fatto che ogni mia esperienza è soggettiva, che scrivo dal punto di vista di un essere umano, di questo preciso essere umano. Questo è quello che ho provato a fare fino ad ora: in questo momento e per la prima volta, sto lavorando a un romanzo, una cosa che mi pare impossibile e che non pensavo avrei mai fatto, ma a parte quello, quello che mi interessa è tradurre esperienze fondamentali di un’esistenza in parole.
Hai vissuto a Roma all’American Academy e ne Il Salto descrivi quella parte della tua vita come caotica e confusa: “visitavo paesi e città e raccoglievo descrizioni di tutto quello che c’era da vedere. Non le rilessi mai. Invece di trascrivere i miei diari di viaggio, passai gran parte di quell’anno di fellowship a cercare, invano, di trascrivere un romanzo su una prigione sperimentale in cui la gente viene sorvegliata in segreto finché non impazzisce. Un po’ ero impazzita, là nella mia celletta in una villa sul colle più alto di Roma”. A tratti, mi sono chiesta se trovarti al di fuori della tua lingua, senza possibilità di traduzione, non ti avesse obbligata a confrontarti con i limiti del linguaggio.
Penso che quello che mi ha fatto un po’ uscire di testa a Roma non fosse stare a Roma, ma piuttosto vivere all’Accademia, in mezzo a tutte le altre persone. Perché vedi com’è il mio studio? Ci sono i libri, una finestra, una scrivania, il mio gatto che entra ed esce, tutto qui. È stato impegnativo abituarsi ad avere altre sessanta persone intorno, in un posto dove appartamenti, uffici e studi sono tutti nello stesso palazzo. Sono passati undici anni da allora, ma ancora sento storie di scrittori e artisti che perdono il controllo. Al contrario, gli accademici, solitamente, se la passano bene: forse il fatto è che da scrittori siamo abituati a un’attività solitaria, non che questo voglia dire che siamo degli dei o altro, solo che è difficile cambiare così tanto.
Scrivere può servire ad affermare la propria esistenza: come se ci si raccontasse ogni volta la stessa storia, solo con stili diversi, per continuare a vivere, come fa Sherazade in Le mille e una notte. In Andanza scrivi, e questo è quello che mi interessa, che scrivere è un modo per dimenticare, per spingersi verso una rarefazione e astrazione della lingua. 300 Arguments, il tuo ultimo libro mi pare muoversi in questa direzione.
Non sapevo quanto connesse per me fossero le azioni di dimenticare e scrivere fino a che non ho scritto Two kinds of decay. In quel libro ho parlato di un periodo molto difficile della mia vita, durato nove anni, in cui sono stata malata: per scriverlo, non ho fatto ricerche, ho solo messo giù quello che ricordavo. Ecco come è nato: adesso ricordo momenti di quel periodo, ma non saprei essere specifica, non potrei più dire cosa è successo nel marzo di un certo anno, è tutto sparito. Ogni libro che ho scritto da quel momento ha avuto lo stesso effetto su di me: riguardano sempre argomenti complessi, la morte di un amico, la nascita di mio figlio: appena li pubblico, i ricordi spariscono, la mia mente si libera ed è un sollievo, un piacere. Dovrei leggere il libro per ricordare, solo non ho nessuna intenzione di farlo. Per me, scrivere è come pulire una stanza.