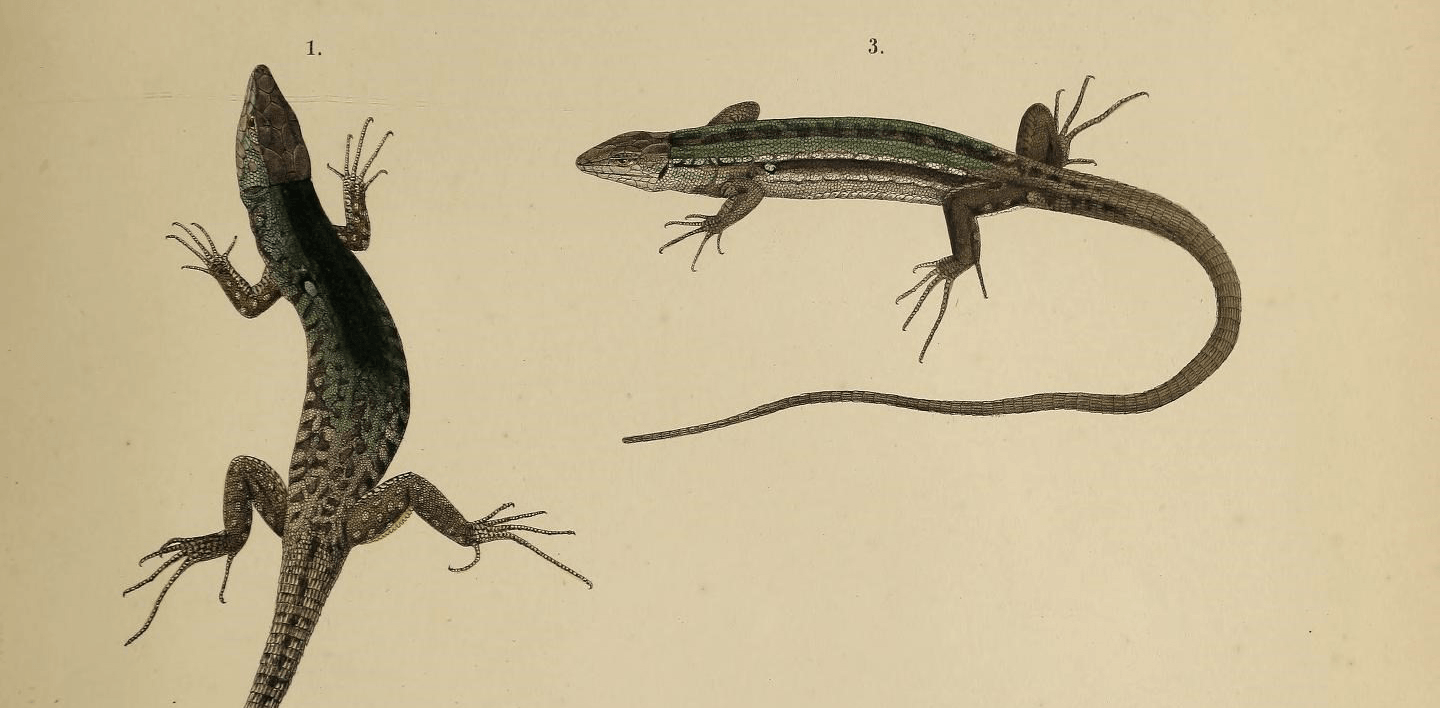
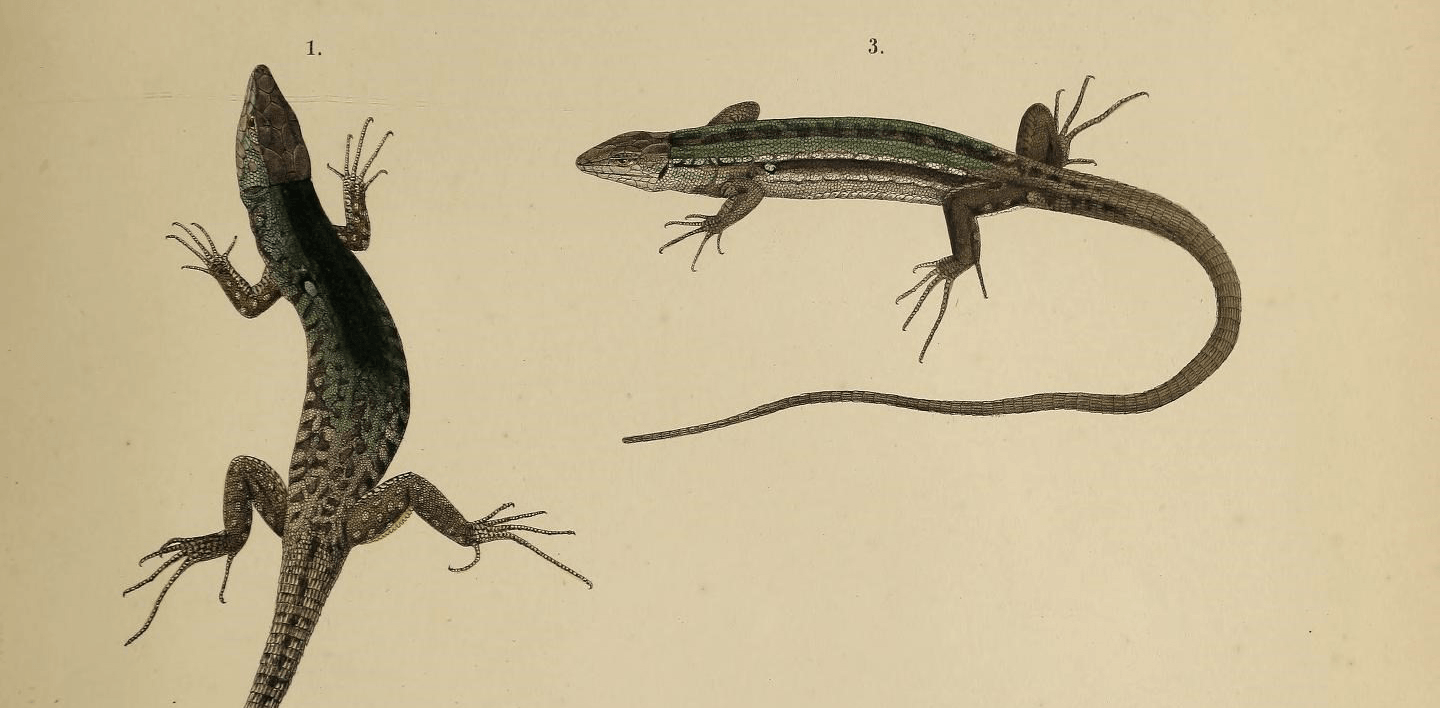
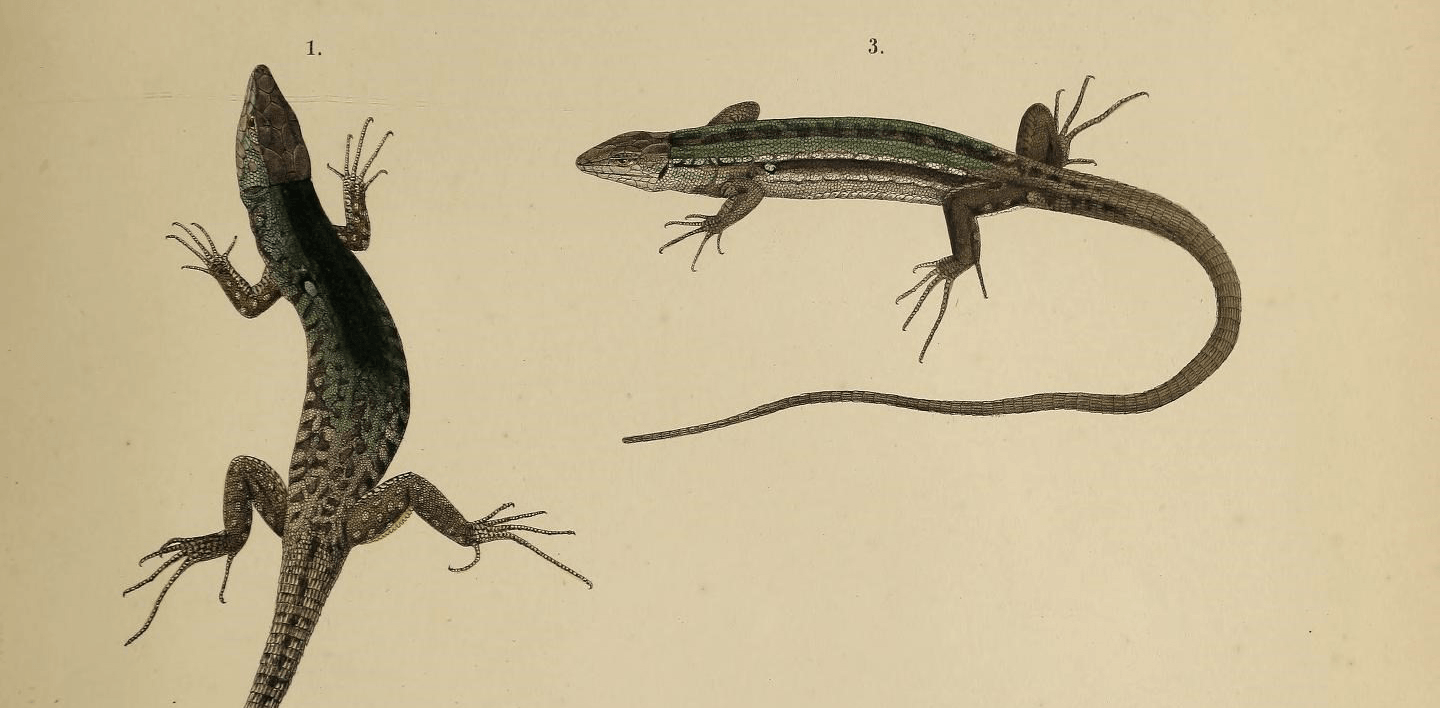
L a prima notizia certa dell’arrivo di un rinoceronte in Europa risale al 1515. Ganda era il dono di un sultano per il re del Portogallo Manuel I e arrivò a Lisbona dopo un viaggio durato quattro mesi. Fu portato a corte, esibito al re e ai cortigiani, fatto combattere con un elefante e poi imbarcato su un’altra nave diretta a Roma, perché venisse dato in omaggio a papa Leone X. La nave affondò al largo della costa ligure e il rinoceronte venuto dall’India morì tra le onde del Mediterraneo.
Da quelle onde, però, l’immagine di Ganda si diffuse in cerchi concentrici in tutta Europa. Un pittore alla corte di Manuel I aveva tracciato un bozzetto dell’animale e lo aveva spedito a un conoscente a Norimberga, accompagnato dalla parola “Rinoceronte”. Il destinatario era Albrecht Dürer, uno degli incisori più famosi dell’epoca, che prese quel bozzetto e lo trasformò in un’opera d’arte: il rinoceronte aveva un corpo massiccio ricoperto di scaglie spesse come un’armatura, gambe tozze e squamose, il celebre corno. Il ritratto incarnava allo stesso tempo le caratteristiche osservate nell’animale dal vivo e quel cumulo di credenze che dalla descrizione di Plinio il Vecchio, passando per i bestiari medievali, lo aveva associato al mito dell’unicorno. Il commento di Dürer in calce alla xilografia s’ispira proprio a Plinio: “Il potente re del Portogallo, Manuele di Lisbona, portò dall’India questo essere vivente chiamato rinoceronte. Questa ne costituisce un’accurata rappresentazione. Ha il colore della tartaruga maculata ed è quasi interamente ricoperto da squame spessissime. Ha le dimensioni di un elefante, ma ha gambe più corte ed è quasi invulnerabile. Ha un forte corno appuntito sulla sommità del naso che affila sulle pietre”. Grazie alla recente invenzione della stampa, quell’immagine venne riprodotta ovunque, dalle Fiandre alla Sicilia, in quadri, libri, stemmi, statue, stucchi, vasi, porcellane.
Nel saggio dedicato a Ganda contenuto nella raccolta Animals Strike Curious Poses (Penguin Vintage, 2017), Elena Passarello definisce il 1515 l’anno in cui “questi due corpi, l’animale e l’idea dell’animale, si sono ritrovati nello stesso continente”. È una descrizione che riassume secoli di rapporto tra uomo e animale, la realtà fisica della convivenza terrestre e l’eco che produce nell’immaginario culturale. Dai primi saggi di storia naturale ai bestiari medievali, fino agli studi di biologia ed evoluzionismo, l’uomo ha cercato di affinare il più possibile l’osservazione degli animali, di conoscerne a fondo la vita e le abitudini. Animals Strike Curious Poses è una collezione di biografie di animali famosi: c’è Yuka, il mammut ritrovato nella steppa siberiana; l’usignolo di Mozart, che intreccia le sue melodie con quelle del compositore; Hans, il cavallo che sapeva fare i conti; Cecil, il leone ucciso da un dentista americano in una battuta di caccia; Arabella, il ragno che tesseva la sua ragnatela nello spazio.
Dai primi saggi di storia naturale ai bestiari medievali, fino agli studi di biologia ed evoluzionismo, l’uomo ha cercato di affinare il più possibile l’osservazione degli animali.
Nel momento in cui incontra l’uomo, ognuno di questi animali stabilisce un legame diverso, diventa il significante di qualcosa d’immateriale, astratto, difficile da comprendere. Ganda il rinoceronte esemplifica il modo in cui la distanza fisica e quella immaginata possono fondersi e completarsi in un unico corpo, mentre il cucciolo di mammut Yuka, con i suoi ciuffi di pelliccia perfettamente conservati per 38.000 anni, permette all’uomo di sentire cos’è veramente il tempo, cos’è lo scorrere dei millenni: “dato che il linguaggio è incredibilmente più giovane sia del pensiero sia dell’esperienza, ‘un mammut peloso’ ha, per il cervello, un significato più simile a quello del tempo. Potrebbe significare tempo anche più del tempo stesso, perché la capacità del cervello di capire una qualsiasi durata di anni è risibile. Pochi corpi hanno sentito la presa reale di un secolo, e sono ancora meno le menti che possono afferrarne dieci, anche in sogno. Cosa c’è di tangibile in cento anni, chiede il cervello, per non parlare di un secolo ripetuto quattrocento volte?”.
Nella sua collezione di celebrità bestiali, Passarello risponde implicitamente alla domanda che John Berger aveva posto quasi quarant’anni prima in Perché guardiamo gli animali? (Il Saggiatore, 2016, traduzione di Maria Nadotti). Secondo lo scrittore inglese: “Da principio gli animali entrano nell’immaginario dell’uomo come messaggeri e come promesse”. Sono esseri viventi simili ma dissimili, familiari ma inconoscibili, entità che lo sguardo dell’uomo cerca di penetrare senza mai riuscirci fino in fondo: “venivano da oltre l’orizzonte, erano a casa laggiù e qui”. Come tutte le fonti di mistero, diventano oggetto dell’arte. Le pitture rupestri, i primi dipinti realizzati dall’uomo, avevano soggetti di caccia. Secondo Berger, non è irragionevole pensare che anche la prima metafora sia stata animale. Nell’Iliade, Omero usa gli animali come termine di paragone per descrivere la forza degli uomini, il loro coraggio, la loro astuzia, le loro reazioni più intense al dolore o alla paura. I segni dello Zodiaco e le costellazioni avevano nomi animali, i totem erano animali, i miti di fondazione delle civiltà più antiche avevano al centro degli animali: “ovunque gli animali offrivano spiegazioni o, più precisamente, prestavano il proprio nome o il proprio carattere a una qualità che, come tutte le qualità, era, nella sua essenza, misteriosa”.
Se Ganda diventa metafora dell’immaginazione e Yuka del tempo, cosa dire di Lancelot? Nel 1985 il Barnum & Baily Circus poteva vantare un ospite d’eccezione nella sua tournée: un vero unicorno. Lancelot era un animale piccolo e dinoccolato, dal mantello bianco e il corno dipinto di rosa, faceva il suo ingresso in scena issato su un carro dorato e si diceva si nutrisse solo di petali di fiori. Più simile a una capra che a un cavallo, Lancelot non aveva la prestanza che ci si sarebbe aspettati da un unicorno. Per giustificare la sua origine, i rappresentati del circo raccontavano che un giorno era semplicemente arrivato al tendone, ma la verità è ancora più singolare. Lancelot era una capra “modificata” secondo un brevetto registrato dal Governo degli Stati Uniti: il corno era frutto di un’operazione chirurgica effettuata su un cucciolo appena nato, quando la base delle corna non è ancora ancorata al cranio, e può essere fusa in un unico elemento al centro della testa. Passarello commenta l’impressione dell’unicorno avuta da bambina: “L’emozione, per me, non dipendeva dalla sua esistenza; era essere seduta (relativamente) vicino a qualcosa che rappresentava magia pura”. Ricollegandosi al saggio di Berger, prosegue: “Lancelot, selvaggio e insensato, era davanti a me; poteva essere visitato e sognato. La capra unicorno era, per me, laggiù e qui”.
Lancelot è metafora di ciò che lega il reale e l’orizzonte. E se l’orizzonte contiene in sé l’idea di futuro, quello che immaginiamo per il rapporto tra uomo e animale non è roseo. Cambiamento climatico, ecosistemi in pericolo ed emergenze ambientali portano a dipingere scenari apocalittici, un altrove che assorbe i timori del qui. Nell’indefinibile Gli animali che amiamo (66th and 22nd, 2017, traduzione di Anna D’Elia), Antoine Volodine crea un mondo post-esotico in cui l’uomo è praticamente estinto, una presenza marginale rispetto agli elefanti solitari, i granchi regnanti e le sirene decapitate che lo abitano. Il libro è composto da una serie di racconti intrecciati, delle intrarcane (“pratiche magiche, un misterioso incantamento”), in cui la desolazione dell’ambiente si riflette nella violenza dei rapporti sociali. In un’intervista al Tascabile, Volodine commenta: “Quando bisogna mettere in scena delle creature che hanno fatto seguito all’umano, pensiamo più che altro a ragni e scarafaggi”. Questo mondo senza uomini, brulicante di ragni, fa eco all’eternità descritta da Dostoevskij in Delitto e Castigo:
Noi ci rappresentiamo sempre l’eternità come un’idea che non possiamo comprendere, come una cosa immensa, immensa. Ma perché dovrebbe essere immensa? E se lassù non ci fosse altro che una stanzetta, simile ad una rustica stanza da bagno affumicata, e in tutti gli angoli ci fossero tanti ragni? Se l’eternità non fosse altro che questo?
Nel bestiario apocalittico di Volodine, l’aldilà è presente nella forma dei sogni di Balbuziar, “principe onirico”, erede di un’antica dinastia granchiesca in grado di creare mondi con la forza del pensiero. L’eternità è consegnata alle pagine scritte da un gruppo di storici, che immortalano la vicenda delle sette sirene decapitate in un racconto dove “le voci rilucono tra un’ombra e l’altra, le immagini ghignano, l’atmosfera è fatta ormai solo di sangue e coltelli”. Le creature che si aggirano sono complesse, hanno Storia e tradizioni, codici di corte e conoscenze esoteriche che rimandano al mondo umano, ma di umano conservano ben poco.
La storia dell’elefante Wong è l’unica in cui l’uomo fa la sua comparsa. Nei due capitoli che aprono e chiudono Gli animali che amiamo, Wong cammina senza meta in un paese in rovina, attraversa tratti di foresta dove gli uccelli sono “rari e apatici” e uno sversamento di veleno ha creato “una sorta d’inguaribile piaga”. In questo paesaggio devastato incontriamo una donna, disperata al pensiero che la specie sia destinata a estinguersi. Quando chiede a Wong di aiutarla a riprodursi, l’elefante non ha dubbi:
“Le generazioni future, poi, altre stronzate. Non avremo successori, ci fermeremo qui”.“Credi?”
“Mi sa di sì” disse Wong. “Tutt’al più, saranno i ragni a darci il cambio. Per me, che se la spassino pure”.