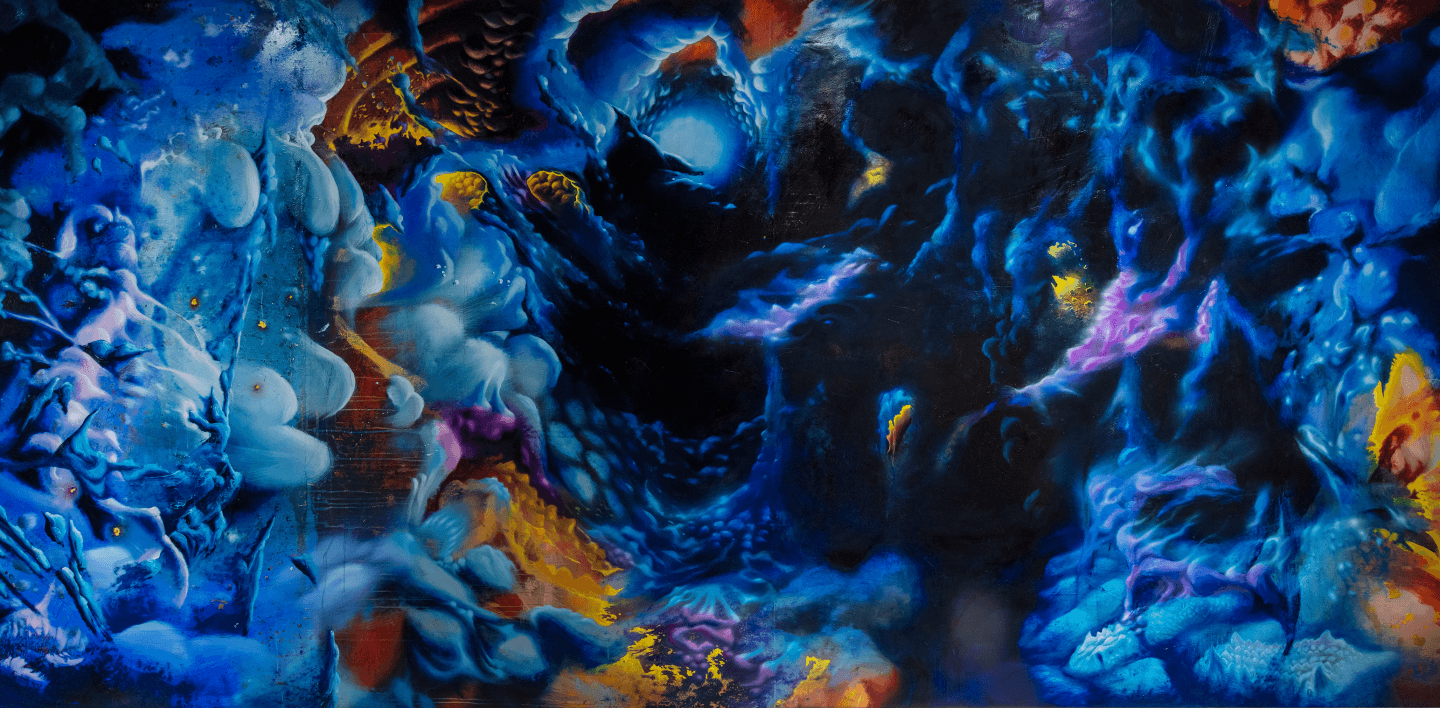
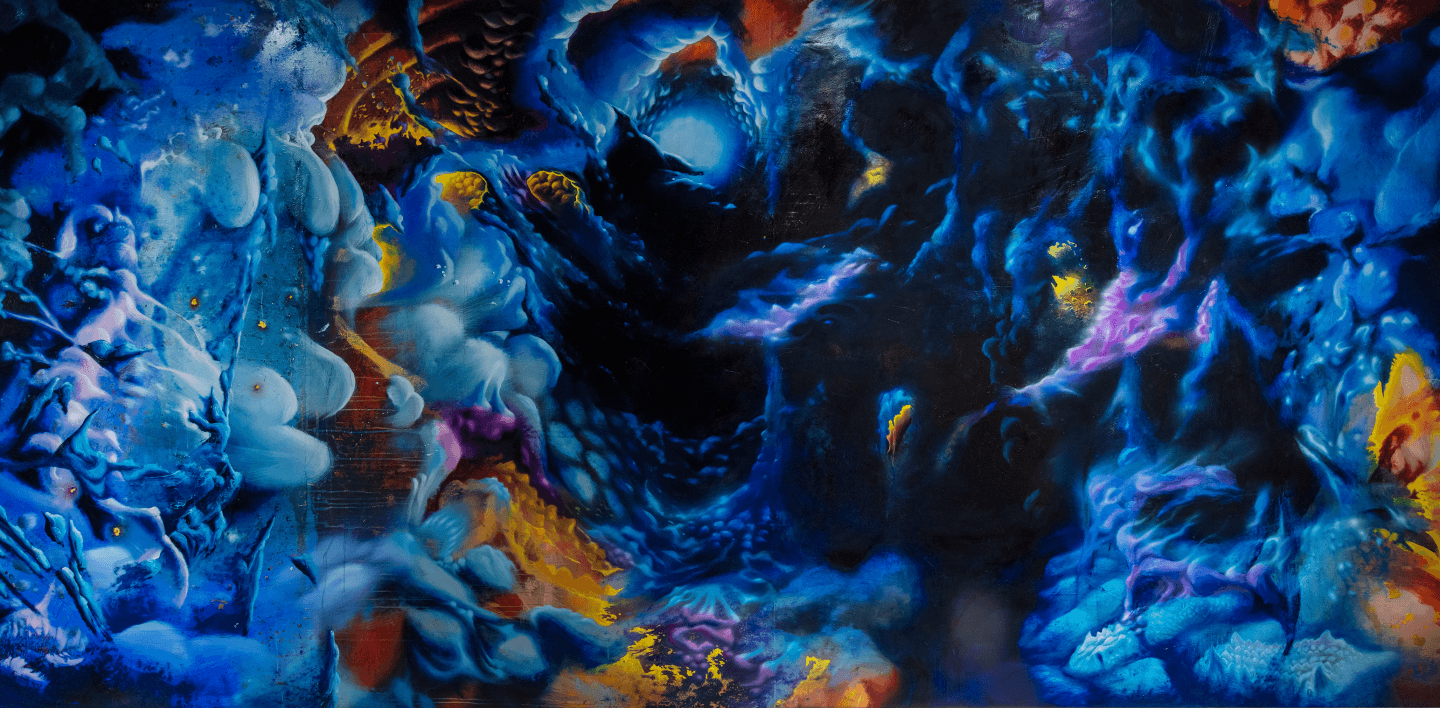
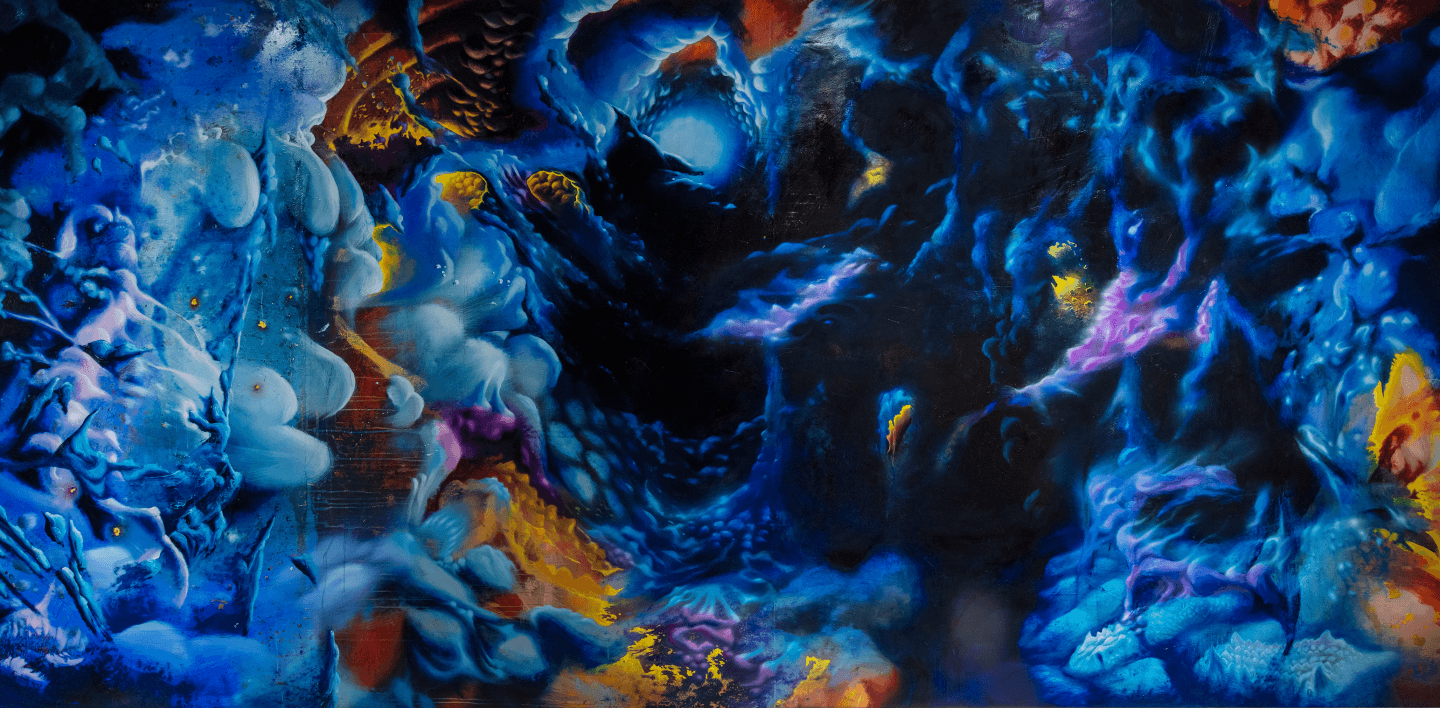
È in uscita per Bompiani L’anno del Fuoco Segreto. Un libro, curato da Edoardo Rialti e Dario Valentini, chiamato a raccogliere i racconti di venti autori e autrici italiani contemporanei radunati attorno al Novo Sconcertante Italico. Definizione che non è tanto un’ingenua risposta italica al new weird, quanto piuttosto un modo per raccogliere insieme scritture difformi e traboccanti, l’esigenza di ribadire una volta ancora l’essenza radicalmente “sconcertante” di ogni vera letteratura. Pensiamo ai “predecessori eretici” di questo sconcerto: al gesto letterario di Landolfi in Cancroregina; alla patria di Anna Maria Ortese, fatta di “folletti, spiriti di Padri morti, di Bambini perduti, di piante che sognano”. Pensiamo ai libri, sempre “paralleli”, tracciati da Manganelli; all’invito a guardare al “retro” del foglio o del nastro del poeta Corrado Costa; alla divinazione elettronica dei “madrigali escatologici” di Emilio Villa, catturati da un imprendibile “sweetromatic cybernetogamig vampire”; e poi, continuando a inseguire questo tortuoso sentiero, pensiamo anche a quella che Cristina Campo chiamava “la lunga fedeltà dei folli”, citata dai curatori nell’introduzione al libro. “L’Anno del Fuoco Segreto”, scrivono Rialti e Valentini sempre nell’introduzione, “non vuole solo additare le strade di una possibile fase nuova dell’orizzonte immaginativo condiviso, ma anche ribadire che in fondo la grande autentica letteratura è sempre sconcertante, e allo stesso tempo è tutta finzione, persino la narrativa più radicalmente realista, persino la cosiddetta auto-fiction, se è arte grande e compiuta, resta artificio supremo”. Sconcertante è dunque il processo con cui la scrittura disorienta se stessa, fa balbettare la banalità dell’esprimibile, non classifica ma “sclassifica”, come nell’invito all’arte posto da Marcel Schwob in apertura al suo Vite immaginarie, avventura della finzione che più di molte altre ha insegnato a “tarlare” con dubbi, ambiguità e stranezze i grandi capitoli chiusi della storia universale.
Da cosa nasce il titolo della raccolta?
Edoardo Rialti: La definizione che noi abbiamo scelto, col suo ammiccamento allo Stilnovo e alle origini della letteratura nazionale, è volutamente ironica per due motivi: prende in giro la traducibilità di certi concetti culturali passati nell’uso comune e dall’altro ha pure una ragione amorosamente storica e locale, dal momento che questi interrogativi e questo lavoro per noi sono nati in un luogo, uno spazio e un tempo ben precisi, quello della comunità di scrittori fiorentini che si è sviluppata attorno a riviste come Mostro e alle sue sperimentazioni, per poi arrivare al dibattito sul Novo Sconcertante Italico uscito per L’indiscreto. Il punto di partenza è la nostra scrittura specifica, ciò che io e Dario Valentini abbiamo sempre avvertito, da percorsi diversi, come importante. Abbiamo voluto scrivere storie come piacevano a noi, suonare una nota o intonare un canto, chiedendo ad altri di aggiungere le loro, di voci.
Dario Valentini: L’Anno del Fuoco Segreto è già di per sé un portmanteau sconfinante, che fonde L’anno del pensiero magico di Didion e il “Fuoco Segreto” di Tolkien. Testi e autori con intuizioni narrative profondamente diverse ma a nostro avviso non mutualmente esclusive. L’idea che ci ha guidato, come rimarcato nella prefazione al volume, è quella della fuga da categorie e definizioni previe. Volevamo essere una anomalia pulsante rispetto a ogni ortodossia, qualcosa che appena si crede di nominare, è già perduto, già altrove, ha già cambiato nome.
Come definire allora il Novo Sconcertante Italico senza riportarlo nella norma sin dal principio?
ER: La definizione di Weird è un “tappeto di misteriosa complicazione”, come direbbe Cristina Campo (una delle nostre fate-madrine). Il dibattito oggi comprende chi si richiama alla storia specifica del termine, da Weird Tales fino a VanderMeer et alia, e chi invece sostiene che pure questa linea si sia ormai mescolata con altri stimoli e fonti, così come le obiezioni di chi – non senza ragioni – diffida di quello che può tradursi nell’ennesimo brand commerciale per occupare più spazi di visibilità possibile. Resta sempre valido che i generi sono porte e soglie, non gabbie, e in arte chiunque tracci un confine dovrebbe farlo solo per suscitare il desiderio di varcarlo, anzitutto in sé stesso. Come notava Chesterton “l’idea di mettere un folletto in laboratorio ha qualcosa di sinistro. L’unica consolazione è che sicuramente non collaborerà”. Le definizioni sono utili nel momento in cui aprono porte e non diventano ghetti, nessuna definizione e nessun incasellamento di genere rende pienamente ragione di un’esperienza data da una grande opera narrativa, questo è vero al fondo per tutti i grandi libri. Aggiungo: il Weird per certi aspetti pare conoscere lo stesso destino di traboccamento dell’aggettivo Queer, che da insulto a bandiera orgogliosamente impugnata sembra oggi una cupola celeste sotto cui ascrivere ogni opposizione al binarismo, con tutti i rischi possibili delle parole-valigia in cui ficcare ogni cosa. Citando Wu Ming 4, possiamo dire che il crossover, la fusione esiste da quando esiste la narrativa perché i generi non (si) bastano mai. Lo “Sconcertante” attesta il fermento – più o meno consapevole e maturo – di qualcosa in più del semplice perenne sovrapporsi, e indica semmai il collasso delle distinzioni medesime.
DV: In quanto al Novo Sconcertante Italico – seppure io non senta necessariamente il bisogno di una categorizzazione – trovo molto interessante la posizione di chi come Vanni Santoni postula una mancanza di corrispondenza precisa tra il new weird anglosassone e lo “strano continentale”, e parla di “nuovi metafisici” o “post-kafkiani” orientando gli sguardi ad est, a Cărtărescu, Gospodinov e Tokarczuk, tra gli altri; a me sono molto care le dimensioni allucinatorie e oniriche e mi sento di guardare ancora più ad est, per esempio a Bulgakov o addirittura a Murakami. Autori che mi hanno insegnato l’ibridazione, la fusione e la rarefazione.
I generi sono porte e soglie, non gabbie, e in arte chiunque tracci un confine dovrebbe farlo solo per suscitare il desiderio di varcarlo, anzitutto in sé stesso.
L’annuncio di questo libro è stato accolto con altrettanto “sconcerto” e dibattito, a partire dall’accusa di riappropriazione di temi e immaginari che altre esperienze editoriali coltivano invece da decenni. Mi sembra però che Francesca Matteoni abbia colto un punto cruciale quando ha scritto in un suo intervento: “la cosa che più conta sono le storie, e la possibilità di portare avanti certe narrazioni”. Immagino che questa antologia voglia essere un congegno immaginativo fatto piombare nel grande mercato editoriale più che un progetto esaustivo ed esclusivo…
DV: Assolutamente, un’operazione come questa è per definizione particolare e non ha nessuna pretesa di esaustività: sono molti quelli che scrivono di strano o in modo strano, e lo fanno bene e da tempo, specialmente nel sottobosco di riviste e piccoli editori ma anche a livello più mainstream. Vorrei però ricordare che prima di diventare un’antologia Bompiani questo ciclo è nato su Nazione Indiana (grazie al maternage proprio di Francesca Matteoni) e si è nutrito per mesi di contributi di autori che partecipavano a titolo assolutamente gratuito e senza nessuna garanzia di sfociare in una pubblicazione – in maniera quindi strutturalmente “indipendente” o “underground”. Questo progetto è nato come cantiere aperto e continua a esserlo sia a contaminazioni letterarie che extra-letterarie. È inoltre un tributo alla storia dell’editoria italiana degli ultimi anni; noi siamo molto fieri del fatto che ci siano sia autori affermati dell’editoria mainstream sia autori della piccola e media editoria che sono stati pionieristici nel loro campo. È infine anche un’operazione transgenerazionale, ne contiene ben tre, con le loro differenze, analogie, ossessioni e idiosincrasie. L’inclusività è una condizione che è stata presente dal giorno zero di questo progetto, noi non siamo padroni di niente se non della nostra fame di scrivere e leggere. Abbiamo accolto scritture molto diverse dalle nostre – che pure sono divergenti tra di loro – e lo abbiamo fatto con gioia, nell’ottica di creare un caleidoscopio più sfaccettato che ci portasse a guardare dove da soli non avremmo guardato. Nel bene e nel male non vogliamo essere alfieri di nulla, ma solo tra i testimoni che la guerra tra realistico e fantastico è forse già conclusa. E in tal caso non potremmo che esserne felici.
ER: Non avevamo né abbiamo la pretesa di definire o appropriarci di alcunché, ma di intercettare a modo nostro e valorizzare un campo di energia, un fermento e delle tensioni che sentiamo per primi stimolanti. Il nostro libro prende il suo titolo anche dalle parole del mago Gandalf sul ponte di Moria: “Io sono il servitore del Fuoco Segreto”. Crediamo che sia un definizione in cui si possa e debba riconoscere chiunque provi a fare narrativa e cultura, il servizio a una vastità che ci supera sempre. Anche per questo il nostro libro vuole essere una soglia dalla quale noi per primi desideriamo muoverci per intercettare e dialogare con altri tentativi e operazioni, altre prospettive sul medesimo nodo. E in Italia ce ne sono tante, talvolta eccellenti, più o meno note, talvolta troppo poco valorizzate.
Vanni Santoni, uno degli autori presenti nel libro, sostiene che lo “strano” attraversa la nostra letteratura da sempre. Prima accennavo ai predecessori eretici dello sconcerto, a quelli che, circondati dall’apparente dominio del realismo o della cronaca, hanno scelto comunque di fare, citando nuovamente Cristina Campo, “una professione di incredulità nell’onnipotenza del visibile”. Chi sono, per voi, le antenate e i custodi di questo vostro lavoro?
ER: La questione è difficile, i fenomeni anche letterari spesso si possono più cogliere come sintomi, risalendo con parzialità alle cause, e la “tradizione”, come insegna Mircea Eliade, è sempre inventata a posteriori. La letteratura italiana è certamente nata con un’esperienza sconcertante, un monstrum ammirabile e spiazzante come la Commedia di Dante, di cui non si ricorda mai abbastanza l’audacia. Un esperimento che fonde con sperimentalismo inconcepibile prima stili e generi, dall’incipit fiabesco e iniziatico alle questioni scientifiche, dalla mistica alla ricostruzione proustiana del tempo e degli affetti, dal Minotauro alle visionarietà psichedeliche, diceva già Zanzotto, della Candida Rosa. A questa impressionante commistione di generi e linguaggi seguirà l’opzione petrarchesca, canonizzata poi da Bembo. Un simile primato della lirica e della perfezione stilistica, per quanto rilevante, è stato spesso troppo enfatizzato, giacché la letteratura italiana ha sempre compreso il fantastico e il bizzarro, spesso con opere e addirittura stagioni di assoluta preminenza, basti pensare alla lunga “primavera arturiana” dei poemi cavallereschi che comprendono le farse di Pulci e la drammatica serietà di Tasso, ma resta valida la vulgata per cui le due grandi opzioni, realistico e fantastico, sono rimaste per molti aspetti due tondelliane camere separate. Già nell’Ottocento, mentre il “nostro” romantico Manzoni si opponeva decisamente al “guazzabuglio” delle fascinazioni per il mostruoso e “l’abiura in termini del senso comune”, Baudelaire fiutava però che il grottesco e la contaminazione sarebbero stati il marchio di quanto sarebbe seguito nell’arte e nel pensiero. Il Novecento ha progressivamente messo in discussione tante vecchie contrapposizioni, anche per la progressiva influenza di diverse correnti: la mitopoiesi – ancora platonica, cristiana e tardo-romantica – di scrittori e teorici come Tolkien e Lewis, il Weird orrorifico di matrice marcatamente lovecraftiana (ateo e materialista) che arriva fino a Ligotti o Vandermeer o pensatori come Fisher e, in Europa, i grandi padri della contemporaneità come Kafka e Freud. Il Novecento si apre con gli occhi sbarrati dello stesso Kafka, con la sua vibrazione che – come diceva Calasso – ricorda quella di chi soffre di deprivazione del sonno, e non distingue più tra realtà concreta e simbolo soggiacente.
DV: Molti sono già stati citati e ce ne sarebbero innumerevoli altri, a livello di ossatura base però forse sarebbero sufficienti Dante, Omero e Shakespeare a contenere tutto il catalogo dei destini possibili e impossibili. Invece tre nomi recenti di una costellazione molto vasta per me sono: Campo, Ishiguro e Houellebecq.
La rivoluzione digitale della rete ha ulteriormente fatto collassare le distinzioni tra ambienti e linguaggi, tra “alto” e “basso”, qualunque cosa vogliano dire.
È ancora così opprimente il dominio della cronaca nell’attuale panorama editoriale?
ER: Negli ultimi 20-30 anni, per una serie di motivi, alcuni dei quali difficili da indagare perché stanno tuttora accadendo e sono legati a una vasta rivoluzione antropologica, ci si trova esposti alla sensazione che la realtà sia diventata completamente pazza, o saggia d’una saggezza per cui gli strumenti e l’opposizione di due modelli narrativi come realistico e fantastico perdono la loro ragione d’essere, anche nella fecondità della loro antica dialettica. Non bisogna poi dimenticare che tanti scrittori di nuove generazioni sono letteralmente cresciuti nutrendosi con una multiformità di fonti e suggestioni e riferimenti, dovute anche alla Rete come quarta dimensione dell’esistente. La rivoluzione digitale della rete ha ulteriormente fatto collassare le distinzioni tra ambienti e linguaggi, tra “alto” e “basso”, qualunque cosa vogliano dire. È interessante notare, così di sfuggita, che persino il processo di passaggio dal mito alla linearità romanzesca e dal politeismo al monoteismo (all’ateismo) vengono oggi rimessi in discussione, quasi di pari passo: l’emergere delle varianti rispetto al processo di razionalizzazione d’una singola vicenda, da A a B, le tempeste di possibilità alternative dei destini, i multiversi, gli stati di coscienza ampliati dagli esperimenti lisergici, le intelligenze artificiali sono tutte esperienze e soglie che per essere raccontate in forma narrativa richiedono un’ibridazione e una contaminazione per cui le vecchie contrapposizioni hanno bisogno di collassare.
Prendersi cura di una storia implica anche saperne vegliare il destino, intrecciarla con altre in un canto plurale capace di non unificare le diverse voci. Qual è il principio che ha mosso la vostra curatela?
DV: Senza dubbio si tratta di una curatela non tradizionale, anzi direi “invertita” perché non è partita dall’alto con il potere intrinseco di evocare altre voci ma è emersa dal basso, da un crepaccio in cui le note di due scritture singole hanno stabilito la tonalità e iniziato a suonare un accordo preliminare a cui poi si sono armonizzati gli altri autori dandoci fiducia. Come dicevamo, questo progetto è cresciuto per un anno sulle pagine di Nazione Indiana ben prima di avere il supporto di Bompiani, che alla conclusione del ciclo ha sposato la causa – comprendente tutti gli autori già pubblicati – e ci ha permesso di espanderla a cerchi concentrici, richiamando alcuni altri autori che ci interessavano o incuriosivano. Il disegno complessivo delle storie è volutamente disarmonico, non abbiamo voluto carteggiare i vari testi perché si inserissero in un nostro schematismo previo, ma semplicemente dare il proverbiale “La” e osservare come a partire dal bicordo dissonante delle nostre due scritture ogni autore chiudesse la progressione armonica in maniera personalissima, di cui non ci riteniamo direttamente responsabili ma che abbiamo deciso di impugnare – parafrasando Shakespeare – come un sortilegio del mare che trasformi in qualcosa di ricco e strano.
ER: Ci siamo mossi in modo assolutamente e deliberatamente centrifugo. Come già accennavo, siamo partiti dalla nostra, di scrittura, dai nostri scambi, interessi condivisi, dagli orizzonti immaginativi messi in comune, dalle nostre urgenze, dalle sfide e contaminazioni che ci interessavano e interessano. Non siamo andati previamente in cerca delle firme migliori del “weird”, ma abbiamo voluto coinvolgere nomi e personalità in una provocazione che per prima cosa e anzitutto interroga noi stessi. Ci incuriosiva come sullo “sconcertante” avrebbero risposto non solo Vanni Santoni e Loredana Lipperini – che sulle sfide dell’immaginario scrivono da tempo con contributi importanti – ma anche una studiosa delle questioni di genere come Carla Fronteddu, o un narratore ironico e minimalista come Gabriele Merlini. Proprio per questo sarebbe ridicolo e presuntuoso accampare qualsivoglia pretesa canonizzatrice o delimitatrice. Abbiamo voluto gettarci in acque ben più vaste di noi, contribuire a smuoverle, ma non a circoscrivere un lago che finirebbe così solo per stagnare. Siamo molto fieri del prisma complessivo, delle sfaccettature che offre e delle gemme che comprende, come il racconto di Andrea Zandomeneghi che significativamente apre la raccolta, subito dopo alcuni versi di Nina Cassian posti in esergo, e anche questo è significativo.
Un’altra domanda che ritengo importante porvi, perché permette di raccontare i processi di contaminazione dall’interno, è proprio quella che vi chiama in causa come scrittori: dal momento che anche voi siete presenti nel libro, cosa ha innescato i vostri racconti, come avete lavorato per primi sullo sconfinamento?
DV: Per quanto mi riguarda non c’è cosa più sconcertante della musica. Per parafrasare Thomas Mann, sconcertante è la violenta dissonanza, sonorità aspra, simile a un sigillo magico, che crea relazioni tra suoni e tonalità lontanissimi. Sconcertante e impossibile è il diritto di disporre di tutte le combinazioni tonali che siano mai state usate. Impossibile è l’accordo di settima diminuita, impossibili certi passaggi cromatici. Così nasce quel “canone delle cose proibite” che anche in letteratura è la cosa che mi interessa di più. Rovesciando quello che dice Adrian Leverkühn: “Non ho voluto scrivere una sonata, ma un romanzo”. Anche io – a un certo livello – ho tentato di scrivere non un racconto ma una canzone. E per la mia scrittura ambisco (spesso fallendo) ad una specie di “prosa musicale” – stilisticamente ancor prima che contenutisticamente – che sia calcolo elevato a mistero.
ER: Per quanto riguarda la specificità della mia scrittura, e dello sguardo sotteso, ci tengo sempre a dire che lo sconfinamento è una sfida che è sempre stata inevitabilmente presente e attiva anche in altri linguaggi espressivi, come la critica e soprattutto la traduzione. Come potrebbe essere altrimenti? Ogni traduzione è anzitutto un tradimento, nel senso originario di consegna, trasferimento. In tutto questo la fusione e sovrapposizione e la contaminazione sono essenziali. Lovecraft mi è servito per tradurre Martin al pari di Dino Compagni, e per tradurre R.K. Morgan ho avuto bisogno di Ellroy, Plath, i Counterparts. Questo si è declinato anche nella mia narrativa, come un tentativo sempre più manifesto, con tributi che vanno da Bernanos a Siti a Marlon James.
La letteratura è un metodo di conoscenza proprio perché non è riducibile a qualsivoglia manuale d’istruzione o a una diagnosi, resta sempre una dinamica che si vive e non si spiega.
A proposito di poesia: proprio in questi giorni è in uscita per il Saggiatore Poesie dell’Italia contemporanea, a cura di Tommaso di Dio. Un’opera che, esattamente come la vostra, farà certamente discutere, poiché è concepita, più che come un’antologia, come un’epica dell’immaginazione poetica, una grande narrazione che, partendo soprattutto dai testi, raccoglie cinquant’anni di scritture senza pacificarle, senza dettare uno stile comune (nemmeno nella rivolta), facendo incontrare poetiche sino a questo momento raramente avvicinate. Questa uscita parallela alla vostra mi sembra il segnale di un comune fermento. Mi viene però da ribadire che, prima ancora del weird come categoria, la poesia è sempre stata consapevole che lo sconcerto, l’invenzione ambigua, la costruzione di parentele tra lontananze apparentemente inavvicinabili non sono soltanto temi, ma proprio i meccanismi essenziali dell’intero processo poetico. Quanto la poesia è ancora di riferimento per voi, e per le voci raccolte in questo libro?
DV: La poesia è bussola indispensabile per ogni mio tentativo narrativo e mi trasporta a un livello della nostra esistenza dove certe contrapposizioni e domande nemmeno si pongono. In poesia non è più immaginifico Federico García Lorca di John Ashbery (poeti diversissimi ma che mi commuovono con uguale intensità e che ho esplicitamente citato in una nota alla fine del mio racconto), così come non sono più fantastici gli “occhiali bicicletta” di Majakovskij rispetto alle “statue sordomute” di Kavafis, i “volti silvani” di D’Annunzio rispetto alle “note inspiegabili” di Ritsos, le “prigioni di pioggia” di Baudelaire rispetto alle “mani unite che diventano archi gotici” di Cristina Campo o ai “mesi crudeli” di Eliot. L’augurio è che per chiunque scriva, la tensione espressiva possa essere libera e imprevedibile come quella della poesia, che non deleghi mai la meraviglia alla trama ma sempre e anzitutto al bagliore dello stile, esposto ai venti dentro e fuori di noi che premono sull’esperienza da ogni direzione.
ER: Sono profondamente d’accordo con Valentini. La poesia è sempre stata e resta per me il luogo primario e fondamentale di ogni sconfinamento e ibridazione, un punto di partenza e approdo per altri linguaggi, dalla critica alla narrativa. Anche certe pagine di George Steiner o Littell o Pasternak o Cortázar conducono nello stesso spazio che si apre in noi leggendo Logue, Rilke o Sexton, solo per citare alcuni dei nomi che amo di più. Siamo condotti a quella voce che, nelle parole di Mario Luzi, dà sempre l’impressione di riprendere a parlare esattamente “in quel punto”. Qual è questo punto? Provare a nominarlo è sempre un errore. Il Dio che si cerca di scorgere al lume di lampada se ne vola subito via, mentre al buio possiamo abbracciarlo.
Nel 1991, Bruno Latour scriveva, in alcune righe fondamentali di Non siamo mai stati moderni: “Quante lacrime si sono versate sul disincanto del mondo! […] Eppure non abbiamo mai smesso di costruire i nostri collettivi con i materiali frammisti di poveri umani e di umili nonumani. Come potremmo essere capaci di disincantare il mondo mentre i nostri laboratori e le nostre fabbriche lo riempiono ogni giorno di centinaia di ibridi più bizzarri di quelli del giorno prima? Come potremmo essere congelati dal freddo respiro delle scienze, quando queste invece sono calde e fragili, umane e controverse, piene di reti pensanti e di soggetti anche loro popolati da cose?”. Giocando con Latour, potremmo dire allora che non abbiamo mai smesso di essere sconcertanti, di attraversare il weird non soltanto come categoria letteraria, ma come processo del vivere, universo di incastri e di mescolamenti, da comprendere e rilanciare verso il futuro?
ER: Per rispondere dall’unica prospettiva che sento aderente e che non scada nel tentativo di proiettare alcuna geometria sull’universo (parlando dello sconcertante e del weird, poi, c’è chi è stato mutato in albero per molto meno), sono anzitutto propenso a citare l’autorità del Professor Tolkien che, chiamato a “spiegare” il suo immaginario, dichiarava: “Io non predico né insegno nulla”. Mantra salutare, del quale è bene ricordarsi sempre. La letteratura è un metodo di conoscenza proprio perché non è riducibile a qualsivoglia manuale d’istruzione o a una diagnosi, resta sempre una dinamica che si vive e non si spiega. Uno specchio, o meglio ancora una finestra, nella quale i tratti del nostro volto si confondono “come per vetri trasparenti e tersi” col paesaggio più innanzi. In questa accezione sì, constatava Verga, “il semplice fatto umano farà pensare sempre” chi cerca di misurarsi con l’arte e in questo senso è vero che oggi le rivoluzioni antropologiche, scientifiche, sociali del nostro tempo palesano spesso con deragliamenti e scossoni interrogativi che mettono in crisi profonda categorie e opposizioni, dentro e fuori di noi, spesso date o imposte come scontate. Tutto questo “fa pensare”, appunto, e pone degli interrogativi per raccontare i nostri passi nel mondo che sono stati ben sintetizzati a mio giudizio da Calasso proprio ne L’Innominabile attuale: “La disponibilità e l’accessibilità di tutte le credenze del passato è appunto uno dei caratteri dell’èra che una volta chiamavo post-storica. Ma, se si esclude quella via inevitabilmente parodistica, quale altra possibilità rimane? Dovrà il soggetto secolare appagarsi della cancellazione dell’invisibile, che ormai è diventata il presupposto della vita comune? È questo lo spartiacque. Se l’essenziale non è il credere ma il conoscere, come presuppone ogni gnosi, si tratterà di aprirsi una via nell’oscurità, usando ogni mezzo, in una sorta di incessante bricolage della conoscenza, senza avere alcuna certezza su un punto d’inizio e senza neppure figurarsi un punto d’arrivo”. Anche per questo, credo, molti pure nelle arti avvertono la necessità di risalire non solo alla cecità visionaria di Omero, padre di ogni tragedia e commedia, epica e avventura fantastica, ma anche alla veggenza di Tiresia, conquistata essendo uomo e donna. Che è una immagine sempre efficace di ogni autentica esperienza artistica, dei suoi tentativi, e dei nostri passi incerti nel buio.
DV: È certo che la realtà – come diceva David Foster Wallace – non è più quella di Tolstoj; e forse non lo è mai stata, come ci insegnano i ragni enormi appostati nelle stanze degli amanti di Dostoevskij e che noi abbiamo apposto significativamente in conclusione al nostro libro. In più, oggi la realtà è sottoposta a un tal numero di innesti, sedimentazioni, iniziezioni, centrifughe e bombardamenti, che probabilmente non solo non abbiamo mai smesso di essere sconcertanti (per noi stessi e per gli altri) ma forse nel futuro lo saremo sempre di più.