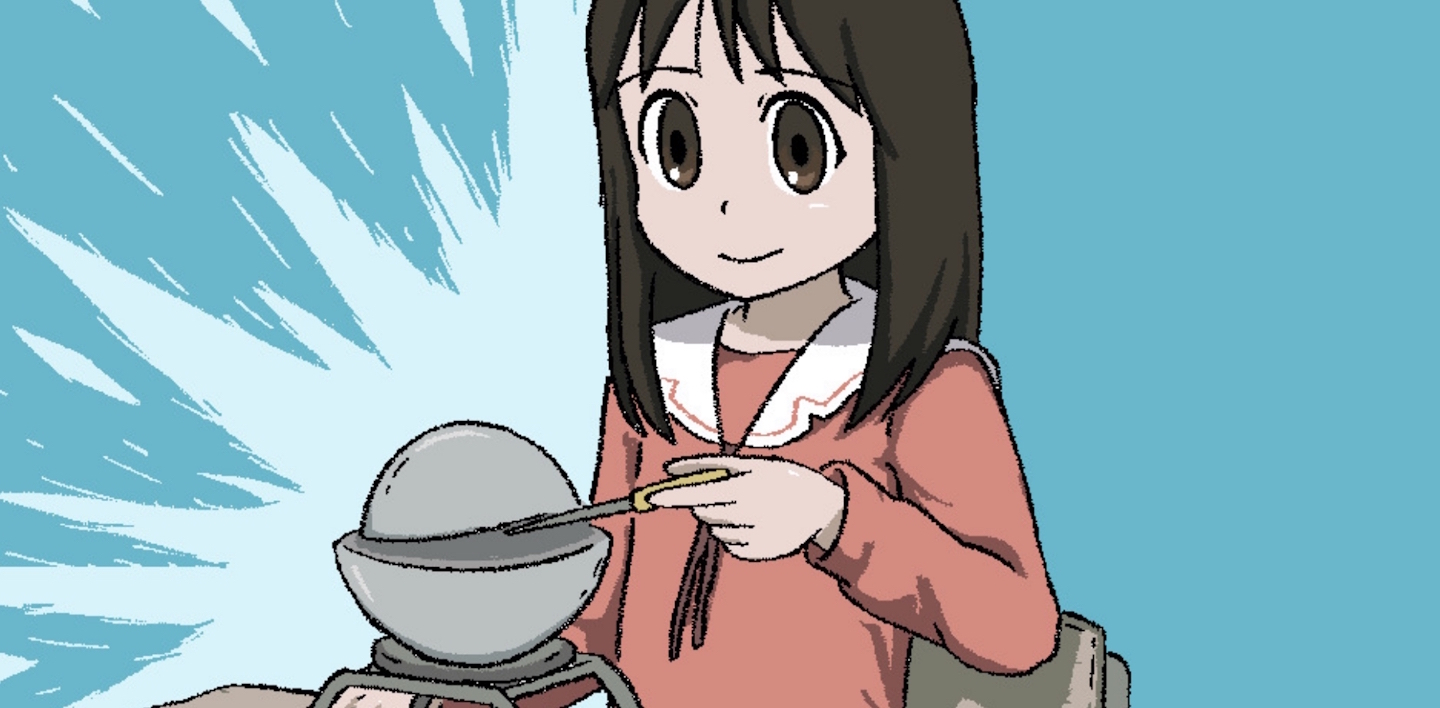
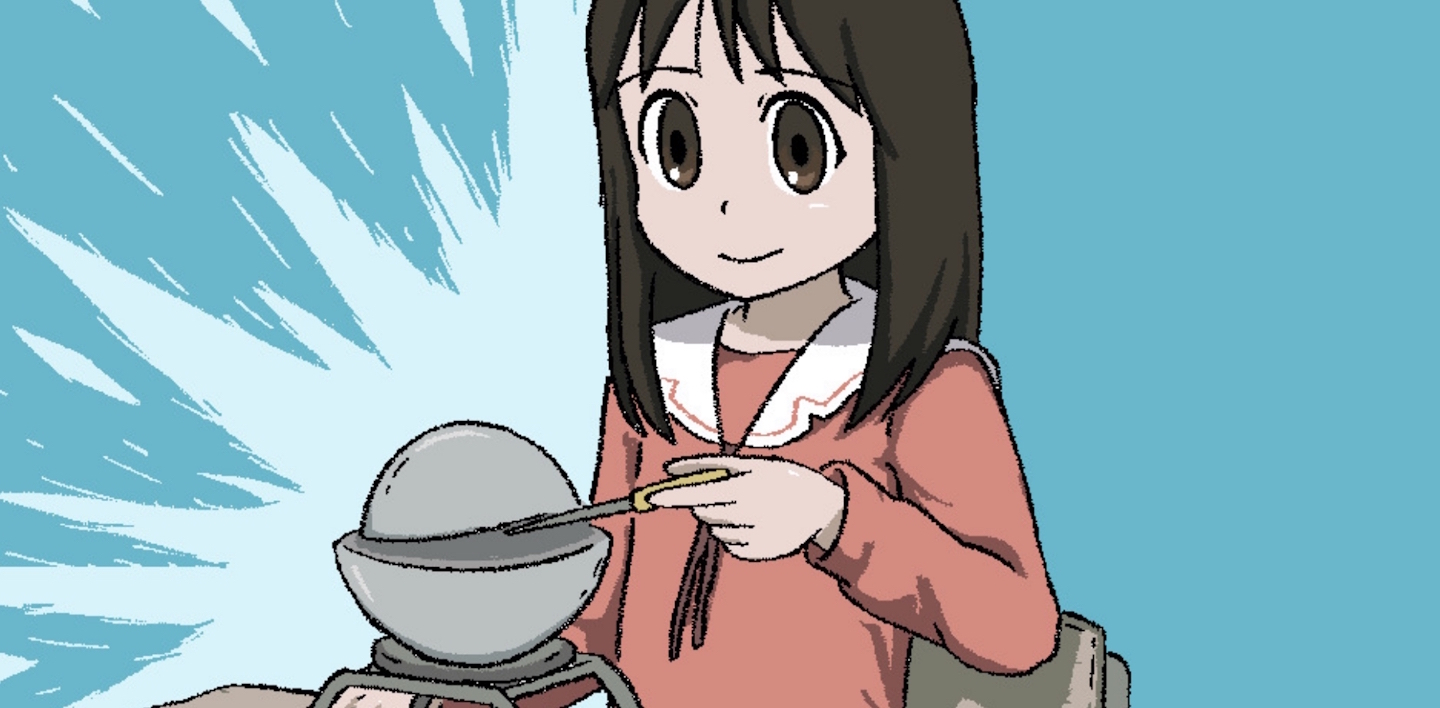
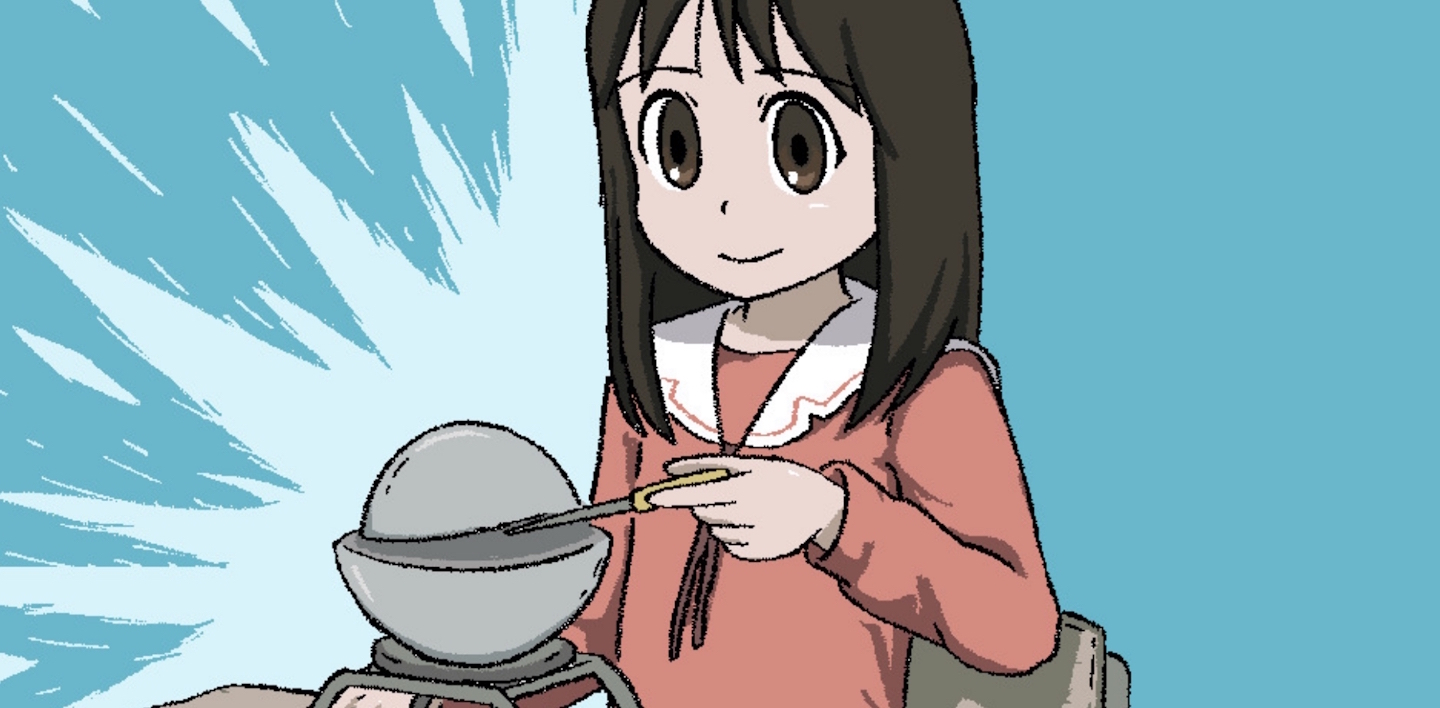
S correndo il pollice in su, lungo lo schermo del telefono, incontriamo di anno in anno più resistenza. Estraiamo contenuti social dal basso, li osserviamo brevemente, e poi li scartiamo verso l’alto.
Nel corso del tempo il gesto è rimasto lo stesso, ma sono aumentate le energie emotive e mentali necessarie ad avanzare nel feed. Scaviamo attraverso strati di materiali che ci riempiono d’inquietudine. Gas mefitici si liberano dalle sacche sotterranee in cui erano compressi. Temiamo che il fondo ceda e un abisso ci inghiotta.
I contenuti social sono davvero diventati più pesanti e difficili da maneggiare: persino le piattaforme un tempo considerate “frivole” traboccano ormai di aggiornamenti e testimonianze strazianti da crisi locali e globali. Anche la pressione interna è cresciuta: i confronti online sono diventati più aspri, i giudizi incrociati più taglienti; per ottenere maggiore visibilità, conviene trattare da nemico chiunque non abbia la nostra stessa posizione in un dibattito, ma anche chi mostri incertezza sulla posizione da adottare o chi verso quell’incertezza esprima comprensione. Il periodo storico fa la sua parte – ci offre scenari preoccupanti tra catastrofi naturali, orrori artificiali e tensioni sociali – ma la fatica e l’angoscia che proviamo mentre ci facciamo strada nel pozzo dipendono dalle abitudini collettive di consumo mediatico.
La sensazione di assistere, tramite i feed social, a un’apocalisse permanente, che non possiamo materialmente impedire e dalla quale non possiamo moralmente distogliere lo sguardo, è abbastanza diffusa da aver fatto emergere nel 2020 un neologismo per descriverla: doomscrolling. Idea suggestiva, lo “scrolling apocalittico”, e tuttavia autoassolutoria, perché si concentra solo sul nostro ruolo passivo, spettatoriale, mentre è attivo il nostro contributo al sovraccarico di contenuti deprimenti. Vale senz’altro per chi ne pubblica o ne condivide, ma vale anche per chi interagisce con essi o si sofferma a osservarli per più di qualche secondo: basta questo per segnalare all’algoritmo che persone con interessi compatibili coi nostri potrebbero volerli vedere e che noi stessi desideriamo vederne ancora.
La fatica e l’angoscia che proviamo mentre ci facciamo strada nel pozzo dei contenuti online dipendono dalle abitudini collettive di consumo mediatico.
Ci avvitiamo così in un circolo vizioso che produce, per ogni catastrofe, un danno collaterale a mezzo social sull’umore (se non addirittura sulla salute mentale) di persone a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Non è in discussione quale sia il problema prioritario: per quanto una persona possa essere turbata dalla crudezza e dall’insistenza dei resoconti di una tragedia, il danno che subisce è presumibilmente inferiore ai benefici che la diffusione di quei resoconti può procurare alle persone colpite dalla tragedia stessa. D’altra parte, se l’informazione può essere utile a qualcuno, l’angoscia non lo è per nessuno, quindi dovremmo potercene liberare.
Cos’è che invece ci costringe a indugiare davanti allo schermo del telefono o del computer tanto a lungo da soffrirne? Forse abbiamo sviluppato una perversa dipendenza dalle cattive notizie; forse proviamo un disgusto per le abbuffate di contenuti social che in realtà non dipende dalla loro natura; o forse siamo vittime di una suggestione collettiva orchestrata da giornalisti e sociologi? Visto che nessuna di queste ipotesi suona convincente, conviene cercare una risposta altrove, nel groviglio tecnologico e psicologico che ci tiene legati alle piattaforme.
L’illusione del controllo
Con ogni accesso a Instagram, TikTok, Facebook o Twitter, per quanto in apparenza annoiato o meramente compulsivo, tentiamo di appagare una certa esigenza. Online possiamo aspettarci di incontrare persone che si esprimono o comportano in modi a noi congeniali, notizie buffe e contenuti gradevoli, ma sappiamo che troveremo anche persone antipatiche o aggressive, notizie che ci metteranno a disagio, opinioni che ci irriteranno. Ci spinge ad accedere (e poi a scrollare fino a sera) la percezione che davanti a tutto questo potremo avere un ruolo attivo. Con ogni gesto – like, commenti, condivisioni e persino sdegnosi silenzi – ribadiremo la nostra posizione di preminenza rispetto a ciò che ci scorre davanti: saremo giudici e forse anche qualcosa in più, una forma di vita intermedia tra Dio e Marie Kondo, perché troveremo il caos e gli imporremo un ordine.
Sulle piattaforme siamo efficaci; dimostriamo continuamente di esistere. Fuori, questa illusione di controllo non ce la dà nessuno: il caos rimane caos. Lontano dagli schermi, bloccare una persona fastidiosa resta un sogno; quantificare il pubblico gradimento di ciò che diciamo, un miraggio. I libri, i film e la musica ci ignorano; i contenuti social invece ci riconoscono una potenza e ci interpellano. Ci invitano a esprimerci, a farci notare, a interagire con altre persone.
Ci spinge a scrollare fino a sera la percezione che davanti a tutto questo potremo avere un ruolo attivo. Fuori, questa illusione di controllo non ce la dà nessuno.
Negli ultimi quindici anni, più o meno, abbiamo preso l’abitudine di frequentare ambienti online dove avevamo la sensazione di riguadagnare l’ultima parola sulla complessità della vita – anche solo per qualche decina di minuti al giorno, come entro i confini di un gioco. Non a caso si è molto parlato, nella seconda metà degli anni Dieci, di gamification, un neologismo inglese che indica l’utilizzo di meccanismi propri del gioco (punteggi, livelli, classifiche) per la progettazione di contesti non ludici. Le piattaforme social, nate come semplici reti di condivisione e scambio, hanno progressivamente elaborato un sistema di premi che ci mette in competizione per avere visibilità e riconoscimento. Ci hanno preso in una trappola, si può dire; fino a un certo punto, però, era ancora una trappola piacevole.
Poi, soprattutto dallo scoppio della pandemia di Covid, i nostri feed hanno iniziato a riversarci addosso più caos e turbamenti di quanti avremmo mai potuto pensare di gestirne. Entriamo sui social per sfuggire alle catastrofi del mondo di fuori, e invece le ritroviamo lì dentro concentrate e amplificate. Sprofondiamo nel doomscrolling.
Non ci rassegniamo però alla passività: per reagire al senso di morte, cioè per scansarlo o trasformarlo, mettiamo in pratica dei complessi rituali collettivi di elaborazione. Ricorriamo spontaneamente agli strumenti e alle forme che negli anni abbiamo imparato a usare online. A seconda delle proprie inclinazioni e dei propri riferimenti culturali (esterni e interni ai social), ogni utente attivo troverà uno o più modi per segnalare come sta vivendo il Grande Evento In Corso. Aggiungerà un filtro con una bandiera alla propria immagine del profilo, o un’emoji dopo il proprio nome. Inizierà a seguire personaggi nuovi, che ritiene esperti degni di ascolto o pericolosi avvelenatori di pozzi da tenere d’occhio. Rivolgerà domande ai propri contatti per stimolare la discussione e sentirsi un punto di riferimento all’interno della propria cerchia. Rilancerà appelli, vignette satiriche, debunking di notizie false e di notizie vere, commenti caustici, deliri senza capo né coda. In generale, prenderà una posizione (talvolta attraverso il plateale rifiuto di ogni presa di posizione) e risponderà alle prese di posizione altrui.
Finita questa piccola apocalisse locale, con il suo ciclo canonico di attenzione-sovraesposizione-noia-repulsione, saremo pronti a passare alla prossima, sempre attivi e reattivi nella nostra passività. Ma davvero non c’è scampo a questa condanna? Davvero l’unico modo per recuperare una percezione meno disastrosa dell’attualità sarebbe girare lo sguardo altrove?
Memare nella tragedia
Tra le forme di espressione social, la più tipica sono i meme. Nelle piattaforme, i meme hanno trovato un habitat ideale dove proliferare e rinnovarsi, riscontrando un successo tale da tracimare anche nelle comunicazioni private e offline. Persone di ogni età e percorso di vita hanno iniziato a usarli per ridere, raccontarsi, far valere le proprie idee e, per l’appunto, reagire ai vapori dell’apocalisse che ciclicamente saturano i social. Negli anni si è consolidata una gamma di strutture memetiche pertinenti in vario modo alle catastrofi, ed è interessante analizzarne alcune perché racchiudono in sé approcci diversi al disagio dell’attualità; in qualche caso, forse, offrono anche una forma di elaborazione dell’apocalisse in grado di non alimentare il circolo vizioso del doomscrolling.
Entriamo sui social per sfuggire alle catastrofi del mondo di fuori, e invece le ritroviamo lì dentro concentrate e amplificate.
Molti dei meme che emergono in relazione a sconvolgimenti collettivi affermano una posizione politica o ne ridicolizzano un’altra, in forme più o meno esplicite. Realizzarli, condividerli o commentarli sono ormai modi legittimi di partecipare al dibattito pubblico; al tempo stesso, però, sono modi (magari involontari) di prendere una distanza emotiva dall’orrore ineffabile delle tragedie. Quando additiamo le responsabilità di colpevoli concreti e di astratti sistemi di prevaricazione, convertiamo l’angoscia in rabbia, la direzioniamo e almeno per un momento ci sentiamo meglio. Analogamente, ci sentiamo meglio quando abbiamo una soluzione da proporre. Non è stupido né pavido comportarsi così – stupide o pavide possono essere le specifiche posizioni o proposte – ma questi comportamenti, come vedremo più avanti, non esauriscono tutte le possibilità a disposizione.
Un filone memetico in particolare rappresenta ormai per antonomasia gli scontri dialettici; è stato tanto usato, negli ultimi anni, da diventare a propria volta oggetto di ironie. Contrappone in una vignetta due personaggi ricorrenti: il soyjak, un uomo magrolino pelato con gli occhiali e una barbetta rada, e il chad, un uomo biondo dalla mascella squadrata ricoperta di una barba folta e curata. La versione più diffusa del meme mostra il soyjak in un accesso di rabbia, con la fronte contratta, le lacrime che gli grondano dagli occhi rossi e la bocca aperta, mentre denuncia un qualche problema o accusa il suo interlocutore. Il chad, colto di profilo, ha la bocca chiusa e lo guarda con sicurezza. Non solo il contegno dei due personaggi, ma anche il diverso stile con cui sono disegnati, contribuisce a rendere il chad più gradevole e autorevole del soyjak.
L’uso tipico di questo formato memetico, infatti, prevede di attribuire al soyjak l’opinione del proprio avversario e al chad la propria. Più di preciso, il soyjak di solito accusa il chad di qualcosa che quest’ultimo beatamente si rivendica, rispondendo all’accusa con un semplice “Sì”. Per fare un esempio relativo a un periodo in cui tutto il dibattito pubblico in Italia si disponeva sui due fronti di una singola frattura, nel 2021 saranno probabilmente circolati in contemporanea un meme in cui il soyjak diceva “Gnoooo non puoi obbligarmi a fare il vaccino” e un altro in cui diceva “Gnoooo non puoi rifiutarti di fare il vaccino”; a entrambi, il chad rispondeva “Sì”.
In sostanza, diamo al nostro oppositore del cretino perdente e frignone, mentre ci dipingiamo saldi in sella alle nostre convinzioni. Oltre a liberarci così dal disagio del vero vuoto intorno al quale bisticciamo, ci sentiamo meno soli, perché aggreghiamo il consenso di chi concorda con noi e litighiamo nei commenti con chi dissente – anche questa, una discreta distrazione.
Ottengono un effetto simile i meme che paragonano la gravità delle catastrofi in corso alla meschinità di qualcos’altro. Per esempio, nel novembre 2023 l’account @cursed_cancellations ha postato su Instagram un’immagine divisa in due: nella metà superiore, la didascalia “Gaza:” introduce la foto di due bambini palestinesi davanti alle macerie di quella che forse è stata casa loro, prima di essere bombardata dall’esercito israeliano; nella metà inferiore, invece, la dicitura “Americans:” presenta due locandine. Una annuncia un seminario intitolato “Gioia al tempo dell’apocalisse. Sui limiti [boundaries]. Una conversazione in diretta sui limiti in questi tempi apocalittici”. Indica poi di pagare il biglietto secondo le proprie possibilità, entro un certo range; “Prezzo suggerito: 33$”. L’altra locandina promuove “Il potere curativo della verità. Affrontare la propaganda coloniale. Una lezione virtuale in diretta di 2 ore. Ammissione su offerta. Donazione minima: 35$. Posti limitati”.
Negli anni si sono consolidate strutture memetiche pertinenti in vario modo alle catastrofi che, in qualche caso, offrono una forma di elaborazione dell’apocalisse in grado di non alimentare il circolo vizioso del doomscrolling.
Un inciso: qui si potrebbe pensare che la trasformazione del dolore della tragedia in antagonismo sfoci in un atteggiamento cinico. È un dubbio ricorrente coi meme, che spesso giocano sulla contrapposizione di immaginari distantissimi. C’era bisogno di tirare in ballo le violenze sulla popolazione di Gaza, pur di dare addosso a chi monetizza sulla retorica della cura e sul set di concetti che garantisce di risvegliare in un certo pubblico sensi di colpa o di rivalsa? Per cercare una risposta con un qualche grado di affidabilità possiamo guardare al contesto: l’account ha sì per bersaglio polemico fisso gli episodi di deriva settaria o ipocrita legati alla cultura woke statunitense, ma dai contenuti che condivide è altrettanto chiaro che prende sul serio le vicende palestinesi. Non si direbbe che, nel realizzare il meme, fosse in cerca di una catastrofe qualunque su cui costruire una sproporzione comica; al contrario, suggerisce che la nostra attenzione vada convogliata sul luogo di un’apocalisse vera e propria, piuttosto che sulla ricerca di “Gioia al tempo dell’apocalisse”.
Caso ancor più emblematico è quello di un filone di meme che torna a circolare ogni volta che scoppia una nuova crisi di un qualche rilievo. Mostra il pianeta Terra mentre viene squarciato da una colossale esplosione interna, che lo spacca a metà e ne proietta i frammenti nello spazio. Il testo in sovrimpressione recita “Oh cazzo, sarà una botta terribile per l’economia”, ma può variare a seconda delle contingenze: un altro esempio celebre è “Oh cazzo, ci saranno conseguenze sulla popolazione di trote”.

Obiettivo dell’accostamento è ridicolizzare la piccolezza delle preoccupazioni di chi – politici, editorialisti, altri utenti social – guarda ai punti di PIL o all’orto di casa quando sono in gioco vite umane. Dunque persino l’immagine della catastrofe per eccellenza, la fine del mondo intesa come distruzione fisica del pianeta, da un lato simboleggia la portata propriamente apocalittica di una data tragedia in corso, dall’altro serve per additare una miopia al pubblico ludibrio e per ritrovare un principio orientante nella realtà.
Oscuri presagi
Esistono però anche meme che prendono una strada completamente diversa e che, messi di fronte all’Incontrollabile, non distolgono lo sguardo verso ciò che si può controllare. Non sono neppure “pugni nello stomaco” o pornografia dell’orrore: anziché rappresentare o commentare direttamente i disastri, li evocano concentrandosi sull’istante che li precede. Rifacendosi a un concetto introdotto da Jacques Derrida e ripreso da Mark Fisher, li potremmo chiamare meme hauntologici, perché non esplorano una presenza – fatto che cadrebbe sotto la lente dell’ontologia – ma un’assenza. Un’assenza che, come un fantasma, infesta (haunt, in inglese) scenette altrimenti quotidiane e prive d’interesse.
Il primo filone a cui guarderemo ha per protagonista la cagnolina Kabosu, celebre su Internet come doge. La troviamo ritratta in contesti diversissimi, dislocati ovunque nello spazio e nel tempo: per esempio, davanti a un edificio basso e largo mentre dice “Caspiterina, come sono contenta di andare alla Columbine High School, il 20 aprile 1999”. Oppure, nell’atmosfera retrò di una stanza con la carta da parati ai muri e le tende ricamate: “Che bella giornata qui a Halifax il 6 dicembre 1917, precisamente alle 9:04:35 del mattino (ora locale). Perché da fuori arriva tutto questo chiasso? Meglio che mi affacci alla finestra per dare un’occhiata”. O ancora, con un ciuffone in testa, fotomontata al posto di John Fitzgerald Kennedy sull’auto presidenziale a Dallas: “Caspiterina, come sono contento di essere un Kennedy, spero che non mi succeda mai nulla di male”.

Come sarà ormai chiaro, il meme mostra personaggi noti o ignoti che stanno per essere travolti da eventi storici drammatici. Nei casi citati: la strage della Columbine High School; la più grande esplosione registrata prima delle bombe atomiche sul Giappone; l’omicidio Kennedy. I protagonisti – quasi sempre, in verità, anonime comparse della Storia – sono colti in un momento di totale ingenuità, non presagiscono nulla e non desiderano altro che vivere tranquillamente la propria vita. Siamo noi, piuttosto, a sentire il peso del cattivo presagio: sappiamo che stanno per fare una brutta fine, o quantomeno per assistere a qualcosa che li cambierà per sempre.
Non è un meme che faccia ridere; anzi, può lasciare spiazzati. A differenza della maggior parte dei contenuti che incontriamo sui social, suscita in noi una reazione difficile da nominare. Possiamo provare a circoscriverla facendo un parallelo con certi prequel. Prendiamo per esempio la serie Better Call Saul: uscita dopo Breaking Bad, racconta eventi che cronologicamente la precedono. Su alcuni personaggi di Better Call Saul incombe così la nuvola grave di un futuro che lo spettatore già conosce o intuisce: di alcuni sa che moriranno nel periodo raccontato da Breaking Bad; di altri segue le vicende con una punta di inquietudine proprio perché in Breaking Bad non compaiono, quindi sa che entro la fine di Better Call Saul sono destinati a morire o ad allontanarsi, ma non sa ancora come o perché. Su nessuna scena, questa consapevolezza pesa tanto quanto sulle scene felici, in cui ogni nodo sembra sciolto e l’avvenire appare radioso. Allo stesso modo, nei meme con Kabosu, la malinconia data dal senso di ineluttabilità stride col carattere solare della rappresentazione.
Genera invece qualcosa di più simile alla tensione un altro filone memetico, simile al primo ma relativo a un singolo incidente. Nel 1946, nei laboratori di ricerca sulle armi nucleari a Los Alamos, il fisico Louis Slotin condusse una dozzina di esperimenti davanti a colleghi e altri osservatori senza adottare neppure le più basilari misure di sicurezza. Doveva avvicinare e allontanare le due metà di una sfera di plutonio, evitando che arrivassero a chiudersi; nonostante il rischio elevato, per distanziarle usava un cacciavite. Un giorno, il cacciavite scivolò; per pochi secondi le due semisfere si unirono e una forte dose di radiazioni si liberò nella stanza. Slotin ne assorbì una quantità tale che morì nel giro di nove giorni; gli altri presenti subirono, per quanto fu possibile rilevare, solo malesseri temporanei. Alla sfera di plutonio, che era già stata al centro di un diverso incidente l’anno prima, fu dato il suggestivo soprannome di Demon Core, “nucleo demoniaco”.
Forse per questo o forse per l’assurdità dell’episodio, intorno alle due semisfere metalliche e al cacciavite è sorta una serie di meme. A volte troviamo il Demon Core abbinato a elementi incongrui: per esempio, avvolto nella carta di un ovetto Kinder Sorpresa. Altre, riprodotto fuori contesto: per esempio, disegnato in uno stile da manuale di istruzioni con la didascalia “Fuck around and find out” (equivalente a “Provaci e poi vedi cosa ti succede”). Spesso è tra le mani di un personaggio che lo tiene precariamente aperto con un cacciavite. Può trattarsi di figure reali o di fantasia, talvolta tratte da altri meme in cui avevano già a che fare con oggetti simil-sferici (il boomer con il barbecue da giardino, lo stregone di Pondering my orb, l’immancabile Kabosu, e così via). In un discreto numero di occorrenze, alle prese con il Demon Core incontriamo delle ragazzine disegnate in uno stile da manga, ingenuamente sorridenti o assorte nell’esperimento che stanno conducendo su un banco di scuola. Mentre Kabosu voleva solo vivere la propria vita, e sapere che non potrà la rende ai nostri occhi un’ignara pedina in una tragedia, i personaggi alle prese col Demon Core sfidano il pericolo in piena incoscienza; ecco perché l’impressione, in questo caso, è piuttosto quella di seguire un thriller.
Sull’orlo dell’abisso
Sarebbe difficile sostenere che meme come quelli con Kabosu o col Demon Core siano meditate espressioni di un certo sentimento dei tempi. In molti casi è possibile che vengano realizzati senza altro intento che l’emulazione di meme precedenti o l’autocompiacimento di rievocare episodi storici poco noti. Tuttavia, una componente del loro fascino è proprio nella portata metaforica che mostrano a chi vuole vederla. Un brivido ci corre lungo la schiena, se pensiamo che lo spirito con cui Kabosu affronta la sua giornata è simile a quello con cui affrontiamo le nostre, e che anche noi potremmo finire travolti dalla Storia; o quando immaginiamo che le persone a cui affidiamo le responsabilità più delicate gestiscano i pericoli con la noncuranza con cui apriremmo una lattina di fagioli. Torna in mente l’ipotesi secondo cui la pandemia di Covid-19 sarebbe iniziata con la fuoriuscita del virus da un laboratorio: che sia andata così o meno, fa paura l’idea che eventi del genere siano possibili; la fiducia della società nel progresso scientifico e tecnologico poggia sul preconcetto che in nessun caso la leggerezza (o persino la malvagità) di uno o di pochi esseri umani sia sufficiente per produrre effetti di così vasta portata come quelli che abbiamo sperimentato nel 2020-2021. L’aspetto paradossalmente rassicurante del Dottor Stranamore era che per rischiare la guerra nucleare fosse comunque necessaria una irripetibile tempesta perfetta di follia, meschinità e inettitudine – non un “ops”.
La fiducia della società nel progresso scientifico e tecnologico poggia sul preconcetto che in nessun caso la leggerezza (o persino la malvagità) di uno o di pochi esseri umani sia sufficiente per produrre effetti di così vasta portata.
Anche sui social, come abbiamo detto, cerchiamo l’illusione del controllo. I contenuti che incontriamo e produciamo, presi singolarmente, contribuiscono nella stragrande maggioranza dei casi a mantenere questa illusione viva in noi. Nei periodi critici, tuttavia, l’accumularsi di notizie e commenti nel feed ci getta in una frenesia angosciosa tale da aver reso necessaria una parola apposita – doomscrolling – per descriverla. Mentre gli approcci memetici più diffusi alimentano questo fenomeno, i meme “hauntologici” vanno controcorrente: non insistono sul fattaccio del giorno e ci offrono piuttosto uno specchio in cui indagare, se vogliamo, lo stato d’animo in cui versiamo. I primi reagiscono alla vertigine apocalittica allontanandosi dall’orlo dell’abisso, i secondi indugiandovi con un certo gusto. Qui, il tanto desiderato controllo è sempre a un passo dall’essere perduto, senza reti di salvataggio, senza motivo e senza catarsi. Gli eventi rappresentati sono sottratti alla catena di cause storiche, sociali e psicologiche al cui interno riusciremmo a razionalizzarli, e sono congelati prima di risolversi nella tragedia che ci permetterebbe il “sollievo” di un’onda di rabbia o di tristezza. La sensazione di fine imminente, nei meme hauntologici, è distillata nella sua forma più pura. Farne esperienza ed esaminarla potrà forse aiutarci a riguadagnare un controllo sullo stesso doomscrolling; per ora, stiamo imparando che esporci ai social media senza filtri è come usare un cacciavite per maneggiare del plutonio.
Estratto da Sta arrivando la fine del mondo? (UTET, 2024).