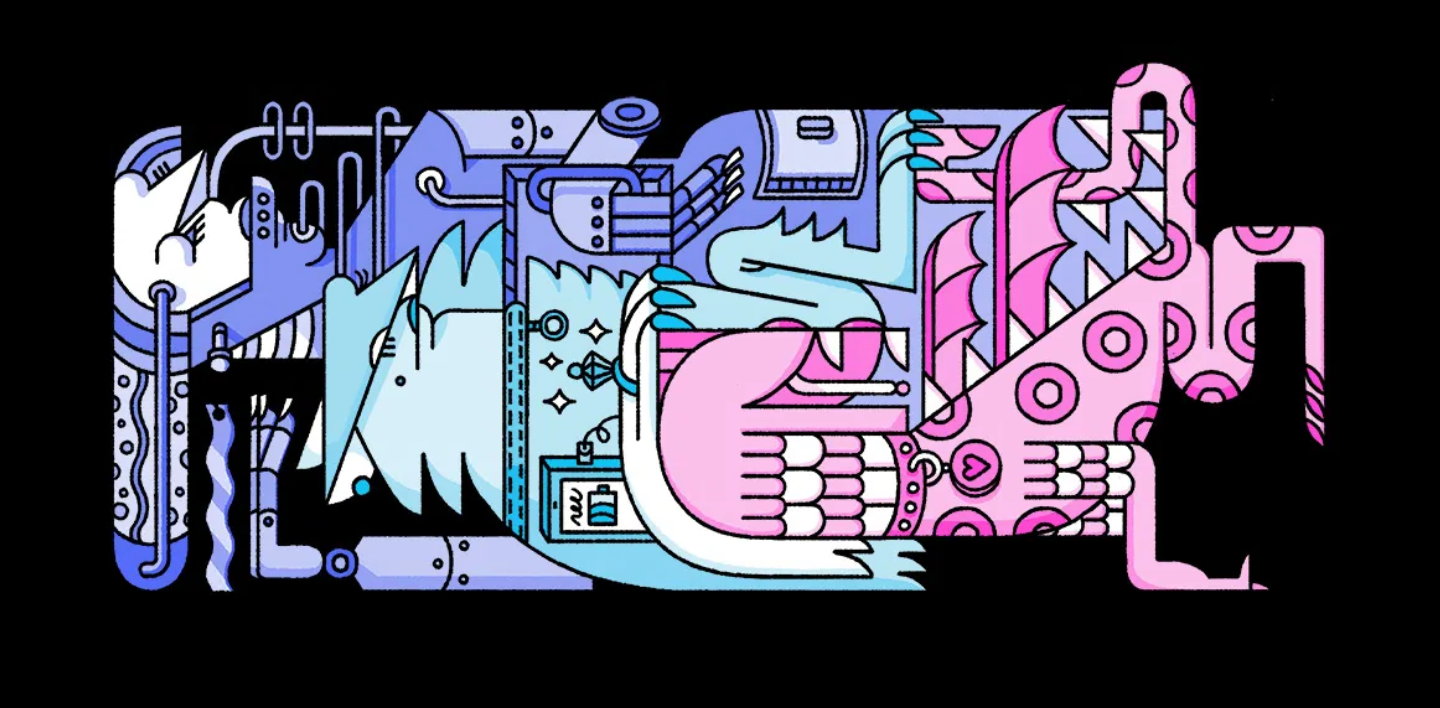
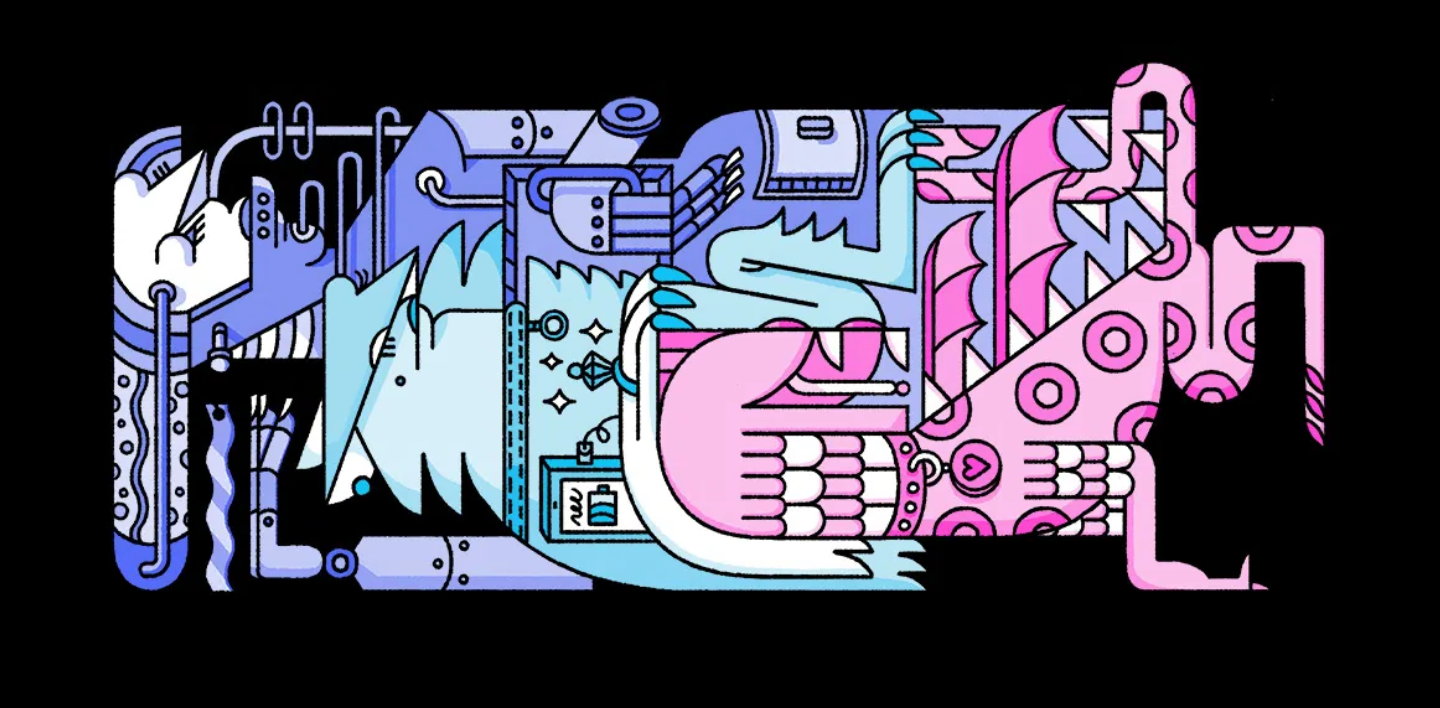
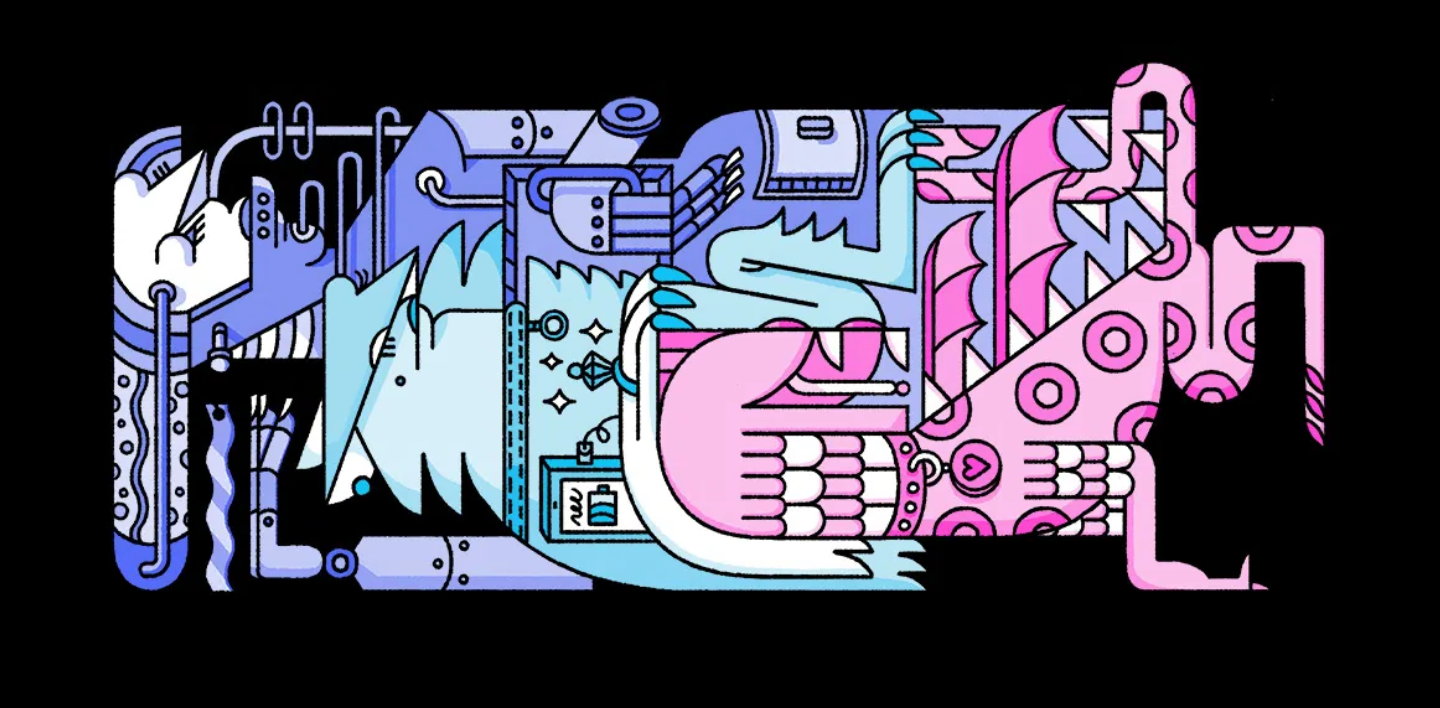
S ecoli dopo l’estinzione umana, o forse millenni (gli esseri umani sono considerati alla stregua di personaggi mitologici) alcuni robot scienziati scoprono l’esistenza della vita organica e cominciano a sperimentare per svilupparla a partire da muschi e licheni. Le loro credenze sono stravolte dalla nuova scienza, la biologia organica, che viene ricevuta da molti come una superstizione, da altri come un pericolo per l’esistenza della vita robotica.
Il mondo inorganico potrebbe essere il risultato di una catastrofe planetaria o di un mutamento climatico, non sembra che i robot ne sappiano molto, non concepiscono (o meglio non concepivano prima di coltivare i licheni) la crescita e l’evoluzione biologica. Probabilmente, come dice il robot scienziato di nome Cecil:
il numero di fabbriche continuò a crescere e la nuvola nera, alimentata dalle loro emanazioni, finì per depositarsi gradualmente nella stratosfera. Bloccando la luce, la nuvola fece abbassare di nuovo la temperatura fino a raggiungere quella attuale. Ogni organismo sopravvissuto fino ad allora finì per estinguersi, probabilmente perché l’acqua nei loro corpi congelò.
Lo sviluppo della vita organica in laboratorio procede tra scoperte elettrizzanti e dubbi abissali: “Quando dici ‘vita inorganica’, fai sembrare come se noi robot fossimo soltanto una delle tante categorie tassonomiche di tutte le forme di vita esistenti”, dice uno di loro. I robot, come gli umani prima di loro, nutrono la convinzione radicata di essere il centro dell’universo ma di fronte agli sviluppi dei nuovi organismi i loro pregiudizi vacillano: “La vita” chiede uno scettico “deve possedere il libero arbitrio, sfruttare l’energia elettrica, avere dei chip ed essere prodotta dalla fabbrica. Quale di questi requisiti soddisfa la tua materia organica?”. Il libero arbitrio non è solo dato per scontato dalle macchine, ma considerato un requisito esclusivo della loro specie.
Esistono resistenze, nella comunità scientifica degli automi, anche di carattere diverso. Ecologiche, per esempio: “Sai cosa dicono tutti? Che il suo laboratorio sia pieno di inquinanti. E sai quanto hanno dovuto lavorare gli scienziati per eliminare l’acqua dalla superficie terrestre? O quanto si siano dovuti impegnare gli ambientalisti per ricoprire la Terra di cemento e per far sì che le fabbriche emettessero una quantità maggiore di polveri, anche se piccola? Quale credi che sia il nostro dovere di scienziati?”. E perfino resistenze di carattere metafisico: “Crede davvero che la materia organica sia viva? Che possieda l’intelletto? Non si vergogna di mettere i robot sullo stesso piano di muffe o simili? Anche loro hanno un’anima? Sono in grado di far progredire una civiltà? Vanno nell’aldilà dopo la morte? Hanno anche un paradiso? Balleremo tutti insieme dopo la morte?”.
Un ribaltamento che ridimensiona e parodizza il modo in cui noi umani vediamo la natura, l’irresistibile specismo a cui forse nessuno sforzo di pensiero saprà mai del tutto sottrarci.
La scrittrice sudcoreana Kim Bo-young, considerata tra le migliori autrici di fantascienza del suo paese e già collaboratrice nella sceneggiatura di Snowpiercer di Bong Joon-ho, un film di fantapolitica accolto da un notevole successo di critica e pubblico, esordisce in Italia con la raccolta L’origine della specie (Add editore, trad. Federica Amodio). Tra Cyberiade di Lem e le Lettere persiane di Montesquieu, il racconto che dà il titolo alla raccolta, quello da cui provengono le citazioni di cui sopra, occupa una buona metà del volume configurandosi come un piccolo romanzo diviso in due parti, la prima all’inizio e la seconda alla fine del libro. Nella seconda parte più che ad Asimov o a Lem si finisce a pensare al Frankenstein di Mary Shelley, a parti invertite: la macchina che sfida dio e genera l’umano.
Il ribaltamento di prospettiva è al centro non soltanto di questo ma di quasi tutti i racconti presenti nella raccolta. Un ribaltamento che ridimensiona e parodizza il modo in cui noi umani vediamo la natura, l’irresistibile specismo a cui forse nessuno sforzo di pensiero saprà mai del tutto sottrarci salvo appunto mutare di specie, abbandonare la nostra matrice biologica e cadere fatalmente in altri generi di miopia conoscitiva. Questo libro ci racconta i possibili sbocchi di un simile “progresso”.
Per esempio mostrandoci la condizione della vita fuori dal corpo, sperduta nei meandri virtuali delle simulazioni digitali, come il personaggio del racconto intitolato “Scripter” che si ostina ad abitare in un metaverso abbandonato per ragioni commerciali. Oppure l’animalizzazione violenta subita dall’uomo in un racconto di ambientazione più fantasy come “L’ultimo lupo”, dove gli umani sono animali domestici in mano ai draghi e dove i primi hanno evoluto in maniere strane e diverse, come i lupi addomesticati e assoggettati da noi uomini sono diventati cani di varie razze. Altro ribaltamento è quello raccontato in “Le stelle brillano nel cielo”, che ci trasporta su un pianeta vicino al centro della nostra galassia molto simile alla terra ma dove c’è sempre luce. A narrare è un narcolettico, vale a dire una persona che ogni tanto si addormenta a differenza di tutti gli altri abitanti di questo pianeta insonne, e che a sua volte fa ipotesi intorno a un possibile pianeta in cui la luce si alternerebbe al buio e dove quindi dormire non sarebbe considerato una malattia.
Che si tratti di stati psichici, fenomeni culturali, ideologie, strutture di potere, i racconti di Kim Bo-young giocano tutti la carta dello straniamento: sono un esercizio radicale di relativismo. E se per l’abilità di muoversi tra gli ambiti diversi del fantastico e del fantascientifico, se per la qualità delle intuizioni e degli sviluppi narrativi queste storie ricordano al lettore quelle dell’ottimo Ted Chiang, per altri versi mostrano una coerenza interna e una visione d’insieme che forse mancano al collega sino-statunitense.
Più che fantascientifica quella di Kim Bo-young meriterebbe il titolo di narrativa filosofica.
Visione che riassumerei in una specie di stupore darwiniano, di fiducia nelle infinite possibilità della vita e dei fenomeni naturali a cui soggiace un’esultanza quasi panteistica verso l’incommensurabile varietà dell’universo. Esultanza che non esclude, e anzi implica, una più pacata e malinconica considerazione dei destini individuali, della precarietà delle forme che la materia via via assume, e del modo in cui fatalmente, di tutta questa abbondanza nel tempo e nello spazio, ci è dato di conoscere soltanto qualche povera briciola: quel “parochialism antropocentrico” che Calvino deplorava nella lezione americana sulla leggerezza, parlando di autori che devono avere ispirato in qualche modo anche questo libro come Cyrano de Bergerac, Lucrezio, Swift ecc.
La fantascienza è notoriamente un genere per lo più maschile, perciò Kim Bo-young, che è una autrice capace di unire una robusta vena speculativa a una più sottile e penetrante ironia, apre la raccolta con un breve testo che mette in relazione il genere della scrittrice con il genere della scrittura, l’etichetta fantascientifica che le viene solitamente assegnata. Basta il seno per fare una donna? Basta la presenza della scienza per fare la fantascienza? Domande che sospendono abitudini di pensiero inveterate e che si prolungano nelle questioni sollevate nel resto del libro: basta la biologia organica per definire la vita? Basta dimostrare di avere volontà e provare emozioni per considerarsi umano? Basta non essere meccanici per essere liberi? Basta essere come tutti per essere sani?
Si tratta di questioni che non contengono al loro interno indicazioni precise sulle tecniche adatte a rispondervi, secondo una pratica che non sarebbe dispiaciuta a Isaiah Berlin, grande pluralista del Novecento. E che però, o meglio perciò, quando finiscono tra le mani di un abile narratore, o di un’abile narratrice, possono diventare storie piene di fascino. L’origine della specie ne offre un esempio brillante e forse per questo, oltre che per questioni di genere, più che fantascientifica quella di Kim Bo-young meriterebbe il titolo di narrativa filosofica.