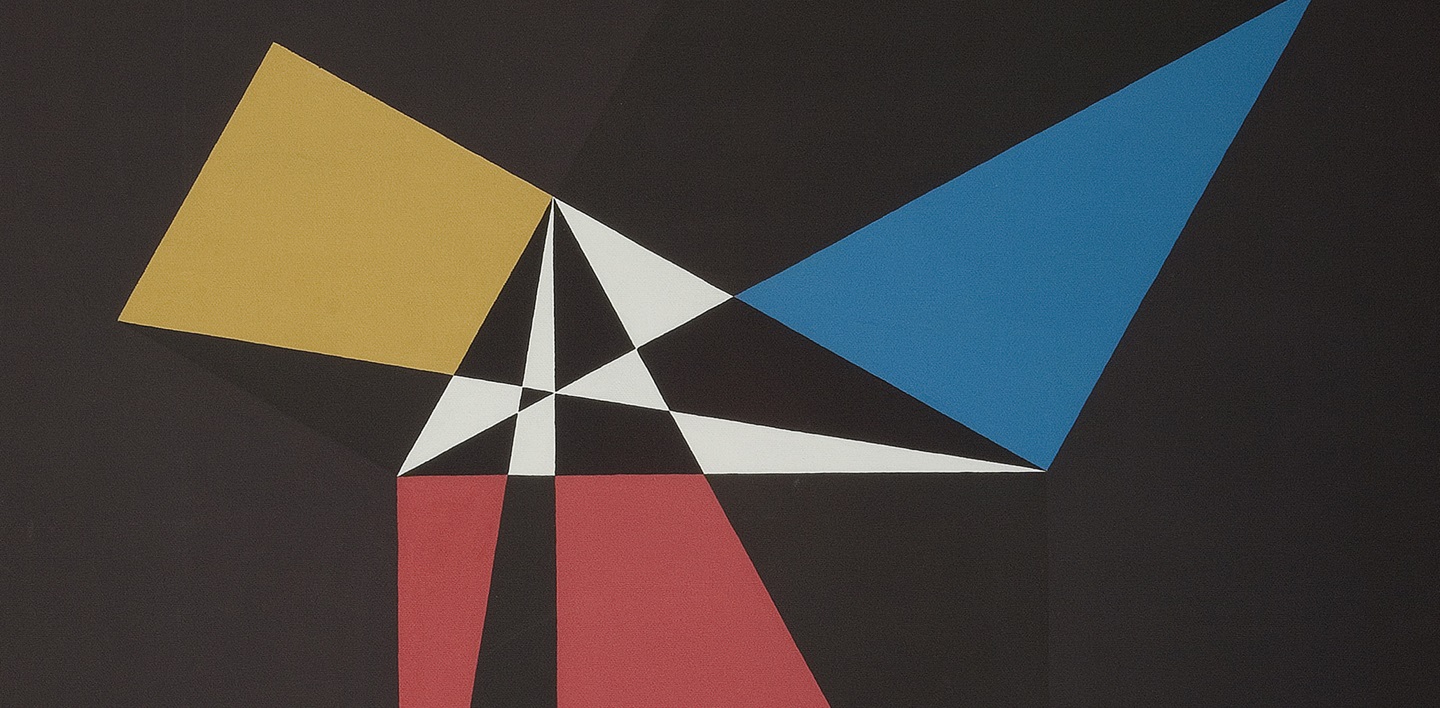
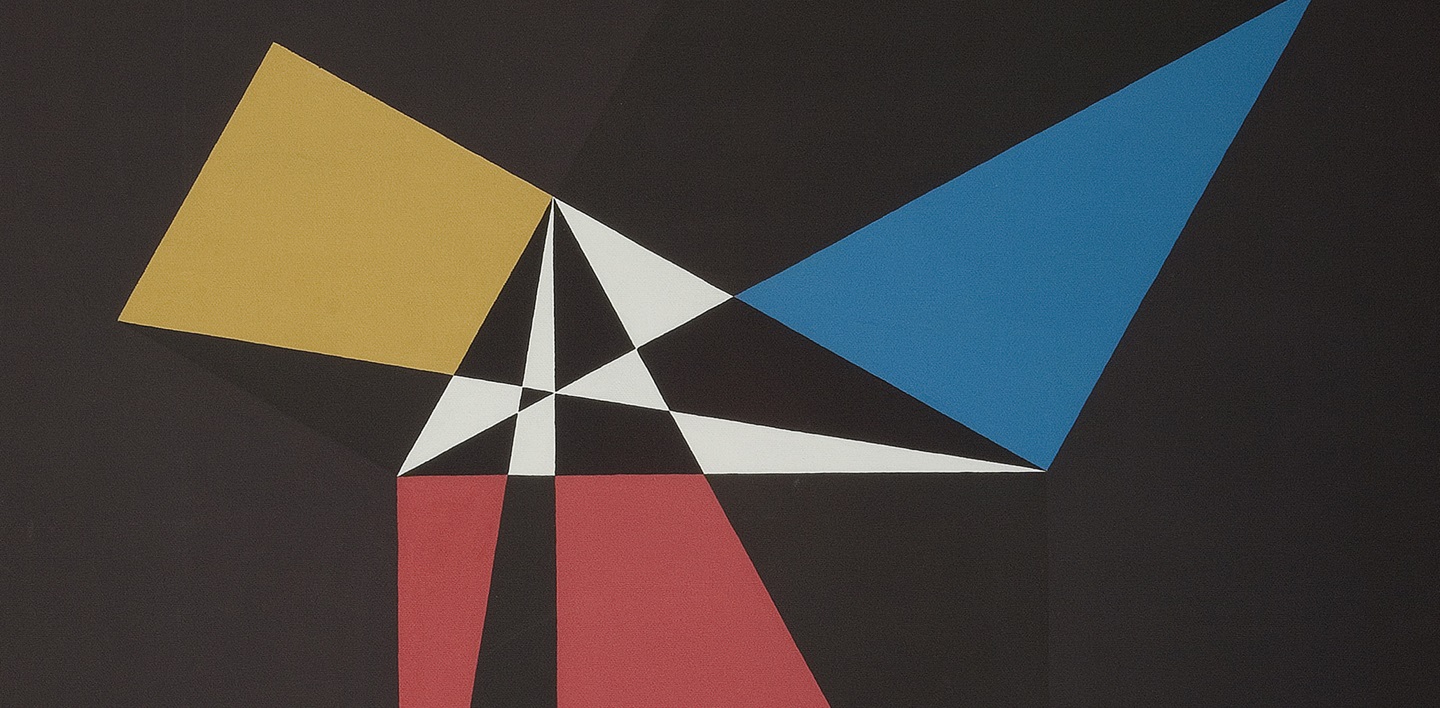
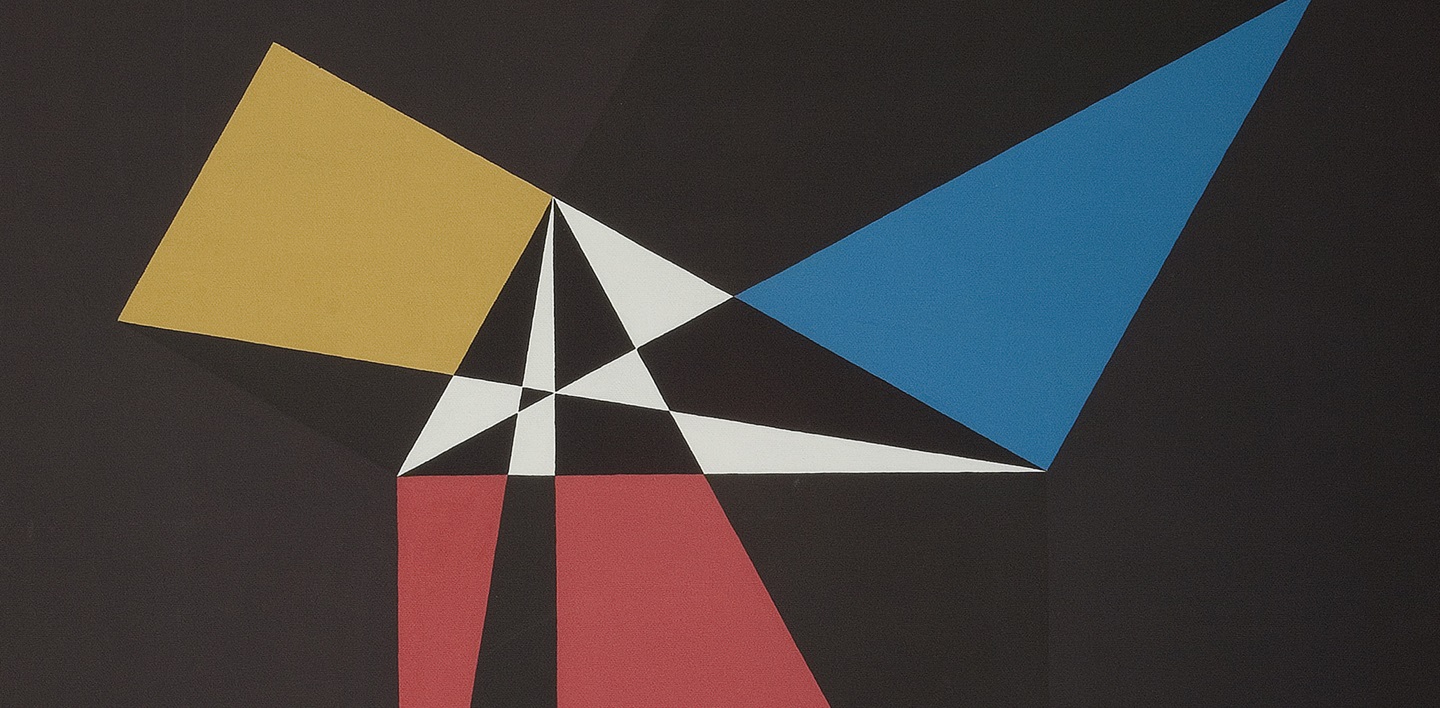
L ’area del quadrato costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Rappresentato dalla celeberrima raffigurazione di quadrati, cateti e ipotenuse, il teorema fluttua come una sentenza sui quaderni e sulle lavagne di tutto il mondo. È diventato simbolo di un metodo, di un canone che dà importanza all’insegnamento dei fondamenti di una comprensione intuitiva dello spazio. Una parte esoterica dell’apprendimento, condivisione di antichi saperi silenziosi, ora praticamente muti nella loro stasi formale. Questa singolarità lapidaria diventa pretesto, più che vero protagonista, di un discorso che, nell’ultimo libro di Paolo Zellini, Il Teorema di Pitagora (Adelphi, 2023), attraversa millenni di storia del pensiero geometrico.
Non è facile accontentare lettori bulimici di dati, storie e fatti; i teoremi non se ne nutrono e non ne vengono nutriti, e raramente diventano argomento esplicito di discussione. Queste ambigue pietre miliari del pensiero non si possono comprendere esclusivamente nella loro veste formale, ma devono essere inserite e interpretate all’interno di canoni che appartengono all’arcaicità, a dimensioni che in virtù della loro estraneità temporale coinvolgono l’intera forma del pensiero.
Zellini è professore ordinario di analisi numerica all’Università di Roma Tor Vergata. La sua carriera accademica si muove all’interno dei confini dell’algebra lineare e dell’ottimizzazione numerica: discipline che sembrano stridere con l’afflato letterario della sua scrittura. È solo un pregiudizio, così come è un pregiudizio quello che porta molti scienziati a credere che solamente la matematica cosiddetta “pura” possa, con parsimonia, adornarsi di strappi nel tessuto formale, fenditure attraverso le quali intravedere una luce diversa dal caustico bagliore del formalismo. Come si presupponesse una topologia intrinseca, un ordine gerarchico del tutto ingannevole. In realtà non c’è alcuna gerarchia di “purezza”: per usare le parole di Hermann Weyl, “la matematica assomiglia piuttosto al delta del Nilo, con le sue acque che si diramano in tutte le direzioni”, a differenza della fisica, che “come un torrente scorre in un’unica direzione”.
Il teorema di Pitagora è diventato simbolo di un canone che dà importanza alla comprensione intuitiva dello spazio.
Uno dei meriti più grandi dell’opera di Zellini è quello di capovolgere il pregiudizio rendendone evidente la miopia. Si fa fatica a considerare i suoi scritti come testi prettamente divulgativi; rappresentano piuttosto uno sguardo obliquo che sfugge da ogni briglia del canone. Un tentativo di “fare matematica”, dando più importanza alle parole, alla sintassi articolata e frequentemente spezzata da riferimenti etimologici: quel sottinteso che più assomiglia agli assunti insindacabili di un sistema formale.
L’esito di questa rottura è un approccio duale alla materia, nel senso tecnico del termine: opposto ma equivalente. Non sorprende che gli esempi matematici di Zellini si riconducano spesso alla scienza dell’approssimazione, alla dialettica dell’errore che tramite somme e sottrazioni dialoga con il valore esatto. Nella sua ricerca all’origine dei fondamenti della matematica è ubiquo il riferimento allo scontro tra il discreto e il continuo, agli algoritmi di approssimazione, alle formalizzazioni di Cantor e Dedekind. Ci si rifà spesso ai linguaggi che sono più affini agli interessi accademici all’autore e il risultato è una scoperta del tutto innovativa di alcune tappe capitali del pensiero formale.
Qual è dunque il motivo del ricorso alla prospettiva duale, alla possibilità discorsiva, spesso osteggiata dall’accademia? Qui il pensiero di Zellini si illumina nella sua coerenza: preservare le analogie, proteggerle dagli strappi temuti dai demoni di Rabelais, quelle lacerazioni e divisioni del continuo che sono inevitabili in ogni processo di formalizzazione. Distinzioni che pur essendo presupposti dell’individuazione, offuscano la possibilità di sovrapporre e comparare nozioni primordialmente attigue che ora si interfacciano da estranee. È un tentativo di salvare la scienza naturale da quella “mancanza di senso” che per Nietzsche implica un’inevitabile sottrazione del suo carattere singolare di “conoscenza dell’uomo come confine”.
Più simili a un solco, a un epigramma inciso nel flusso del divenire, i teoremi non hanno origine né sono fonti.
Le incarnazioni del teorema di Pitagora sono evanescenti e non è sempre facile isolarne le apparizioni. Ad esempio negli spazi di Hilbert – insiemi astratti di simboli chiamati “vettori”, definiti attraverso le loro proprietà algebriche – lo spirito del teorema aleggia a testimonianza del loro imprinting geometrico. L’algebra si occupa dello studio di insiemi di simboli manipolabili attraverso operazioni che generalizzano nozioni come “somma” o “prodotto”, mettendole in relazione attraverso assiomi che ne garantiscono la coerenza. Un discorso di tipo algebrico non cela l’estraneità rispetto a ogni intuizione geometrica: quest’ultima, a differenza dell’algebra, non si occupa di studiare rapporti fra simboli astratti ma piuttosto la coesistenza di entità che, pur non potendo trascendere da una descrizione “simbolica”, godono di una loro intrinseca estensione spaziale.
In questo dinamismo algebrico, ossia nella possibilità di comporsi e decomporsi attraverso le operazioni caratterizzanti il carattere formale, gli spazi di Hilbert fanno intravedere la loro natura spaziale. In questi spazi, esistono molteplici modi di decomporre un vettore in elementi “ortogonali” ed è possibile immaginare queste decomposizioni come scelte diverse di cateti per un’unica ipotenusa che rappresenta il vettore originario. Ciascuna di queste scelte ci permette di definire univocamente una nozione di “lunghezza” per il vettore-ipotenusa, una quantità che è indipendente dall’arbitrarietà della scelta di decomposizione.
Chiedersi se la nozione di ortogonalità preceda la possibilità di associare distanze e lunghezze ai vettori è una domanda senza risposta, forse del tutto errata. La forza del teorema di Pitagora non è quella di gerarchizzare ma di riflettere l’intimo rapporto fra algebra e geometria attraverso una possibile comprensione della natura dell’angolo retto. A dimostrazione del potere dell’astrazione, gli spazi hilbertiani, pur preservando le regolarità caratterizzate dal teorema, formalizzano strutture che, a prima vista, hanno poco da spartire con la concezione pitagorica di numeri come particelle indistinguibili disposti in un certo ordine nello spazio. Rappresenteranno, ironia della sorte, il cuore simbolico che sottintende tutto lo sviluppo della meccanica quantistica e il fallimento dell’atomismo.
La forza del teorema di Pitagora è quella di riflettere l’intimo rapporto fra algebra e geometria.
Zellini riconosce il ruolo del teorema nel sogno cartesiano di fondere, in una disciplina di carattere analitico, la tradizione computazionale di origine babilonese e quella geometrica di stampo greco. Il teorema rivela una connessione analogica fra algebra e geometria che ci avvicina alla sua quidditas, lasciandoci ancora troppo distanti. Zellini va oltre e per comprendere il teorema penetra nelle profondità del rapporto fra numero e forma. “Numero e geometria sono forme erette contro l’incessante distruzione del divenire”, ed è all’interno dell’invariabilità nel mutamento, tema fondamentale di tutta l’opera di Zellini, che si cela la possibile risposta, potente chiave interpretativa della matematica contemporanea.
Il neoplatonico Giamblico, biografo di Pitagora, narra che il mistico di Samo soleva paragonare la Giustizia al rettangolo scaleno, il quale può assumere un numero infinito di forme non equivalenti, pur preservando lo stesso rapporto fra i quadrati disegnati sui loro lati. Le proprietà della natura, secondo la tradizione orfica, rappresentano le costanti nel flusso continuo di mutamenti. Il teorema e il suo inverso – se in un triangolo il quadrato su uno dei lati è equivalente alla somma dei quadrati sui rimanenti due, l’angolo contenuto dai due lati rimanenti è retto – colgono una di queste immutabilità in maniera perfetta, catturando e governando l’essenza dell’angolo retto: la posizione intermedia tra eccesso e difetto che accomuna elementi diseguali.
Quando un teorema incomincia a svincolarsi dal contesto creativo per entrare ufficialmente nel pantheon delle verità matematiche? Forse la domanda è mal posta. Il matematico olandese e padre dell’intuizionismo Lorentz Brouwer ci insegna che ogni dimostrazione dovrebbe essere identificata con la proposizione che intende dimostrare. Questa prospettiva elimina la necessità di presupporre aprioristicamente la decidibilità, e si limita a identificare la dimostrazione con la costruzione formale della proposizione stessa. La dimostrazione non è più al servizio della verità, la quale, come spiegato da Gödel, non può che cristallizzarsi in modo anomalo eludendo qualsiasi formalizzazione. Partendo da questo presupposto, che attenua le necessità teleologiche di una scienza matematica, si può dire che esistano diversi teoremi di Pitagora identificabili in maniera tanto più flebile quanto è diverso il contesto della loro sintesi.
Zellini va oltre e per comprendere il teorema penetra nelle profondità del rapporto fra numero e forma.
Zellini, ovviamente, non ignora le diramazioni ancora più arcaiche che ci riconducono al teorema e che precedono la scuola pitagorica. In un antico testo di astronomia e matematica cinese, il Chou Pei Suan Ching, appare il “diagramma dell’ipotenusa”, una figura che racchiude al suo interno, in un gioco di accrescimenti e giustapposizioni, una dimostrazione visiva del teorema. Nei trattati di geometria più antichi le dimostrazioni tendono spesso ad avere la struttura di diagrammi capaci di racchiudere l’intuizione in un’unica immagine, mosaici di figure geometriche contenenti, a loro volta, enunciato e dimostrazione. Questa prospettiva è ancora lontana dalla tradizione euclidea, che invece diluisce l’intuizione, fino a farla scomparire, in una fitta catena di enunciati. In queste rappresentazioni visive, il teorema appare esplicitamente al servizio di una necessità che, dopo essere scomparsa, come un fiume carsico riaffiora con Von Neumann e i metodi algoritmici: è la necessità di identificare procedure che consentano di ingrandire strutture geometriche conservandone le proprietà fondamentali.
In alcune dimostrazioni del teorema di Pitagora ritorna il leitmotiv dello studio geometrico dell’accrescimento, della “crescita gnomonica”. Secondo Zellini, molto della matematica contemporanea andrebbe ricondotto allo sviluppo di tecniche che rispondessero alla necessità di poter ingrandire o rimpicciolire una forma: non tanto per necessità pratica, quanto come requisito ontologico di chi vede nell’essenza dei numeri disposti nello spazio o nella disposizione dei mattoni degli altari vedici lo strumento adatto a rappresentare l’invariabilità nel mutamento. Si tratta di una tesi affascinante, anche se molto spesso ignorata dagli storici della matematica.
La costruzione rituale dell’altare vedico del fuoco aveva lo scopo di simboleggiare la ricomposizione dei frammenti del corpo del dio Prajapati, smembrato nel momento della creazione. Ogni ricomposizione del divino usando mattoni non può che esserne una pallida ombra, una proiezione circoscritta nello spazio e nel tempo. Il carattere assoluto e trascendente è catturato dalla possibilità di ingrandire arbitrariamente quella figura geometrica e le direttive vediche avevano quindi lo scopo di rappresentare questa potenzialità: la crescita ad libitum che diventa parte della complessità geometrica della costruzione dell’altare. L’altare stesso cattura solamente un’istante, ed è il processo di crescita nella sua totalità ad opporsi fedelmente allo smembramento di Prajapati. L’altare vedico si avvicina al carattere trascendente del divino non nella sua materializzazione fisica, ma nella sua idealizzazione geometrica che cattura in sé un’invarianza nel divenire, la descrizione geometrica della possibilità del suo ingrandimento.
Quando un teorema incomincia a svincolarsi dal contesto creativo per entrare ufficialmente nel pantheon delle verità matematiche?
Considerazioni simili sono presenti nelle tradizioni cinesi e mesopotamiche, e vengono giustificate nel credo metafisico pitagorico di elaborare l’immutabilità del divenire attraverso il concetto di numero. Questa motivazione ricorrente sembra essere esplicita nelle prime dimostrazioni geometriche, dove l’intuizione primaria è spesso quella di racchiudere, attraverso adeguati prolungamenti, una struttura seminale all’interno dell’ingrandimento di se stessa. E allora quand’è che, nel teorema di Pitagora, il principio dell’invarianza nel divenire di numeri e forme è andato perduto?
Ovviamente è impossibile stabilire una cesura netta, ma si coglie un’ovvia distanza nel metodo assiomatico di Euclide. Il libro primo degli Elementi contiene una dimostrazione del teorema molto diversa da quelle basate sull’ingrandimento, poiché fondata sulla “teoria delle proporzioni”, che il poeta persiano Omar-i Khayyām “riteneva corretta ma non altrettanto ‘vera’”, in quanto smette di rappresentare l’essenza del rapporto matematico. Nel calcolo simbolico, le grandezze non si misurano più paragonandole ad altre grandezze attraverso un procedimento di sottrazione e ingrandimento, ma passando per l’algebra delle proporzioni. Euclide sceglie così di riservare al teorema un ruolo fondamentale, come se gli affidasse l’essenza del triangolo rettangolo, occultandone però la vera natura all’interno della catena deduttiva. Le catene di proposizioni in Euclide perdono l’immediatezza intrinseca delle prove geometriche e con essa anche molto della loro natura.
Come spiegato da Zellini, il teorema riappare nelle parole del Salviati, uno dei protagonisti del Dialogo di Galilei, per giustificare la limitatezza che imbriglia il nostro intelletto: “perché insomma, che altro è l’esser nel triangolo il quadrato opposto a quello dell’ipotenusa eguale a gli altri due che gli sono intorno, se non l’esser i parallelogrammi sopra base comune e tra le parallele, tra loro eguali?”. Il teorema è equivalente ad ogni enunciato che fa parte della catena deduttiva che ci porta alla sua dimostrazione. La prerogativa del pensiero divino è invece quella di non aver bisogno delle catene deduttive che, a causa della nostra umana imperfezione, ci convincono che un enunciato “non sia altro che qualcosa d’altro”. La divinità coglie le deduzioni con immediatezza: che abbaglio, quello di Salviati, nel credere al carattere divino dell’uguaglianza fra proposizioni. Più simile ai diavoli di Rabelais che alla divinità onnisciente, il demone della matematica teme ogni equazione, finzione sintattica che nasconde le ferite della recisione, di quell’arbitrarietà implicita nell’atto del definire e del delimitare.