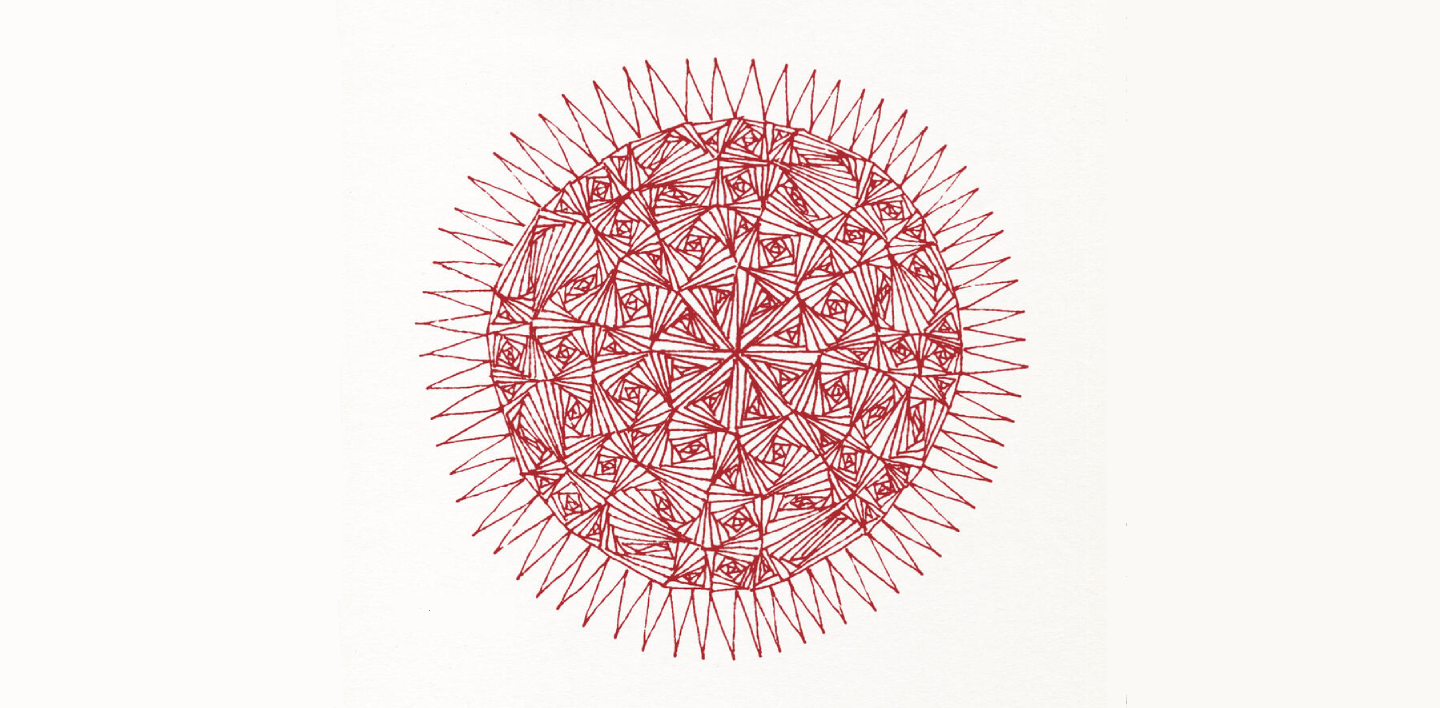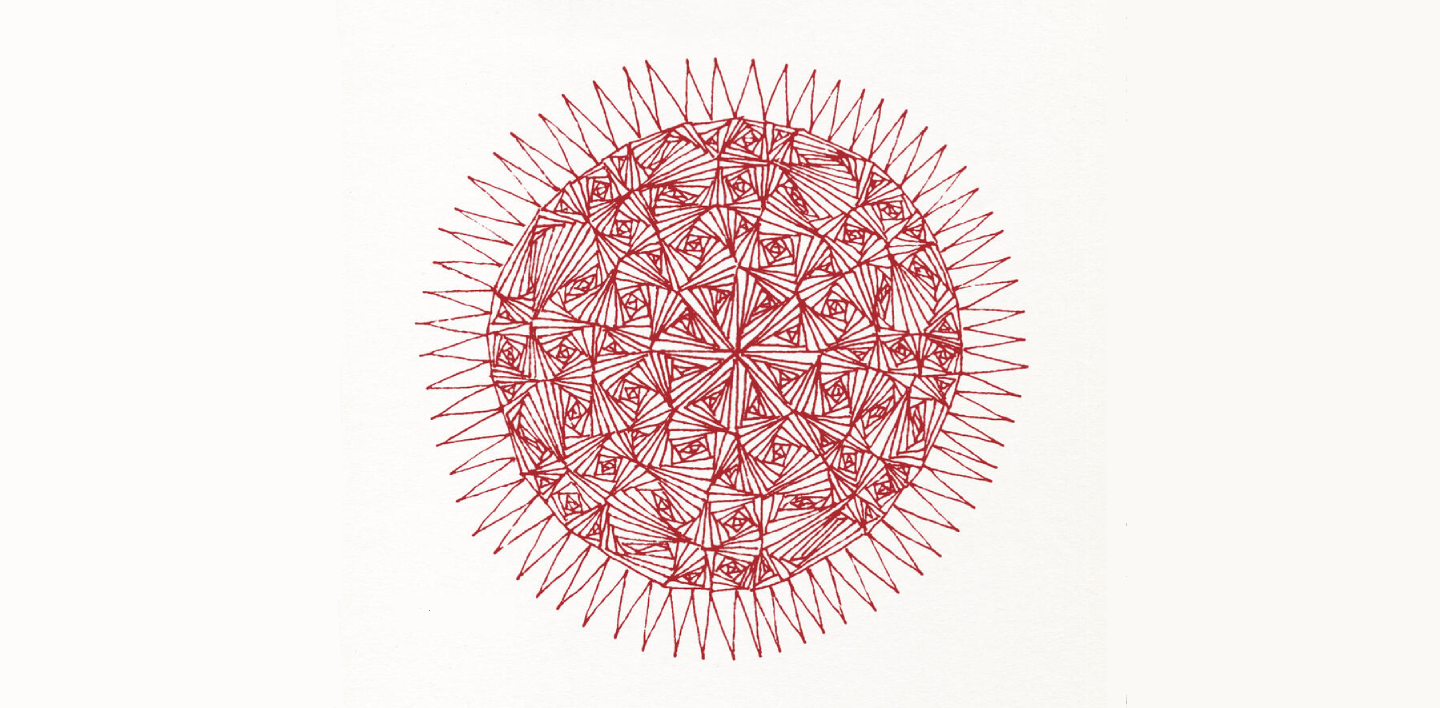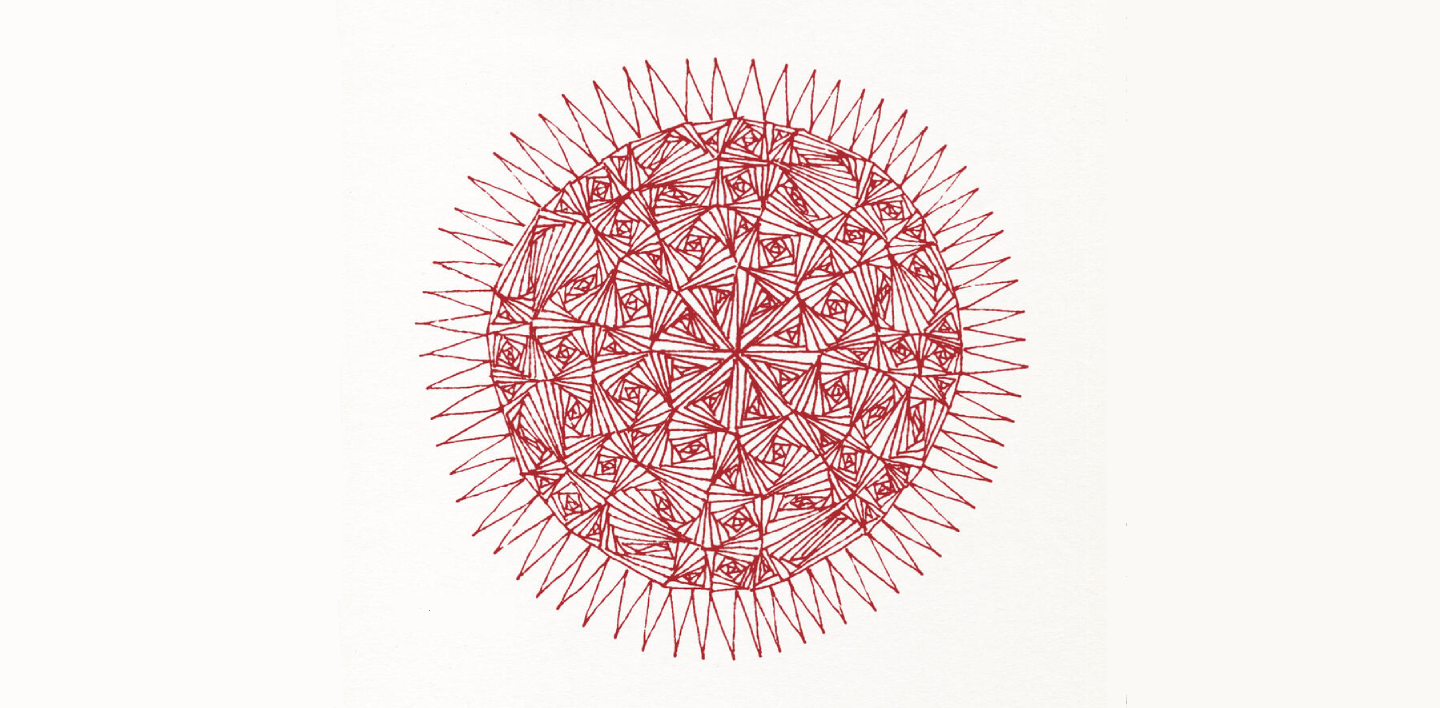L
a casa del mago (Ponte alle Grazie, 2023), l’ultimo libro di Emanuele Trevi, sembra muoversi all’interno di un ecosistema autobiografico che come negli altri suoi testi dà forma a una letteratura compatta, tra la saggistica e la diaristica. Non una semplice autobiografia in forma di ricerca del tempo perduto, ma un vero e proprio sistema vivo che agisce in un delicato rapporto tra memoria e presente, dove una modifica l’altra, e viceversa. Ne La casa del mago, l’attrattóre della narrazione è il padre di Trevi, ricordo di un uomo riletto attraverso il suo studio, ora abitato dal figlio, e le sue carte. Dai ricordi d’infanzia, al lavoro di psicanalista junghiano del padre Mario, l’autore mappa la morfologia di una relazione che piano piano rivela la sua essenza.
Nei tuoi romanzi parti sempre da un rapporto affettivo profondo, alle volte indiretto, come con Pasolini, altre volte diretto, come con la cagnetta Gina, Cesare Garboli, Rocco Carbone e Pia Pera; e infine, con la casa del mago, e tuo padre. Relazioni che in qualche modo divengono una forma di rivelazione di te stesso. Qual è quindi il rapporto per te tra la scrittura e gli affetti?
Io in realtà scrivendo mi isolo il meno possibile, se mi chiami al telefono ti rispondo, non cerco mai la concentrazione, la distrazione è più produttiva. Quindi non è poi tanto paradossale che la mia scrittura sia popolata di presenze, visto che lo è anche la mia vita. Fondamentalmente, gli altri mi interessano molto più del mio mondo interiore. Più che un autore di auto-fiction, mi considero un ritrattista.
Ne Le casa del mago ribadisci un desiderio di invisibilità, che nessuno si aspetti nulla da te, e ti avvii per una sorta di scalata, un confronto continuo in cerca di una sorta di rivelazione. Come definiresti – se esiste – l’effetto trasformativo della scrittura su di te?
Temo che in questa cosa della scrittura che trasforma ci sia una specie di abbaglio: è il tempo che trasforma tutto, esseri viventi, cose, spazi. Quindi il problema non è cosa fa di te la scrittura, ma il percorso che fai per arrivare a quel dato libro, che dipende dal gioco delle forze della vita, dal caso, dalle strategie che mettiamo in atto per andare avanti. La mia domanda fondamentale non è mai: di cosa voglio scrivere? Semmai è: è questo il momento giusto?
Il genere umano è cementato da memorie ancestrali, che lo inducono più di quanto crede a ripercorrere strade antiche.
Scegli di andare a vivere in quello che fu lo studio di tuo padre, che è per certi versi un luogo ancor più intimo di una casa e anche più misterioso. Inoltre la nostra società si regge anche sullo scambio di case che furono dei nonni, dei genitori e che finiscono per “puntellare” l’economia di figli e nipoti, diventando le loro prime case, ma restando pur sempre case “altrui”, conquistate e “guadagnate” dagli antenati. La casa dunque ridotta a risorsa della memoria e non più di un futuro possibile, immaginato?
Dovresti rivolgere questa domanda a chi, oltre a essere figlio come tutti, è anche, a sua volta, padre. Però hai colto un aspetto importante della storia che racconto: in effetti, all’inizio c’è una decisione, che nasce dal desiderio che un bene immobile (di non grande valore, se vogliamo dire la verità) resti in famiglia, non venga venduto trasformandosi in denaro risparmiato, in tasse. Questo atavismo italiano non può spiegarsi solo con la congiuntura economica e sociale, a volte suggerisce anche scelte del tutto svantaggiose dal punto di vista pratico.
Sembra una forma di rifugio che in parte ricorda – pur con le differenze del caso – la ritirata a Vado di Camaiore di Cesare Garboli, uno dei tuoi maestri, dopo il rapimento di Aldo Moro. Una ricerca interiore e al tempo stesso un abbandono?
Ogni tanto il legame con il mondo mi sembra irreale, non è che mi isolo, ma mi sembra che le cose intorno a me perdano consistenza, diventino prossime all’evaporazione. Nel libro descrivo uno di questi periodi ricorrenti. Jung dice che gli individui che si accorgono di vivere nella loro testa a un certo punto si spaventano e vogliono tornare indietro, e ha ragione.
Nella casa di tuoi padre ti installi in modo permanente, ma precario, scatoloni e vestiti lasciati sul divano. Una forma di protezione di quella memoria? Cosa resta infine, della casa di un padre?
Beh, a dieci anni dal trasloco i vestiti sono ancora lì, il fatto è che sono una persona veramente disordinata, ai limiti del barbonismo, mentre mio padre era ordinatissimo, e questa è un’altra cosa che mi affascinava descrivere, la sovrapposizione di strati in uno stesso luogo. Di solito le persone ordinate si considerano superiori alle disordinate, non solo dal punto di vista igienico ma morale. Non ho mai capito il mistero della loro superiorità, ma è una gerarchia consolidata fin dall’infanzia (“metti in ordine la tua stanza !”). Invece mio padre, che era addirittura ossessivo, era molto divertito da come vivevo. Una volta era venuto a trovarmi a Parigi, ai tempi in cui studiavo, e voleva fare delle foto, diceva che ero una Venere con gli stracci di Pistoletto vivente. Non si sentiva più bravo di me perché metteva tutto a posto. Ho cercato nel libro di mettere in evidenza questa diversità perché è una specie di correlativo oggettivo della differenza di carattere.
Descrivi tuo padre come un uomo taciturno e al tempo stesso svagato. La sua morte diviene un’occasione di indagine della sua complessità, un modo per fare ordine, un movimento che nella tua letteratura ti accompagna spesso, una forma di “invenzione” della memoria?
Guarda, è abbastanza naturale che i ritratti che faccio siano di persone morte, per ovvi motivi di compiutezza narrativa e di libertà di indagine, ma se leggi Limonov di Carrère capisci che lo puoi fare anche con le persone vive. L’importante non è la morte, è trovare un congedo dalla persona che ti permetta di scriverne.
L’idea di un’opera complessiva è l’unico elemento che resiste bene alla corrosione dell’intelligenza operata dall’industria culturale.
La memoria diviene la compensazione di una perdita? Uno spazio dentro al quale ridefinire confini e contorni?
La memoria non funziona mai come vorremmo che funzioni o come ce la immaginiamo, questa è la verità! Perché la memoria fa parte dell’inconscio, così come fa parte della coscienza. Può essere ampia, come dici, ma anche incredibilmente stretta. Forse ha ragione Proust: meno le chiedi, più ti dà.
La tua letteratura assume libro dopo libro una forma compatta. Quanto è importante per te la costruzione formale di un’opera? E l’esplicitazione autobiografica, quale funzione ha per te dal punto di vista letterario?
Questa tua osservazione mi fa piacere, perché l’idea di un’“opera” complessiva è l’unico elemento che resiste bene alla corrosione dell’intelligenza operata dall’industria culturale, al prevalere del consenso e della pubblicità sulla critica. Un’opera non è la somma aritmetica dei libri che hai fatto, ma un’immagine potente della vita.
Il tuo libro sembra vivere nello spazio che sta tra la presenza e l’assenza, un andamento che sembra caratterizzare tutto il tuo lavoro letterario, come vivi l’azione del caso?
Il genere umano è cementato da memorie ancestrali, che lo inducono più di quanto crede a ripercorrere strade antiche. Quando tieni insieme il caso e l’idea di un’armonia prestabilita, quando non si tratta più di un’alternativa ma di un accordo musicale, allora il mondo ti si rivela in una specie di estatica totalità. Sono momenti molto effimeri, ma rivelatori. Ogni tanto, quando sono in treno, e sta calando la sera, guardo fuori dal finestrino e riconosco nel paesaggio questa coincidenza degli opposti, il convivere del caso e della necessità nello stesso istante, nello stesso orizzonte. Ed è come se un angelo custode, che non vedevo da tanto tempo, mi assicurasse della sua presenza.