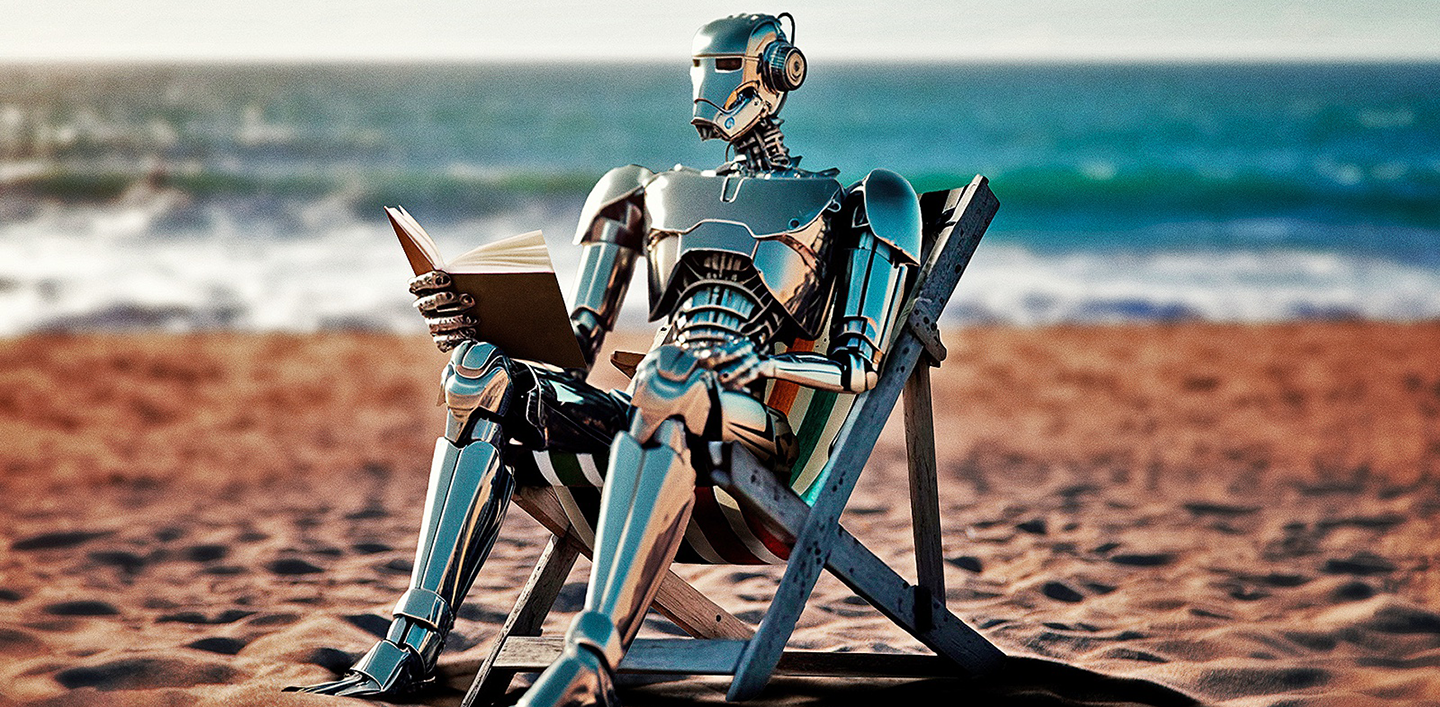
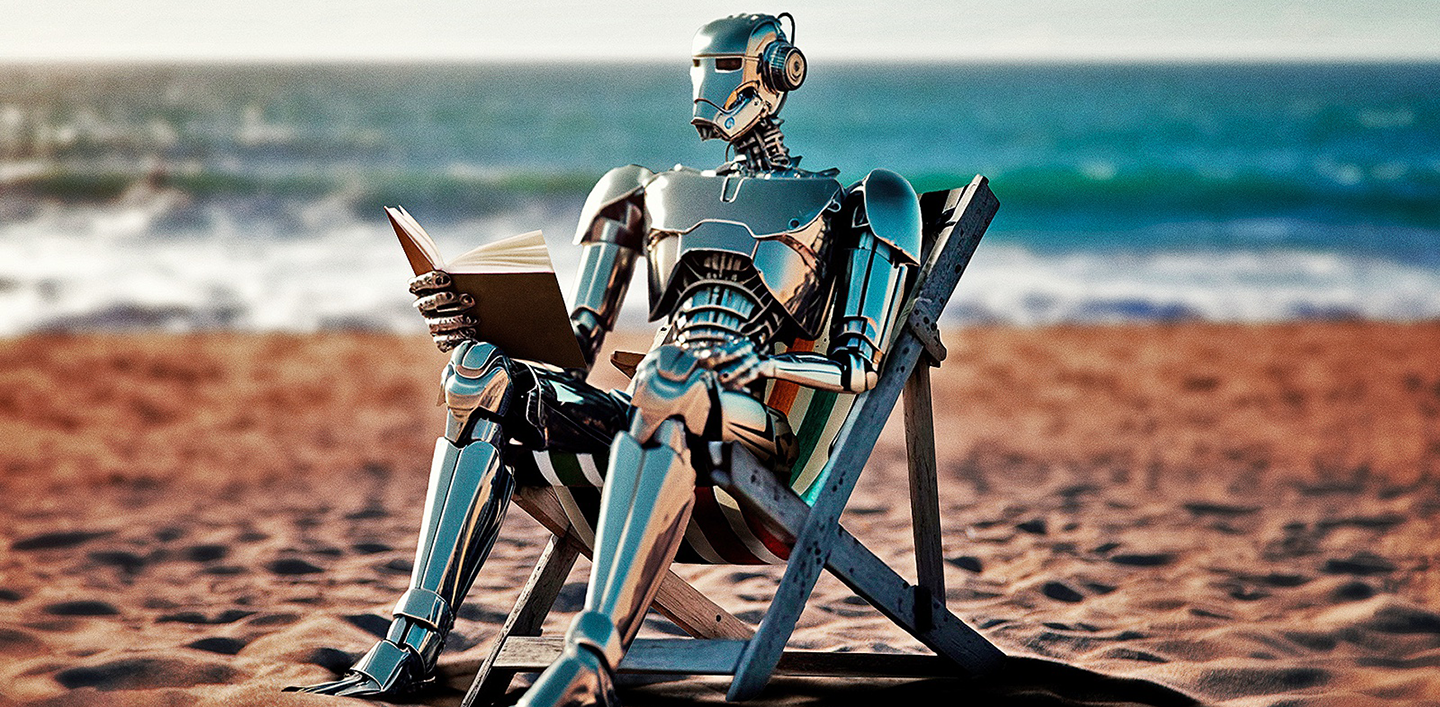
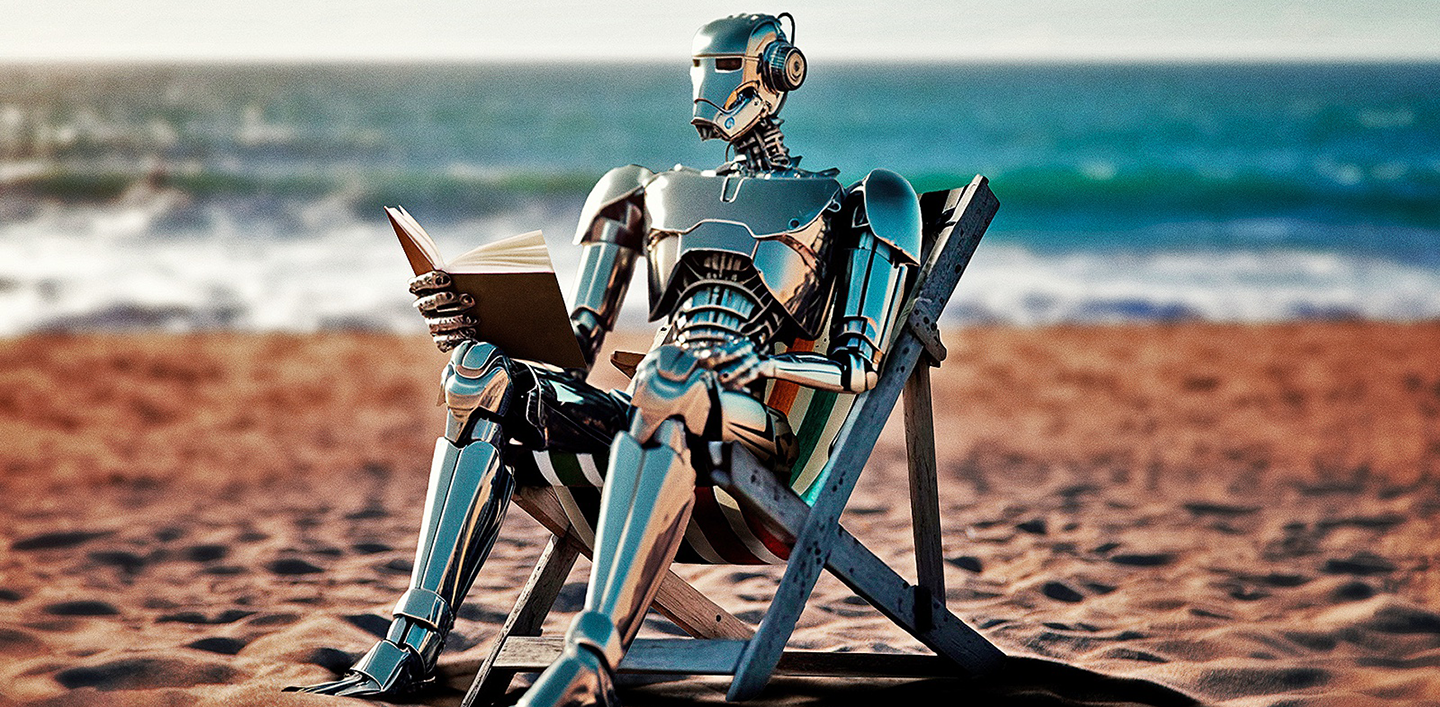
L e dita di un impiegato pigiano ripetutamente i due tasti di un mouse. L’inquadratura, strettissima, si allarga a immortalare lo sguardo di un uomo sui sessant’anni, che fissa vacuo lo schermo di un computer. “Mi sveglio ogni mattina alle 6. Mi faccio una doccia, vado al lavoro alle 7, resto in ufficio fino alle 23. Torno a casa, ceno, vado a dormire a mezzanotte. Faccio questa cosa ogni giorno”, dice la sua voce fuori campo. Con un piano sequenza la telecamera immortala, alla sua destra, sua figlia, a braccia conserte, a fissarlo con un misto di compassione e riprovazione: “Non voglio per me questa vita, mio padre dice che ha fatto tutti i suoi sacrifici per noi, noi siamo il premio per i suoi sacrifici, dice. Non sono d’accordo”.
Si apre così After Work, l’ultimo documentario di Erik Gandini (regista italo-svedese autore fra gli altri di Videocracy, sull’era berlusconiana): una scena piuttosto didascalica che focalizza l’attenzione dello spettatore su un aspetto secondario – quello generazionale – di una questione cruciale della nostra epoca: il rapporto tra tempo e lavoro. Gandini si chiede se sia possibile immaginare come impiegheremo il nostro tempo quando il lavoro umano, per come l’abbiamo finora concepito, sarà reso superfluo dalla tecnologia. Se lo chiede, sì, anche se sembra non volere o non essere in grado di dare una risposta, tanto che il film si conclude con i primi piani di alcuni intervistati che, alla domanda se sia possibile smettere di lavorare, fissano la telecamera senza dire nulla. L’impasse del dibattito è forse il fulcro di questa analisi.
Gandini si chiede se sia possibile immaginare come impiegheremo il nostro tempo quando il lavoro umano, per come l’abbiamo finora concepito, sarà reso superfluo dalla tecnologia.
Gandini intervista persone di estrazione sociale differente (working poors, impiegati statali, imprenditori, ricchi ereditieri), provenienti da diverse parti del mondo – Stati Uniti, Italia, Kuwait e Corea del Sud, vale a dire, per metonimia, Nord America, Europa, Medio ed Estremo Oriente. L’operazione è un po’ azzardata: contesti geopolitici molto specifici sembrano eletti a universali, chiamati a mappare idealmente l’intero mondo industrializzato sotto l’egida culturale e economica capitalista. Come è azzardata l’idea di poter utilizzare l’operaia Astrid, il manager Pa Sinian, l’imprenditore John, e poi ancora Armando, Meqdaq, Fatima, Rory, Ferdinando, Boseong – tutti significativamente evocati senza i cognomi – non come individui, ma quali, di nuovo, metonimie della classe sociale a cui appartengono. Alle interviste del regista si aggiungono, inoltre, fonti secondarie, materiali d’archivio, brevi interventi di intellettuali e personalità di spicco come Noam Chomsky, Yuval Noah Harari, Yanis Varoufakis, Elon Musk, le cui parole aiutano a orientare lo spettatore attraverso un tentativo di affresco contemporaneo.
Il documentario procede per giustapposizione di testimonianze, ma è impossibile capire in che modo Gandini si stia servendo delle parole degli intervistati. Infatti allarga quanto più possibile il campo della questione, pur partendo da casi singoli chiamati per nome e solo per nome, astrae il problema dai particolarismi di una vita o di una classe sociale specifica. Ad esempio, alle interviste a due ex ministri del lavoro sudcoreani sulle politiche contro la cultura del superlavoro nel loro Paese, Gandini accosta la testimonianza di un imprenditore americano, simbolo della middle class affamata di successo, uno yuppie rampante che ride sguaiato all’idea che in Europa sia socialmente accettato prendersi sei settimane di ferie all’anno. Alle lamentele concitate del manager di una grande azienda, che preoccupato spiega come l’85% dei lavoratori globali svolga mal volentieri le proprie mansioni, affianca la voce emozionata della dipendente di Amazon che definisce il proprio compito di consegna dei pacchi un piccolo gesto rivoluzionario, che migliora la vita delle persone, una missione a cui dedicarsi completamente. Poi conosciamo Rory e Ferdinando, una coppia: lei ricca ereditiera la cui unica occupazione sono i suoi svariati e esotici hobby; lui ricco imprenditore contrario al reddito di cittadinanza il cui hobby è il lavoro. All’estetica dell’uomo super-impegnato, sexy e stimabile proprio perché oberato di lavoro (“I’m so busy” è il mantra remixato che si ripete in modo martellante), sono poi affiancati i NEET, “Not in Employment, Education or Training” (anche questa frase è remixata e fa da ulteriore colonna sonora al documentario), persone giovani che scelgono “volontariamente” di non lavorare né di formarsi al livello scolastico o professionale.
Man mano che compara contesti anche molto diversi – e mescola opinioni diversissime senza tirare le fila – ha il potere di rendere la stessa questione del lavoro, in qualche modo, metafisica. Per chiedersi se sia possibile immaginare una società post-lavorista (forse non dissimile da quella immaginata da Srníček e Williams in Inventare il futuro, saggio cardine del pensiero accelerazionista di sinistra), Gandini assume un punto di vista filosofico, più che economico o sociale, ponendosi una domanda molto più radicale di quella che formulerebbe la mente di un economista. E in fondo l’aspetto cruciale del film sembra sia chiederci se possiamo accettare culturalmente (tutti, in tutto il mondo) che la nostra vita smetta di assumere valore in relazione a ciò che produciamo: sarà accettabile, in futuro, l’idea che si possano ricevere soldi senza produrre merci?
L’operazione è un po’ azzardata: contesti geopolitici molto specifici sembrano eletti a universali, chiamati a mappare idealmente l’intero mondo industrializzato sotto l’egida culturale e economica capitalista.
In conseguenza di questa tensione filosofica, il film non indaga la sostenibilità materiale di un reddito universale o di un mondo del lavoro quasi interamente robotizzato, ma, più per dir così più poeticamente, riflette sul nostro rapporto con il tempo e con la vita. Forse, a ben vedere, la risposta a queste questioni è ancora più profonda, e riguarda il nostro rapporto con la morte: per superare la società del lavoro dobbiamo riuscire a concepire una vita che sia degna di essere vissuta senza produrre nulla, senza lasciare traccia.
Tutte le filosofie occidentali apparentate con l’etica capitalista, che prevedano una dimensione teologica o siano totalmente materialiste, si fondano sull’assunto ineludibile del possesso, individuale o collettivizzato che sia. Per questo Gandini mette al centro del proprio documentario l’etica del lavoro: fa risalire la nascita del dissidio tra tempo occupato e tempo libero al modo di vita dei puritani, che nel 1600, in piena Riforma Protestante, terrorizzati dall’idea che la salvezza si ottenesse non tramite il pentimento e la sincera adesione ai dettami del Vangelo, ma per mezzo delle proprie azioni in vita, fondarono una società interamente imperniata sul lavoro, sul guadagno e – come estrema conseguenza in tempi recenti – sul consumo. Sono le teorie espresse più di un secolo fa da Max Weber nel suo famoso saggio sull’etica protestante, ma possiamo risalire fino alla parabola dei talenti contenuta nel Vangelo: “Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.
“Non esiste il non far niente, il non far niente è solo la morte”, dice in After Work Armando – ovvero Armando Pizzoni Ardemani –, che è presentato come giardiniere dei Giardini Barbarigo a Valsanzibio. Allo spettatore non è rivelata la sua origine, io l’ho scoperta solo casualmente tramite una ricerca su Google. Armando Pizzoni Ardemani è conte, figlio di nobili e proprietario dell’intera tenuta nella quale viene immortalato al lavoro. I suoi giardini sono pieni di rimandi simbolici all’elevazione spirituale e alla purezza, raggiungibili, nella simbologia del luogo, attraverso un percorso che conduce il visitatore all’ascesi per mezzo del superamento delle insidie materiali, come il labirinto all’interno del quale Armando è immortalato mentre lavora senza sosta alle siepi. Chissà che a volte non abbia avuto anche lui difficoltà a uscire dalla trappola di cui è inconsapevolmente prigioniero.
E in fondo l’aspetto cruciale del film sembra sia chiederci se possiamo accettare culturalmente (tutti, in tutto il mondo) che la nostra vita smetta di assumere valore in relazione a ciò che produciamo.
Negli stessi giardini la telecamera di Gandini immortala una statua di Crono, divinità greca del tempo: “Il tempo vola, il tempo è inesorabile”, dice Armando. Il nostro rapporto con il tempo modella il modo in cui concepiamo la nostra vita e la nostra utilità mentre siamo vivi. Il tempo è valore materiale, tanto che il tempo si può perdere e guadagnare e, per uno strano paradosso culturale, secondo molte persone smettere di lavorare e comunque ricevere soldi significherebbe essere più poveri, perdere tempo invece di guadagnarlo.
Possiamo sentirci definiti dal nostro lavoro? Possiamo identificarci con esso? Esistono veri e propri workaholic, persone affette da stacanovismo performativo, una dipendenza dal lavoro – che non possono fare a meno di definire una malattia anche in casi non patologici. È proprio la performatività l’elemento più disturbante di un sistema lavorativo che tenta di nascondere le proprie storture dietro il mito della dedizione alla grande macchina produttiva sociale. Sarebbe anche nobile lavorare molto, se non fosse che è ritenuto ignobile non fare niente. Ed è proprio l’etica del lavoro, ci dice il documentario di Gandini, che porta alla conseguenza del consumismo sfrenato: spendiamo perché lavoriamo, lavoriamo per spendere e per dimostrare – a noi stessi e agli altri – di poterlo fare.
È così che in Corea del Sud il governo ha deciso di mettere in pratica uno shutdown forzato di tutti i sistemi informatici pubblici alla stessa ora, per costringere le persone a smettere di lavorare. Quella della iperperformatività, spiegano gli esperti sudcoreani nel film, è una tendenza figlia del processo di trasformazione economica che ha portato il Paese a diventare una potenza globale del tech e ha trasformato una popolazione mediamente molto povera in un gruppo di persone benestanti. L’etica del lavoro, la religiosa dedizione alla crescita, impedisce a queste persone di godersi, in pieno riposo, i frutti storici del cambiamento.
Performance è anche messinscena, è anche fingere di lavorare e fingere che sia necessario farlo in qualunque circostanza, come nel caso del Kuwait, dove lo Stato assume mediamente venti persone per fare il lavoro di una e i lavori di cura sono delegati esclusivamente agli immigrati, con conseguenze dannose per la salute mentale delle persone. D’altronde, ricevere la stessa quantità di soldi dallo Stato senza fare almeno finta di lavorare genererebbe nelle persone, dicono gli intervistati di After Work, una sorta di crollo della fiducia negli stessi fondamenti della società di appartenenza. È un dato di fatto che molti lavori siano pagati poco, male o per niente. Possiamo affezionarci a un sistema che ci rende schiavi? Eppure, continuiamo a ritenere che una società sana sia fondata sul sacrificio. Così anche i lavoratori diventano sacrificabili. Se continuiamo a racchiudere nel lavoro il senso della nostra esistenza, non ci libereremo mai dalla schiavitù.
Possiamo affezionarci a un sistema che ci rende schiavi? Eppure, continuiamo a ritenere che una società sana sia fondata sul sacrificio.
Gandini tenta di condurre lo spettatore, una questione alla volta, nei meandri del dibattito sul futuro del lavoro umano. Lo fa forse con eccessiva leggerezza argomentativa, con scarsa profondità di analisi, cercando di fotografare un’istantanea sul dibattito più che di scavare a fondo nella questione o provando a inventare il futuro, per l’appunto. Il regista mette una accanto all’altra le immagini di una sorta di polittico sul lavoro di oggi, con l’obiettivo di registrare quanti più “tipi” umani esistenti. Il film assume tinte più cupe solo nel finale, quando prova a inquadrare il fenomeno delle malattie psichiche derivanti dal lavoro: stress, ansia, depressione, burnout. Eppure, la testimonianza a questo proposito è quella di un solo ragazzo e nessuno degli intervistati riesce ad ammettere a voce alta la possibilità che si possa modificare il nostro rapporto con il lavoro. Forse, ci dice Gandini, e in questo avrebbe un merito, dobbiamo scendere a patti con la consapevolezza che per l’uomo immaginare un futuro senza lavoro è ancora impossibile.
Ci illudiamo che la contemporaneità sia segnata dal crollo di tutte le ideologie forti, di ogni pensiero assoluto che porta a credere nell’esistenza di un principio unificante, motore e generatore di realtà. Ci illudiamo di esserci liberati di Dio e delle ideologie. Ciò di cui ancora non possiamo fare a meno, però, sono le strutture profonde di pensiero che legano la nostra esistenza all’idea che la nostra morte debba essere giustificata. Per superare l’etica del lavoro è necessario, forse, fondare una nuova religione che ci autorizzi a morire serenamente, come i protagonisti del Decameron di Boccaccio, che scelgono di passare i loro ultimi giorni a raccontarsi storie a voce senza trascriverle, in un tempo rigidamente scandito e allo stesso tempo sospeso, per poi tornare a Firenze, dove moriranno certamente di peste. Ridere e lietamente morire, possibilmente senza lasciare tracce.