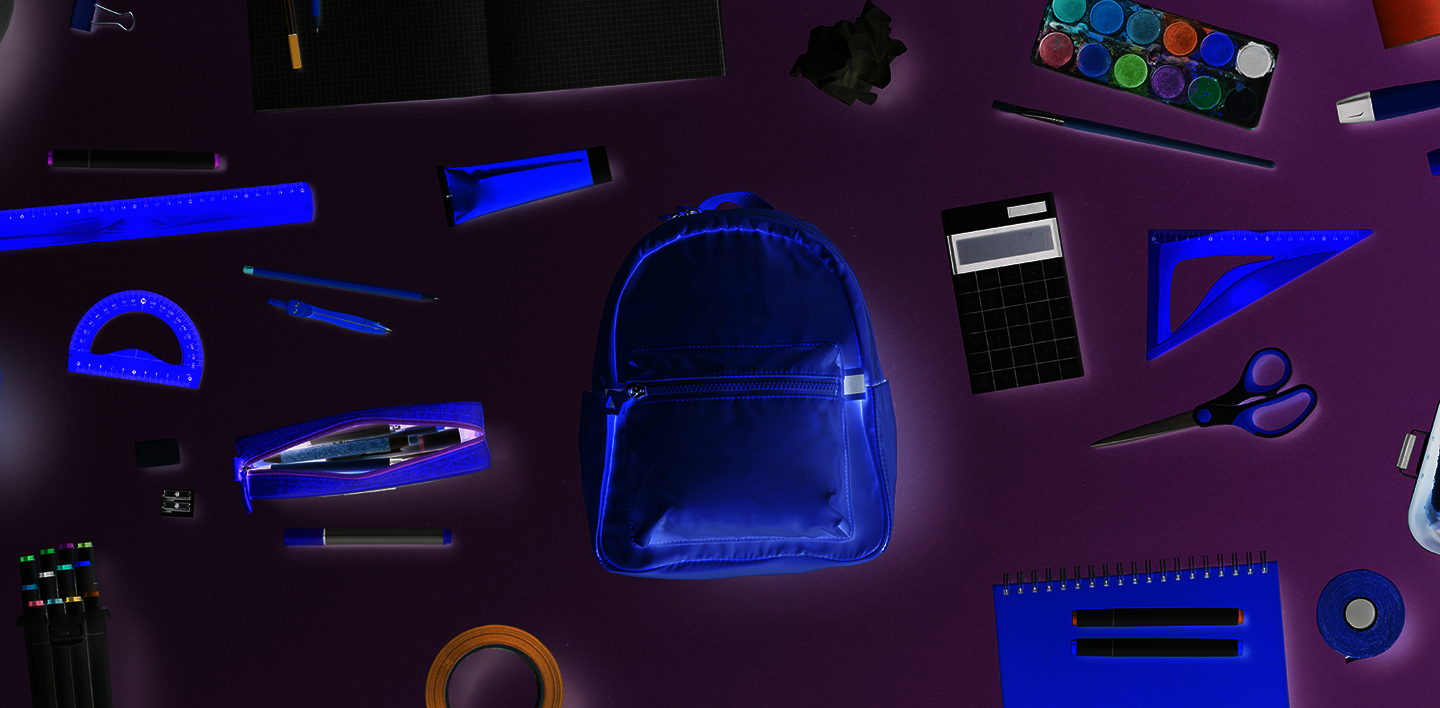
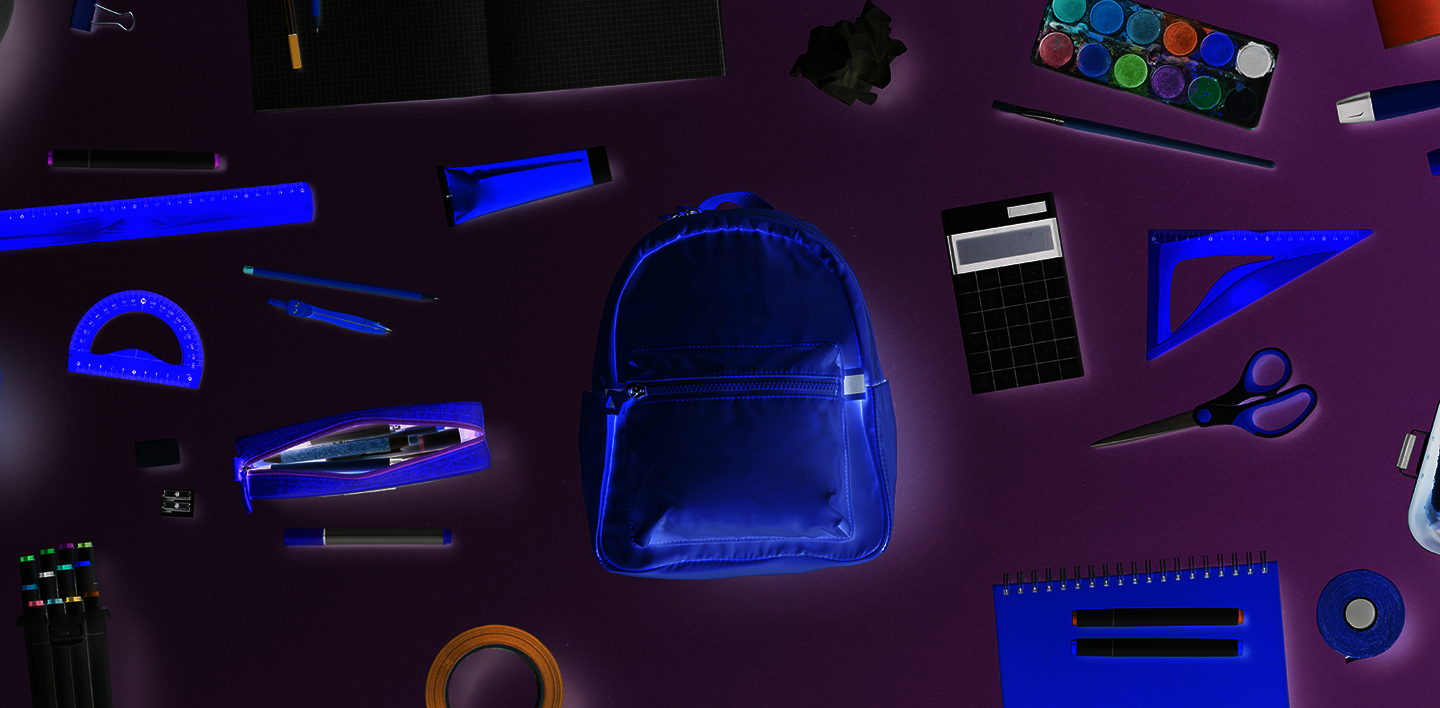
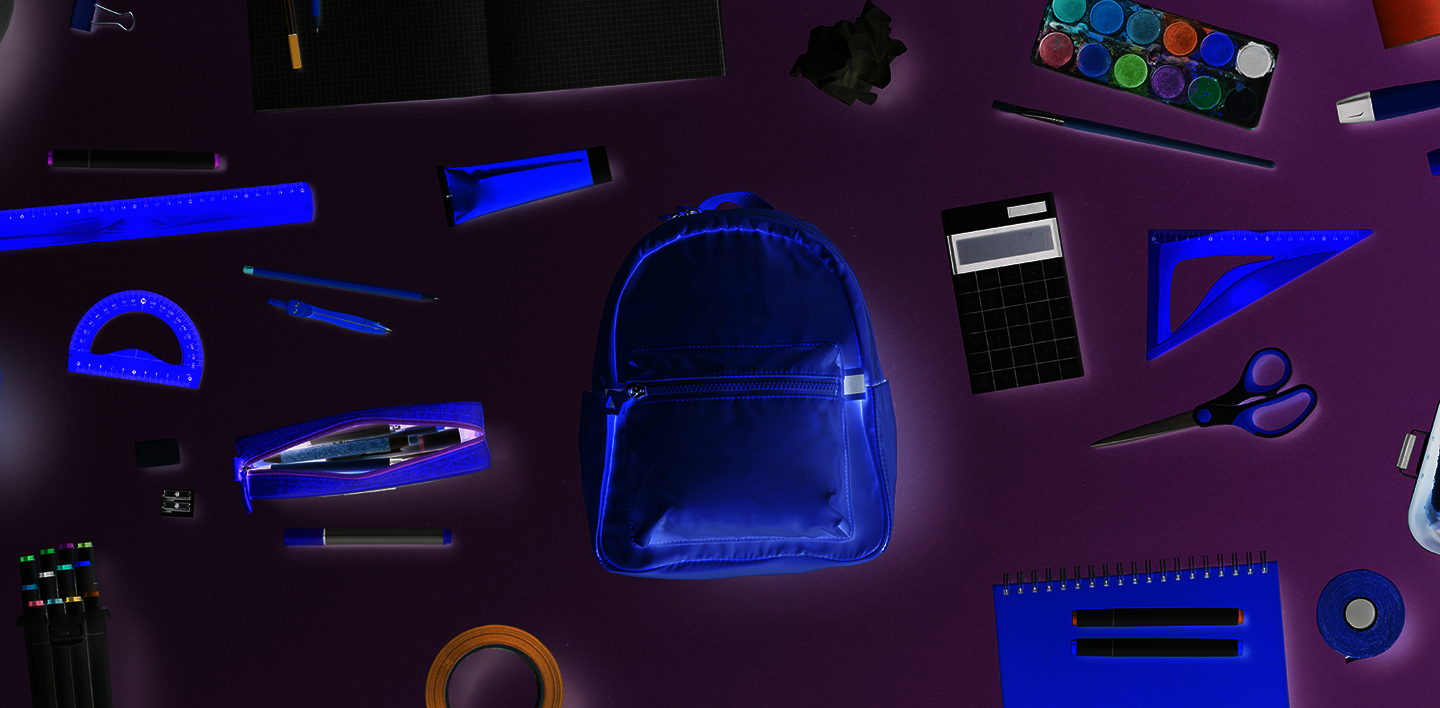
C he della scuola si senta in diritto di parlare chiunque, da Diego Abatantuono a Claudio Santamaria, in una rassegna di non sequitur, petizioni di principio, luoghi comuni e idiosincrasie, è sintomo del grande rumore e diciamo pure dell’anomia dei nostri tempi. Che gli addetti ai lavori e i ministri avvicendatisi al governo, assieme con i settori dirigenziali del paese e del continente (le associazioni di categoria dell’industria e del commercio, i singoli imprenditori) ne parlino, di contro, in un quadro di mero senso comune, è il segno che una parte della società non è per nulla confusa, a riguardo. Quella tra saggi improvvisati ed élite di buon senso è in realtà una contrapposizione fittizia, che compone una diade complementare nella sua funzione discorsiva e politica. Se si osserva il quadro nel suo complesso, infatti, si vede bene come la funzione egemonica della società civile e di quelle voci che hanno un’autorevolezza socialmente riconosciuta (la competenza è un dettaglio irrilevante) preparino un consenso ideologico generalizzato verso la funzione direttiva della società politico-economica, le cui scelte hanno trasformato in senso neoliberista la scuola, il suo mandato sociale e l’originaria funzione democratico-costituzionale.
La scuola di oggi ha dismesso gli strumenti simbolici in grado di conferire un orizzonte civile e politico al senso di un’istruzione di massa.
La scuola di oggi ha dismesso gli strumenti simbolici in grado di conferire un orizzonte civile e politico al senso di un’istruzione di massa, al significato collettivo che l’emancipazione educativa assumeva per chi in passato accedeva alla scuola dopo secoli nei quali l’educazione era riservata a un’élite. L’intera responsabilità educativa (anche e soprattutto nei suoi tratti disfunzionali) è oggi ridotta ideologicamente a responsabilità individuale del singolo studente: la recente scelta di affiancare al termine istruzione la parola merito non è che l’ultimo epifenomeno di un processo ideologico di lungo corso, che da ormai diversi anni inquina il dibattito pubblico (M. Boarelli, Contro l’ideologia del merito, Laterza, 2019).
Secondo questa prospettiva, il principale problema della scuola è da collocarsi nell’orizzonte della formazione anziché in quello dell’educazione o dell’istruzione – si tenga a mente questo scivolamento semantico per nulla secondario, ancorché spesso inavvertito –, ed è sinteticamente riassunto da un anglicismo: mismatch tra formazione e mondo economico, disallineamento tra offerta di competenze tecniche acquisite dalla manodopera e necessità di forza lavoro del sistema produttivo e commerciale. Una circostanza della quale, naturalmente, è sempre e solo la scuola, e in particolare la secondaria di secondo grado (la scuola superiore), a doversi fare carico, poiché è il luogo formativo nel quale si cerca di fare fronte al rapido cambiamento delle competenze tecniche richieste dal settore economico dell’industria e dei servizi. A sentire l’apparato dirigente, il “naturale” sviluppo delle scuole, e in particolare delle scuole tecniche e professionali, dovrebbe dare risposta a questa domanda di innovazione e divenire, senza troppi mezzi termini, un grande corso di formazione. Il processo è già in corso, sebbene la rapidità dei cambiamenti non consenta alla scuola, pachiderma dal provvidenziale ventre molle, di tenere dietro alle richieste dell’ultima innovazione tecnologica. Meglio così, anche se si tratta di una tendenza destinata a logorare gli effetti democratici dell’istruzione di massa. Il vero sogno proibito della classe imprenditoriale europea non è una scuola che educhi ma, secondo la distinzione deweyana, che addestri. Vediamo in che senso.
A sentire l’apparato dirigente, il ‘naturale’ sviluppo delle scuole, e in particolare delle scuole tecniche e professionali, dovrebbe dare risposta alla domanda di innovazione e divenire un grande corso di formazione.
La riforma più recente degli istituti superiori (tracciata dal decreto legislativo n.61, del 13 aprile 2017 e seguenti atti normativi) riguarda le scuole professionali, che, come è noto, raccolgono le iscrizioni degli studenti più deboli dal punto di vista della capacità di concentrazione e di astrazione, spesso appartenenti agli strati sociali più svantaggiati. Proprio per questo gli interventi legislativi e le trasformazioni dell’assetto istituzionale e didattico dei professionali sono un indice particolarmente sensibile di cosa si chiede alla scuola, in termini di obiettivi sociali e civili. È di particolare interesse la lettura delle Linee guida del passaggio al nuovo istituto professionale, lo strumento operativo per chi deve implementare la riforma, dalla quale – limato il gergo pedagogico, ridotto ormai a un espediente eufemistico-burocratico per intorbidire le acque – si trae l’impressione complessiva di un violento classismo, mascherato da un confuso zelo pedagogico paternalista. Il primo obiettivo, candidamente dichiarato, è infatti rafforzare la distanza, e sin dal primo biennio, tra gli istituti professionali e le scuole tecniche, conciliando invece i primi con l’IeFP (cioè con gli Istituti di istruzione e formazione professionale, di durata triennale e di competenza regionale), cosicché siano più agevoli i passaggi degli studenti verso la formazione professionale, nell’ambito della quale gli aspetti di istruzione sono ridotti ai minimi termini. Come a dire: scaviamo una trincea tra chi, a tredici anni, sceglie che il suo futuro sarà quello di cameriere (pardon: operatore del settore dell’accoglienza e del turismo) e chi invece diventerà un quadro tecnico di qualche settore industriale; al limite si può consentire un riorientamento al ribasso, per cui il futuro cameriere può scegliere, attraverso la qualifica professionale regionale, di semplificarsi la vita levandosi dai piedi gli impacci istruttivi. A che pro, del resto, un futuro cuoco dovrebbe confrontarsi con le paturnie linguistiche di Dante o con l’astrazione matematica? E allora, perché ostacolarne il successo formativo con i vecchi cascami scolastici? Perché insistere sulle leggi della fisica quando possiamo avere un buon operaio meccanico o tessile?
Dalla riforma si trae l’impressione complessiva di un violento classismo, mascherato da un confuso zelo pedagogico paternalista.
Un’altra raccomandazione delle linee guida, quasi ossessiva, è l’attenzione alla “vocazione del territorio”, parafrasabile senza troppe perdite semantiche con la forza lavoro necessaria alle aziende del distretto territoriale dell’istituto, la cui attività didattico-formativa, del resto, viene inquadrata attraverso i codici ATECO che rimandano all’ambito di produzione, al pari di qualsiasi altra attività economica, in modo da rendere chiara la spendibilità di chi completa il ciclo di istruzione e favorirne il fantomatico match. Pertanto, ciascun istituto avrà facoltà di manovra nella distribuzione delle ore disciplinari, che potranno essere articolate secondo le esigenze “territoriali”, in armonia con ciò che la Regione di appartenenza indica quanto a necessità di figure professionali. Ciò ha anzitutto una diretta conseguenza didattica: è possibile, ad esempio, abolire l’ora di storia nella prima classe (una sola: la stessa riforma riduce le ore di storia da due a una) per redistribuirla verso altre discipline, percepite come “più utili” alla formazione professionalizzante. Una seconda conseguenza, più generale e sistemica, è che gli istituti sono spinti non solo a collaborare con le Regioni, presso le quali tra l’altro possono accreditarsi come certificatori di percorsi regionali di formazione professionale (vale a dire che uno studente può fermarsi al terzo anno e ottenere la qualifica regionale come se avesse frequentato l’IeFP), ma soprattutto a seguirne indicazioni rispetto agli obiettivi finali e allo sviluppo o al rafforzamento di questo o quell’indirizzo. Le Regioni assumono dunque un ruolo di orientamento inedito in ambito di istruzione: un dettaglio non secondario in un momento storico in cui i tempi sembrano maturi per la regionalizzazione dell’istruzione, di fatto già parzialmente avviata per quanto riguarda gli istituti professionali.
C’è però un’ulteriore indicazione che a mio avviso rivela in modo chiaro, ancorché complicato dalla macchinosità del congegno burocratico, la logica profonda di questa riforma, che attraverso l’alibi pseudo-progressista del successo formativo intende introdurre una consequenzialità naturale tra la scelta di una scuola professionale e la quieta accettazione del ruolo subordinato di manodopera nella società. Mi riferisco alla programmazione per unità di apprendimento (UDA). Funziona così: vengono definite dodici competenze di area generale (ossia di quelle materie che pertengono all’istruzione: lingua e letteratura italiana, storia, inglese eccetera) e dodici professionalizzanti, specifiche per ciascun indirizzo. Esse sono stabilite dal ministero secondo indicazioni europee e rappresentano l’orizzonte di obiettivi che ciascuno studente deve raggiungere al termine del percorso di istruzione. La programmazione didattica di ciascuna materia (ossia il lavoro di progettazione degli insegnanti) dovrà essere organizzata in coerenza con tali competenze finali, in un percorso che va strutturato a partire dalla conclusione.
La riforma, attraverso l’alibi pseudo-progressista del successo ‘formativo’, introduce una consequenzialità tra la scelta di una scuola professionale e la quieta accettazione del ruolo subordinato di manodopera nella società.
Si hanno, così, due fondamentali conseguenze. La prima appare tutto sommato condivisibile – benché solo a un primo livello teorico: si tratta dell’interdisciplinarità delle unità didattiche, che dovrebbero proporre dei pacchetti di insegnamento nei quali le diverse discipline si intreccino e offrano un’organizzazione della conoscenza che valorizzi le interrelazioni tra i saperi. Dunque se si affronta, ad esempio, il funzionamento meccanico di un tornio è possibile far convergere più argomenti di diverse discipline: la storia dell’industria meccanica, il testo regolativo, la comprensione di indicazioni d’uso in lingue straniere, le astrazioni matematiche e fisiche che ne regolano l’attività, e così via. È tutto così pedagogicamente bello… e così didatticamente irreale: la scuola è da lungo tempo sottofinanziata e non ha gli spazi, gli strumenti, le possibilità che tale organizzazione comporta; gli insegnanti, inoltre, non sono pronti per una simile impostazione didattica, che richiederebbe un’adeguata formazione e moltissime ore di progettazione comune, per le quali non è previsto alcun riconoscimento economico. D’altra parte in pochi anni di insegnamento si apprende rapidamente che ogni trasformazione metodologico-pedagogica – che quasi sempre fornisce l’occasione, guarda caso, di una diminuzione della spesa pubblica – ricade sul piano materiale dell’organizzazione del lavoro, nella pressoché totalità dei casi aggravandola.
Per comprendere la seconda conseguenza a proposito dell’organizzazione didattica secondo UDA occorre osservare più da vicino il contenuto delle competenze finali. Lo farò dal punto di vista di un’insegnante di materie umanistiche. Il documento che le riporta, nel complesso, fa a pezzi l’impianto storicistico-idealistico sul quale la scuola è stata fondata sin dalla sua comparsa come istituzione di massa. Il programma storico-diacronico è ridotto a pochi cenni, che fanno pudicamente riferimento alla “diffusione della specie umana nel pianeta”, alle “civiltà antiche e alto-medievali” e alle “Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel Mondo”. Fine. Per il resto, nell’ambito dell’asse culturale storico-sociale, è tutto un fiorire di anacronismi (cui l’editoria scolastica ha prontamente dato seguito, infarcendo i testi di attualizzazioni ardite e discutibili), ristretti, tra l’altro, al campo professionale e territoriale cui pertiene la scuola: “Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi sui servizi e sulle condizioni economiche”; “Problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con il settore produttivo e i servizi in cui si opera”; “Aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici del proprio territorio”.
Ancor più che la storia in sé, tuttavia, è la storia della letteratura che appare violentemente decurtata, laddove invece si insiste molto sui caratteri sincronici della lingua e della letteratura (in particolare della narrativa). Al di là del merito dei problemi posti dall’insegnamento della letteratura incardinato a un’impostazione storica (a proposito del quale il dibattito è complesso e per nulla scontato – si veda, per esempio, la discussione che segue questo articolo), è necessario interrogarsi sulle ragioni profonde di una sparizione per molti versi eclatante, visto che la storia della letteratura e delle forme letterarie, nel dettato desanctisiano e postunitario aggiornato al Novecento, rappresenta l’impianto ideologico che ha guidato alla conoscenza delle lettere milioni di studenti negli scorsi decenni. Un’urgenza che appare tanto più evidente in quanto nelle altre scuole la storia della letteratura non scompare affatto, ed è anzi ancora rintracciabile nelle linee guida per i tecnici e nelle indicazioni nazionali dei licei.
Ogni trasformazione metodologico-pedagogica – che quasi sempre fornisce l’occasione, guarda caso, di una diminuzione della spesa pubblica – ricade sul piano materiale dell’organizzazione del lavoro, nella pressoché totalità dei casi aggravandola.
Nella celebre introduzione al Secolo breve, lo storico britannico Eric Hosbawm scrive: “La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei contemporanei a quella della generazioni precedenti è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono”. In questo eterno tempo presente, che nei primi decenni del nuovo millennio non ha fatto che rafforzare il proprio isolamento, le innovazioni formali della poesia di Leopardi o l’importanza dei Promessi sposi nella storia del romanzo italiano non hanno più senso di essere studiate da chi è destinato al lavoro manuale. Semmai, gli autori del canone andranno compendiati e semplificati nei loro aspetti biografici o nelle loro opere più famose e spendibili, sempre e solo come elementi di conoscenza che possano essere messi a valore nelle professioni per le quali ci si prepara.
C’è da temere, perciò, che la citata interdisciplinarità sia da interpretare non tanto come tentativo di insegnare a osservare la realtà in modo complesso e stratificato, quanto piuttosto come espediente per addestrare a mettere a frutto le conoscenze in un mercato che invade ogni ambito della vita e che sempre di più richiede un supplemento immaginario per rivalutare i prodotti in vendita. Così, nell’insegnare a un alberghiero, ho assistito a diverse cene pirandelliane o ad aperitivi futuristi; ho visto redigere alcuni menu che riportavano le “penne alla Pascoli” o le “fettuccine a Silvia”. Conoscenze disarticolate, curiosità, che confluiscono in uno storytelling giocoso e promozionale, tutto orientato a un’idea di vendita che al prodotto o al servizio fornisce il valore aggiunto di una creatività narrativa semplice e ripetitiva, che affabuli l’interlocutore-cliente. In effetti, nello stesso professionale alberghiero, durante un collegio docenti, la dirigente scolastica (ex professoressa di lingua e letteratura italiana) disse sardonicamente che non capiva perché noi insegnanti di italiano continuassimo a incaponirci con la storia della letteratura, visto che “gli studenti non la comprendono” poiché “non ne intendono il fine”. Avremmo dovuto, invece, puntare molto di più sulla narratologia e sulla lingua (cioè sul programma del biennio iniziale), poiché, quello sì, stimola gli studenti e può essere utile alla loro futura professione di venditori di esperienze. Lo strutturalismo semplificato, il formalismo smart trionfano sulla pesantezza della macchina storicistica. Ho menzionato l’ambito alberghiero da un lato per esperienza personale, dall’altro perché mi pare un settore su cui il nostro paese ha puntato, decisamente e sciaguratamente – vista la miseria salariale e la devastazione dell’ambiente e delle città che provoca. D’altra parte sono evidenti le difficoltà nell’applicazione di un simile modello in un settore che esuli il campo commerciale. Lascio al lettore il compito di immaginare come possa realizzarsi un simile progetto in un professionale meccanico oppure odontotecnico.
Si sta tornando a un’idea di istruzione precedente alla riforma del 1963, cioè a un’era in cui la scuola concepiva se stessa come un organo di riproduzione sociale, che divide brutalmente chi può studiare e chi deve zappare.
Nel film La scuola (Daniele Luchetti, 1995), il grottesco professore di francese Mortillaro ripete continuamente un leitmotiv reazionario: “c’è chi è nato per zappare e c’è chi è nato per studiare.” Quella scuola cinica e dispotica per fortuna non esiste più, ed è per questo che la comicità caricaturale del personaggio è tanto esilarante: il suo pontificare delirante ritorna da un passato ormai sepolto, sotto forma di smorfia. Eppure ho l’impressione che, nel silenzio generale – o forse si tratta di tacita approvazione? –, si stia rapidamente tornando a un’idea di istruzione precedente alla riforma della scuola media unica del 1963, cioè a un’era in cui di fatto la scuola concepiva se stessa come un organo di riproduzione sociale, che divide brutalmente tra chi può studiare e chi deve zappare. La riforma che ho tentato di mettere a critica traccia, dissimulato dal gergo mellifluo, un solco feroce tra due società dai caratteri incommensurabili, che non si incroceranno mai: chi deve studiare incontrerà la scuola, con le sue richieste mnemoniche o di astrazione – certo, talvolta assurde o inattuali –; chi invece è destinato al lavoro incontrerà la formazione, l’alternanza scuola-lavoro e i pacchetti culturali di sapere commerciabile. Dietro l’alibi dell’inclusività vi è in realtà un’inaccettabile rinuncia all’aspirazione, eticamente alta e politicamente importante, di fornire un’istruzione comune a tutti e tutte, anche a coloro che hanno scelto una scuola orientata al lavoro. Istruzione comune che, oltre a fornire un terreno di identificazione collettivo (che in qualche modo crea un, pur problematico, legante sociale) è altresì il luogo a partire dal quale sono attinti gli strumenti di autonomia e consapevolezza per orientarsi nei problemi del presente. Includere Sayef o Luca, iscritti al professionale sulla base di una scelta spesso dettata da condizionamenti o addirittura necessità sociali, non può voler dire incasellarli in un ruolo di manovalanza come se fosse l’unico possibile per loro, come se ne fossero costretti dal fato. O almeno, non può essere questo l’obiettivo di una scuola che si dica libera e democratica. Ammesso che ancora la scuola voglia ancora definirsi tale.