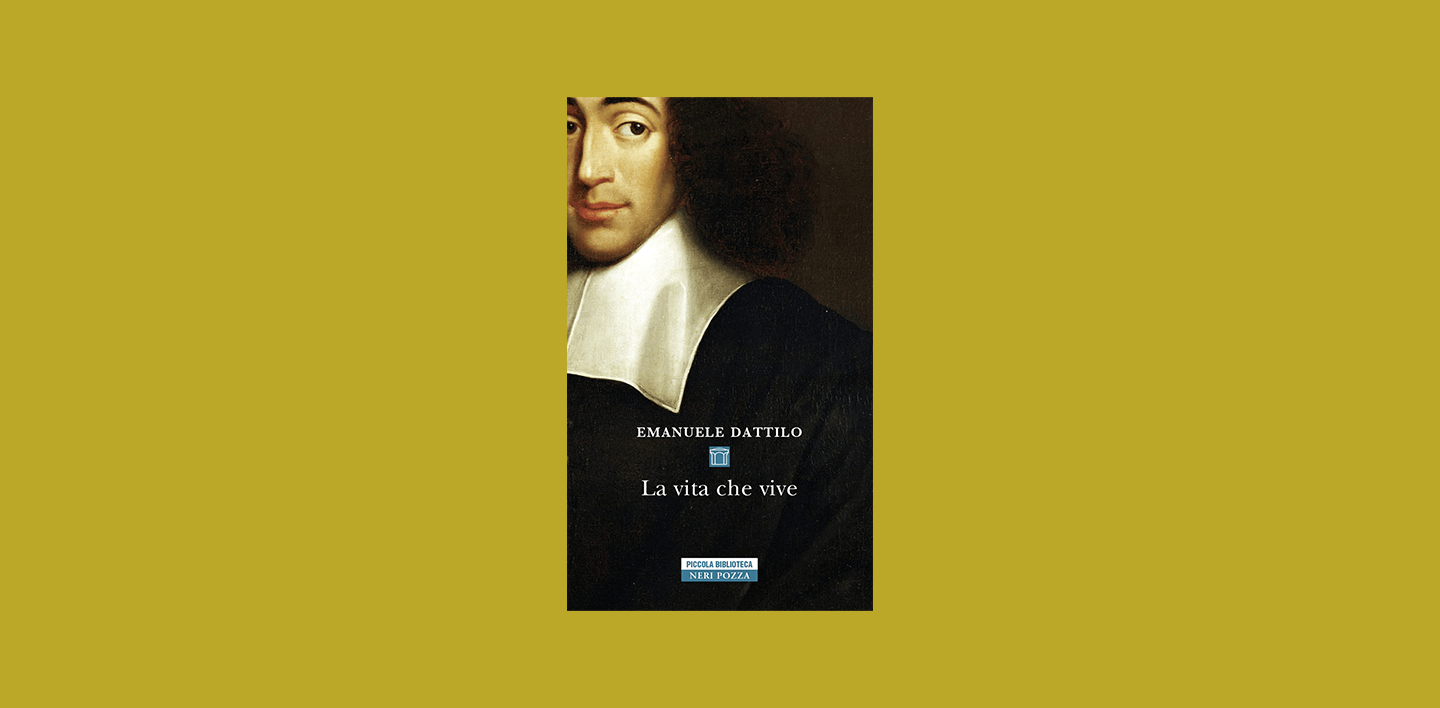L
a vita che vive (Neri Pozza 2022) è il titolo, eloquente e poetico, dell’ultimo lavoro di Emanuele Dattilo. Dopo un poderoso saggio sul panteismo, è giunto questo “piccolo” studio sul desiderio, sulla felicità. Al centro: Spinoza e il concetto di conatus. L’opera che per l’autore è proprio la “formulazione più elaborata, più coerente e più perfetta del panteismo”: l’Etica. Dietro alla proposta filologico-reinterpretativa di Dattilo, il rinnovamento di quella “farmaceutica” dello stesso Spinoza: la ripresa dell’idea antica secondo cui con l’etica non ne va della morale, della volontà e del libero arbitrio, delle leggi, ma della vita felice, della vita buona, della vita bella. Filosofia pratica, come ebbe a dire Gilles Deleuze. Le pagine di questo “libro per tutti e per nessuno” non sono quelle di un’epitome specialistica, nonostante ognuno dei brevissimi, quasi aforistici, ventiquattro capitoli sia denso di raffinatissima conoscenza storico-filosofica e teologica, ma piuttosto ne fanno un breviario di arte della vita, un oggetto d’uso etico esso stesso.
L’incipit è offerto da una delle proposizioni più dirompenti dell’Etica: “L’uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte; e la sua sapienza è una meditazione non della morte, ma della vita” (Eth. IV, prop. LXVII). Radicalissima messa in questione di una tradizione di pensiero che, muovendo dal dualismo corpo/anima (o materia/forma, sensibile/intelligibile, essere/agire, potenza/atto etc.), passando per il cristianesimo e arrivando fino al nefasto essere-per-la-morte heideggeriano, ha fatto della vita nell’al di qua un preliminare (e tutto sommato secondario, valutazione e svalutazione delle opere incluse) momento di passaggio. Non meditazione angosciosa della finitezza, dunque, ma contemplazione lucente di gioia dell’eterno che palpita nell’effimero.
La possibilità di raggiungere questa somma sapienza è data dalla conoscenza della matrice delle nostre azioni. L’essere umano libero è infatti colui o colei (non ce ne voglia Spinoza) che vive secondo il dettame della ragione che indica di “desiderare direttamente il bene”, ossia di agire, ossia di conservare il proprio essere perseguendo il proprio “utile” (Eth. IV, demonstratio, prop. LXVII). La vera quaestio gnoseologica non riguarda gli scopi o i risultati del nostro fare, ma la spinta, l’impulso che lo ingenera. “Cosa ci muove” è la domanda-guida, scrive Dattilo. La ragione pertanto non è quella dei razionalismi volgari che pretendono il distacco (tanto sdegnato quanto morbosamente attratto) dalla sensibilità, dalla carne, e il governo repressivo delle passioni, ma, chiarisce in modo esatto Dattilo, si tratta di una ragione ricettiva, essendo il suo stesso fondamento quella cupidità anteriore a ogni passione che Spinoza chiama conatus.
Secondo la prima definizione che ricorre nell’Etica (III, prop. VII): “Lo sforzo col quale ciascuna cosa si sforza di perseverare nel suo essere, non è altro che l’essenza attuale della cosa stessa”. Mettiamo noi in corsivo “sforzo” per sottolineare, seguendo Dattilo che lascia la parola in latino, la parzialità di questa traduzione. Il Dictionnaire étymologique de la langue latine di Alfred Ernout e Antoine Meillet sostiene infatti che la vicinanza tra conitor (‘sforzarsi’, appunto) e conor abbia influenzato una tale consuetudine; mentre in conor c’è anche il significato del ‘mettersi in cammino’ e poi ‘intraprendere’, ‘provare’, ‘sperimentare’. Scrive allora Dattilo: “Il conatus è un tendere, una tensione iniziale, e in questo senso può essere forse avvicinato al tonos stoico, a quella tensione che percorre musicalmente l’essere e che fa sì che il rapporto tra noi e il mondo sia, anzitutto, un’operazione di intonazione”. Il conatus esprime la nostra e l’essenza di ogni cosa (fuori dal paradigma gerarchico antropocentrico), l’essenza è attuale perché non si aggiunge agli enti, ma coincide con la loro natura. “Tutto ciò che vive, finché vive, desidera mantenere il proprio stato e conservarsi in esso. […] La vita sarebbe, così, l’arte di opporre resistenza a tutto ciò che la minaccia e la consuma, l’insieme delle tecniche che resistono alla morte”. Nell’universale movimento sincronico di mente e corpo, i due attributi tra gli infiniti della Sostanza infinita che a noi è dato conoscere, il pensiero si presenta in questo senso essenzialmente pulsionale e viceversa la materia essenzialmente intelligente, viva.
Con l’etica non ne va della morale, della volontà e del libero arbitrio, delle leggi, ma della vita felice, della vita buona, della vita bella.
Dattilo ci guida nel suo scavo storico-genealogico, qui più contratto rispetto al precedente Il dio sensibile. Oltre il debito (nella differenza) con Thomas Hobbes, il precedente del conatus è da ravvisare nell’appetitus sese conservandi rinascimentale (Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Francesco Patrizi); prima ancora, l’idea di una “materia vibrante”, ossia la panteistica univocità dell’essere, riconduce agli “eretici” Amalrico di Bène e, soprattutto, David di Dinant (di cui l’autore ha da poco curato un’edizione singola del frammento dei Quaternuli titolato Mens Hyle Deus), dunque all’affermazione di un’identità di tipo dinamico tra mente e materia che fa saltare la differenza ontologica tra Creatore e creato, che fa saltare, cioè, lo stesso mito della creatio ex nihilo.
Dio diventa allora il nome della natura, della sua infinita (eterna e increata) produttività (Natura naturans) – tutt’altro che immateriale, Egli è anche estensione. I modi finiti (Natura naturata) sono affezioni o modificazioni della Sostanza. Il discorso teologico fondato sul rapporto analogico o metaforico evapora (su questo insiste Dattilo sia ne Il dio sensibile che nella Introduzione al frammento di David): venuto meno lo scarto ontologico tra Entità divina e creature, viene meno anche quello linguistico. Affiora piuttosto, aggiungiamo noi, il piano di immanenza di una rete di infiniti nessi metonimici (parti per il tutto, parti del tutto), il pulsare luminoso, espressivo, relazionale di ogni essenza singolare. Nulla è esteriore all’Essere: questa è l’ontologia che non consente più né morale né teleologia con Bene e Scopo finale quali istanze superiori alla Natura. Istanze fantasmatiche, che si dissolvono con l’acquisizione della conoscenza razionale. Scrive Dattilo commentando i Cogitata Metaphysica I, 6: “il bene ha una natura dinamica, ha cioè a che fare con la nostra potenza e con il movimento; il contaus già possiede il suo bene, ciò verso cui tende, e in qualche misura coincide con esso”.
La dinamica in questione è quella della stessa essenza singolare, che coincide con la sua potenza, con l’espressione di ciò che è, ossia di ciò che può fare, della sua capacità di agire (potentia agendi, infatti). L’universo è una gradazione differenziale di potenze, interconnesse (secondo naturalistici rapporti di composizione e decomposizione), già sempre agenti, che nell’agire si modificano a vicenda. Quello che viene definito il determinismo di Spinoza consiste in questa eterna catena di azioni e reazioni, cause ed effetti, che però è anzitutto una catena energetica, di relazioni tra forze. Ciò che ci sta più a cuore qui è l’indice affettivo che la innerva: a ogni modificazione del corpo corrispondono un aumento o una diminuzione della sua potentia agendi e, nella mente, l’idea di questa medesima affezione; quel che ostacola il perseverare nel proprio essere sarà fonte di tristezza, quel che lo agevola e incrementa, fonte di gioia. Nello spazio di questa fluttuazione si gioca l’etica. Si capisce allora perché la conoscenza debba farsi affettiva, per compiersi propriamente. Non c’è efficacia o felicità in una “conoscenza contro gli affetti” – un sapere che non sente o è sterile, non tangendo affatto la dinamica della potenza o, peggio, produce diminuzione di potenza (quante volte in un’analisi non si riesce a disinnescare la coazione a ripetere nonostante l’intelletto sembrerebbe averne afferrato il meccanismo?). “Non basta conoscere la verità, ma bisogna che essa si radichi nell’affetto fondamentale, nel conatus – occorre, cioè, che la verità appresa ci faccia sentire vivi”.
Cupiditas chiama Spinoza l’appetito (cioè il conatus) consapevole di sé. È anzitutto la conoscenza di questa coscienza di sé che deve trasformarsi in affetto. Ricordiamo la domanda fondamentale: “cosa ci muove?”. Solo questa conoscenza prima può guidarci nel percorso di libertà, ossia di liberazione dalla conoscenza confusa dell’immaginazione e dalla dimensione passiva degli affetti (le passioni, appunto). Libero o libera è chi ha idee adeguate delle cause di affetti e fenomeni (secondo genere di conoscenza), la cui gioia o incremento di potenza è esito di un fare mosso da attività; beato o beata (terzo genere di conoscenza), chi intuisce e contempla il canto polifonico della totalità – aperta e sempre in movimento – delle essenze singolari, ossia l’eterna potenza o perfezione di Dio. O anche: la vita che vive. Risulta ora chiaro perché il conatus non sia il semplice istinto di autoconservazione, né, prosegue il nostro autore, è da considerarsi coincidente con l’antica philautia o con il narcisismo primario: il conatus “si esprime in qualcosa di ancora più originario che l’istinto sessuale o la fame”. “Implica un soggetto panteistico: l’essenza eterna”.
Non c’è efficacia o felicità in una “conoscenza contro gli affetti”.
Desiderare “direttamente il bene”, ricercare il proprio “utile” nulla hanno a che fare con la reintroduzione di un pensiero finalistico, nel primo caso, né con un’etica utilitaristica, di tipo strumentale, nel secondo. Bene e utile – parole che, entrando nella sfera del terzo genere di conoscenza (Eth., V), vanno infatti in dissolvenza – nominano l’accrescimento di potenza, l’affermazione dell’essere, l’aderenza sempre più perfetta alla propria essenza. Si è forse piuttosto di fronte al paradosso di fini immanenti ai mezzi. Il conatus si rivela allora fondamento insieme ontologico e politico del mondo: “Il bene che ciascuno, che segue la virtù, appetisce per sé, egli lo desidererà anche per gli altri uomini, e tanto più quanto maggiore è la conoscenza di Dio che avrà acquisito” (Eth., IV, prop. XXXVII). Nulla è più utile all’essere umano dei suoi simili (Eth., IV, scholium, prop. XVIII e corollarium II, prop. XXXV): amicizia, coalizione, integrazione di individui in individui più grandi agevolano l’incremento di potenza e la capacità di essere affetti secondo la propria natura (il concetto astratto di individuo è una fictio del resto, date le continue variazioni generate dai rapporti di composizione e decomposizione in natura, che ne fanno, piuttosto, un equilibrio metastabile).
Ancora nello scolio alla proposizione XXXV: “l’uomo è un Dio per l’uomo. […] [D]alla comune società degli uomini derivano assai più vantaggi che danni. I Satirici si facciano dunque beffe quanto vogliono delle cose umane, e i Teologi le detestino, e i Melanconici lodino, quanto possono, la vita incolta e agreste, disprezzino gli uomini e ammirino i bruti; essi tuttavia sperimenteranno che gli uomini possono procurarsi molto più facilmente coll’aiuto reciproco ciò di cui hanno bisogno, e che solo con forze unite possono evitare i pericoli che incombono dappertutto […]”. Così Dattilo: “La novità dello spinozismo è stata fare del conatus […] il principio di ogni comunità e di ogni stare insieme tra gli uomini”.
Poche pagine dopo Dattilo dismette però “ogni domanda sul che fare”, in quanto a monte “mal formulata”, e onde evitare i rischi insiti in una lettura eccessivamente ideologizzante di Spinoza (la distanza dalle interpretazioni più politiche è infatti esplicitata più volte): circoscrivere goffamente di nuovo in una concezione fatta di regole e precetti (in fondo nuovamente moralistici) volti al raggiungimento di un fine esteriore (seppur condivisibile) la grandezza metafisica di Spinoza, la stessa vita che vive. “[I]l bene non consiste in qualcosa, ma nella capacità di afferrarlo, di riconoscerlo, in modo autonomo, al di là di dove si presenta”. L’iniziato che abbia bevuto il ciceone può fare a meno delle “regole sancite, su cui si fonda il vivere associato”. “La sua acquisita attenzione etica testimonia qualcosa di assolutamente eterogeneo, e di incompatibile con l’allucinato mondo socializzato”.
Riconoscere il bene: un altro modo di dire tiqqun? Il processo di riparazione messianica del mondo secondo la dottrina qabbalistica di Yitzchaq Luria, per come Dattilo lo ha letto sul finire del suo saggio sul panteismo: “il tiqqun non è un’azione speciale, non vi sono particolari gesti che vanno compiuti per riparare il mondo, poiché non si tratta di riparare ciò che è rotto – ma è qualcosa che compiamo perfino in quel più semplice e profano mistero – che era, come diceva Hegel, il contenuto dei misteri greci – di ‘mangiare pane e bere vino’”. Non “uno stato di cose giusto da realizzare”, dunque, ma una “vitalità che giace nascosta negli oggetti” da “intercettare”.
Amicizia, coalizione, integrazione di individui in individui più grandi agevolano l’incremento di potenza e la capacità di essere affetti secondo la propria natura.
Tornando a Spinoza, Dattilo si serve del Breve trattato su Dio, l’uomo e il suo bene, dei già menzionati Cogitata Metaphysica e dell’Epistolario, arrestandosi sempre un attimo prima del 1670: di qui al 1677 Spinoza scrive il Trattato teologico-politico, continua a lavorare all’Etica e inizia il Trattato politico che, col sopravvenire della sua morte, rimarrà incompiuto. L’idea della “vita vera”, per fare riferimento a un altro testo degli anni Sessanta, il Trattato sull’emendazione dell’intelletto, come esito di una ascesi intellettuale che in fondo richiede l’esodo dalla politica mondana, non viene in seguito profondamente ripensata da Spinoza? La grandezza del Trattato teologico-politico, dell’Etica stessa e del Trattato politico – con le dovute differenze tra i tre – non sta anche, e non secondariamente, nell’abolizione delle separazioni gerarchiche tra ambiti del sapere? Non più filosofia prima e filosofie seconde – secondo una distinzione ricalcata poi a lungo anche dagli studi spinozisti, tra metafisici e politici appunto –, ma un’ontologia che è già politica, e politica ed etica come eminenti campi di espressione della natura umana.
La riflessione sulla democrazia come “Stato più naturale” ci indica questo (Tractatus theologico-politicus, XVI); come forma associativa e istituzionale, scriverà poi Spinoza nel Tractatus politicus (V, 6, 5), propria di “una moltitudine libera” che abbia cioè di mira la “vita”, che “si ingegn[i] a vivere per sé”, cioè secondo ragione, cioè secondo la “vera virtù e la vita della mente”. Dall’Eth., IV, scholium, prop. XVIII:
Nulla dico di più eccellente per conservare il proprio essere gli uomini possono desiderare se non che tutti si accordino in tutto in modo che le menti e i corpi di tutti formino quasi una sola mente e un solo corpo, e tutti si sforzino insieme, per quanto possono, di conservare il proprio essere, e tutti cerchino insieme per sé l’utile comune di tutti; donde segue che gli uomini che sono guidati dalla ragione(…) non appetiscono nulla per sé che non desiderino per gli altri uomini.
Il passaggio dall’immaginazione alla ragione è anche il passaggio dai rischiosi giochi emulativi e proiettivi dell’imitatio affectuum – basati sulla similitudo, su una conoscenza non ancora chiara e distinta che pertanto tende all’uniformazione dell’alterità o alla cristallizzazione di identità contro altre – alla convenientia, alla convergenza razionale nella differenza delle essenze singolari. Tanto maggiore è la conoscenza di Dio, tanto più si conviene – di nuovo secondo la proposizione XXXVII. All’aumento dell’autonomia e della potentia agendi individuali corrisponde una coalizione più stretta e più ampia con altri, d’altra parte – torna il rapporto chiasmatico –, l’incremento della potentia agendi collettiva, l’associazione guidata da ragione, significano accrescimento di quella individuale, avanzamento nel processo di liberazione di ciascuno.
L’agire politico allora è da intendersi, secondo chi scrive, come un momento intermedio sulla via della saggezza, della beatitudo. E se è da respingere la volgarizzazione del pensiero panteistico che vuole tutto confusamente “unito e connesso al resto”, ci chiediamo tuttavia se la scientia intuitiva del terzo genere di conoscenza sia contemplazione delle cose nella loro “assoluta irrelatezza” o, piuttosto, nella loro autonoma, paradossale e perciò sublime, relazione. Irriducibile singolarità di ogni essenza in cui riluce Dio e che in Dio risiede, infinita potenza della Natura naturans: germinare eterno di rapporti e rapporti di rapporti, splendore della differenza di ciascuna cosa singolare in questa trama universale e necessaria.
L’incremento della potentia agendi collettiva, l’associazione guidata da ragione, significano accrescimento di quella individuale, avanzamento nel processo di liberazione di ciascuno.
Concludiamo pensando a Elsa Morante, che Emanuele Dattilo richiama, insieme ad Anna Maria Ortese, come altissimo esempio letterario di “contemplazione della vulnerabilità di tutto ciò che è vivo”; in particolare a La Storia. “La storia, si capisce, è tutta una oscenità fin dal principio”, ma poi accade che ci siano anni più osceni di altri, in cui innumerevoli, troppe combinazioni nocive producono concatenazioni immani di distruzione, stupro, annichilimento della vita. Se non si riesce a ostacolare chi ostacola la felicità, la scientia intuitiva più difficilmente si offre, il conatus si esaurisce: si può riconoscere ancora il bene, nel genio dell’infanzia, questo è il caso, che seppure intimamente turbato dall’orrore della Storia, ancora non ha perso la ricettività gioiosa, la sensibilità immediata della parola poetica che canta il mondo, ossia “la somiglianza di tutte le cose”, dal “verme” a una “paglia”, fino a Dio – “Dio, ossia la natura” –; si riconosce il bene, ma non lo si riesce più a desiderare, non si è più capaci di desiderare. “Io desidero che Dio NON esista. Desidero che di là non ci sia più niente, e basta. […] Io desidero non essere più”. “Di fronte a questa oscenità decisiva della Storia, ai testimoni si apr[ono] due scelte: o la malattia definitiva, ossia farsi complici definitivi dello scandalo, oppure la salute definitiva – perché proprio dallo spettacolo dell’estrema oscenità si p[uò] ancora imparare l’amore puro…” .
Così canta il piccolo Useppe, dall’indelebile segnatura tragica – “piccole”, “tante” poesie, come il baluginare dell’eterno nel transitorio:
Le stelle come gli alberi e fruscolano come gli alberi.
Il sole per terra come una manata di catenelle e anelli.
Il sole tutto come tante piume cento piume mila piume.
Il sole su per l’aria come tante scale di palazzi.
La luna come una scala e su in cima s’affaccia Bella che s’annisconne.
Dormite canarini arinchiusi come due rose.
Le ‘ttelle come tante rondini che si salutano. E negli alberi.
Il fiume come i belli capelli. E i belli capelli.
I pesci come canarini. E volano via.
E le foie come ali. E volano via.
E il cavallo come una bandiera.
E vola via.
La vita che vive.