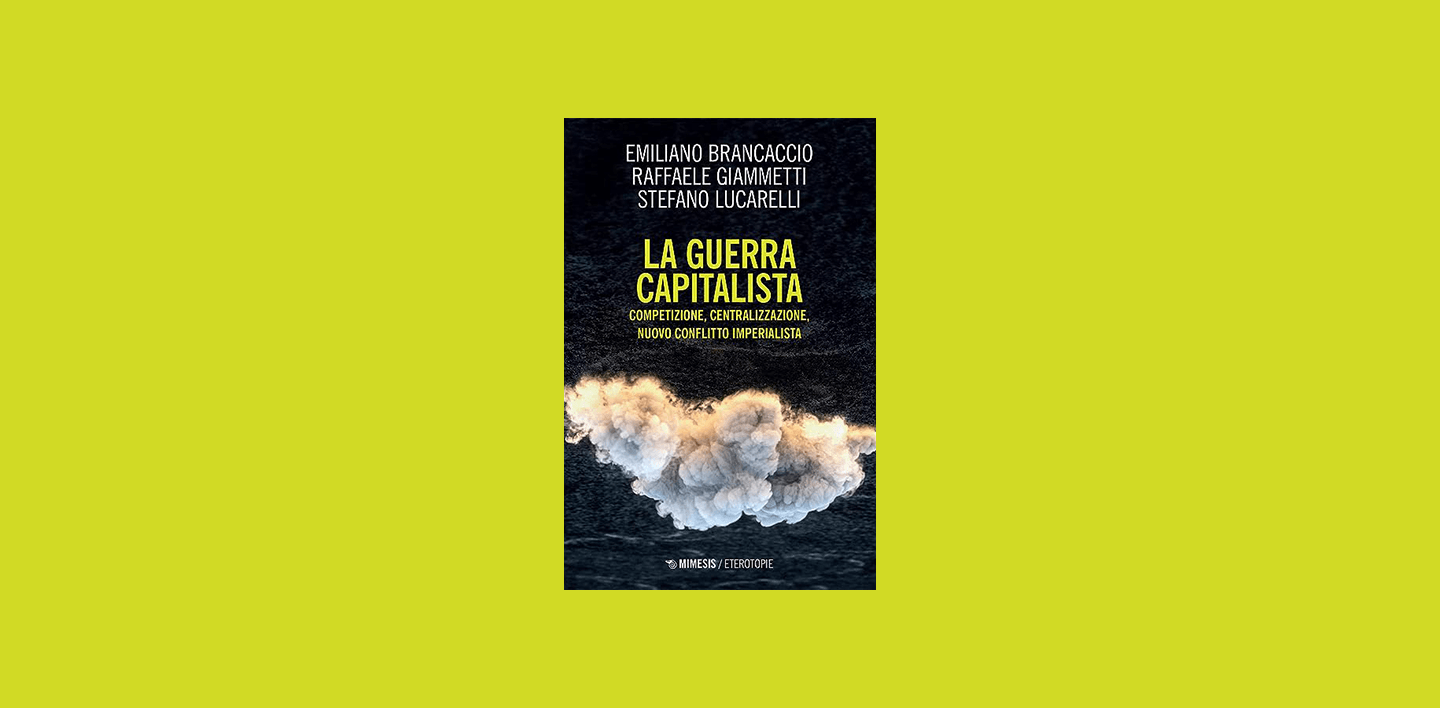
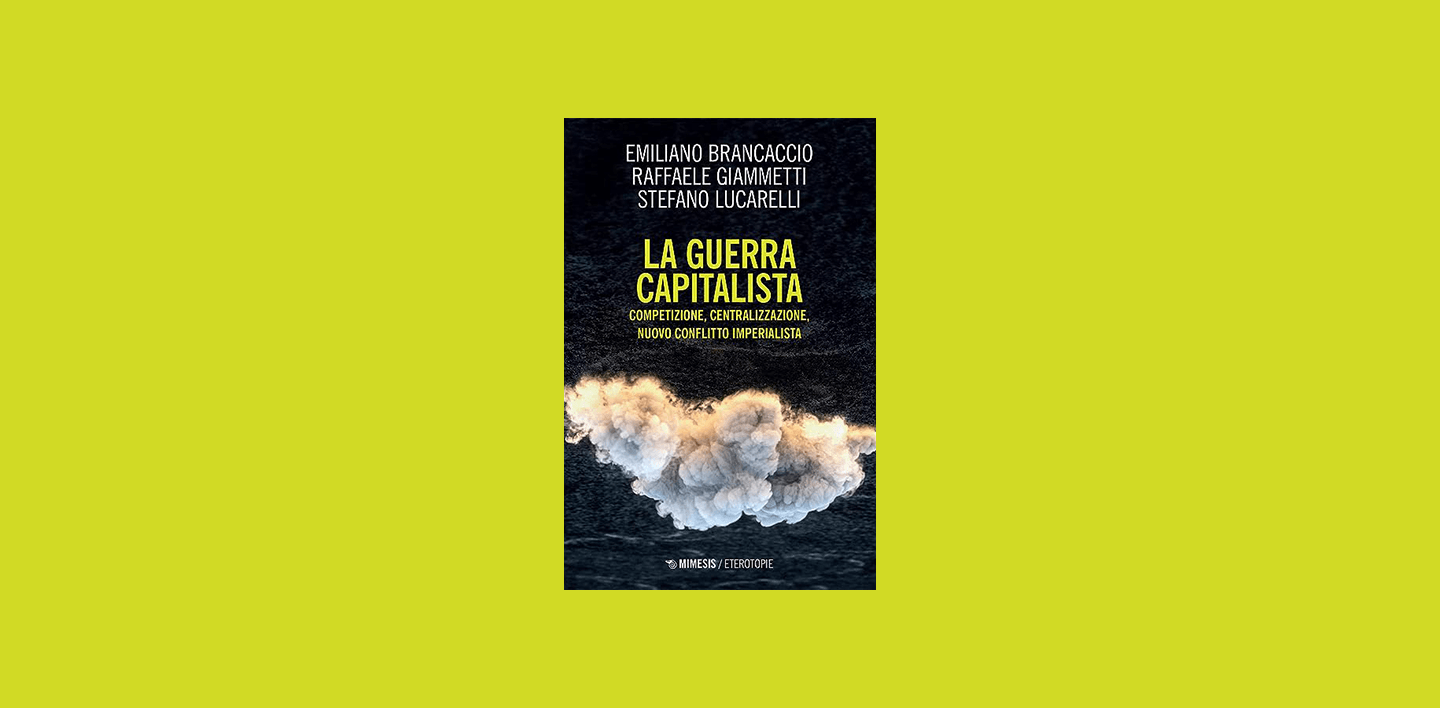
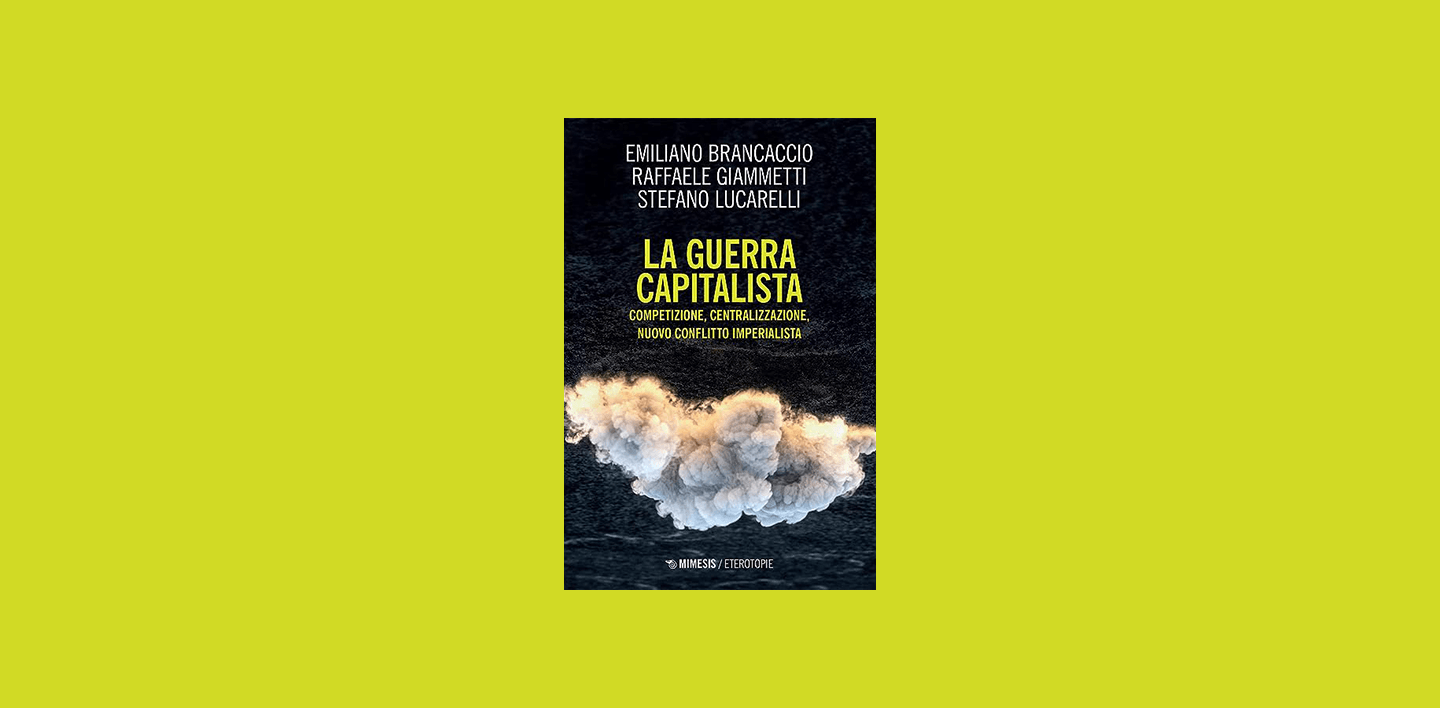
M ai il pacifismo è stato così timido e vergognoso nei paesi europei. E non solo a causa della consueta campagna mediatica che appoggia in tutti i paesi le decisioni dei governi di sostenere Zelensky inviando armi, ma perché i movimenti, le persone che li compongono, gli intellettuali, gli attivisti sono dilaniati dalle impasse contraddittorie.
Il sentire comune in questi circuiti sulla consistenza della storia coloniale e dei suoi effetti sul presente tende a individuare nella cultura e nella società occidentale l’unico responsabile dell’ingiustizia sociale globale, interpretando le azioni violente perpetrate da paesi asiatici, africani o sudamericani ai danni delle popolazioni o delle classi più fragili come il prodotto storicizzato della cultura coloniale. In questa prospettiva, il land grabbing di matrice araba o cinese che sta consumando i territori fertili centrafricani o del sudest asiatico è un fenomeno ascrivibile alla sfera del vecchio colonialismo più che una forma neocoloniale: è inutile indicare nuovi aggressori, sono soltanto burattini manovrati dai pupari di sempre. Per fugare ogni altro possibile dubbio, anzi, un fortunato filone di ricerca prodotta nei dipartimenti di postcolonial studies si affanna a dare evidenza scientifica all’idea che il neocolonialismo cinese sia frutto della pura invenzione occidentale, smentita dalla percezione delle popolazioni che ne sarebbero in teoria soggette.
Quale migliore occasione della guerra in Ucraina per dare vigore a queste argomentazioni, si sarebbe detto? Una situazione in cui un Occidente che ha intrapreso o coperto politicamente e militarmente decine di guerre in ogni parte del mondo in barba ai diritti umani esige continue condanne e sanzioni da tutti i paesi del mondo nei confronti delle violenze perpetrate da Putin, e viene platealmente sconfessato da quasi la metà degli stati membri dell’ONU – la maggioranza dei non occidentali? Un quadro la cui pericolosità cresce di settimana in settimana, e nel quale il perenne strombazzamento da parte NATO della difesa dei valori democratici e di giustizia sociale viene delegittimato dai due terzi della popolazione mondiale, a mano a mano che le forniture di armi raggiungono livelli quantitativamente e qualitativamente più inaccettabili (dopo i tank e i droni, l’uranio impoverito e le bombe a grappolo)?
Ma invece di dare rilievo alla potenza di questa presa di posizione insolitamente ampia, che unisce Cina e India a Brasile, Cuba e un grandissimo numero di stati asiatici e africani, si è preferito impelagarsi nelle sabbie mobili dell’invasione territoriale (“C’è un aggressore e un aggredito!” “No, viene prima il massacro da parte ucraina in Donbass!”. Ma non si era tutti antisovranisti a prescindere? La nazione e i confini territoriali non erano il demonio, pane per i denti neofascisti?) o dei valori progressisti (i russi discriminano persone e comunità LGBTQ; gli ucraini invece gli ebrei) o dei “due imperialismi” in stile guerra fredda, USA contro Russia (e la Cina? Omessa perché complica le cose).
Mai il pacifismo è stato così timido e vergognoso nei paesi europei.
Tutte posizioni talmente contraddittorie e ristrette da tagliarsi le gambe da sole: le discussioni troppo approfondite rischiano di incrinare quelle certezze così facili da comporre in una biennale d’arte contemporanea o nella letteratura accademica di maniera, safe spaces in cui la colpevolezza assoluta occidentale si sposa perfettamente con l’intersezionalità e le popolazioni subalterne globali non vogliono altro che un mondo privo di discriminazioni di classe razza e genere.
E così si preferisce tacere, annullare in partenza ogni dibattito per preservare intatte quelle idee rassicuranti ed evitare, per un eccesso di imprudenza, di essere accusati di complottismo o complicità con il regime oligarchico e il machismo di Putin. Paradossalmente in questo distopico universo reputazionale le culture wars appaiono molto più pericolose delle guerre reali, e in un incredibile rovesciamento delle priorità gli ambienti della sinistra intellettuale e sociale ritengono molto più importante per la propria sopravvivenza mantenere un profilo basso e parlare d’altro – cioè mettere al sicuro il proprio capitale simbolico – che esporsi per combattere un potenziale conflitto nucleare o una crisi geopolitica ed economica mondiale. Esattamente come era successo con il Covid.
La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista [nel quale è stata ripubblicata questa intervista con la redazione del Tascabile, n.d.r.] di Emiliano Brancaccio, Raffaele Giammetti e Stefano Lucarelli è una risorsa straordinaria per uscire dal pantano, perché imposta la discussione su un piano completamente diverso, più alto e al tempo stesso più materiale che etico, rivelando l’urgenza assoluta di prendere posizione e reclamare la pace per mezzo di strumenti di politica economica.
La guerra, secondo gli autori, è un conflitto globale tra paesi debitori (USA e occidente) e paesi creditori (Cina e altri paesi orientali, tra cui in misura minore la Russia): non ci sono buoni e cattivi. Nell’attuale ordine economico mondiale fondato sul libero mercato, infatti, non regna, come dice la favoletta neoclassica, l’equilibrio, ma il suo opposto: una divaricazione crescente tra vincitori e perdenti, tra paesi creditori che “liquidano e assorbono i debitori a colpi di esportazioni di capitali, acquisizioni e fusioni” e paesi debitori che a un certo punto, per difendersi dai meccanismi del mercato deregolato che essi stessi hanno creato, attuano politiche protezioniste, le quali storicamente hanno altissime probabilità di sfociare in guerre militari.
Nel libero mercato non regna l’equilibrio, ma una divaricazione crescente tra paesi creditori e debitori che, per difendersi dai meccanismi del mercato deregolato che essi stessi hanno creato, attuano politiche protezioniste, con altissime probabilità di sfociare in guerre militari.
Attualmente gli USA, esposti verso l’estero per oltre il 60% del loro Pil, rappresentano il fronte più agguerrito del protezionismo unilaterale: il cosiddetto friend shoring (fare affari con gli amici), cioè l’imposizione di restrizioni e sanzioni sugli scambi con paesi “non amici”, è una politica inaugurata ben prima dell’avvento di Trump – negli anni di Obama, per la precisione – e cresciuta senza sosta fino a Biden, fino a produrre questo conflitto armato per ora limitato al fronte russo-ucraino.
In questo scenario la Cina, che è l’oggetto principale delle sanzioni soprattutto sul settore dell’alta tecnologia, cerca a tutti i costi di imporre il primato del mercato deregolato, battendosi con ogni mezzo per difendere l’ordine economico neoliberale, che le ha permesso di diventare egemone in qualità di grande creditore ed esportatore. Nel frattempo, naturalmente, contrattacca con altre sanzioni che possono mettere in ginocchio interi settori dell’economia occidentale e non solo.
È intuitivo comprendere che questo è un gioco suicida: forse avremmo bisogno di una nuova edizione di War Games con le sanzioni al posto delle bombe termonucleari e il computer primitivo ma precocemente intelligente Joshua che si fa altre due-trecento partite a tris alla velocità della luce e poi con la sua voce meccanica sentenzia ancora una volta che nessuno può vincere.
Per capire come siamo arrivati a questo punto bisogna tornare a Marx, e in particolare alla sua legge di centralizzazione dei capitali, a lungo sottovalutata dagli stessi studiosi marxisti e “riscoperta” non in qualche oscuro dipartimento universitario (non solo) ma dal gotha del capitalismo globale. Negli ultimi anni Financial Times, Economist e Wall Street Journal fanno a gara a chi la cita di più. Finanzieri, politici e banchieri conosciuti per le più efferate politiche di austerity riconoscono apertamente che la libera competizione tra capitali genera una selezione feroce tra vincitori e vinti, e che il soccombere dei pesci piccoli (i debitori che falliscono e vengono assorbiti dai pesci grandi) produce un’inesorabile concentrazione della ricchezza in sempre meno mani. Deregolamentare il mercato aumenta cioè le disuguaglianze e gli squilibri di potere, e a grande scala la centralizzazione non può che innescare crisi geopolitiche.
Per capire come siamo arrivati a questo punto bisogna tornare a Marx, e in particolare alla sua legge di centralizzazione dei capitali.
La ricerca scientifica in campo economico, in particolare tramite l’analisi dei network proprietari, continua a dare evidenza empirica al mantra che risuona dalla crisi del 2008: circa l’80% del capitale azionario mondiale si trova effettivamente nelle mani del 2% degli azionisti, e la tendenza è verso un’ulteriore centralizzazione. Il che rende il regime capitalistico sostanzialmente incompatibile con l’ordine democratico, “anche semplicemente inteso nel senso occidentale e liberale del termine”.
Prima che questa escalation peggiori in modo irreversibile, sostengono Brancaccio, Giammetti e Lucarelli, urge trovare un nuovo accordo internazionale multilaterale teso a neutralizzare i due imperialismi: quello protezionista dei debitori e quello ultraliberista dei creditori. Un accordo che porti esplicitamente alla ribalta il ruolo della politica intesa come azione sul piano materiale e non puramente simbolico, e che imponga una sorta di “repressione finanziaria”, limitando i movimenti di capitale e compensando gli squilibri nelle bilance dei pagamenti dei diversi stati.
Chi ritiene che un accordo del genere sia inconcepibile, sopraffatto dall’introiezione del principio thatcheriano del TINA (There Is No Alternative), farebbe bene a ripensare che, seppure in una versione imperfetta, nel 1944 furono attuati gli accordi di Bretton Woods. Solo che allora furono necessarie due guerre mondiali per ottenerli, e sarebbe nel nostro interesse arrivarci prima della prossima, invece di arroccarsi su un’idea di riformismo “dei piccoli passi” tutto interno all’ideologia del capitale.