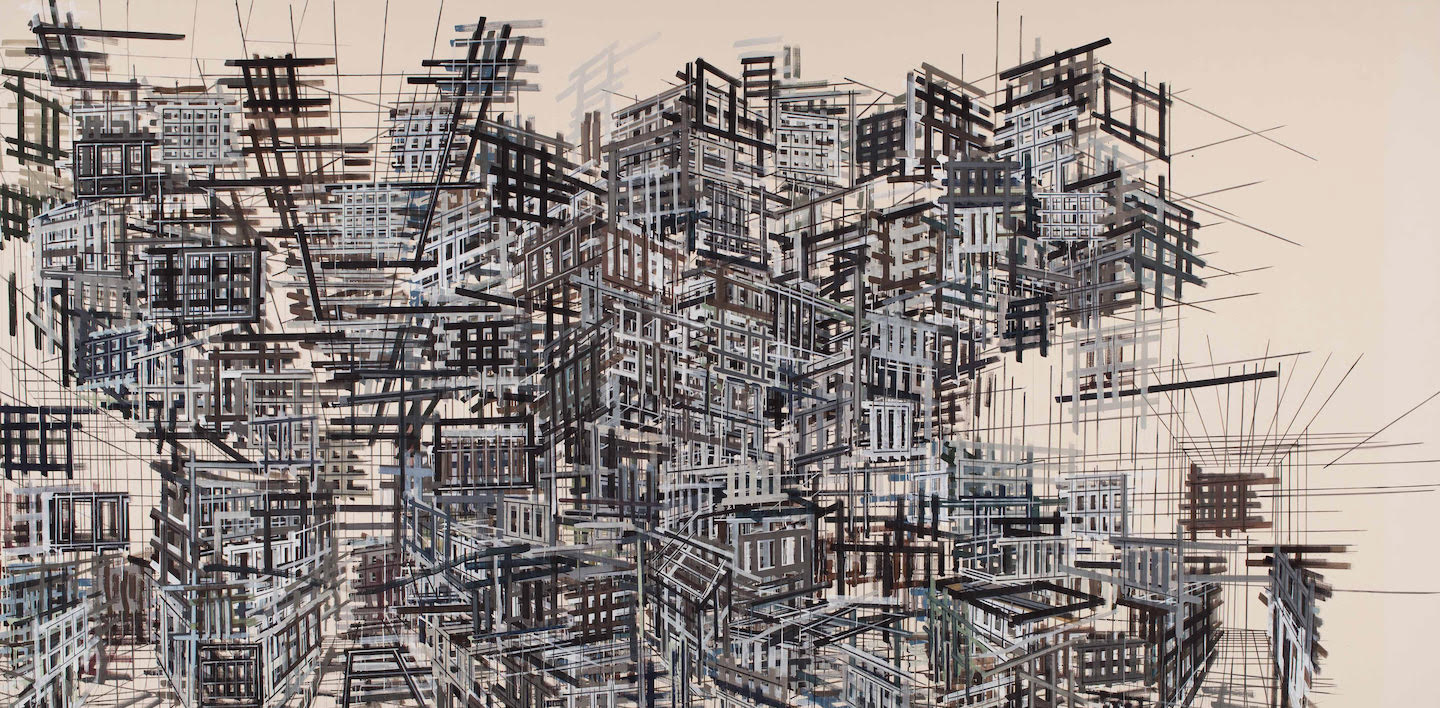
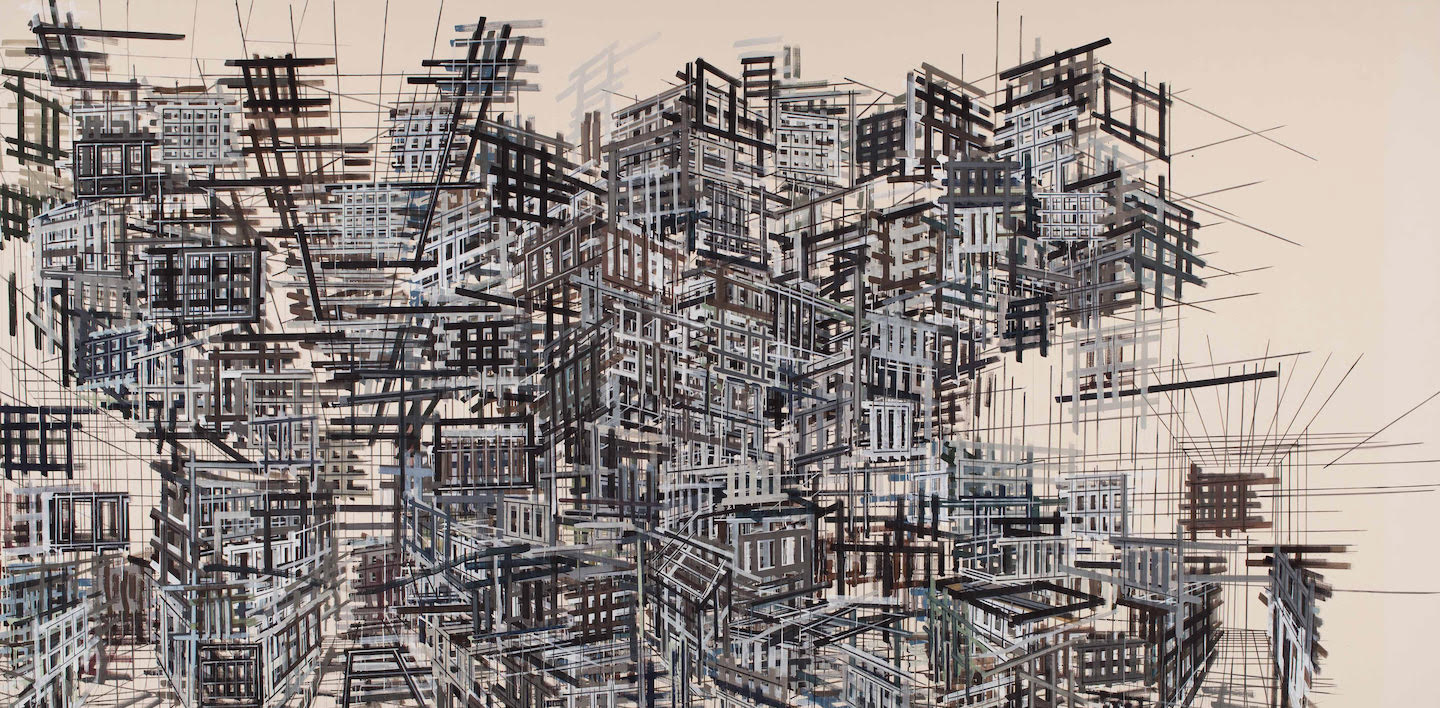
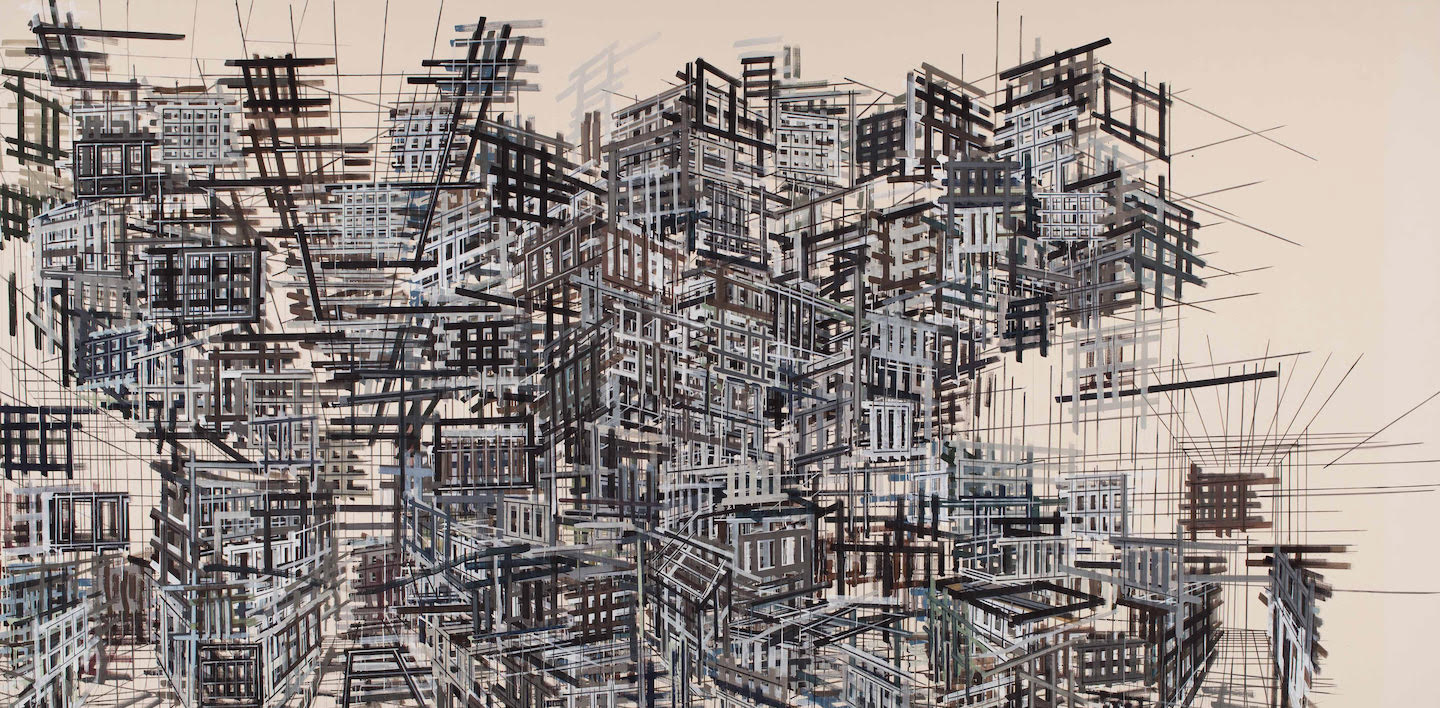
D ue libri usciti di recente meritano una certa attenzione in un periodo in cui la vicenda di Alfredo Cospito, e dello sciopero della fame che ha portato avanti da ottobre ad aprile per protestare contro l’ergastolo ostativo e il 41-bis, ha riacceso il discorso intorno al carcere e alla permanenza di regimi detentivi speciali. Discorso che se da un lato mostra la disponibilità di una (esigua) parte di società civile a confrontarsi con una serie di norme e idee naturalizzate nel tempo, dall’altro vede il continuo riproporsi del carcere come immutato e immutabile luogo di mantenimento delle aspettative, unica risposta possibile al danno.
Se pure a partire da esperienze e contesti diversi, La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere di Giusi Palomba (minimum fax) e Abolizionismo. Femminismo. Adesso. di Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners, Beth E. Richie (Alegre) si inseriscono tra quei contributi che provano a muoversi in un’altra direzione, a rompere la narrazione dominante che dà la prigione e il sistema di giustizia penale per scontate, che ragionano, a latitudini diverse e da diverse angolazioni, a partire da una comune urgenza: è possibile immaginare una risoluzione dei conflitti che non implichi il ricorso alla polizia e agli strumenti della giustizia punitiva? È possibile separare la giustizia dalla vendetta? Se sì, che cosa significa questo nella pratica? Perché il femminismo non può che essere abolizionista?
Ogni volta che si parla di abolizione o si prova a mettere in dubbio l’esistenza delle prigioni, con ogni probabilità tremende forme di violenza verrano chiamate in causa dalla controparte per legittimare la necessità del carcere, soprattutto se ad avanzare i dubbi è una donna: lo stupro, la violenza di genere, gli abusi sessuali verso i minorenni e le fasce più deboli. Il carcere, però, ci ricordano le autrici di questi due libri, più che essere una soluzione, fa da tappo a problemi strutturali: la violenza in una società omofoba e machista, la povertà in economie neoliberali dove lo smantellamento del welfare e dei sistemi di cura ha portato al progressivo impoverimento delle fasce più svantaggiate, il razzismo istituzionale che criminalizza le persone senza documenti, dove si può finire rinchiusi in un CPR (centri di permanenza per rimpatrio), di fatto vere e proprie prigioni, per un permesso di soggiorno scaduto.
In un paese come gli Stati Uniti, poi, in cui risiede in più alto numero di popolazione carceraria al mondo, il carcere è l’epitome dell’irrisolta questione razziale, residuo della schiavitù, dove la linea del colore e la povertà espongono alla giustizia soprattutto le persone non bianche, in primis nere e latine; si pensi al fatto che ci sono più uomini neri in prigione oggi di quanti ce ne fossero schiavi nel 1850, come afferma Bryan Stevenson nel documentario 13th.
Cosa si può ottenere da questo ricorso ossessivo alla detenzione se nelle prigioni si riflette esattamente la società machista di fuori, le stesse strutture sociali violente, le stesse relazioni di potere, e l’idea dell’uomo dominante ultravirile, invulnerabile e invincibile? Cosa otterremo alla fine della pena se non uomini ancora più pericolosi e poco consapevoli di se stessi, che nel quadro giudiziario attuale sfuggono alla giustizia?
Questa è una delle tante domande da cui si articola La trama alternativa, in cui Giusi Palomba parte dal racconto di una esperienza di giustizia trasformativa a cui ha preso parte dopo che il suo migliore amico era stato accusato di stupro: la persona che aveva subito l’abuso aveva deciso di non denunciare l’episodio alla polizia, ma di fare appello alla responsabilità collettiva della sua comunità di riferimento, mettendo in moto un processo che avrebbe coinvolto persone dei giri stretti e allargati sia suoi che della persona responsabile della violenza.
Ogni volta che si prova a mettere in dubbio l’esistenza delle prigioni, con ogni probabilità verrano chiamate in causa tremende forme di violenza per legittimare la necessità del carcere, soprattutto se ad avanzare i dubbi è una donna.
È qui che avviene lo strappo. Lo strappo emotivo causato dalla rabbia per la fiducia tradita da un amico caro, lo strappo che provoca il rimettere in discussione la risposta all’abuso e alla violenza al di là della punizione, lo strappo che impone di uscire dalle categorie vittima/carnefice, lo spiazzamento all’idea che la rabbia possa essere anche generatrice di un processo di trasformazione, oltre il desiderio di vendetta.
Anche chi legge fa esperienza di questo strappo: nel primo capitolo l’autrice accompagna nel vivo della relazione quotidiana con Bernat (nome di fantasia), traccia il profilo di un amico attento, di un uomo sensibile, vicino agli ambienti femministi e dell’attivismo, che gode di un certo prestigio e di una certa visibilità grazie all’impegno nel quartiere. Siamo a Barcellona, nel pieno del neomunicipalismo di Barcelona en Comù e dell’elezione a sindaca di Ada Colau, vicina ai movimenti di lotta per la casa, un periodo in cui le istanze femministe e LGBTQ+ entrano nei palazzi e diventano parte integrante della vita politica.
Lo strappo che interrompe questa tranquillità, ossia la notizia dell’abuso, anticipa un tema che ricorre a più riprese nel libro: spesso ad agire la violenza non è l’abietto, l’incarnazione del carnefice perfetto secondo la società neoliberale, un uomo senza potere, né prestigio – magari povero e non bianco – abbandonato dalle istituzioni e senza reti attorno. Giusi Palomba ci parla di una violenza che si annida nel tepore delle relazioni, delle case, espressione di una violenza sistemica che, anche negli ambienti ritenuti safe, torna a ricordare gli effetti di una cultura patriarcale, dove parole come consenso, empatia, educazione affettiva sono ancora utopie. Come rispondere alla violenza evitando di ricorrere alla polizia e alla giustizia penale come unico strumento di risoluzione dei conflitti? È possibile slegare la giustizia dalla punizione? È possibile pensare, pensarsi, al di là di questi strumenti? Cosa implica, nella pratica, una prospettiva abolizionista?
Queste domande sono al cuore de La trama alternativa, che muove in primis dal riconoscere una mancanza nella risposta del femminismo mainstream alla violenza: se negli ultimi anni movimenti come il #MeToo hanno scosso dal torpore una società abituata a coprire uomini violenti, dall’altra il femminismo che si è imposto si è spesso fermato alla sola ricerca di rappresentazione delle donne, poi alla rappresentazione delle vittime, poi alla sola diagnosi della violenza di genere.
Come rispondere alla violenza evitando di ricorrere alla polizia e alla giustizia penale come unico strumento di risoluzione dei conflitti? È possibile slegare la giustizia dalla punizione?
“Sono tutti passaggi necessari – riconosce l’autrice – eppure manca qualcosa: da un lato riconoscere l’inefficacia del castigo come unica soluzione, dall’altra ricercare la cura”. Il rischio di questo approccio, continua Palomba, è quello di restare nella cornice di un individualismo neoliberale che schiaccia l’empatia nel nome del successo e della realizzazione personale, esacerbato da quell’attivismo online o influencer feminism, che rischia di ridurre il discorso sulla violenza a liste nere e prescrizioni: cosa fare, chi odiare e chi idolatrare, senza mettere in discussione la risposta penale come unica possibile.
Questo tipo di femminismo, inoltre, difficilmente esce dagli argini di quel che bell hooks definisce femminismo riformista, ossia di quello strumento per “donne privilegiate che si ribellano contro la loro classe e la gerarchia patriarcale all’interno della loro classe” e che oscura quelle pratiche alternative alla punizione e le critiche che hanno prodotto i femminismi comunitari, decoloniali e anticarcerari che da anni, per necessità di preservare legami identitari e comunitari contro la stigmatizzazione razziale, si interrogano sulle alternative al ricorso della polizia nelle proprie comunità, come dimostrano le esperienze di femminismo abolizionista negli USA e altrove, di cui è riportata una genealogia in Abolizionismo. Femminismo. Adesso.
Nato dall’urgenza innescata dalle proteste negli Stati Uniti dopo l’omicidio di George Floyd, dall’urgenza di ripensare il carcere durante il confinamento, così come da quella di tenere traccia della lunga storia di battaglie quotidiane all’interno delle comunità nere, immigrate, queer e indigene, Abolizionismo. Femminismo. Adesso. ripercorre la storia delle lotte femministe abolizioniste negli USA in continuità con i movimenti per l’abolizione della schiavitù. Qui l’abolizione è una prospettiva che abbandona il focus sulla specifica istituzione carceraria a favore di una più ampia visione del carcere come prodotto di rapporti sociali, economici e culturali che vanno ben oltre la condotta criminale individuale; è chiaro, per le autrici, che è impossibile smantellare le prigioni lasciando intatto tutto il resto: il razzismo strutturale, che collega la prigione alla società nel suo complesso, o l’eteropatriarcato e la transfobia che alimentano la violenza di genere e sessuale.
Già in Aboliamo le prigioni? Angela Davis aveva rintracciato il nesso tra quel che lo storico William Du Bois definisce capitalismo razziale e la nascita del complesso carcerario industriale che tra gli anni Ottanta e Novanta avrebbe portato negli Stati Uniti al boom della costruzione di prigioni e alla parallela impennata della popolazione carceraria, incrinando così l’assunto che le persone si trovano in prigione semplicemente perché hanno commesso dei crimini, ma vedendo piuttosto le prigioni in continuum con l’eredità della schiavitù. Il carcere, secondo Davis, ha istituzionalizzato i linciaggi dell’inizio del XX secolo e ha reso evidente, come notava Du Bois, quel vuoto di condizioni che dopo l’abolizione della schiavitù avrebbero potuto permettere alle persone nere di inserirsi nella società: quando la schiavitù fu abolita, infatti, i neri vennero liberati, ma non avevano avuto accesso alle risorse materiali che avrebbero consentito loro di farsi una vita da persone libere.
Quando la schiavitù fu abolita, i neri vennero liberati, ma non avevano accesso alle risorse materiali che avrebbero consentito loro di farsi una vita da persone libere. Il proliferare delle prigioni è direttamente collegato alla mancanza di quelle risorse.
Il proliferare delle prigioni è dunque direttamente collegato alla mancanza di quelle risorse e alla permanenza di alcune fra le strutture più radicate della schiavitù che continuano a rendere le prigioni e la polizia un “oltretomba dello schiavismo”. Si pensi, per esempio, agli effetti del tredicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che nel momento stesso in cui aboliva la schiavitù, fissava anche una deroga a questo principio per le persone condannate per atti criminali minori come il vagabondaggio, codificati in nuovi “codici neri”, applicati solo agli afroamericani. Clausola, questa, che ha continuato a incentivare le condanne penali minori e ad alimentare la carcerazione selettiva degli afroamericani durante l’era di Jim Crow e i lavori forzati nelle piantagioni carcerarie e che avrebbe posto le basi, negli anni successivi, per la carcerazione di massa, giustificata in nome della lotta alla droga.
Si ribadisce a più riprese, in Abolizionismo. Femminismo. Adesso., come ne La trama alternativa, la necessità di un femminismo abolizionista e di un abolizionismo femminista, di una prospettiva che metta in luce come razza, genere e marginalità giocano un ruolo di primo piano nella criminalizzazione, di uno sguardo che faccia emergere gli intrecci, passati e presenti, tra i vari sistemi di oppresione e la matrice che unisce, in luoghi diversi e a diverse intensità, le violenze della polizia sui corpi ritenuti più “sacrificabili”.
Cruciale, per le autrici di Abolizionismo. Femminismo. Adesso. il contributo portato dalle battaglie quotidiane all’interno delle comunità nere, immigrate, queer e indigene, di chi quotidianamente combatte contro la militarizzazione dei quartieri poveri; inevitabile il rimando, nel testo, a Marielle Franco, attivista queer femminista e antirazzista assassinata nel marzo 2018 a Rio De Janeiro, che si batteva con fervore contro la militarizzazione delle favelas, ribadendo che la difesa delle donne nere dovesse essere legata alla battaglia contro la violenza della polizia, anche se le vittime più numerose di questa violenza sono principalmente gli uomini. Collegando la povertà, la militarizzazione, la violenza e la repressione all’impatto strutturale e istituzionale della razza e del genere (“le morti hanno razza, colore, classe sociale e territorio”), riconosceva come la de-militarizzazione dei territori dovesse andare di pari passo a politiche pubbliche dirette a tutti i settori: alla salute, all’istruzione, alla cultura e alla creazione di reddito e di posti di lavoro e che rispondessero in particolare ai bisogni delle donne nere nelle favelas, alla battaglia per i diritti riproduttivi, all’incremento degli asili notturni per i figli delle donne lavoratrici.
Contributi come quello di Marielle Franco, continuano le autrici, hanno profondamente ispirato le lotte femministe abolizioniste negli Usa, rafforzando la consapevolezza che il movimento per porre fine alla violenza di genere e sessuale non può essere isolato dalle battaglie per mettere fine alla violenza di stato, inclusa la violenza della polizia. È per questo che l’abolizione non è immaginabile senza il femminismo, come il femminismo non è immaginabile senza l’abolizione.
Ritorna qui la necessità di guardare all’abolizionismo non solo come orizzonte critico, ma come impegno concreto.
Ritorna qui, come nel libro di Giusi Palomba, la necessità di guardare all’abolizionismo non solo come orizzonte critico, ma come impegno concreto che possa agire su un doppio binario: da un lato rifiutare la sorveglianza e la polizia come risposta e dall’altro costruire reti di cura e di mutuo appoggio, battersi per l’assistenza sanitaria, la demilitarizzazione delle scuole, istruzione e alloggi accessibili a tutti: Per noi il femminismo abolizionista rappresenta un impegno politico che abbraccia l’idea di andare avanti su un “doppio binario” abbandonando la logica per cui uno dovrebbe escludere necessariamente l’altro insieme a un riformismo di facciata. Riconosciamo la relazione tra violenza di stato e violenza individuale e alla luce di ciò impostiamo la nostra resistenza: fornendo sostegno ai sopravviventi e pretendendo l’accountability di chi commette violenza, agendo a livello locale e internazionale, costruendo comunità senza smettere di far fronte alle necessità immediate. Lavoriamo al fianco delle persone detenute e contemporaneamente chiediamo la loro scarcerazione. Ci mobilitiamo indignati contro lo stupro dell’ennesima donna e rifiutiamo l’incremento delle forze di polizia come soluzione. Incoraggiamo e costruiamo cambiamenti politici e sociali sostenibili e a lungo termine per porre fine ad abilismo e transfobia e al contempo metodi di intervento immediati nei casi in cui la violenza si è già verificata.
Nel ricostruire la genealogia del femminismo abolizionista, Abolizionismo. Femminismo. Adesso. si sofferma su alcuni casi, come quello di INCITE! Women of Color Against Violence, rete di femministe radicali of color contro la violenza di stato e la violenza domestica. Nata alla fine degli anni Novanta, periodo in cui i movimenti antiviolenza orientati alla giustizia sociale erano stati ormai praticamente cooptati dallo stato, INCITE ha giocato un ruolo cruciale nel mettere a critica gli effetti politici della criminalizzazione e il ricorso alla giustizia penale come risposta alle violenza, creando coscienza critica e mettendo in pratica risposte comunitarie alla violenza di genere e sessuale.
La rete, ricordano le autrici, si inserisce in una lunga eredità del femminismo radicale nero, che già a partire dagli anni Quaranta e Cinquanta denunciava (si pensi agli scritti di Claudia Jones) la natura strutturale della violenza sessuale, come nel caso delle lavoratrici domestiche, lavoro a cui la maggior parte delle donne nere era relegata durante i decenni seguenti all’abolizione della schiavitù e che riproduceva le stesse minacce che queste avevano affrontato durante di essa: stupro, abuso sessuale e molestie in senso più ampio.
Altro contributo trascurato dalla storia ufficiale, ricordano le autrici, è quello di Rosa Parks nell’anticipare l’attivismo contro le violenze sessuali alla fine degli anni Sessanta. Rosa Parks, Esther Cooper Jackson, Anne Braden e molte altre attiviste legarono le campagne contro lo stupro alle campagne contro la strumentalizzazione razzista nei casi di uomini neri, tra cui Emmet Till (1955), ucciso dopo l’accusa di aver rivolto commenti sessuali a una donna bianca. Qui la lotta per difendere gli uomini neri dalle false accuse di stupro si ricollegava direttamente alla difesa delle donne nere che ne erano vittime: lo stupro e la sua manipolazione razzista erano due fenomeni sostanzialmente connessi. Agli albori del movimento, gran parte dell’impegno delle femministe nere e of colour consisteva nel tentativo di correggere i resoconti storici, facendo notare che le donne bianche non erano le uniche a dover affrontare la misoginia e il patriarcato e che le donne razzializzate erano impegnate in questa lotta in un modo più complesso e intersezionale, come ci ricorda la conversazione tra bell hooks e Maya Angelou riportata ne La trama alternativa.
La lotta per difendere gli uomini neri dalle false accuse di stupro si ricollegava direttamente alla difesa delle donne nere che ne erano vittime: lo stupro e la sua manipolazione razzista erano due fenomeni sostanzialmente connessi.
“Come facciamo a rendere una persona responsabile di un torto commesso, e allo stesso tempo a restare in contatto con la sua umanità quanto basta per credere nella sua capacità di trasformarsi?” È il 1998, bell hooks pone questa domanda a Maya Angelou nel corso di un dialogo in cui le due autrici si ritrovano a parlare del caso giudiziario che ha coinvolto il pugile nero Mike Tyson, accusato di stupro, condannato a sei anni di prigione e scarcerato dopo tre. bell hooks racconta che negli anni in cui il caso dominava i media tutti volevano sapere per chi parteggiasse, senza nessuna ulteriore richiesta di riflessione, e ricorda di aver avuto la necessità di tenere insieme due tensioni: che Tyson rispondesse della violenza, ma che si aprisse anche un dibattito pubblico sulla cultura in cui Tyson era cresciuto e che l’aveva reso uno strumento di violenza.
La necessità di tenere insieme queste tensioni, che è alla base del lavoro di INCITE e dei movimenti abolizionisti of color, fa risuonare una domanda, che torna anche nel libro di Giusi Palomba: e se avessimo relegato ai margini il compito di pensare ad alternative, a chi è costretto a farlo per la sopravvivenza delle proprie comunità?
Come fa notare l’autrice de La trama alternativa, tutta una classica e confortevole tradizione politica ci chiede soltanto:
schieratevi e basta, e poi escludetelo, allontanatelo, boicottatelo. Sarebbe così semplice, ma semplice non è la parola giusta. Sarebbe popolare e giustificato, non desterebbe così tanto scalpore. E dall’altra parte, la comunità in un processo trasformativo ci invita a negare quelle pratiche, e contribuire a crearne un’altra nel nostro orizzonte e vedere che succede, ed è difficile a volte non sentirsi un po’ come se fossimo cavie.
Quando l’esclusione da uno spazio o da una comunità non è esplicita richiesta della persona che subisce l’abuso, come nel caso riportato nel libro di Giusi Palomba, la possibilità di ragionare sulle alternative all’esclusione può essere un modo per affermare un principio: la responsabilità collettiva. Il punto non è allontanare la mela marcia, riproponendo l’idea di una giustizia come “epurazione del deviante”, ma agire su un esame intimo e collettivo delle logiche di dominio che strutturano i nostri rapporti.
La possibilità di ragionare sulle alternative all’esclusione può essere un modo per affermare un principio: la responsabilità collettiva.
È per questo che al centro dei processi di giustizia trasformativa e dei movimenti abolizionisti, ricordano le autrici dei due libri, c’è la questione della responsabilità (accountability), sottratta al regime carcerario, dove anche le parole lasciano aperto lo spazio della trasformazione, come racconta Palomba a proposito dell’esperienza che l’ha vista coinvolta: Si scelgono le parole per nominare i processi e le persone, in relazione a ciò che è accaduto. Sopravvivente e non vittima. Persona che ha inferto il danno e non predatore o perpetratore. Mar (la persona che ha subito l’abuso, n.d.a.) decide insieme al suo gruppo che la sua identità non debba ridursi alla vittimizzazione, nel suo caso, o colludere con un linguaggio che non preveda un cambiamento, nel caso di Bernat.
Decenni di campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere ci hanno abituati a una rappresentazione della vittima come soggetto colto nel pieno della sua vulnerabilità, spesso ragazze bianche di classe media, decorose e rispettabili, cosparse di lividi e cicatrici, un occhio nero, un corpo accovacciato in un angolo, le mani davanti al volto a difendersi: soggetti completamente spogliati di qualsiasi possibilità narrativa e di controllo sulla propria storia, raccontata sempre da qualcun altro, dove l’immaginario maschile si ripropone sia nell’atto della violenza che nella sua rappresentazione. Perché la vittima perfetta – ricorda Palomba – l’unica che ha conquistato il privilegio di essere creduta, ha anche una funzione precisa. Dipingere le donne come vittime eterne significa mantenerle al loro posto, e prevedere per loro una sola via d’uscita: rivolgersi all’autorità, a un potere superiore – sempre fuori da se stesse e dalle proprie comunità – che possa difenderle in una sola maniera possibile, ovvero privare il loro carnefice – unico responsabile della violenza – della libertà fisica per un certo periodo di tempo.
Speculare a quella della vittima perfetta è l’immagine del carnefice perfetto, il “deviante”, un singolo portatore di violenza che assolve a una funziona ben precisa: tracciare una linea tra gli “uomini per bene”, che non hanno niente da rimproverarsi, e gli altri, i violenti, gli stupratori, i mostri. Questi meccanismi alimentano la rappresentazione della violenza come qualcosa al di fuori del quotidiano, “concentrata in un solo punto, un buco nero di orrori” e non come strutturale alla società, in cui anche gli uomini più reticenti finiscono per interiorizzare una cultura che li vuole infallibili, intoccabili, che assegna loro il diritto di occupare spazio quando e come vogliono, di non accettare il rifiuto.
Racconta l’autrice: Improvvisamente ho bisogno di accelerare l’apprendimento di questa nuova educazione politica. Mi dicono che in questi casi un gruppo di alleati accompagna gli uomini nel percorso. Un gruppo di supporto che organizzerà con Bernat incontri, discussioni, momenti di autocoscienza. Sarà formato prevalentemente da uomini – questa è la scelta di Mar – che non dovranno sottolineare differenze o considerarsi migliori, ma ragionare insieme sui motivi che lo hanno spinto ad agire violenza. Motivi di cui è possibile riconoscere tracce nell’esperienza di tutti. Un terzo gruppo di collegamento farà da ponte tra i due di supporto e comunicherà le decisioni di Mar a Bernat e i progressi di Bernat a Mar. (…) Il processo innescato sta aiutando Mar a non prendere decisioni mosse solo dalla rabbia. Il gruppo di supporto è lo strumento che serve a trasformare la collera in altro. Se può essere condivisa, la rabbia si può smontare pezzo per pezzo e generare un progresso.
Iniziare un processo trasformativo ha innanzitutto significato per Mar, continua Palomba, il rifiuto di lasciare che altri definissero il senso della propria storia: soltanto prendendo le redini della situazione, chiedendo aiuto e supporto secondo i propri tempi, è stato possibile chiudere il cerchio o, meglio, “lasciare che mille altri se ne aprano, sotto forma di alternative, pronte a mettere in crisi ciò che è scontato.” Di nuovo, lo strappo: pensare e immaginare risposte alla violenza strappate a certezze e percorsi obbligati, dove la rabbia può farsi possibilità.
Stare nel processo: questo è l’invito, guardare alla giustizia trasformativa non come a una soluzione applicabile all’occorrenza, ma come a un esercizio per spingere l’immaginario oltre i percorsi già tracciati.
Più che consegnare a chi legge una definizione di giustizia trasformativa, il libro di Giusi Palomba restituisce la complessità di un percorso che mette al centro il disimparare, il dismettere i processi automatici con cui la logica punitiva si riproduce, anche a partire dal quotidiano. Non ci sono prescrizioni o consigli, piuttosto una matassa di domande che interpellano nel vivo chi legge. Stare nel processo: questo è l’invito, guardare alla giustizia trasformativa non come a una soluzione applicabile all’occorrenza per rispondere a situazioni di violenza, ma come a una possibilità, un esercizio per spingere l’immaginario oltre i percorsi già tracciati, come occasione per chiedersi, in prima istanza: che cosa è una comunità? Di cosa parliamo quando parliamo di responsabilità collettiva?
Questioni che il femminismo abolizionista nero e of color aveva già anticipato, mettendo in luce il legame tra razzismo strutturale, sessismo, povertà e militarizzazione, battendosi per la strumentalizzazione razzista della violenza sessuale e allo stesso tempo lottando contro il sessismo all’interno delle proprie comunità.
Quel che ritorna, ciclica, in entrambi i libri, è la necessità di un’immaginazione radicale, che spinga oltre gli argini del già dato, che faccia spazio a quel che non è ancora pensabile, ma situato ai margini del possibile, e di farlo a partire dalle nostre vite, dalla nostra rabbia, dalle nostre intimità: se i modi che scegliamo per gestire un conflitto o un abuso determinano la forma delle società in cui viviamo e se questi si rivelano non sufficienti per concretizzare le nostre visioni, allora vuol dire che dobbiamo inventarne altri. Non si tratta di trovare un finale diverso, ma di riscrivere l’intera trama.
E di farlo adesso.