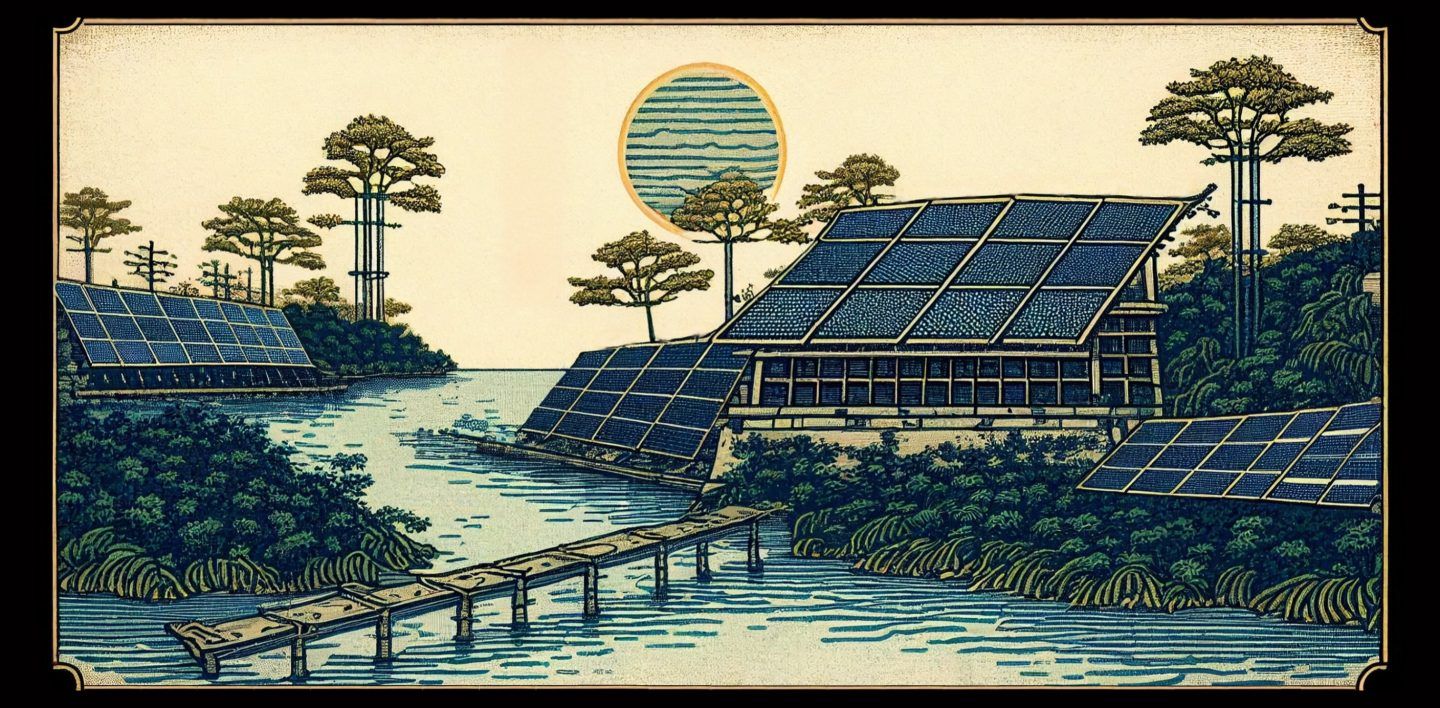
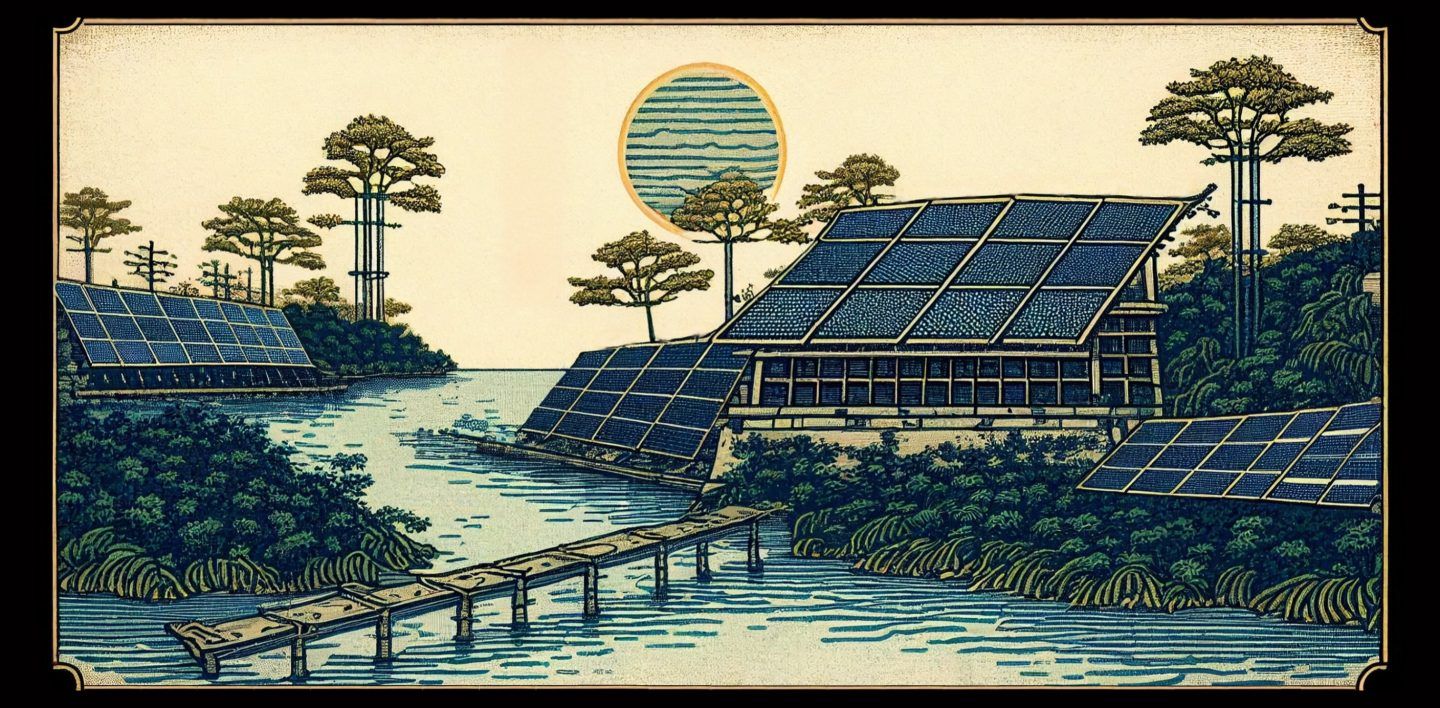
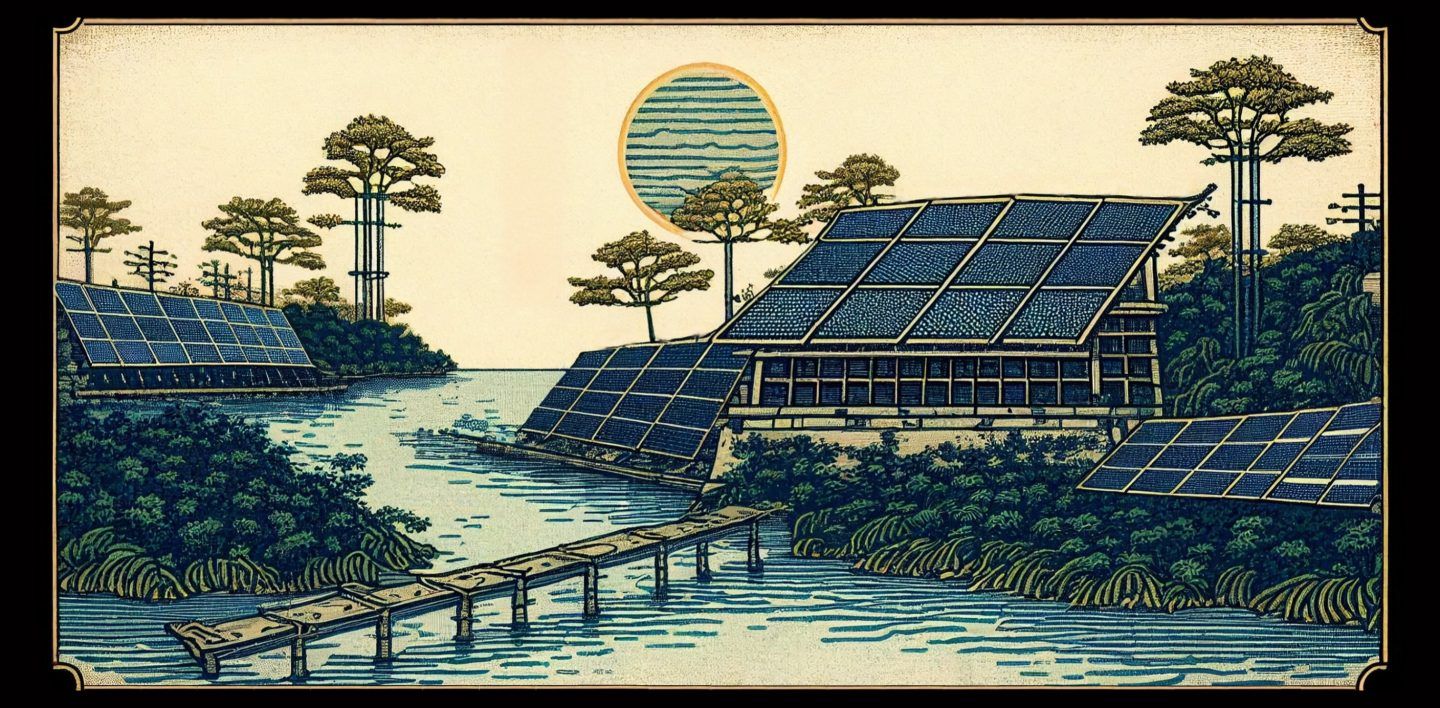
P er capire il rapporto tra Cina e crisi climatica non bisogna partire dai discorsi e gli scritti di Xi Jinping sulla civilizzazione ecologica, ma da I trentasei stratagemmi, trattato di strategia militare composto nel sesto secolo e ripubblicato (in versione emendata) dal Partito comunista cinese negli anni Sessanta. Lì c’è praticamente già tutto sull’arte della confusione e del controllo, sui principi che guidano la strategia del paese più popoloso del globo in una delle grandi partite di questo secolo, la decarbonizzazione del mondo.
Uno degli stratagemmi dice: “Attraversa il mare senza che il cielo lo sappia”. Ecco, non esiste al mondo una transizione energetica furibonda quanto quella cinese, da un decennio nessuna economia aggiunge così tanti gigawatt di rinnovabili ogni anno. Un rapporto di Energy and Climate Intelligence Unit uscito a novembre sosteneva che la Cina tende addirittura a sottostimare i suoi progressi in energia pulita, per non dare l’idea di essere troppo avanti, o di avanzare lungo questa strada per ordine dell’ONU o degli Stati Uniti. Attraversare il mare, senza farsi guardare dal cielo. “Rumore a est, attacco a ovest”: l’effetto sorpresa costante, da un decennio.
La Cina nel gioco del clima è entrata come ospite, è diventata padrona, ma continua a fingersi ospite.
Quando arrivò, nessuno si aspettava l’annuncio cinese di un azzeramento delle emissioni nel 2060, solo dieci anni dopo quanto promesso da Unione Europea e Stati Uniti. Ma rumore a est e attacco a ovest vuol dire anche alternare gli arretramenti ai progressi, diventando illeggibili dall’esterno: un anno si impegnano a non costruire più centrali di carbone fuori dai propri confini, l’anno dopo autorizzano 50 GW di nuove centrali a carbone dentro i propri confini, la più grande espansione dal 2015 per la fonte fossile più sporca.
Sempre dagli stratagemmi: “Scambia i ruoli dell’ospite e dell’invitato”. È il grande trucco cinese sulla scena del clima, convocata ogni anno in vertici multilaterali chiamati COP, “conferenze delle parti” (perché non ci sono solo i paesi, ma anche i sindacati, i popoli indigeni, la società civile). Le COP sono come le cene con delitto, eventi cerimoniali come un rito nuziale, dove tutti hanno un proprio ruolo, noto in partenza, e un tavolo a cui sedersi, con un protocollo di comportamento già scritto. Lo sposo fa lo sposo. Il testimone fa il testimone. L’amico ubriaco fa l’amico ubriaco. La prima COP si tenne nel 1995, a Berlino, con una giovane Angela Merkel ministra dell’ambiente a guidarla. La Cina era un’economia povera, quindi giocava nella squadra dei paesi in via di sviluppo, con tutte le doglianze di chi aveva contribuito poco alla crisi climatica, subendo gli effetti peggiori di quello stile di vita americano che, nel 1992 al Summit di Rio, George Bush Sr., con una mossa geopoliticamente disastrosa, definì “non negoziabile”. Da allora sono passati quasi trent’anni e 27 COP, la Cina è nel frattempo diventata la seconda economia mondiale, il primo paese al mondo per emissioni, il secondo per emissioni storiche, ma quando si parla di clima si veste ancora da contadina umile e un po’ stracciona, con le risaie rovinate dai SUV americani. Insomma, la Cina nel gioco del clima è entrata come ospite, è diventata padrona, ma continua a fingersi ospite.
O ancora, altro stratagemma, “Rimuovi la scala quando il nemico è salito sul tetto”. In quel caso il nemico sono sempre loro, cioè noi, Unione Europea e Stati Uniti, saliti sul tetto della giustizia climatica, della lotta alla diseguaglianze, anche del giusto senso di colpa esibito e della responsabilità riconosciuta verso i paesi africani o del Pacifico ridotti alla fame o all’annegamento per le emissioni di carbonio che ci hanno fatto ricchi, prosperi e sviluppati. Una volta saliti lì, la Cina ci ha tolto la scala, conducendo alla COP27 di Sharm el Sheikh del novembre 2022 il negoziato sui risarcimenti climatici con un’ambiguità spietata, dalla parte del poveri e della giustizia climatica, costringendo Frans Timmermans (uomo clima dell’Europa) e John Kerry (inviato di Biden per la faccenda, per altro in quei giorni chiuso in hotel col COVID) a superare la linea rossa per eccellenza dell’Occidente, la creazione di un fondo “loss and damage”, un piano perpetuo di risarcimenti ogni volta che un ciclone impensabile in un altro clima devasta un paese in via di sviluppo (come appena successo con Freddy in Malawi e Mozambico).
Il capolavoro cinese è stato aver negoziato per conto dei piccoli e dei vulnerabili, diventando il capo sindacalista climatico del Sud globale, pur essendo ormai da tempo il padrone e il principale responsabile corrente del disastro. Per ora la Cina nemmeno figura nell’elenco dei paesi che dovranno erogare questi risarcimenti. Come direbbe un altro dei trentasei stratagemmi: muta la pelle dello scarabeo d’oro. Fingi di essere quello che non sei, o di non essere quello che sei.
Ma tutto questo sforzo aveva bisogno anche di una narrazione più contemporanea dei trentasei stratagemmi della dinastia Ming. Ed è qui che entra in campo Xi Jinping in persona. Per trovare la formula giusta, locale e globale allo stesso tempo, ha pescato il concetto adatto da quell’ecologia agricola marxista che provava, senza grandi risultati, a imporsi nell’URSS al tramonto, negli anni Ottanta. Sono due parole: civilizzazione ecologica. Serviva un concetto autoctono al socialismo anche perché in Cina ogni cosa globale ha un suo doppio locale, con caratteristiche cinesi, motori di ricerca, social network, circuiti di pagamento, l’economia di mercato. Un mondo replicato e digerito, il partito e i tycoon cinesi sono come un uccello che mastica e rigurgita il pasto in bocca ai piccoli, adattandolo al contesto, alle circostanze e ai rischi. Lo stesso vale per lo sviluppo sostenibile.
Questo concetto nasce alla Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972 e si coagula nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’ONU nel 2015, stesso anno dell’Accordo di Parigi. Per il Partito comunista cinese questi obiettivi sono manufatti occidentali, lo sviluppo sostenibile è una forma di imperialismo coloniale, è l’idea americana dell’ecologia. “Dobbiamo tenere conto che anche tutte le istituzioni per la lotta ai cambiamenti climatici nascono per azioni politiche dei paesi sviluppati, basate su un lessico occidentale. Questo è il tentativo cinese di inserirsi nel discorso internazionale sui beni pubblici globali con concetti cinesi”, spiega Filippo Fasulo, analista di ISPI. E così lo sviluppo sostenibile è stato riformulato come civilizzazione ecologica.
Come spiega Nis Grünberg, analista della transizione ecologica di Pechino per conto del Mercator Institute for China Studies, “la civilizzazione ecologica è il tentativo di riformulare una serie di parametri già stabiliti nell’idea di sostenibilità dentro una narrazione cinese secondo cui l’obiettivo non è il bilanciamento tra economia e ambiente ma qualcosa di più elevato, una forma di idealismo cinese millenario sull’equilibrio tra natura e cultura, con un background filosofico che risale fino alle origini del taoismo e Confucio”. Un modo per dire agli occidentali che in fondo non hanno inventato nulla, ripescando per questo scopo antiche idee cinesi da inserire in formule nuove, adatte a un mondo multipolare.
Oggi la Cina ha in mano lo sviluppo tecnologico della transizione, costruisce sette pannelli solari su dieci e sei batterie elettriche su dieci, e guida la globalizzazione commerciale con tutte le varianti della Via della Seta.
In attesa di vedere dove porteranno i tentativi di reindustrializzazione verde degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, oggi la Cina ha in mano lo sviluppo tecnologico della transizione, costruisce sette pannelli solari su dieci e sei batterie elettriche su dieci, inoltre guida la globalizzazione commerciale con tutte le varianti della Via della Seta, e sta cercando di costruire una cornice ideologica intorno a tutto questo, per dire al mondo: si fa così perché noi pensiamo così. Un esercizio di egemonia.
La civilizzazione ecologica è stata spinta nel dibattito pubblico da una serie di discorsi del presidente Xi Jinping, in buona parte difficili da tradurre senza sembrare vaghi o addirittura buffi in inglese o in italiano. L’espressione più usata suona più o meno così: “Le montagne verdi sono montagne d’oro e montagne d’argento”, a simboleggiare l’interdipendenza tra il popolo cinese, la sua aspirazione alla ricchezza e i suoi ecosistemi naturali. La formula chiave, ormai diventata un manifesto amministrativo per indirizzare l’operato di migliaia di funzionari locali, è “costruire una bella Cina”. La civilizzazione ecologica è diventata uno degli assiomi del pensiero di Xi Jinping, messo dal 2017 nella Costituzione del partito comunista insieme a quello di Mao e di Deng Xiaoping. L’ambientalismo con caratteristiche cinesi è uno degli strumenti di Xi, arrivato al terzo mandato, per aggiungere il suo tassello alla storia millenaria cinese. “Incoraggiamo un modo di vivere semplice, moderato, verde e a basse emissioni, e ci opponiamo alla stravaganza e al consumo eccessivo”, ha detto a un incontro con la commissione del partito.
Al di là di questi generici propositi di sobrietà, è difficile individuare le differenze filosofiche sostanziali rispetto alla cultura occidentale della sostenibilità. Una chiave per capire la civilizzazione ecologica cinese è l’approccio “cinque in uno”. Lì dove lo sviluppo sostenibile occidentale è il tentativo di coniugare sostenibilità ambientale, sociale ed economica (talking point ormai assorbiti da qualunque parlamentare di basso livello europeo come pezza di appoggio per dire qualsiasi cosa sulla transizione), la versione cinese aggiunge altri due livelli. Il primo è la politica, che è la politica cinese, senza una società civile liberale a fare da vero attrito. In questo senso la politica è intesa come pianificazione dall’alto, motore di propagazione attraverso tutti i livelli di governo locale. Il secondo è la cultura come telaio intellettuale. L’ideologia della civilizzazione ecologica è un tentativo di rigenerare la cultura tradizionale verso la “nuova era di sviluppo di qualità”, basato sulla ricerca dell’armonia con la natura in contrapposizione con la sottomissione della stessa natura che, nella lettura di Xi e dei suoi ideologi, caratterizza tutta la filosofia dello sviluppo occidentale. È una storia obiettivamente difficile da vendere. Per diventare fabbrica del mondo la Cina è diventata il paese più inquinato e inquinante al mondo, affetto da un’aria irrespirabile e con il carbone ancora al centro del suo mix energetico per tutto il decennio. Ma è la storia che la Cina ha scelto per sé.
La tempolinea cinese per la transizione prevede il picco delle emissioni nel 2030 (quando il mondo sviluppato, secondo il mandato della scienza e i vari Green Deal, dovrà averle già dimezzate), lo sviluppo completo e organico della teoria della civilizzazione ecologica entro il 2035, la costruzione della “bella Cina” nel 2050 e l’azzeramento delle emissioni nel 2060. In mezzo ci sono sforzi come la creazione dei primi parchi nazionali, annunciata nel 2022, 230mila chilometri quadrati che in teoria ospitano il 30 per cento della biodiversità terrestre cinese. Di recente Xi si è fatto fotografare mentre piantava alberi a Pechino, l’undicesima volta in cui partecipava da presidente, vanga alla mano, a un rituale a cui tiene molto. “La partecipazione del leader nella messa a dimora degli alberi ha lo scopo di mobilitare il popolo in tutto il paese a lavorare per una bella Cina”, diceva un comunicato ufficiale. L’afforestazione è uno degli sforzi pratici più vistosi di civilizzazione ecologica, viaggia al ritmo da 3 nuovi milioni di ettari ogni anno, con l’obiettivo di piantare o preservare 70 miliardi di alberi entro il 2030.
Questo è il racconto globale che la Cina fa di sé. Poi ovviamente c’è il piano locale, il governo di un miliardo e trecento milioni di persone. Lo sviluppo in Cina è arrivato con decenni di ritardo rispetto all’Occidente, quindi oggi è in corso un ripensamento del modello di sviluppo che da noi si era innescato negli anni Sessanta. È come se Pechino stesse affrontando in questi anni i temi del Club di Roma (1968) e dei limiti della crescita. Come spiega Fasulo di ISPI, “nei decenni passati l’idea cinese di crescita economica era stata solo quantitativa, ma con i numeri che salivano sono arrivate anche le questioni ambientali, l’inquinamento devastante delle città, del suolo e dei fiumi, con una domanda dal basso di ambiente pulito molto diffusa”.
Il fatto che quella cinese sia una società pianificata e senza un’opinione pubblica non vuol dire che sia una società inerte. La civilizzazione ecologica risponde anche a questo tipo di spinta dal basso. “Come abbiamo visto con le proteste contro i lockdown del 2022, quella cinese è una società che sa contestare il potere, e, al di là di quelle in epoca COVID ci sono centinaia di manifestazioni ogni anno che riguardano questioni ambientali di tipo locale, la popolazione porta una forte richiesta di attenzione alla tenuta degli ecosistemi, in particolare aria e acqua. La valutazione sull’operato dei funzionari, nell’infinita frammentazione della governance cinese, si fa anche in base alla buona governabilità della sua area”. In Cina fa carriera chi amministra un territorio che contesta poco, le proteste sono il segno che qualcosa non funziona e va cambiato, per il supremo valore della stabilità, dentro un regime che tramanda se stesso da quasi un secolo. L’ambiente è uno dei punti di rottura della società cinese e il pensiero di Xi viene diffuso anche come manuale pratico su come si governa una nuova classe media che con lo sviluppo ha iniziato anche a guardare alla qualità di quello che mangia, beve e respira.
La società, il partito, la gente, Xi, i funzionari, le COP, Confucio: la civilizzazione cinese è stato il lavoro dei millenni e poi degli anni.
La mette sullo stesso piano anche Grünberg: “Le proteste locali in Cina sono trattate come un allarme anti-incendio, il monitoraggio su cosa dicono le persone, online e offline, è costante, è l’unico modo per far funzionare un’idea di policy che è tutta dall’alto verso il basso”. E quindi l’ecologia cinese nasce per spegnere gli incendi sociali di una popolazione estenuata dall’inquinamento locale, prima ancora che preoccupata per la crisi climatica globale. “Oltre a essere uno strumento di dominio geopolitico, l’ecologia in Cina è stata vista come un problema di sicurezza interno. La prima spinta viene da lì. Il tutto si è innestato con la visione di Xi Jinping, che da membro del partito locale e da governatore parlava spesso di ambiente e ha messo l’inquinamento in cima all’agenda già nel 2011, due anni prima che arrivasse la prima crisi di irrespirabilità, e nel 2014 ha dichiarato la guerra all’inquinamento”.
La società, il partito, la gente, Xi, i funzionari, le COP, Confucio: la civilizzazione cinese è stato il lavoro dei millenni e poi degli anni, ma aveva un bisogno di andare oltre la propaganda interna, e anche oltre i negoziati dietro le quinte a COP sul clima guidate da altri paesi (Regno Unito nel 2021, Egitto nel 2022). Serviva un grande palcoscenico globale tutto cinese per fare la grande anteprima, il debutto in società dell’eco confucianesimo. E quel debutto è stato un disastro: la Cina avrebbe dovuto ospitare la conferenza delle parti a Kunming, nello Yunnan, nel 2020. Era un appuntamento decisivo del negoziato ONU parallelo a quello sul clima, e altrettanto importante (anche se meno mediatizzato): quello sulla biodiversità.
Mentre sul clima, grazie all’accordo di Parigi, erano stati raggiunti risultati diplomatici reali, la protezione multilaterale di flora e fauna è stata a lungo la storia di un fallimento continuo. La tutela della biodiversità era stata affidata negli anni Dieci agli obiettivi di Aichi, un protocollo organizzato per punti e parametri misurabili. Al 2020 non ce n’era uno che fosse stato raggiunto, così la XV Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità aveva l’obiettivo di ripensare il sistema per il nuovo decennio, e di farlo in Cina, sotto la guida di Xi, che avrebbe spiegato al mondo come le montagne verde sono montagne d’oro, eccetera. Xi immagianva un “accordo di Kunming” per il quale usare tutte le leve culturali e politiche della sua rivoluzione culturale green, la civilizzazione ecologica incubata per un decennio. Niente di tutto questo è successo: i lockdown da COVID durissimi della Cina hanno reso impossibile organizzare della COP di Kunming, che è stata quindi spostata dopo due anni di rinvii a Montreal, in Canada (paese per altro oggi ostile alla Cina per il caso Huawei). Si è tenuta a dicembre del 2022, ha raggiunto risultati buoni (un piano di proteggere il 30% della Terra entro il 2030) ma senza nessuna vera ispirazione cinese. La civilizzazione ecologica era un concetto oscuro fuori dalla Cina nel 2020 e lo è ancora oggi nel 2023.
Nei vari e fallimentari tentativi di organizzare l’evento a Kunming, prima della rinuncia finale, il partito comunista cinese ha anche imparato una lezione nuova: l’ecologia si può programmare dall’alto, ma solo fino a un certo punto. Ci sono cose che non si possono proprio pianificare. Una di queste sono le intenzioni di un elefante. In Cina oggi resiste una piccola popolazione di elefanti, concentrati nella provincia dello Yunnan, un gruppo sotto pressione per la frammentazione dell’habitat, la costruzione delle infrastrutture, l’inquinamento, le tensioni con gli umani. Insomma, animali a rischio estinzione per tutte le caratteristiche del capitalismo, cinese e non, ecologicamente civilizzato e no.

Nel 2021 una quindicina di questi elefanti hanno fatto una cosa che nessun funzionario locale, per quanto avido lettore degli scritti di Xi, poteva prevedere. Si sono messi in viaggio. Senza un apparente motivo, si sono allontanati dalle foreste dove avevano sempre vissuto, alla ricerca di spazio e cibo, attraversando spazi urbani e strade trafficate. Visto dall’alto, il loro viaggio sembrava avere una sola destinazione: Kunming. I quindici pachidermi erano una specie di frammento di società civile non umana che voleva prendere la parola in un negoziato in cui si sarebbe parlato di loro.
In Cina, e poi anche fuori, quegli elefanti sono diventati un fenomeno virale sui social media: milioni di cinesi hanno seguito il loro disordinato viaggio, gli animali, essendo animali, hanno creato caos e disordine, ma erano diventati troppo famosi per essere abbattuti, come probabilmente il partito avrebbe ordinato di fare con qualsiasi manifestante umano. Gli elefanti hanno viaggiato per centinaia di chilometri e per mesi interi, la rappresentazione plastica della difficoltà di calare la sostenibilità, o civilizzazione ecologica, nel mondo reale, qualcosa che a occidente purtroppo avevano imparato da tempo. In ogni caso, come sappiamo la conferenza non si è fatta a Kunming, mentre, con una serie di manovre e trappole, gli elefanti sono stati riportati a casa. Da mesi non si sa più niente di loro, sono usciti dai riflettori e da questa storia, ma i funzionari del governo fanno sapere che stanno bene.

