


N ella primavera-estate 2020, mentre decine di prigionieri muoiono in circostanze ancora da chiarire nelle carceri italiane, e a migliaia ne mancano nelle RSA lombarde, l’ergastolano settantacinquenne Mario Tuti, fondatore, nel 1972, del neo-fascista Fronte Nazionale Rivoluzionario, ottiene un permesso speciale di alcuni mesi che trascorre in semilibertà nella campagna viterbese presso l’azienda agricola di un amico. Qui lo va a trovare il collettivo cinematografico Santabelva (Gianvito Cofano, Henry Albert, Saverio Cappiello, Nikola Lorenzin), per il docufilm Corpo dei giorni in concorso al Torino Film Festival 2022.
Già all’età di trent’anni, la stessa dei tre filmmaker oggi, Tuti aveva sentito le sbarre chiudersi per sempre dietro di lui per aver ucciso a colpi di mitraglia due carabinieri; ma dopo l’indagine era stato assolto per fatti relativi a diversi attentati ferroviari, collegati ai processi relativi alla cosiddetta “strategia della tensione”. Ucciderà poi insieme a Concutelli, altro noto killer nero, in carcere: la vittima sarà Ermanno Buzzi, a sua volta condannato per la strage di Piazza della Loggia. Buzzi viene portato nel supercarcere di Novara, lo stesso dove dimoravano Tuti e Concutelli, pochi giorni dopo che Tuti lo condanna a morte su una rivista carceraria clandestina vicina alla estrema destra. Le guardie lasciarono ai due assassini il tempo di scrivere sul muro una filastrocca di sfottò: “Buzzi Buzzi sento odore di infamuzzi”. Infine, dopo anni di carcere di cui quattro in isolamento, Tuti guiderà la spettacolare rivolta dell’87 nel carcere di Porto Azzurro. Oggi, condannato a tre ergastoli, in regime di semilibertà presso il carcere per anziani di Civitavecchia, Mario Tuti, quando è fuori, è un nonno affettuoso, innocuo, nostalgico. Alleva cavalli, scrive libri e aiuta il nipote a fare i compiti. Dentro, i carcerati li chiama compagni. Non si è mai pentito, ma incalzato dagli intervistatori afferma che oggi non farebbe la lotta armata, perché non verrebbe capita. Attorno a lui, il film documenta un interessante e inquietante spaccato sulla destra sociale e proletaria della campagna laziale, dove Tuti trova largo appoggio.

Fermo restando che c’è solo un verso giusto di prendere il fascismo, rivoluzionario o governista, ossia quello caro all’antifascismo; e posto che gli anni di piombo non possono essere letti come un fenomeno unitario (a partire, per esempio, dalla diversa complicità del terrorismo rosso e nero con Stato, P2, servizi segreti internazionali e industriali), il Corpo dei giorni interroga la nostra contemporaneità più che la memoria di anni di conflitto riappacificato solo in superficie. O almeno questa sembra l’intenzione e l’interesse principale dello sguardo che filma. Tuti non è certo un esempio, ma perfino lo scontro con le tensioni individuali e storiche degli anni Settanta funge da specchio per noi oggi. Uno sguardo retrospettivo alla modernità, con tutto ciò che ha generato: colonizzazione, devastazione ambientale, sfruttamento e sviluppo, violenza, disuguaglianza, esaltazione futurista di allora, per comprendere la confusione che essa ha accumulato nel futuro incerto di oggi, mentre incancrenita muore per lasciare spazio alla “generazione Ryanair”, come la chiama Tuti.
Per ragionare con gli autori del documentario, partiamo da uno scambio tra Gianvito Cofano e Mario Tuti. Cofano dice: “La differenza sostanziale tra me e te sta nel dubbio: tu non ti poni dubbi, e io questo non riesco a comprenderlo, perché nel dubbio c’è tutto, se non avessi dubbi non crescerei. Infatti quello che mi chiedo è: In questi anni sei cresciuto? O sei rimasto a cinquant’anni fa?”.
Mario risponde: “Sicuramente sono cambiato, non necessariamente cresciuto… Io obiettivamente dubbi non ne ho, io ho certezze”.
C’è, secondo i registi, qualcosa di “generazionale” nella radicale differenza di mentalità tra soggetti politici come Tuti e la nostra generazione incerta, più complessa, talvolta depressa?
Henry Albert: C’è, senza dubbio. Mario Tuti nasce nel ‘46, prima ancora del muro di Berlino, e vive una stagione politica di contrasti assoluti. Il più giovane di noi nasce nel ‘92, l’anno di uscita di quel gran equivoco che è stato The End of History di Fukuyama, gli altri tutti nell’‘89. Una generazione cresciuta in una società di ideali ci ha fatto sapere, fin dalla nascita, che ci aspettava un mondo post-ideologico… Ed è per questo che abbiamo sempre avuto l’impressione di parlare a Mario di idee, mentre lui ci rispondeva con ideologie. Ma se un’ideologia è eterna, non è intrinsecamente desueta?
Nikola Lorenzin: Ci è stato detto, da sempre, che apparteniamo a una generazione post-ideologica, imponendoci un nichilismo e una disillusione dai quali è difficile liberarsi e che troppo assomigliano a una forma di controllo. Lo scontro generazionale è quindi il tentativo di sfuggire a questa forma di controllo, per sottrarci a un bendaggio volto a nascondere i fallimenti del passato.
Gianvito Cofano: Mario e la sua generazione sono nati e cresciuti in un momento storico preciso, post-guerra. Questo elemento ti racconta per tutta la vita che il cambiamento, in bene o in male, è possibile, quindi la sensazione che la tua azione possa fare la differenza nel presente è enorme. Oltre questo, Le ideologie “sul mercato” erano polarizzate, quindi in distinzione netta, quasi semplice se vuoi. Come diceva Mario, i comunisti avevano “il libro”, una bibbia che ti dice cosa è giusto o sbagliato.

I nostri nonni e genitori, quando parlavano di cambiamenti, si riferivano all’ottenimento di cose essenziali e palpabili – avere la luce in casa, permettere alle donne di votare eccetera… Mi sembrano necessità primarie e soprattutto che toccano il personale in maniera drastica, l’azione è per te e ora. Noi viviamo un mindfuck totalizzante, siamo stati formati da una cultura capitalista e individualista. Se però guardi alle lotte e le posizioni che vorremmo affrontare oggi, si tratta di lotte e rivoluzioni globali, che guardano il macro, sia a livello temporale che spaziale, le lotte sono “per il pianeta”, per il “sistema capitalistico globale”, “per il futuro, perché per l’oggi è tardi”. È un modo molto diverso di ragionare il cambiamento. Le nostre generazioni si mettono a confronto con il sistema mondo, in molti argomenti addirittura universo, non Stato o casa. In più, a causa dell’annullamento delle distanze e la velocità delle informazioni, la consapevolezza delle sfaccettature del mondo è più grande e complessa. Il tutto con, sul groppone, l’assoluta sicurezza che tutto quello che vorremmo risolvere è stato causato da quelle generazioni che si presentano piene di certezze, le stesse che non vogliono fare i conti con i danni fatti.
Pietro Sarasso: Forse sarà inevitabile fino a quando pretenderemo di cambiare il pianeta o il sistema globale come dici tu. In effetti chi non si sentirebbe impotente di fronte a tale enormità? Magari cominciando dal piccolo e dal prossimo, organizzandosi senza sopravvalutarsi si può vivere in maniera meno straniante. Voi nel vostro piccolo perché avete fatto questo film?
HA: Se siamo stati in grado di diventare enormi al punto da poterci garantire un’estinzione autoinflitta, siamo enormi abbastanza da evitarla. Cominciare da sé, dalla propria prossimità, è riconoscere che l’operato umano è interamente culturale. E per questo credo che dal personale al politico ci saranno ancora catalizzatori di trasformazioni globali, dal basso.
GC: Premetto che secondo me non va cercato un motivo del perché si fa un film: fare un film non è legato alla sfera dell’utilità. I film andrebbero sempre presi come manifestazioni del presente. Quando siamo partiti era marzo 2020, Siamo andati da un ergastolano perché non sopportavamo l’idea di essere rinchiusi, lo trovavamo disumano, eravamo mossi da questioni emotive personali condivise e volevamo avere un confronto con un soggetto estremo, come un ergastolano fascista, qualcosa di molto lontano da noi, pensando che magari, sotto sotto, a livello umano, avremmo trovato una dimensione di sofferenza comune a prescindere da tutto. Trovarci di fronte a un soggetto “disumano”, una persona che non aveva nessuna intenzione di parlare di sofferenza, perché pretendeva di non essere debole, ci ha messo fortemente in crisi. Non capivamo come questa cosa fosse solo lontanamente possibile. Quindi il film è diventato una ricerca disperata di umanità. La cosa bella è che ne eravamo circondati, tutto intorno a Mario c’erano lacrime, di gioia per una figlia ritrovata, di tristezza per paura di rimanere soli, del tentativo disperato di cercarle dove provano a nascondersi. Forse abbiamo continuato a fare questo film perché non abbiamo mai accettato che risultare “deboli” fosse una sconfitta.
NL: Posso solo aggiungere che ero molto attratto dall’idea di indagare in che modo Mario avesse resistito a così tanti anni di isolamento nei cosiddetti braccetti della morte. Come per altri tentativi d’indagine che abbiamo intrapreso nei suoi confronti, la risposta è stata deludente e una soltanto: eravamo di fronte a un monolite.
PS: Mario Tuti dice di aver vissuto in guerra. In effetti anche una commissione parlamentare ha riconosciuto in quegli anni la forma di una guerra civile a bassa intensità. In che modo pensate che differisca il rapporto con la violenza tra la nostra generazione e quella moderna?
GC: Le nostre generazioni vedono violenza da tutta la vita, in internet, al cinema, in televisione, ne siamo totalmente assuefatti, L’abbiamo sempre vissuta in maniera estetica e non fisica, questa è una prima differenza che ci ha sempre fatto riflettere sulla natura e l’efficacia della violenza. Ma non si tratta solo di una questione generazionale, il rapporto con la violenza cambia tanto in base a dove e come nasci, le rivolte di “Black Live Matters” ne sono un esempio, se sei nero e la polizia ti ammazza, la situazione cambia.
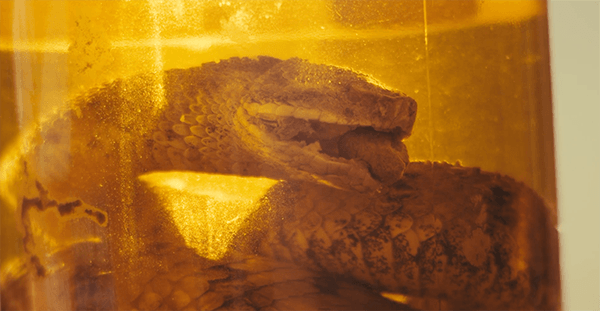
Come dice anche Henry nel nostro film, “sono cambiati i modi ed i mezzi che ci permettono di metterci in gioco”. Durante le proteste di BLM, mentre i neri erano per strada in una dinamica molto violenta, ricevevano supporto da ragazzini e ragazzine di tutto il mondo con un attacco tutt’altro che violento, tutti fan del Kpop, una rete di ragazzini uniti nel supportare le proteste BLM, hanno fatto fallire diversi tentativi della polizia di individuare gli attivisti per strada tramite l’aiuto degli utenti contro la protesta, la polizia aveva lanciato un hashtag da usare per accorpare facilmente tutte le segnalazioni delle persone. I fan del Kpop, uniti, hanno reso questo hashtag totalmente inutile utilizzandolo diversamente e inondandolo di contenuti di cantanti Kpop, così rendendo l’individuazione dei manifestanti molto più complessa. Hanno utilizzato lo stesso metodo per agevolare le proteste distribuendo informazioni utili, come gli atti violenti della polizia, creando in un batter d’occhio centri di donazione, luoghi di incontro e assistenza legale. È solo un esempio come ce ne sono tanti di questo tipo, ma rende bene l’idea dell’efficacia di altri modi per combattere. La violenza una volta era il miglior modo di essere notati, di guadagnarsi una voce. Oggi ci sono molti modi diversi di far sentire la propria voce. Si può bloccare il mondo senza torcere un capello a nessuno.
NL: Di nuovo, la differenza è strutturale. Le ideologie offrivano un posto preciso alla violenza, incanalandola e informandola di significato. Veniva giustificata perché era volta alla trasformazione del mondo – dal terrorismo alla geopolitica. Oggi, in mancanza delle categorie che possano assegnarle un significato, la violenza è rimasta spoglia di qualsiasi sovrastruttura, ridotta a mero atto pragmatico volto a mantenere uno status quo: quello capitalista colonialista patriarcale, di sfruttamento intensivo delle risorse del pianeta, volto a mantenere la divisione del mondo in primo, secondo e terzo.
PS: Benasayag parla di “età dell’incertezza”. Dice che “fragilità vuol dire che il non sapere è intrinseco alla vita” e che saper vivere la fragilità con coraggio decreterà la fine della modernità. Può la fragilità essere un valore?
HA: La fragilità non è un valore, è una componente fondamentale dell’esperienza umana. L’accoglienza, la comprensione, la tutela della fragilità sono valori, mi viene da pensare antropologici ed estendibili a livello individuale, familiare, tribale, societario. Una società costruita per ricevere i suoi membri più fragili è una società pronta a ricevere tutti.
GC: Accettare le proprie fragilità vuol dire accettare quelle di tutti, vuol dire essere inclusivi e rigettare il sistema in cui viviamo che si basa sulla forza e l’individualismo, quindi sull’esclusione. È assolutamente un valore, volto ad un cambio di sistema totale. Come dicevo nella prima risposta, il problema è che una strada lunga e straniante, perché contrapposta a tutto quello che ci hanno insegnato, con cui ci scontriamo quotidianamente.

NL: Per porla al centro del cambiamento va inquadrata come valore, sovvertendone il significato. La realtà dei fatti è che fragili lo siamo tutti, al netto di qualsivoglia forzatura ideologica. Forzare una struttura basandosi su assunti troppo semplici e rigidi ha già ampiamente dimostrato il suo fallimento. La sfida che abbiamo davanti è quella di creare una struttura più flessibile, modulare, inclusiva, che possa fare a meno della violenza. Il rischio è quello di perdersi nella sua costruzione, tracciando continuamente nuovi confini. Probabilmente ne vale la pena. Di fronte a certe cose, e in certi percorsi di rivendicazione ed evoluzione sociale però sarebbe meglio non essere fragili o confusi.
HA: Perché no? Forse sarebbe meglio non essere soltanto fragili e confusi. Si parla appunto di evoluzione sociale – l’evoluzione è un processo di fluidità e concatenazioni, che necessità la consapevolezza delle sue complessità per essere impattato. La determinazione cieca crea sbarramenti superficiali, funzionali a chi vuole un controllo dall’alto della direzione dell’evoluzione sociale. La migliore risposta, dal basso, è l’empatia, la ricerca del tracciato comune, che è molto più evidente nelle paure, nelle indecisioni, nella fragilità, nella confusione.
NL: La cieca difesa di un sistema a tutti i costi ha portato soltanto a sviluppare la retorica per difenderlo. Come dicevo sopra, il rischio è quello di perdersi. Però è proprio questo il punto: accettare la fragilità, a livello collettivo, significa accettare che guidi il nostro percorso. Avere il coraggio di essere fragili significa avere il coraggio di perdersi, confondersi, e ripartire, consapevoli che la somma degli errori avrà risultante positiva. Accettare la fragilità è un patto di fiducia sociale, collettivo, che implica una rivoluzione strutturale.
S: Voi vi siete persi nel dialogo con Mario, ma vi siete anche ritrovati? Avete scelto di esporvi entrando con la vostra autenticità come soggetti nel documentario. È un documentario su di voi quanto su Mario Tuti, o meglio sul vostro incontro. Cosa avete scoperto di voi stessi riguardandovi?
NL: Sento di rigettare e di ribaltare, con una decisione che non avevo, l’accezione negativa insita nell’etichetta di generazione post-ideologica. Penso che sia per noi l’unico punto di (ri)partenza possibile.