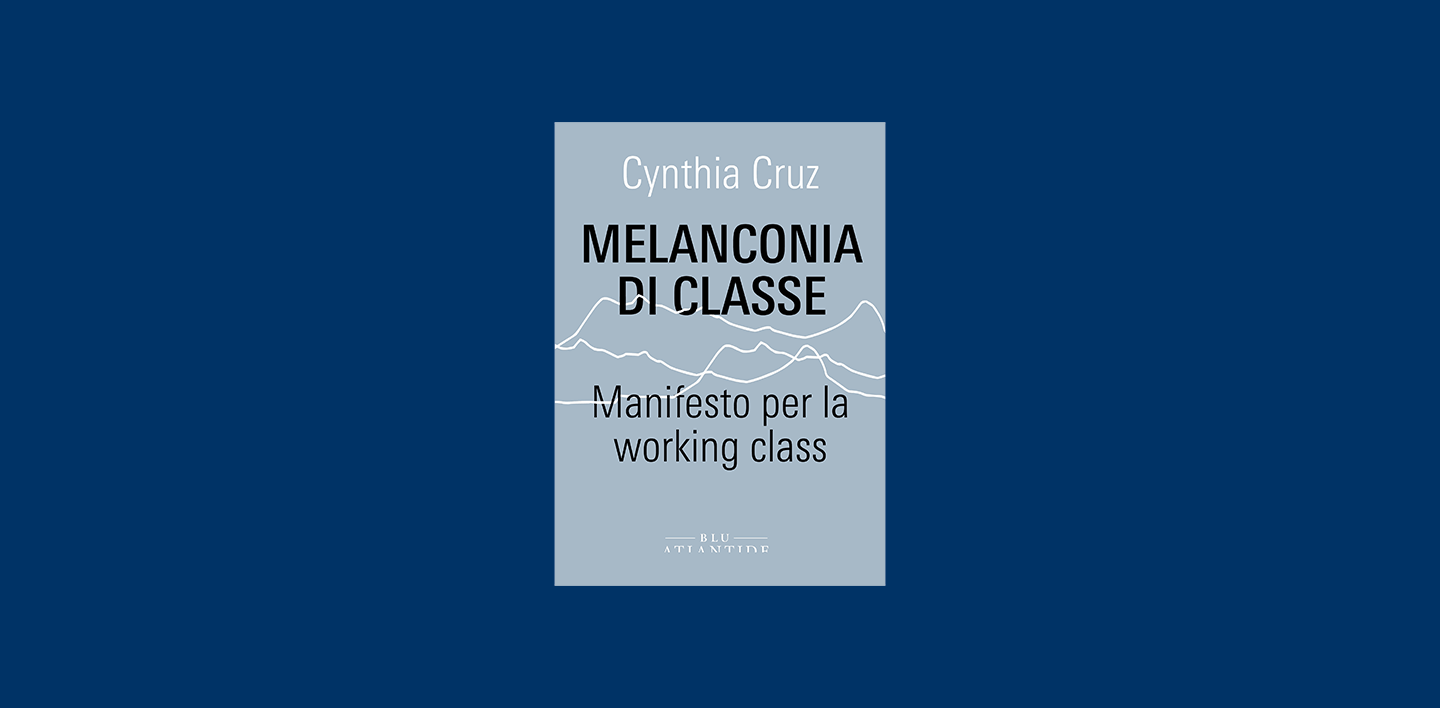
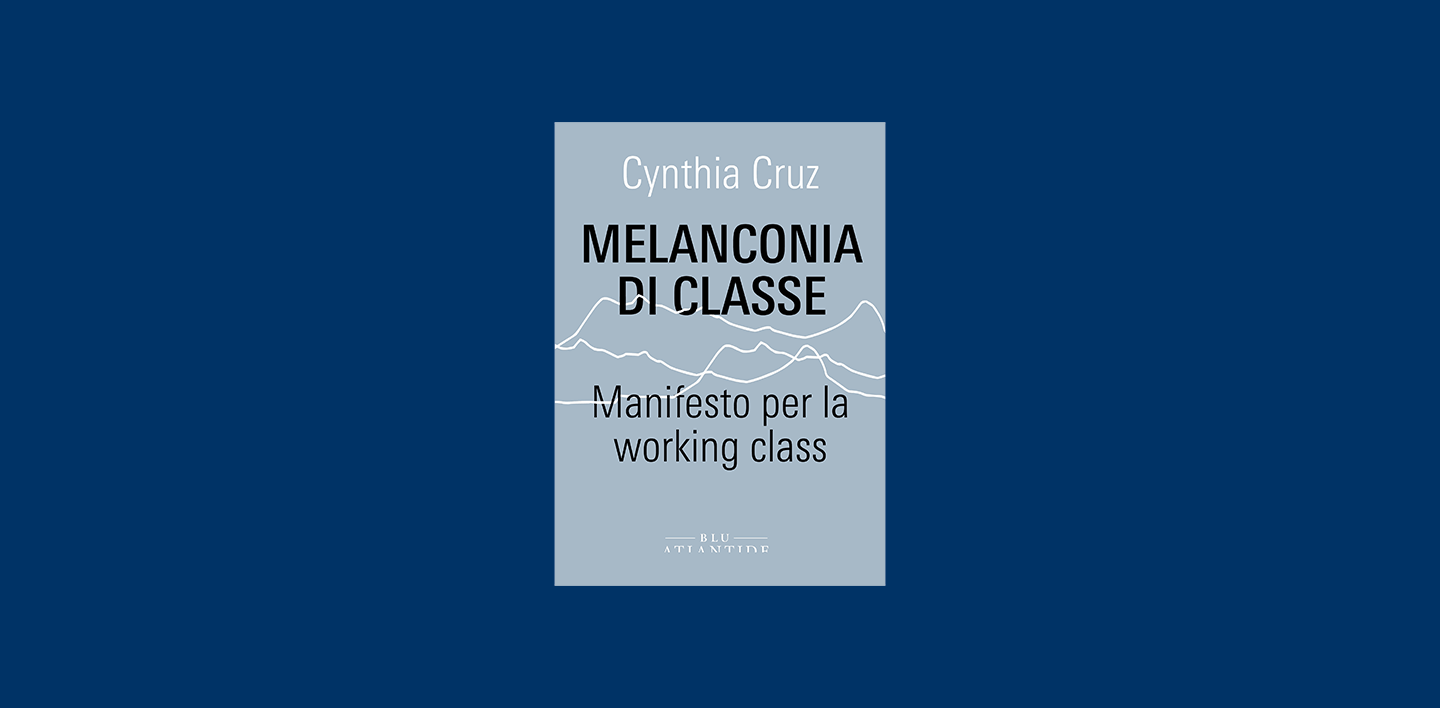
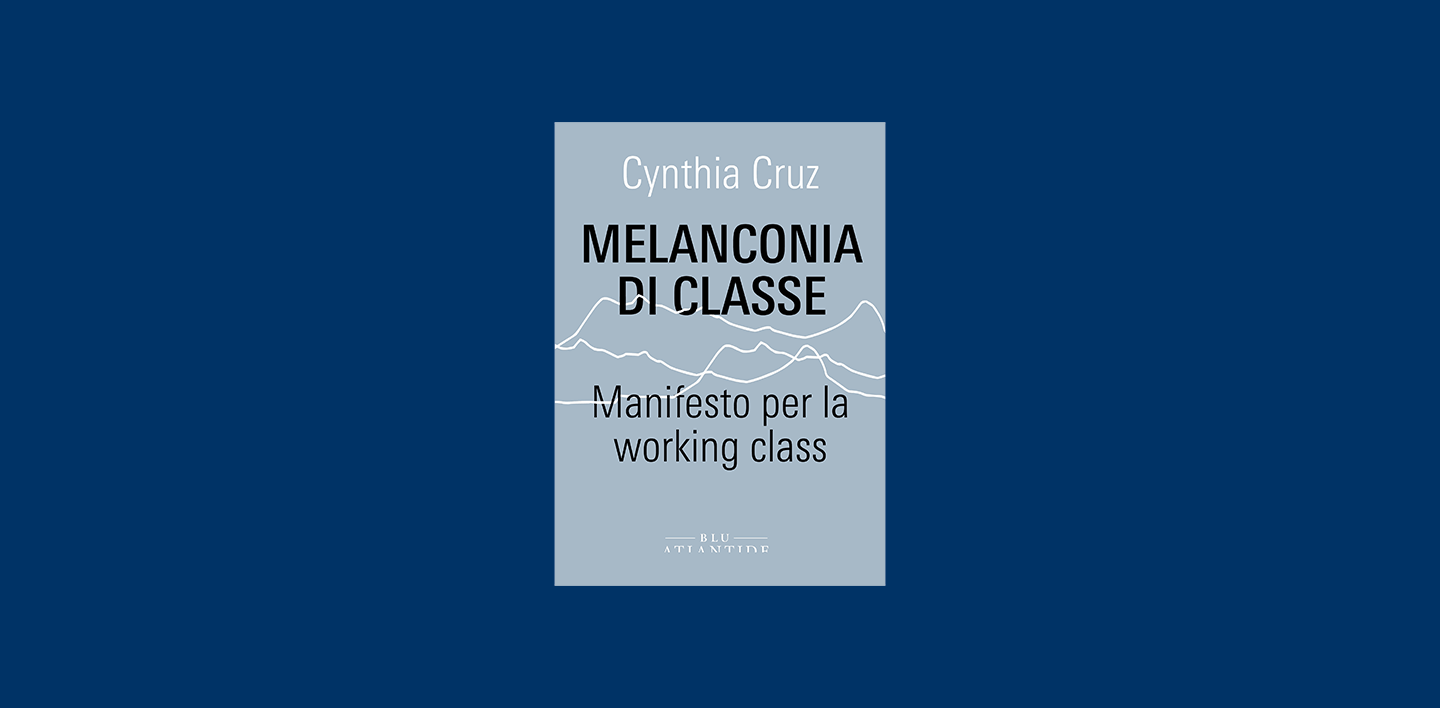
F ino a pochi decenni fa, i problemi degli intellettuali erano di natura puramente gnoseologica. Un intellettuale si dimostrava tale nella misura in cui sapeva delle cose ed era in grado di compiere ragionamenti brillanti. Sebbene sin dalla civiltà greca siano esistite nicchie e correnti di pensiero stravaganti – “sottoculturali” – che cercavano di scardinare il pensiero dominante, con la nascita del marxismo e poi soprattutto con l’avvento del Sessantotto qualsiasi forma di pensiero ha dovuto fare i conti – la frase potrebbe terminare qui! – con la sociologia, con l’antropologia e con la “volgare” economia. Da quel momento in poi l’intellettuale non ha potuto più proferire parola con la leggerezza con cui era solito farlo nelle epoche precedenti. Da quando la borghesia è stata descritta sin nei suoi tratti più oscuri, ovvero quelli che riguardano la liceità del potere, parlare anche semplicemente di una sedia significava schierarsi da una parte o dall’altra. Da qui il monito “ogni cosa è politica”. Fare un discorso in cui si dà per scontato il fatto che certe persone possano legittimamente esercitare forme di potere su altre persone equivale a essere considerati “borghesi”, o a perpetuare il “pensiero borghese” o “capitalista”.
Fare un discorso in cui si dà per scontato il fatto che certe persone possano legittimamente esercitare forme di potere su altre persone equivale a essere considerati ‘borghesi’, o a perpetuare il ‘pensiero borghese’ o ‘capitalista’.
Dall’altra parte c’è la cultura proletaria, ovvero quella caratterizzata da chi è sottomesso a forme di potere, o da chi mette in discussione queste forme di dominio. Parlare di qualcosa senza avere in mente questo asse manicheo è considerato dalla cultura proletaria come una forma di pensiero borghese. Non c’è scampo. Il libro di Cynthia Cruz, Melanconia di classe, fa la sua dichiarazione di intenti nell’introduzione, proclamando che “il neoliberismo sostiene che siamo nati tutti uguali, con lo stesso accesso al capitale materiale, culturale e sociale, e che le classi sociali non esistono”. Per l’autrice, “continuare ad affermare il contrario significa dimostrarsi degli ingrati, essere negativi, deprimenti e spesso perfino malati di mente”.
L’intellettuale contemporaneo è quindi afflitto da questa consapevolezza. Egli è costretto a compiere questa scelta o a muoversi nell’ambiguità. In qualunque campo della cultura esso operi, le sue forme espressive ambiscono a un pubblico, ed egli teme più di ogni cosa il giudizio negativo della sua platea. Per un militante esiste qualcosa di più insultante dell’essere considerato un “intellettuale borghese”? Probabilmente no. Chi non trova insultanti queste due paroline non è un militante, quindi ragiona mediante una tassonomia critica astratta, che può essere considerata addirittura anarchica o agnostica, ma proprio per questo non ha diritto a proferire parola sulla questione politica: o meglio, può farlo, ma le sue considerazioni non sono accettate dalla comunità militante. Colui che invece ha a cuore questa problematica deve fare una scelta che investe tutto lo spettro della sua esistenza. Quest’ultima è compromessa a seconda del grado di radicalità al quale l’intellettuale in questione vuole aderire. Ad esempio: l’intellettuale non borghese che vuole operare nel mondo mainstream ha accesso a qualsiasi media, dalla tv ai social, ma sarà preso in considerazione unicamente dalla platea che fruisce di quel mondo mediale senza problematizzarne i meccanismi capitalistici e le sue accentuate forme di dominio propagandistico. Da questo punto di vista è lampante la parabola esistenziale di un personaggio come Zerocalcare: appassionato militante che proviene dal mondo dei centri sociali e della sottocultura punk romana, scontratosi con il successo mondiale e con la fagocitazione della sua figura pubblica da parte del mondo mainstream. Qualsiasi affermazione di Zerocalcare è infatti arricchita da una lunga serie di ampollose secondarie che hanno l’intento di giustificare questa sua accettazione di quel mondo così distante e antitetico al mondo in cui è cresciuto. Gli sguardi dei militanti radicali a cui Zerocalcare risponde con le sue giustificazioni sembrano gridargli che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, proprio come non si può essere accettati dal mondo anni Novanta dei centri sociali e contemporaneamente da quello del pubblico di Espresso e di Propaganda Live, a meno che si abbia la capacità di non parlare di questioni inerenti la politica e il sociale – e in tal caso la circonferenza degli argomenti da trattare si restringerebbe in maniera vertiginosa.
Per un militante esiste qualcosa di più insultante dell’essere considerato un ‘intellettuale borghese’? Probabilmente no.
In maniera non troppo diversa, anche Cynthia Cruz compie la stessa operazione di Zerocalcare. La prima parte del suo libro è una lunga giustificazione che si concretizza nel racconto delle sue origini umili in un contesto borghese. Da qui emerge un grande problema: “La città in cui vivevo e le scuole che frequentavo erano borghesi, e sebbene non ne fossi consapevole, immaginavo che vivere in quel contesto avrebbe fatto diventare borghese anche me, in qualche modo”, principalmente, e più semplicemente, perché tutto il mondo circostante è “espressione della classe media”. Secondo pensatori considerati dal mondo mainstream come vetero-comunisti, ma che hanno fatto la storia del pensiero politico mondiale, come ad esempio Mario Tronti, la scomparsa della frattura tra mondo operaio e mondo borghese in favore dell’ascesa di una classe media totalizzante è stato tra i fattori che hanno contribuito clamorosamente a determinare la scomparsa di quella lotta politica che avrebbe potuto sconfiggere il capitalismo. Per Tronti, il fondatore di quella corrente del marxismo non ortodosso chiamata Operaismo, questo evento coincide con l’avvento della società dei consumi. Come a dire, dopo la società dei consumi, qualsiasi forma di politica militante che abbia ambizioni rivoluzionarie è impossibile. D’altronde, proprio Jean Baudrillard, che coniò la definizione, di società dei consumi, in un suo famoso libro del 1970, disse che qualsiasi atto rivoluzionario dopo quell’epoca, caratterizzata dall’ascesa dei media e della pubblicità, equivaleva a una mera replicazione simulatoria di un contenuto. Baudrillard ebbe modo di cogliere, negli anni Sessanta, la società dei consumi proprio nel suo momento di nascita. Si assistette all’illusione generale di benessere collettivo – mai così tante persone prima di allora avevano posseduto oggetti utili, come ad esempio il frigorifero –, ma anche al suo conseguente processo di omologazione culturale. Il Sessantotto, da questo punto di vista, è stato il culmine dell’omologazione e della rivoluzione. Piuttosto, è stato il simulacro della rivoluzione: il corpo è liberato, l’essere umano è emancipato, la rivoluzione si è fatta atto. E dopo l’abbuffata rivoluzionaria sessantottina, non resta altro che il nichilismo, dal momento che nulla è cambiato, se non addirittura peggiorato.
Bisognerebbe cercare di scoprire una volta per tutte se il movimento politico generale del Sessantotto avesse avuto tra i suoi intenti quello di mettere in atto una rivoluzione con gli stessi intenti di quella russa, ovvero se avesse espresso la volontà di porre fine ai soprusi dei potenti nei confronti dei deboli. Il Sessantotto è stato questo o un macro-prodotto della società dei consumi? Ad esempio, per Baudrillard è stato la seconda cosa. Dopo la società dei consumi (e anche dopo il Sessantotto), arriva lo spazio per la controcultura – sebbene fosse nata già prima, mai prima di quel momento aveva avuto un ruolo così importante. Quasi a voler dire: la cultura dominante è questa e tale resterà, tanto vale creare o aderire a una “nostra cultura”. Lo splendore sottoculturale è durato infatti alcuni decenni. Per anni ha avuto quantomeno una funzione: “L’illusione è la regola fondamentale”, ancora secondo Baudrillard. Dopo la rivoluzione totale del Sessantotto, in cui ogni cosa è stata rivoluzionata, perfino il sesso e il corpo, non restava altro che il nichilismo. Tutto era stato rivoluzionato, ma al tempo stesso nulla era stato rivoluzionato. Cynthia Cruz racconta delle sue esperienze con gli Husker Du e gli X (“la musica e le parole rispecchiavano la mia rabbia interiorizzata: quella coincidenza di sentimenti mi dava un immenso sollievo”) lasciando emergere la matrice nichilista del piacere procurato dall’ascolto. Cruz insiste sull’illusorio portato rivoluzionario del progressismo quando dice che si tratta di “[…] un’ideologia della classe media, un’ideologia dello status quo, superficiale e anti-rivoluzionaria”. È proprio così. Ma nemmeno le sottoculture, ovvero quelle subculture che “[…] con la loro mera esistenza incarnano degli atti di resistenza contro lo status quo”, si autoproclamano come rivoluzionarie. È proprio nell’etimologia del termine che viene svelata la loro funzione: essere al di sotto o contro la cultura dominante. Sottocultura e controcultura sono quasi sinonimi, se non altro ambedue i termini danno per scontato l’esistenza di una cultura altra dalla quale si discostano. Con sottocultura solitamente si fa riferimento a quell’insieme di persone che condivide la passione per interessi e valori atipici, che però non intendono contrastare la cultura dominante; è piuttosto intuitivo a questo punto capire invece cosa si intenda abitualmente per controcultura.
Dopo l’abbuffata rivoluzionaria sessantottina, non resta altro che il nichilismo, dal momento che nulla è cambiato, se non addirittura peggiorato.
Senza cultura dominante non esisterebbero quindi nemmeno le subculture. Vi è una sorta di rassegnazione all’interno di questo discorso, una disfatta che dà per scontato l’esistenza di un mondo dotato di una cultura errata, ma dominante, che si pone in una situazione di potere nei confronti di un’altra, inferiore, sottostante, storta, deviata. Quest’ultima è la subcultura. La cultura della working class. Una cultura che si pone in contrasto con la cultura “vera”, alta. La cultura con la “C” maiuscola, che non equivale a dire cultura classica, né tantomeno cultura popolare, bensì, semplicemente, la cultura dominante (ancora una volta) – dove “dominante” richiama proprio il dominio marziale. Tanto per cominciare, un tipo di cultura che non è progressista e che non considera il futuro come qualcosa di radioso, ma come qualcosa di cupo e di grigio. Eppure si può essere controculturali anche organizzando divertenti feste in pigiama (come si narra facessero i Beat Happening) o, più clamorosamente, mettendo “fiori nei vostri cannoni” e professando la pace, come facevano invece coloro che furono tra gli iniziatori delle controculture, gli hippie. Se è vero infatti che il termine melanconia è spessissimo associato a qualcosa di perduto nel tempo, è giusto soffermarsi sul carattere temporale della controcultura. Se una cosa è stata controculturale un tempo, non è detto che oggi lo sia. Anzi, probabilmente, ponendosi la controcultura come movimento avanguardistico nei confronti di certi valori inosservati o addirittura ripudiati dalla cultura dominante, col passare del tempo quegli stessi valori hanno finito per essere assorbiti e inglobati nella cultura dominante. Per fare un esempio chiaro: il rap, uno dei generi musicali più controculturali, per via dei suoi testi espliciti, fortemente critici e di rottura, era ricchissimo di frasi contro le donne e della parola madre tra quelle proibite, il termine “nigga”, mentre oggi un artista come Kendrick Lamar ha vinto il premio Pulitzer e ha interrotto alcuni dei suoi concerti dopo aver notato tra il pubblico qualche bianco cantare un suo pezzo contenente la parola “nigga”. C’è sempre stata confusione tra cosa fosse e cosa non fosse controculturale, ma oggi il suo significato originario sembra essere totalmente svanito. Tornando alla società dei consumi, le sottoculture, per come le hanno conosciute le persone innamorate di quel mondo, probabilmente oggi non potrebbero proprio esistere. Esse infatti ebbero il loro massimo periodo di splendore parallelamente al periodo di esplosione dei grandi consumi di massa, quei decenni in cui si sperimentarono processi industriali per ogni desiderio, passione e hobby inerente l’umano. Tra questi ovviamente quello musicale, letterario, cinematografico, artistico. Questo avvenimento velocizzò in maniera talmente convulsiva i processi creativi e produttivi (spesso non sempre direttamente legati e quelli artistici) da consumare il consumabile nello spazio di alcuni decenni. Qualsiasi forma e contenuto sono stati esplorati, così come qualsiasi contro-forma e contro-contenuto. L’istantaneità di internet ha dato il colpo di grazia. Un tempo sapere cosa pensasse un grande scrittore di un avvenimento storico era cosa che poteva circolare solo dopo un certo periodo di tempo e attraverso dei media ancora ipo-moderni. Con internet siamo invece definitivamente entrati nel moderno. Qualsiasi avvenimento, anche il più insignificante, può (e deve) essere commentato in maniera istantanea, rendendo la vita dell’intellettuale un percorso esistenziale che col passare del tempo sembra assumere sembianza sempre più atelofobiche, piuttosto che del pensatore dallo spirito libero a cui la visione romantica della cultura dominante ci aveva abituati.
Senza cultura dominante non esisterebbero quindi nemmeno le subculture.
Le sottoculture erano quindi nichiliste, e non rivoluzionarie, come spesso si sente dire. Ce ne dà conferma quella che resta ancora oggi l’ultima, a mio parere, vera sottocultura musicale: la vaporwave. Si tratta di una sottocultura particolare, la prima davvero diversa dalle altre del passato. Innanzitutto essa non è legata al proprio territorio di appartenenza, in quanto si manifesta come fenomeno puramente internettiano. Non è generalmente legata a supporti fisici, né tantomeno a concerti. È un movimento in tutto e per tutto virtuale. Ma questa sottocultura interamente virtuale, composta da misteriosi avatar e nickname, ha per messaggio nientemeno che il fallimento utopico del progetto internet. La vaporwave è caratterizzata da un immaginario che rappresenta l’esaltazione di un futuro radioso e tecnologico, ancora tutto da realizzare, che la primissima fase internettiana aveva introiettato negli utenti (e non) dagli anni Novanta.
Il messaggio lanciato dalle sottoculture era nichilista, ma era pur sempre un messaggio. Almeno, attraverso le sottoculture, le persone avevano (hanno?) l’opportunità di sviluppare una “protocoscienza” di classe. Chi subisce realmente il fascino delle sottoculture, pur non dichiarandolo esplicitamente, dovrebbe ritrovarsi automaticamente in conflitto con la liceità del potere. La sottocultura è forse una sorta di pre-linguismo di quello che accademici e intellettuali verbalizzeranno poi in maniera pedante e noiosa. Cynthia Cruz sembra aver capito che le subculture non esistono più, stanno scomparendo come qualsiasi prodotto della società dei consumi. Qualsiasi prodotto, come del resto qualsiasi cosa, ha un ciclo vitale che conclude con la morte. Da qui la romanticizzazione nei confronti della classe: Melanconia di classe.