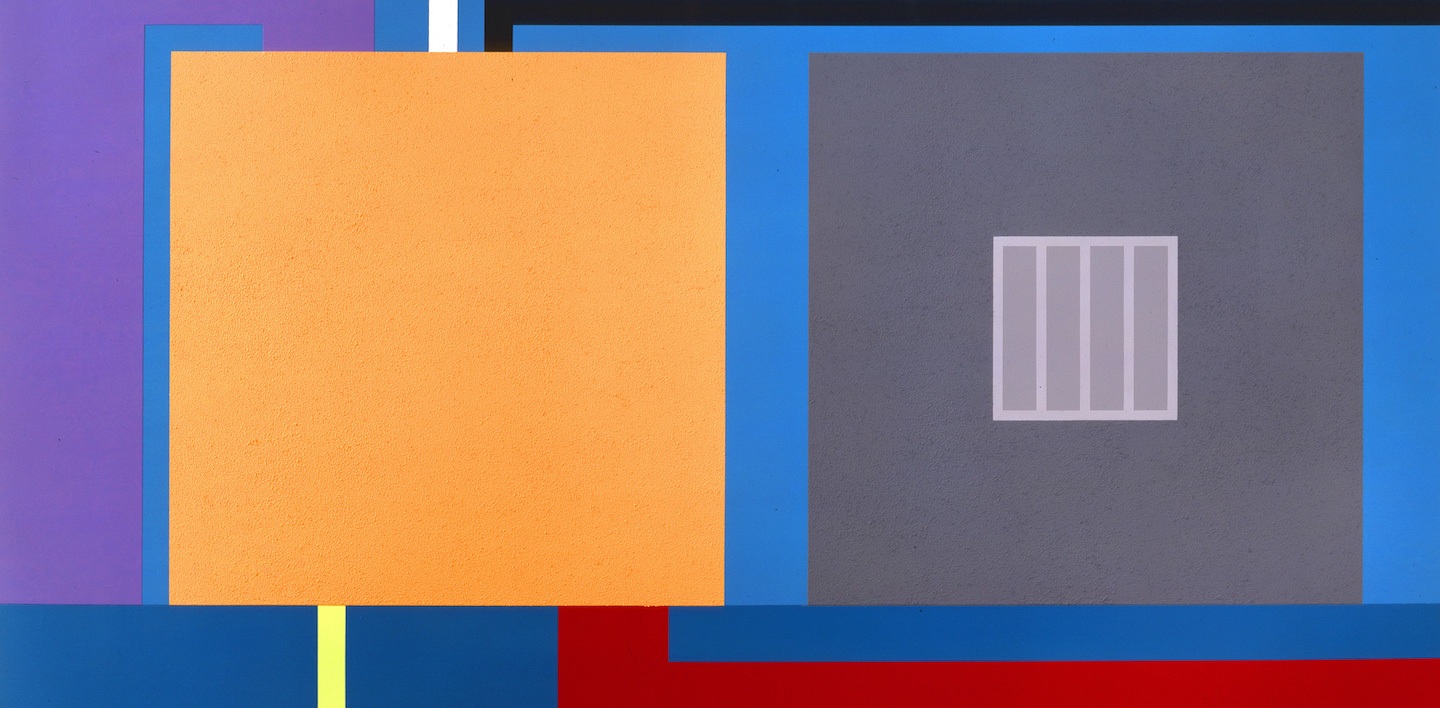
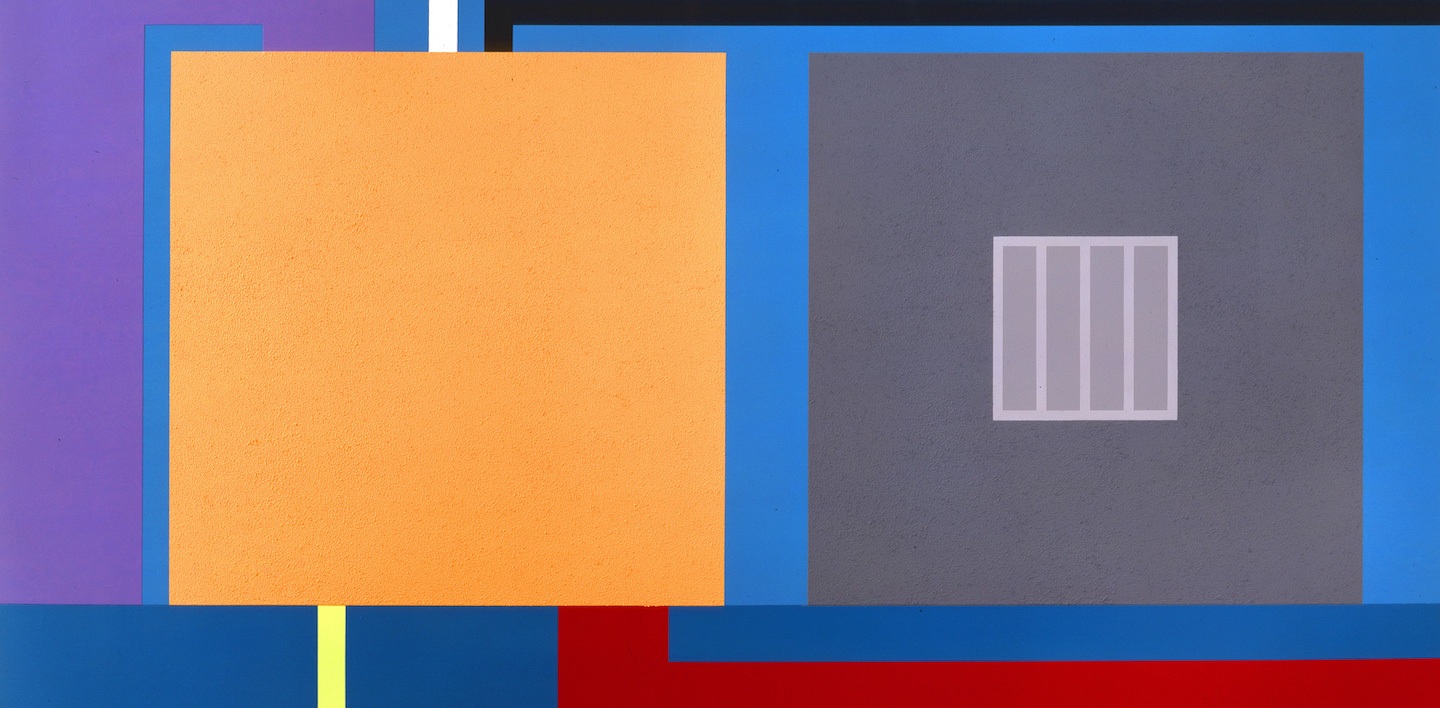
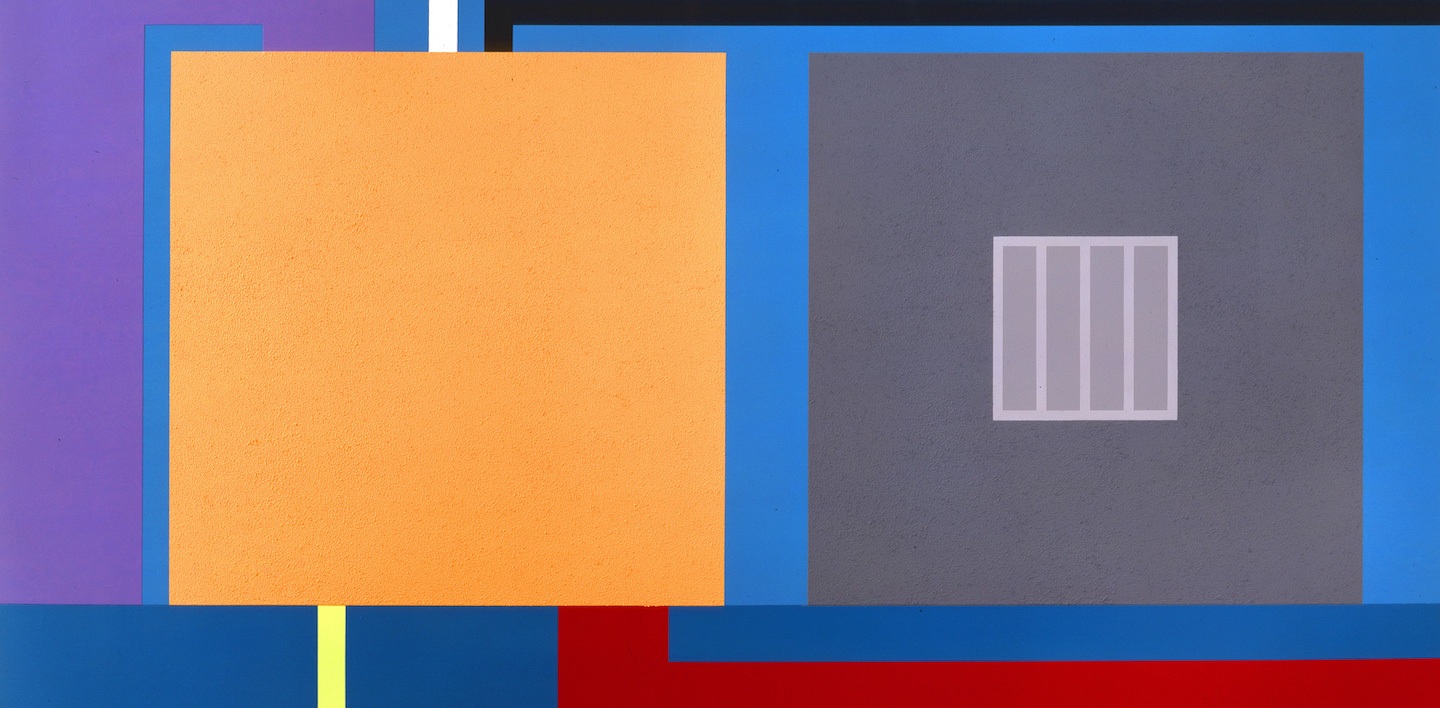
L e multinazionali, la libera circolazione dei capitali e le grandi unioni economiche sono state a lungo indicate come segni di una globalizzazione che superava la forma dello Stato, e le sue problematiche eredità, per volgere verso un mondo privo di confini e conflitti. Un “flat world”, nelle celebri parole di alcuni. Un mondo alla “fine della Storia” in quelle ancor più celebri di altri. Un mondo “senza più giochi a somma zero”, per citare un mantra dell’era Clinton. Un mondo che avrebbe abbracciato i valori, “moralmente superiori”, della democrazia e del libero mercato, dell’interdipendenza e della cooperazione, a discapito di ideologie e divisioni antiquate.
Gli assertori di queste tesi erano certi che, una volta assaporato il benessere, anche la Cina si sarebbe convertita alla democrazia. Senza tale convinzione essa non sarebbe stata accolta con tanta “serenità” nel processo di divisione internazionale del lavoro, nella forma sancito dalla sua adesione al WTO nel 2001.
L’Occidente aveva del resto scelto di dare letture asimmetriche a due eventi dello stesso anno, il 1989: la caduta del muro di Berlino e i moti di piazza di Tiennamen. Del secondo aveva decantato solo il potenziale rivoluzionario, sottovalutando la fermezza della repressione di Deng Xiaoping. Nel primo aveva scorto solo un proprio trionfo, senza rendersi conto che esso era soprattutto il frutto di un fallimento endogeno dell’URSS. Due peccati di hybris che, a posteriori, ci ricordano la fiducia riposta nell’evangelizzazione liberale a cavallo tra anni Novanta e Duemila.
Seppure rimodellata al ribasso tale fiducia ha resistito all’11 settembre, alla “war on terror”, al crack del 2008, alla crisi del debito europeo, alla “piccola” guerra fredda mediorientale. Si può dire che essa abbia iniziato a mostrare crepe solo nel 2016, con la Brexit e la vittoria di Trump. Due shock, per molti versi simili, che hanno colpito i due ventricoli del cuore occidentale: Londra e Washington, la vecchia e la “nuova” capitale dell’Impero. Al tempo parvero anomalie. Oggi sappiamo che erano avvisaglie di un “nuovo normale”. Sotto i colpi del covid, del revisionismo putiniano e della tensione sino-americana, l’epoca delle “magnifiche sorti e progressive” globali pare tramontata. Sono tornati in scena i grandi attori geopolitici con tutto il loro bagaglio di divisioni e sfere d’influenza, alleanze e ostilità.
La Brexit e la vittoria di Trump parvero anomalie. Oggi sappiamo che erano avvisaglie di un “nuovo normale”.
Negli ultimi due anni la sintomatologia del nuovo evo post-globale si è palesata dovunque. Nei sospetti sull’origine del covid. Nelle risse per i vaccini. Nel rafforzamento del controllo sociale. Nell’interventismo politico su tassi, moneta e deficit. Nell’ampia diplomazia richiesta dai rebus energetici e dall’economia di guerra. Nonché, ovviamente, nella guerra stessa.
Il combinato “pandemia + guerra” ha colpito con particolare durezza uno dei principali motori della globalizzazione: il processo produttivo transnazionale, le “global value chain” (GVC). Rese possibili dalle due più importanti innovazioni economiche del secondo Novecento (il computer e il container), negli ultimi decenni le GVC hanno permesso di ridurre i prezzi dei consumi occidentali al punto da “mascherare”, con la complicità di alcune bolle finanziarie, l’andamento stagnante dei salari e il notevole aumento delle disuguaglianze nei paesi OCSE. Sebbene con metodi spesso problematici, esse hanno inoltre contribuito allo sviluppo di paesi che, ancora negli anni Novanta, erano sotto-industrializzati. Su tutti la stessa Cina.
Le GVC paiono tuttavia giunte al capolinea, almeno per come erano concepite fino al gennaio 2020. Covid e quarantene hanno prima mostrato la fragilità dei sistemi logistici da cui dipendono (tra crisi del container e singhiozzi del just-in-time), dopodiché la crisi energetica ha assestato loro un colpo quasi mortale sotto forma di aumento galoppante dei costi operativi. Esacerbandosi l’un l’altro, questi due fenomeni hanno sancito il ritorno dell’inflazione: la malattia economica che, perlomeno dal Cinquecento, preannuncia il trapasso dei grandi cicli storici.
Riconfigurare le attuali GVC significherebbe (significherà?) dire addio agli “specialisation gains” a cui si devono i loro effetti deflativi sui prezzi (almeno nel contesto OCSE). Ovvero il principale vantaggio del modello, nonché quello dal maggiore peso socio-politico. È infatti evidente che i prezzi bassi di cui il “primo mondo” ha goduto in questi decenni hanno agito per molti versi da shadow welfare. Una volta venuti meno, il re apparirà più nudo, le disuguaglianze più spietate.
I prezzi bassi di cui il “primo mondo” ha goduto in questi decenni hanno agito per molti versi da shadow welfare. Una volta venuti meno, il re apparirà più nudo, le disuguaglianze più spietate.
A peggiorare la situazione c’è la guerra commerciale, sempre meno fredda, tra Cina e Stati Uniti sul fronte delle tecnologie. Iniziata con trambusto da Trump e liquidata in principio come una stramba crociata di uno strambo individuo, essa è stata continuata con meno spacconaggine ma con mano ancor più pesante da Biden. A inizio ottobre gli USA hanno, per esempio, intensificato i controlli sulle esportazioni tecnologiche in Cina. Una decisione coerente con il CHIPS and Science Act approvato il 9 agosto per destinare 280 miliardi di dollari all’industria USA dei semiconduttori. Un atto di grande importanza, che conferma come il rafforzamento dell’industria domestica del chip sia, per l’America, tema strategico a lungo termine. Al cui interno le necessità della difesa si sposano alle ragioni dell’economia.
Non è ovviamente una novità. Simili provvedimenti si registravano anche nel mondo “di prima” (il protezionismo sui chip risale alla guerra fredda ed è dal 2001 che gli USA hanno un’agenzia che vigila sulla relazione tra export e sicurezza). Tuttavia è la retorica circostante a essere cambiata. Se fino agli anni Dieci l’America comunicava l’idea che stringersi intorno alla difesa di singoli interessi nazionali era sconveniente per tutti, l’indicazione che al momento arriva dall’altra parte dell’Atlantico è che il mondo sta diventando un posto “too contested” per non farlo. La richiesta di sicurezza, interna ed esterna, é cresciuta e gli Stati Uniti stanno adeguandosi. È stato Biden a dirlo, più volte, e senza mezzi termini, non ultimo nella sua introduzione al recente exposé sulla strategia per la sicurezza nazionale. Dove si legge che il “nostro mondo” è giunto a un decisivo “inflection point”. Che “l’era post-Guerra Fredda è definitivamente finita ed è in corso una competizione tra le principali potenze per plasmare ciò che verrà dopo”.
Negli ultimi dodici mesi gli USA hanno deciso di affrontare la propria “decisive decade” destinando più di un triliardo di dollari in infrastrutture a sostegno della “middle-out economics” di Biden. Un piano di sviluppo basato sull’idea di “riportare tutto a casa” come cantava Bob Dylan. Ovvero di ritornare a “produrre americano”, “consumare americano”, “vendere americano”. Soprattutto “lavorare americano”. Anche qui non siamo molto lontani dal Trump che urlava da un podio le sue tre parole d’ordine – “jobs! jobs! jobs!” – per rendere l’America “great again”. La realtà è che sono almeno dieci anni che i presidenti americani, incluso Obama, promettono di “ricostruire” le infrastrutture americane ma solo Biden ha stanziato una somma credibile per farlo davvero.
Una volta tenuto conto di tutte le voci di spesa, quello di Biden è a tutti gli effetti un New Deal post-postmoderno da quasi 6 triliardi di dollari. Al cui interno le esigenze del rilancio post-pandemico convivono con progetti di difesa, rafforzamento socio-economico, transizione energetica e strutture per mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Parliamo di una cifra colossale, pari a un terzo dell’intero PIL dell’Unione Europea, che, oltre ad aver dato il proprio “contributo” all’inflazione globale, richiederà accomodamenti finanziari, e monetari, tali da rendere ancora più caldo ed ostile il fronte degli oppositori al “privilegio del dollaro”. E questo è, in fondo, uno dei temi che tiene, e terrà, insieme tutto ciò di cui stiamo parlando. Uno dei nodi gordiani della policrisi contemporenea.
La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti sul fronte delle tecnologie, iniziata da Trump, è stata continuata con meno spacconaggine ma con mano ancor più pesante da Biden.
È evidente che l’idea di tornare a produrre il più possibile in casa ha svariate implicazioni “virtuose” per gli Stati Uniti. Oltre a rendere la vita un po’ più difficile alla Cina, dovrebbe in teoria permettere agli USA di re-indirizzare quelle enormi quote di capitale al momento ‘male’ impiegate (“i social network dalla capitalizzazione virtuale” a cui ha alluso persino Putin nel discorso del 30 settembre) per trasformarle in capacità industriale.
La “bidenomics” dovrebbe insomma consentire agli USA di attenuare, almeno in parte, il trend all’impoverimento delle classi medie che negli ultimi anni ha messo a durissima prova la loro tenuta sociale. Al punto che, in vista delle elezioni di midterm, Biden si è sentito in dovere di mettere in guardia da una possibile deriva anti-democratica del paese. Con una sterzata di 180 gradi rispetto a decenni di politiche unicamente improntate al rafforzamento dei meccanismi di mercato, il Council of Economic Advisers ha dopotutto di recente ammesso che “le evidenze empiriche dimostrano che un’economia forte dipende da solide fondamenta di investimenti pubblici e che gli investimenti nei lavoratori, nelle famiglie e nelle comunità ripagheranno per decenni a venire”. Entrati nel loro tardo-impero gli Stati Uniti puntano a tirarsi a lucido per le fasi più più calde della sfida egemonica con la Cina. Basterà? E soprattutto: durerà o un nuovo presidente invertirà la rotta?
Il problema della continuità nel tempo dell’azione politica è un “problema” che la Cina evidentemente non ha. Riconfermato in sella, Xi Jinping ha davanti a sé molti anni per plasmare il percorso di crescita del Dragone. Il problema è che, con la complicità del covid, la “politica di potenza” di Xi al momento ha rinculato e la Cina rischia di finire in un cul de sac economico chiamato “middle-income trap”. Come ne uscirà? Probabilmente regionalizzando ancor più il “sogno cinese” (per esempio attraverso le iniziative nell’ “estero vicino” della Belt and Road Initiative) e rispondendo ai veti americani su chip, con la ricerca di traiettorie di sviluppo tecnologico più autonome. Una ricerca che nel lungo termine potrebbe, chissà, persino produrre esiti tali d far rimpiangere all’America il protezionismo. Non sarebbe la prima volta che accade. Tuttavia è anche possibile che la risposta cinese si traduca in un aumento di aggressività e pressione su Taiwan, dove, come noto, ha del resto sede la più avanzata azienda di chip dell’Asia. Uno scenario con un potenziale di escalation molto elevato e pericoloso.
La Storia, in ogni caso, sembra andare verso il ritorno a una struttura a blocchi antagonisti: su un versante il mondo atlantico con un epicentro di potenza sempre più circoscritto intorno ai soli Stati Uniti. Sull’altro la Cina e le sue alleanze con alcuni enormi punti di domanda quali l’India, la stessa Russia e, ovviamente, il Medio-Oriente dove ormai si naviga a vista e tutto può accadere nella guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran (a sua volta magma in divenire). Una contrapposizione la cui posta in gioco è nientemeno che la definizione di concetti come modernità, democrazia, diritto. Con, da una parte, l’Occidente che rivendica l’universalità della propria traiettoria culturale e, dall’altra, paesi come Cina e Russia che sostengono l’avvento di una “nuova era globale”, fondata su “nuove regole” e sul riconoscimento della loro definizione, storicamente eterogenea, di parole come “democrazia” e “Stato”.
Cina e Russia sostengono l’avvento di una “nuova era globale”, fondata su nuove regole e sul riconoscimento della loro definizione, storicamente eterogenea, di parole come democrazia e Stato.
In questo “grande gioco” tra Stati-civiltà, in cui contano pesantemente le dotazioni primarie e le geografie delle risorse, l’Europa è al momento un vaso di coccio. Assomiglia più a un teatro che a un attore del confronto. L’eventuale ri-industrializzazione americana le riduce un mercato e le aggiunge un concorrente, tanto più spinoso in quanto alleato strategico, proprio mentre la necessità geopolitica di disaccoppiarsi da Russia e Cina ne mina la capacità competitiva. L’evidente crisi d’identità della Germania di questi mesi la dicono lunga in merito. E non è detto che sia finita qui. Più le richieste di prendere una posizione netta si fanno pressanti e più diventa lampante la storica, e sempre latente (qui un mio vecchio pezzo in proposito), scissione tra gli interessi e la cultura di una influente fetta di Germania e quelli del mondo anglo-atlantico.
Sebbene al posto del turbo-liberismo americano, la UE abbia sempre sostenuto la tesi di una “managed globalization”, la realtà è che il Vecchio Continente si è, nel tempo, reso molto più dipendente dalla globalizzazione di quanto lo siano gli Stati Uniti. Come ha ricordato Christine Lagarde in un recente discorso a Washington: dagli anni Novanta a oggi l’integrazione europea nelle global value chain è cresciuta del 20% in più rispetto a quella USA. L’Europa dipende dal mondo per quasi tutto: tanto per il “vecchio” essenziale (energia, materie prime, manodopera) quanto il per nuovo (chip, batterie, memorie).
Nel momento in cui, per la prima volta nell’epoca industriale, si ritrova in balia del mondo senza più particolari privilegi imperialisti (diretti o per procura americana), l’Europa rischia di scoprirsi per ciò che è: un mercato ancora molto ricco di capitali ma un continente povero di tutto ciò che serve oggi per prosperare. Ciò significa che i costi per raggiungere l’ “autonomia strategica” di cui parla Macron, così come quelli per “re-industrializzare” o “regionalizzare” i processi economici dell’Unione, saranno per gli europei molto elevati. Permettono un margine di errore ridottissimo.
Che fare? La risposta che più circola è “innovazione”: nell’energia, nei sistemi, nei processi. La verità è che la rapidità e il costo dell’innovazione tecnologica degli ultimi decenni erano, in gran parte, frutto della crescente interdipendenza globale. Ovvero della situazione opposta a quella verso cui andiamo. Il risultato è che l’Europa è al momento tagliata fuori da alcune delle industrie di cui maggiormente avrebbe bisogno per affrontare, per esempio, la transizione energetica. Un caso esemplare è il dominio cinese sulla supply chain dei pannelli solari e dei materiali per costruirli. Oggi il gigante asiatico produce quasi il 95% del polisilicio e più dell’80% dei pannelli solari al mondo seppure costituisca solo il 30% della domanda mondiale. Viceversa l’Europa ne produce meno del 3% (con costi unitari superiori del 35% allo stato dell’arte cinese) ma ne “consuma” il 16%. È dunque evidente che se l’Europa volesse (o dovesse) rivedere tali percentuali dovrà necessariamente confrontarsi con le idee del governo cinese in merito.
In questo “grande gioco” tra Stati-civiltà, in cui contano pesantemente le dotazioni primarie e le geografie delle risorse, l’Europa assomiglia più a un teatro che a un attore del confronto.
A questo si aggiunga che il Vecchio Continente è, di gran lunga, anche il continente più vecchio del mondo per età media dei suoi abitanti, un quinto dei quali è over 65. Il che complica ulteriormente la via dell’innovazione per ragioni culturali che si traducono in scelte politiche, priorità pratiche ed economiche.
Questi sono solo alcuni dei motivi per cui l’Europa difficilmente riuscirà ad adattarsi al “nuovo normale” con la stessa rapidità e probabilità di successo degli Stati Uniti. A farne le spese saranno soprattutto le classi medie e i ceti popolari, con gli immaginabili effetti di “sfogo” sulle loro preferenze politiche. Ne sappiamo qualcosa in Italia, come sempre laboratorio politico all’avanguardia purtroppo raramente di segno positivo.
La verità infatti è che gran parte delle contrapposizioni odierne hanno come “primo motore immobile” il malessere socio-economico delle middle-class occidentali che vedono diminuire, anno dopo anno, la quota di crescita globale che riescono a catturare. Un fenomeno con caratteri di inevitabilità tali che sarebbe necessario iniziare a introdurre con maggiore trasparenza nel dibattito politico. La realtà dei nostri giorni è una popolazione mondiale che ha percezioni del futuro contrastanti (peraltro non sempre corrispondenti alla realtà della loro situazione, specie in relazione alla minaccia dell’emergenza climatica): sempre più nere in Occidente, specie in Europa e nel Midwest americano, sempre più rosee nel resto del mondo, specie in Asia.
Il fatto è che i primi stringono ancora le redini di sistemi essenziali per il funzionamento della società globale e non sembrano intenzionati a condividerle, perlomeno nel breve-medio termine. Mentre i secondi, in molti casi, hanno urgenze sistemiche che li spingono a chiederne la condivisione il prima possibile. Ne va della loro ascesa. In alcuni casi della loro stessa sopravvivenza. È un dilemma il cui risultato è l’entrechment che abbiamo riassunto fino a qui. Per alcuni versi esso ricorda il clima politico internazionale degli anni Trenta e per altri ha qualcosa del mercantilismo settecentesco. Due precedenti non esattamente di buon auspicio.