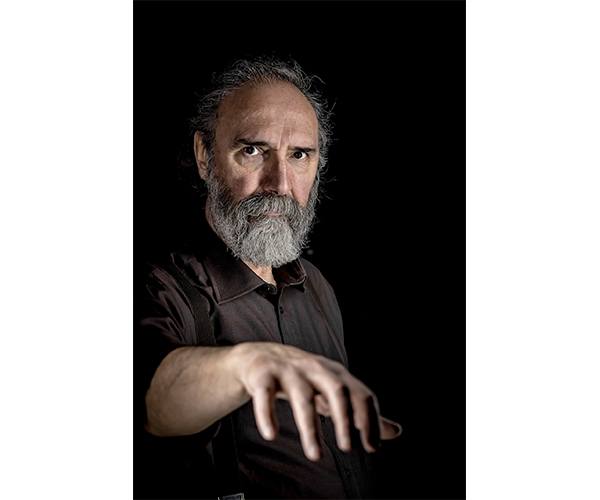N ell’estate del 1972 cominciò a consolidarsi il nucleo di artisti da cui sarebbe scaturito l’International Popular Group chiamato Area: l’esperienza musicale più originale e controversa mai avvistata in Italia. A definirne il carattere contribuì il contesto sociale e politico dell’epoca: a fine febbraio era cominciato il processo a Pietro Valpreda, imputato della strage di piazza Fontana (accusa dalla quale fu assolto definitivamente nel 1987), il 3 marzo le Brigate Rosse compirono il primo sequestro di persona (vittima il dirigente della Sit-Siemens Idalgo Macchiarini), undici giorni dopo morì ucciso da un’esplosione ai piedi di un traliccio dell’alta tensione a Segrate l’editore e fondatore dei Gruppi d’Azione Partigiana Giangiacomo Feltrinelli, il 7 maggio la Democrazia Cristiana trionfò alle elezioni politiche raccogliendo quasi il 39% dei voti e il 17 dello stesso mese venne assassinato a Milano il commissario Luigi Calabresi. Una sequenza di avvenimenti che descrive in maniera eloquente lo zeitgeist. Domando perciò a Patrizio Fariselli, insieme a Paolo Tofani unico superstite del quintetto in cui si stabilizzò l’organico dal 1973, come avesse vissuto quella fase drammatica della storia nazionale da ragazzo qual era allora. Risponde: “Guardarla da distante, come stiamo facendo noi adesso, è diverso dall’esserci dentro: sarebbe come chiedere a un pesce com’è l’acqua in cui nuota. Ero un ventenne immerso in quella situazione, perciò fatico a ragionare su come mi sentissi: eravamo dentro quel tornado, nell’occhio del ciclone, e ci sforzavamo di capire ciò che accadeva e in che modo comportarci. Saprei descrivere meglio cosa avvenne una decina di anni dopo, quando l’onda del Movimento rifluì: provai un autentico shock, perché non riconoscevo più le cose in mezzo alle quali ero cresciuto da quando avevo l’età della ragione. Gli anni Settanta erano stati un periodo straordinario, per creatività e impegno sociale, durante il quale si acquisirono diritti e garanzie sul lavoro di cui successivamente siamo stati privati. L’epiteto ‘anni di piombo’ dimostra la superficialità con cui gran parte degli organi d’informazione e qualche storico hanno affrontato quell’epoca”.

Certo è che l’influsso degli eventi concomitanti plasmò l’identità degli Area: in quale misura? “Il contesto sociale è sempre rilevante per un artista, che ne sia consapevole oppure no. Il presupposto è che qualunque cosa uno faccia ha inevitabilmente un risvolto politico, e ancora di più per un musicista, che ha nella condivisione l’essenza stessa della sua ragion d’essere. L’esperienza musicale è una sorta di rito comunitario, di spiritualità laica che fa battere i cuori all’unisono e catalizza le energie. La musica è sostanzialmente un fatto sociale, ovunque nel mondo e in qualsiasi epoca. Di conseguenza, la situazione circostante incide enormemente su ciò che un artista produce. Attenzione, però: un conto è l’influenza che la cultura del momento può avere sulla musica d’arte e un altro la spinta dell’industria dell’intrattenimento e dello svago, in cui la ricerca del profitto e del successo allontana i musicisti dall’autentica ispirazione espressiva. Essere artista significa studiare e applicarsi, sperimentando di persona diversi stati della mente e cercando di offrire alla fine un pensiero vero, profondo e possibilmente non banale”.
La musica è sostanzialmente un fatto sociale, ovunque nel mondo e in qualsiasi epoca.
Per convenzione, la genesi del gruppo viene associata a una circostanza specifica: a inizio luglio, negli studi Fonorama di Milano, stava prendendo forma l’esordio discografico da solista di Alberto Radius, chitarrista dei Formula 3, sotto contratto con la Numero Uno, etichetta fondata da Mogol e Battisti. Area era il titolo di un brano incluso nell’album, frutto – come tutti gli altri – di una jam session d’improvvisazione cui avevano partecipato, costituendo incidentalmente un mosaico cosmopolita: Demetrio Stratos (nato da genitori greci ad Alessandria d’Egitto, già cantante nei Ribelli) all’organo, Johnny Lambizzi (ungherese per parte di madre) alla chitarra elettrica, Patrick Djivas (francese della Costa Azzurra) al basso e – unici anagraficamente italiani – Giulio Capiozzo e Leandro Gaetano, rispettivamente alla batteria e al sax tenore. Fariselli ridimensiona tuttavia l’enfasi mitologica attribuita a quel frangente: “La registrazione del disco di Radius fu solo un episodio occasionale in un flusso di avvenimenti molto più articolato e complesso”. E racconta: “In quel periodo io facevo il servizio militare in Friuli e usavo ogni licenza per andare a trovare il gruppo, che in prevalenza era di stanza a Rimini, vicino a Cesenatico, dov’ero nato e suonavo nell’orchestra di mio padre Terzo, che l’aveva creata dopo essere stato per molti anni in quella di Henghel Gualdi: per me lavorare con lui significava contribuire all’azienda di famiglia. Avevo studiato pianoforte al conservatorio di Pesaro con il maestro Sergio Cafaro ed ero amico di Giulio Capiozzo fin dall’adolescenza: suonavamo spesso insieme in cantina con altri ragazzi e condividevamo l’amore per il jazz, su cui ci applicavamo con disciplina e passione. Lui aveva cinque anni più di me e presto si trasferì a Milano: entrò nel gruppo di Demetrio e fu intorno a quel nucleo che crebbe il desiderio di costruire qualcosa di significativo”.
L’organico embrionale della formazione era mutevole e Fariselli rievoca così il proprio ingresso: “Fui l’ultimo a entrarci, quando ancora cercava una sua identità. Mi chiamò Giulio, in sostituzione di Leandro, parecchi mesi prima della registrazione di Arbeit Macht Frei, disco che sancì l’effettivo atto di nascita degli Area. Il gruppo non venne progettato a tavolino: fu un processo di selezione naturale che maturò e si protrasse nel tempo. L’ambizione di tutti era far parte di un organismo originale e potente, in grado di produrre musica elaborata che valorizzasse il talento di ciascuno. Ricordo il senso di totale libertà che provavamo. In quel periodo la mia educazione musicale subì un’accelerazione pazzesca: nel giro di tre/quattro anni, da ragazzino che sapeva a malapena mettere insieme gli accordi, mi ritrovai a lavorare su strutture particolarmente complesse, scoprendo tra l’altro la mia vocazione da compositore”. Il rodaggio vero e proprio avvenne dal vivo, aprendo in autunno i concerti di band inglesi allora in voga: Nucleus e Gentle Giant. “Sì, ma anche gli Atomic Rooster, quando io ancora non c’ero: entrai qualche settimana prima del tour con i Gentle Giant”, precisa Fariselli. A organizzare quelle tournée fu Franco Mamone: “Allora era uno dei promoter italiani più importanti e innovativi, non a caso manager della Premiata Forneria Marconi e del Banco del Mutuo Soccorso. Con il suo fiuto vide in noi delle possibilità e si offrì di occuparsi del gruppo. Poi, insieme a Gianni Sassi, creò la Cramps Records apposta per pubblicare il nostro lavoro d’esordio. Noi avevamo cominciato a guardarci intorno in cerca di qualcuno disposto a pubblicare l’album, rendendoci conto che l’ambiente discografico dell’epoca non era pronto ad accoglierci. Per chi usciva dal classico seminato della canzone italiana mancava uno sbocco e Gianni fu il primo a intuirlo”.
Intorno alla figura di Sassi aleggia un’aura leggendaria, dai cenacoli in cui mescolava con attitudine “warholiana” feccia e aristocrazia alla nomea di “rivoluzionario in Mercedes”. Come spesso accade, la realtà era meno strabiliante: “In Mercedes Gianni io non l’ho mai visto: guidava – male e malvolentieri – una vecchia Fiat, dunque chi ha messo in giro quelle voci evidentemente non l’ha mai conosciuto. Era una persona molto colta e in qualche modo anche artista. Oltre ad avere talento come creatore d’immagini, gli piaceva innescare processi creativi attraverso il rito conviviale, invitando personalità del mondo dell’arte diversissime tra loro. Durante le famose cene al ristorante Barbarossa di Milano abbiamo potuto conoscere musicisti come Juan Hidalgo e Walter Marchetti, esponenti delle ultime avanguardie del Novecento: per me furono incontri folgoranti. Come dicevo, Gianni era uno straordinario uomo di cultura, dotato di un intuito fuori dal comune e molto interessato alla dimensione sociale e politica della musica, in particolare del rock. Oltre ai suoi deflagranti lavori in pubblicità, quando lo conoscemmo aveva già curato la copertina di Fetus di Battiato ed era editore di riviste d’arte. In politica era vicino alle correnti situazioniste e in campo artistico a Fluxus. Ci rendemmo conto che era la persona di cui sentivamo il bisogno: noi avevamo la musica, ma ci mancava tutto il resto. Eravamo poco più che ventenni e Gianni si rivelò essenziale nel nostro processo di crescita. Lo considerammo subito un membro del gruppo. Ci propose di scrivere i testi dei nostri pezzi, firmandosi Frankenstein, e fu determinante anche nell’istituire un metodo per il nostro lavoro: periodicamente ci riuniva intorno a un tavolo per lunghe discussioni sulle strategie di comunicazione e il concept dei brani, uno sforzo pazzesco per dei musicisti irruenti come noi”.
Frattanto c’era stato un altro avvicendamento: al posto di Lambizzi era entrato Paolo Tofani, che viveva a Londra e tornò in Italia su invito di Mamone, mentre alla formazione si era aggregato il navigato sassofonista di origine belga Victor Edouard Busnello. Tutti i tasselli erano finalmente al loro posto: “Dopo mesi di prove in vari posti, fra cui una cascina ad Abbiategrasso, e parecchi concerti, ci recammo negli studi Fonorama della Ricordi, in via Barletta a Milano, e registrammo su un 16 piste, che ci parevano più che sufficienti, assistiti da Gaetano Ria, un ottimo fonico”. Com’erano stati concepiti quei sei pezzi? “La prassi creativa degli Area era varia e dinamica, difficile ridurla a una formula. Alcuni, e io fra questi, erano più inclini alla composizione, mentre altri erano più portati all’arrangiamento e all’elaborazione delle sonorità. Nel gruppo confluivano i nostri talenti e nella spontanea capacità d’improvvisare s’innestava la composizione. Mi spiego: spesso, quando abbozzavo un’idea, la proponevo al collettivo per verificare anzitutto se potesse sopravvivere al vaglio degli altri e quando la ritenevamo valida diventava subito patrimonio condiviso e tutti contribuivano a far germinare quel seme, che acquisiva corpo e sonorità man mano che si aggiungevano elementi, dalle ritmiche di Giulio all’accompagnamento del basso, dalle elaborazioni elettroniche di Tofani alle parti vocali di Demetrio, a volte seguendo la linea tracciata dal compositore e altre esplorando invece nuove direzioni individuate lì per lì”.
Aprendo la copertina del long playing appariva Capiozzo con la kefiah in testa e a terra c’erano falce e martello: un biglietto da visita impegnativo.
Una volta pronto il disco, a chi venne l’idea di aprirlo con una poesia in arabo? L’aneddoto del testo trafugato da Capiozzo in un museo del Cairo ha qualche fondamento? “La storia della registrazione pirata ci faceva gioco, ma non era vera. Mentre eravamo in Fonorama, passeggiando in corridoio, io e Demetrio udimmo una voce provenire da uno studio adiacente, dove una ragazza stava registrando qualcosa in arabo. Fu lui ad avere l’idea. Stavamo lavorando a Luglio, agosto, settembre (nero), che cominciava con un’introduzione di organo e voce, ma sentivamo che c’era bisogno di qualcosa di particolare, più d’effetto. La voce di Rafia Rashed era esattamente ciò che serviva. Ci affacciammo nello studio e ci presentammo, scoprendo che era palestinese: sembrava un segno del destino. Così le proponemmo di venire da noi il giorno dopo a registrare qualcosa. Lei arrivò con una sua poesia e la recitò con passione. Fu ‘buona la prima’…”. Dicono i versi conclusivi: “Lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere in pace”, in apparente contrasto con lo spunto tragico della canzone, ossia il massacro avvenuto nel settembre 1972 a Monaco di Baviera durante i Giochi Olimpici, quando un commando dell’organizzazione palestinese Settembre Nero sequestrò una decina di atleti israeliani. Materia scabrosa da maneggiare… “Si trattò di una decisione meditata: era il nostro invito ad approfondire quella storia terrificante, all’origine della quale c’era la tragedia del popolo palestinese, una vicenda così drammatica che dura ancora ai giorni nostri, tuttora pressoché ignorata. Il titolo provvisorio che avevo dato al tema principale, abbozzandolo, era Jazz Fedayn, mentre quello definitivo fu coniato da Sassi, che inoltre sviluppò il testo. Quella scelta comportò un pedaggio pesante: il circuito angloamericano divenne inaccessibile per noi, anche se ci definivamo International Popular Group e Demetrio era praticamente anglofono, come pure Tofani, quindi non avremmo avuto nemmeno l’ostacolo della lingua. Nonostante la nostra dimensione fosse davvero internazionale, non potemmo svilupparla. Provammo anche con la Virgin a Londra, dove – grazie a Mamone – avevamo un contatto ad alto livello, ma l’accoglienza riservata a me e Paolo fu gelida. Avremmo dovuto aspettarcelo, del resto: aprendo la copertina del long playing appariva Capiozzo con la kefiah in testa e a terra c’erano falce e martello: un biglietto da visita impegnativo. E poi, dal punto di vista commerciale, ciò che facevamo risultava inclassificabile: un insieme di jazz, folklore mediterraneo e musica contemporanea. L’abbiamo pagata cara, ma se rinascessi rifarei esattamente le stesse cose, come anche gli altri, immagino…”.
Una suggestione ulteriore perpetuatasi nel tempo riguarda il brano di chiusura, L’abbattimento dello Zeppelin: aveva qualcosa a che fare con gli incidenti del luglio 1971 al Vigorelli di Milano, durante il concerto della band di Plant e Page? “Assolutamente no: avevamo anzi grande stima dei Led Zeppelin. In realtà il nostro Zeppelin rappresentava una metafora dello show business, di quel modo di fare spettacolo al quale ci sentivamo totalmente estranei e che ci sarebbe piaciuto abbattere. Era un’affermazione della nostra diversità”. E c’era poi la pistola di cartone infilata nell’involucro del disco: ancora una trovata di Sassi? “Sì, era farina del sacco di Gianni: amava le idee forti e sconcertanti”. A ripensarci adesso, sembra quasi un’anticipazione del metodo applicato da Malcolm McLaren ai Sex Pistols: come God Save the Queen, anche Arbeit Macht Frei era uno schiaffo al senso comune… “Sì. Oltre a evocare l’orrore dei campi nazisti, il titolo rappresentava una velata critica alla sinistra di quei tempi, che in nome del lavoro e dell’interesse collettivo tendeva a schiacciare – alla maniera sovietica – la creatività individuale. Un difetto conservato anche dopo il salto carpiato compiuto durante gli ultimi decenni, in cui ha abbandonato completamente i diritti sociali e dei lavoratori, omologandosi in toto all’aberrante ideologia del conformismo di mercato e all’emarginazione di ogni dissenso”.
Gianni Sassi chiamava ciò che facevano gli Area ‘radical music’, espressione nella quale confluivano la ricerca vocale di Stratos, il free jazz, il folklore nordafricano e altro ancora.
Sassi chiamava ciò che facevano gli Area “radical music”, espressione nella quale confluivano la ricerca vocale di Stratos, il free jazz, il folklore nordafricano e altro ancora. Avevate delle stelle polari in senso artistico o andavate alla cieca? “Qualsiasi giovane musicista ha ovviamente i suoi maestri: non si nasce dal nulla e ci si appoggia sempre sulle spalle dei giganti che ti hanno preceduto per cercare di salire un altro gradino. Poi però c’è la fase successiva: bisogna liberarsi dei propri ispiratori, mangiarli e digerirli per arrivare a esprimere pienamente sé stessi. Questo viene facilitato anche dalla collaborazione fra musicisti di talento, perché l’originalità degli altri stimola e sviluppa quella di ognuno”. Ma non c’erano dischi che ascoltavate insieme durante la gestazione di Arbeit Macht Frei? “Certamente. In particolare ricordo una bellissima collana dell’etichetta francese Arion, dedicata soprattutto alla musica balcanica: sentivamo quei dischi a casa di Demetrio. Recentemente ho riarrangiato un paio di quei brani tradizionali nel mio album 100 Ghosts”.
Con i pezzi depositati in Siae a nome di Terzo Farinelli (“Fu necessario fare così, perché allora nessuno di noi era iscritto”, spiega Patrizio), il disco uscì il 15 settembre 1973, tre mesi dopo la presunta apparizione degli Area alla terza edizione del Pop Festival di “Re Nudo”, l’ultima prima della trasformazione in Festa del Proletariato Giovanile con il trasloco a Parco Lambro… “Era all’Alpe del Vicerè, nei dintorni di Como. Ma quella volta noi non suonammo, andammo solo a farci un giro. Non c’era corrente elettrica e gli organizzatori cercarono di alimentare l’impianto con generatori di fortuna. Ricordo che a valle c’erano i posti di blocco della polizia che impedivano l’accesso, così dovemmo camminare a lungo in salita per portare la nostra solidarietà. Suonammo l’anno dopo al Parco Lambro…”. Per sincronia cronologica Arbeit Macht Frei finì, vostro malgrado, nel calderone del “prog” italiano: vi disturbava quell’analogia? “Allora non ce ne importava nulla, i nostri riferimenti non venivano certo da quel fronte. Non lo dico per snobismo, ma perché era davvero così: tranne forse per qualche piccolo dettaglio, eravamo molto distanti da quei parametri. Siamo stati risucchiati in quel genere in un secondo tempo, soprattutto all’estero: in Giappone, ad esempio, dove vanno matti per il ‘prog’ italiano, non c’è verso di spiegare che gli Area non hanno nulla a che farci”. A quel disco, dopo la cui pubblicazione Busnello abbandonò il gruppo, imitato da Patrick Djivas, che si unì alla PFM e venne sostituito da Ares Tavolazzi, con il quale si compose il quintetto “classico” degli Area, ne seguirono altri quattro, finché la morte prematura di Demetrio Stratos, il 13 giugno 1979, pose fine a quell’esperienza, proseguita in verità per inerzia fino al 1980 con “Tic & Tac”.
Al materiale del disco d’esordio Fariselli e Tofani hanno rimesso mano poi nel 2013, rimasterizzandolo per la riedizione del quarantennale: che sensazione hai provato rivisitandolo? “Personalmente non lo sentivo da un’infinità di tempo e riascoltarlo in studio fu una piacevole sorpresa. Tuttora Arbeit Macht Frei mostra pochi segni d’invecchiamento: anche se certe sonorità rimangono legate a quel periodo, suona bello fresco ancora oggi. E continua a pungere. Con Paolo considerammo che gigante era Eddy Busnello, allora già ultraquarantenne, quindi molto più grande di noi: un autentico fuoriclasse del sassofono, un maestro”. Visto che siamo a un passo dall’attualità, se ne percepiscono riverberi nella musica italiana dei giorni nostri? “Mi piacerebbe molto, ma non saprei dire se abbiamo fatto scuola, magari un po’ sì e forse non me ne sono accorto. In conclusione posso solo affermare che in quegli anni ho fatto quel che mi sembrava giusto fare e ho continuato a farlo anche dopo la fine degli Area”.