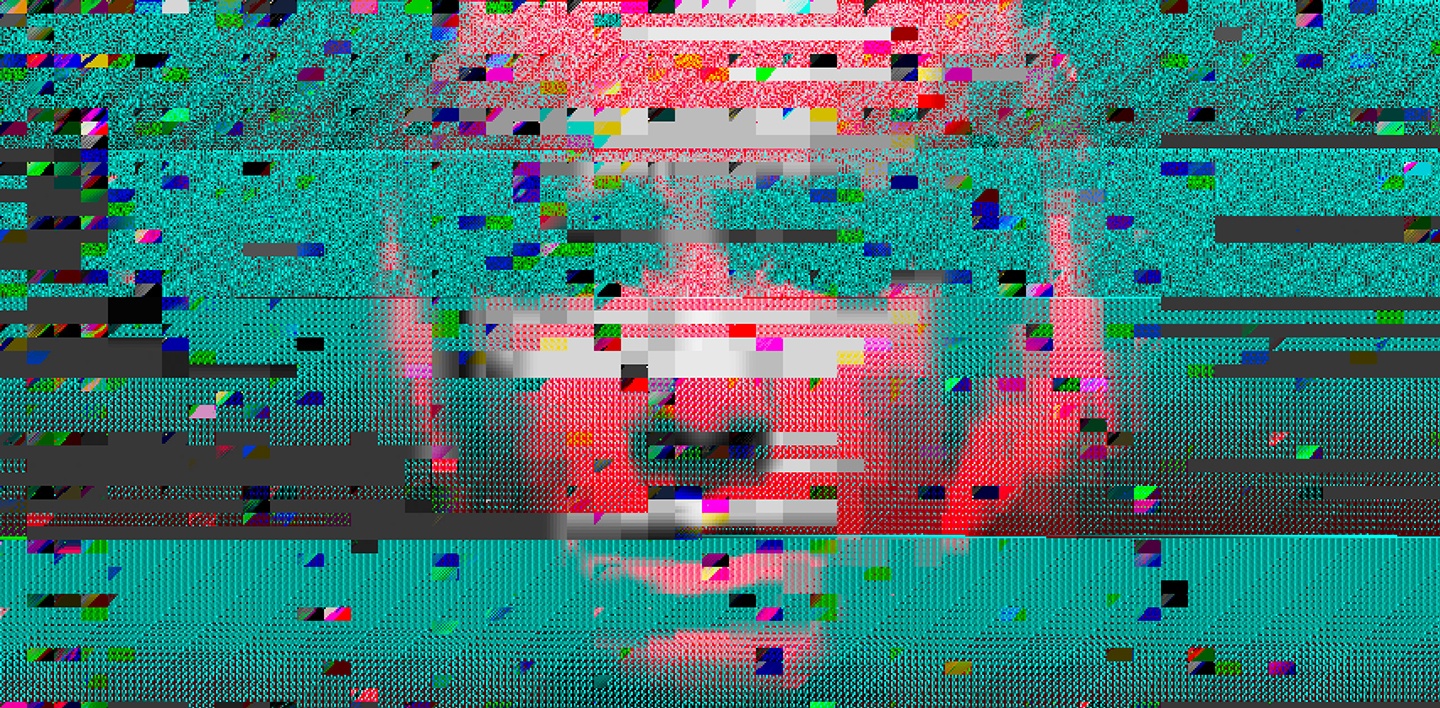
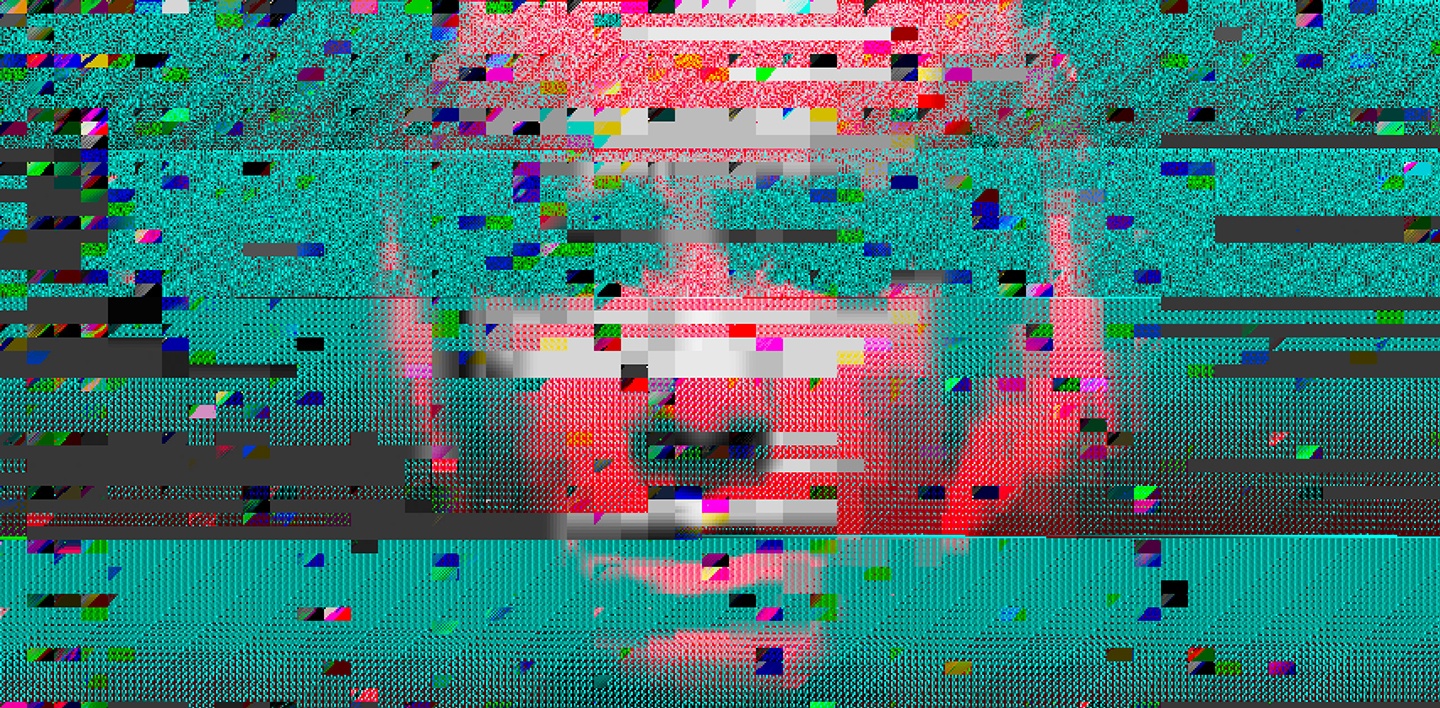
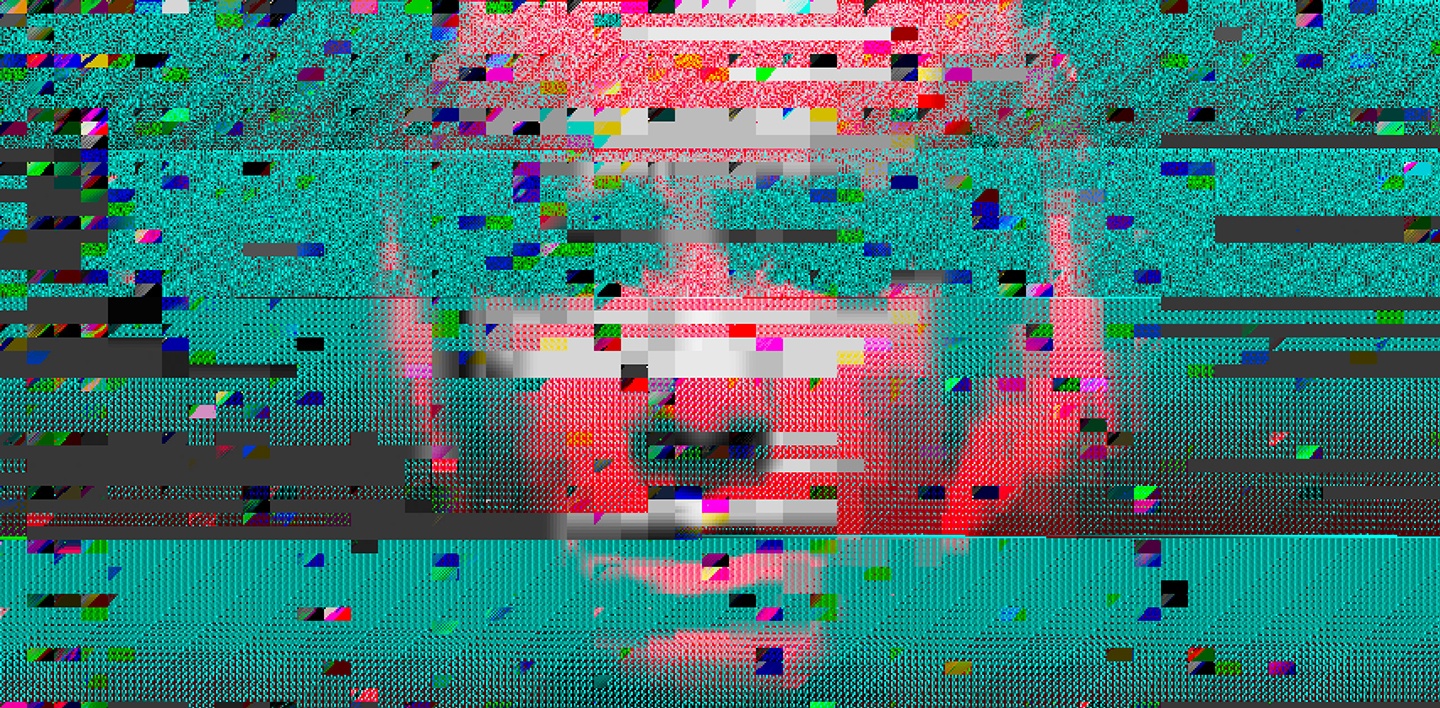
L’ odierno dibattito sull’identità e il suo rapporto con le nuove tecnologie è un campo d’indagine popoloso, in cui vecchi schemi binari si scontrano con una molteplicità entropica e innovativa. L’asprezza del conflitto è lo specchio di un’urgenza in parte indotta dalle cronache destabilizzanti degli ultimi anni, fatte di crisi che si affastellano l’una sull’altra: la realtà ha smesso di apparire come un costrutto razionale lasciando le nostre coscienze a fluttuare nel vuoto, prive di punti di riferimento e bombardate da input che non riescono a integrare. È così che un’urgenza indotta è diventata necessità esistenziale, dove Io sempre più fragili si sentono assediati da un mondo sull’orlo della disgregazione.
La stessa idea di identità sta diventando obsoleta pur rimanendo una necessità psicosociale a suo modo ineludibile, non di rado soddisfatta da fantasie di complotto, nazionalismi e settarismi vari, e in generale dal ritorno di un rimosso certamente violento ma apodittico e rassicurante – o comunque preferibile alle pastoie dell’indistinzione. Per molti la deriva identitaria della destra fa il paio con le strategie politiche messe in campo dalle minoranze progressiste, che fondano le proprie piattaforme di rivendicazione sulla comunanza di alcuni tratti specifici di determinate categorie: genere, razza, religione, orientamento sessuale, neuroatipicità, disabilità e così via. Conosciute come identity politics, le “politiche identitarie” sono spesso associate dai loro detrattori a un attivismo woke, digitale, velleitario e radical chic. Secondo questa visione, l’identitarismo di destra sarebbe una naturale conseguenza del proliferare delle etichette politicamente corrette (leggasi neopuritane) della sinistra, in una guerra culturale che si svolge prevalentemente online, sui social network, attraverso l’autorappresentazione digitale. Un nesso, va detto, riconosciuto dagli stessi fautori delle identity politics, ma visto non come risposta legittima alla fantomatica dittatura del politicamente corretto, bensì come reazione violenta che si scatena quando ad essere attaccato è il privilegio (maschile, etero, bianco e cisgender) e che prende il nome di backlash, “contraccolpo”.
Tutto questo per ribadire che parlare d’identità e rappresentazione, o di identità e tecnologia, significa tirare in ballo un ambito gravido di insidie, in cui l’unica certezza è quella di toccare un nervo scoperto e doloroso del presente. In un’intervista rilasciata a L’indiscreto pochi mesi fa, Franco Berardi Bifo, trattando della crisi delle identità sociali, descriveva così il legame intricato e contraddittorio che le masse intrattengono con l’identità:
La grande accelerazione ha privato le persone di un panorama riconoscibile, di un modo riconoscibile di auto-identificarsi. La cara vecchia nevrosi del soggetto borghese freudiano è stata sostituita dall’esternalizzazione dell’inconscio, dall’ingiunzione di guardare di più, sentire di più, annusare di più, consumare di più. (…) Le masse sono state vittima di una dis-identificazione brutale, accompagnata dall’incitamento ad affermarsi, ad affermare la propria identità.
Nell’inflazione semantica del tardo capitalismo, l’identità dei singoli è diventata un capitale su cui investire, mentre al contempo si assisteva al crollo delle grandi categorie – politiche, ideologiche – novecentesche sulle quali in passato si era fondato il senso d’appartenenza. Riprendendo ancora le parole di Bifo, la vittoria incontrastata della finanza globalizzata e di un mondo virtuale asettico e impersonale ha asservito gli individui “al dominio di un codice astratto e omologato, il codice del denaro, del lavoro, dello scambio che azzera le differenze linguistiche, tradizionali, mitologiche, antropologiche sulle quali si fondano le identità” (in Come si cura il nazi?, Tlon 2021).
In questo modo, la spinta annichilente all’omologazione entra in contrasto con l’obbligo a diventare imprenditori di sé stessi e dunque a performarsi continuamente per sopravvivere sul mercato del lavoro, scatenando un cortocircuito fra l’ingiunzione a corrispondere a determinati canoni sociali e la coazione a distinguersi, a emergere primi inter pares, per averla vinta nella competizione globale. Il risultato, come acutamente nota Bifo, è l’ingiunzione guardare di più, sentire di più, annusare di più, consumare di più: un’ipertrofia di stimoli che immerge l’Ego nel flusso della sovrapproduzione semantica digitale e lo fa esplodere dall’interno, finendo per diluirlo in una logica da sciame. Nello sciame (nottetempo 2015) è anche il titolo di uno dei saggi dedicati al mondo digitale di Byung-Chul Han, in cui il filosofo teorizza la dissoluzione del soggetto in tante “isole narcisistiche di Ego”. Per Han il medium digitale, lungi dal potenziare l’intersoggettività come pronosticato dai suoi entusiastici araldi, si è rivelato terreno fertile per l’isolamento sociale nonché strumento principale di una psicopolitica “che sorveglia, controlla e influenza gli uomini” con un grado di pervasività mai visto prima d’ora.
Per Han, il ripiegamento dell’Ego su sé stesso suscitato dall’immersione digitale è la causa principale dell’assenza di empatia, dell’aggressività e dell’ostilità veemente che ci circonda.
In Le non cose (Einaudi 2022) Han sviluppa il ragionamento da un punto di vista non più sociale ma ontologico, e individua nella smaterializzazione operata dal digitale l’elemento che, togliendo il negativo della cosità dal mondo, lo svaluta e lo riduce a prodotto di consumo, distruggendo la realtà in quanto tale. Le cose, con il loro carattere individuale, capace di accogliere l’investimento libidico di chi le possiede (nella figura non di un consumatore ma di un collezionista, secondo l’interpretazione che ne dà Benjamin), sono state sostituite dagli oggetti, sottoposti anche loro, come i segni, a un processo di inflazione che ce li rende indifferenti e interscambiabili. Oggetti e informazioni formano uno strano ibrido a cui Han dà il nome di infoma, agente fisico che elabora e veicola informazioni grazie all’intelligenza artificiale, e il cui esempio più emblematico è lo smartphone. L’inflazione semantica e l’entropia informativa del mondo digitale contribuiscono inoltre a offuscare la verità, proiettandoci in un’epoca post-fattuale che mina alle basi le fondamenta della stabilità umana, individuale e collettiva. Anche la scomparsa delle cose è direttamente connessa alla perdita di stabilità sul piano psicologico e, peggio ancora, temporale. Le cose custodiscono i nostri ricordi, il nostro passato. Sono il legame che abbiamo con le storie personali e perciò con la Storia: la loro scomparsa e sostituzione con un flusso di informazioni instabili ci condanna a vivere in un eterno presente. Il cuore del ragionamento di Han, tuttavia, il tasto su cui batte a più riprese nei suoi saggi, è che a venire a mancare nel mondo digitale sarebbe soprattutto l’esperienza dell’Altro. Per Han, il ripiegamento dell’Ego su sé stesso suscitato dall’immersione digitale è la causa principale dell’assenza di empatia, dell’aggressività e dell’ostilità veemente che ci circonda. Le psicopatologie che dilagano nella società contemporanea vanno ricollegate alla positività strabordante delle non cose, all’assenza di negatività simboleggiata dalla superficie liscia del touch screen che riflette in ogni momento la nostra immagine.
Ma forse non è un caso che a incarnare una lettura tanto negativa del presente tecnologico siano visioni e prospettive maschili. In Glitch Feminism (Giulio Perrone, 2021), la scrittrice e curatrice artistica Legacy Russell ci restituisce la complessità di uno sguardo situato, che parte dall’analisi dell’arte performativa queer nera contemporanea per indagare il rapporto fra costruzione del sé e identità digitali. Pur concordando in molti punti con l’analisi di Han, Russell dà un’interpretazione positiva della rivoluzione digitale e ne esplora le potenzialità presenti e future facendo propria l’eredità del cyberfemminismo degli anni Novanta. La diagnosi è la stessa, insomma, ma la prognosi è diametralmente opposta. A differenza di Han, che si muove su un piano totalmente astratto e disincarnato, Russell attraversa la realtà virtuale rimanendo sempre ben ancorata alla materialità dei corpi: paradossalmente è proprio il corpo, con i suoi limiti e le sue contraddizioni, il fulcro del suo ragionamento sul mondo digitale. Per questo decide di aprire la trattazione esplicitando il proprio posizionamento e sottolineando l’importanza del contesto offline: in “un East Village che si gentrificava rapidamente”, dice, dove “le facce, le identità e la pelle come la mia” avevano sempre meno agibilità, “[ero] una donna Nera, cisgender, femme, queer”, e “nella vita di tutti i giorni mi sentivo intrappolata, sempre a disagio, schiacciata dal peso dell’incessante sguardo eteronormativo bianco”.
Nella dissoluzione operata dal digitale il corpo ha l’occasione di tornare a una dimensione astratta e disincarnata, che permette all’Io di re-immaginarsi e ricreare sé stesso al di fuori delle etichette ereditate prima di tornare a performare la propria materialità
.
È innanzitutto la rivendicazione di un corpo, dunque, di una fisicità precisa inserita in uno spazio e un contesto sociale ben definiti, a rendere evidente come la smaterializzazione lamentata da Han non sia un processo uguale per tutti. Non è la stessa cosa se a dissolversi nello sciame digitale sono corpi che nella quotidianità (o meglio, per usare l’espressione di Russell, nel mondo AFK, Away From Keyboard) hanno sempre avuto spazio per riconoscere e sperimentare loro stessi, oppure corpi che non possono in alcun modo sottrarsi alle gabbie categorizzanti della società patriarcale eteronormata. “Il mondo intorno non mi permetteva di dimenticare mai quegli identificatori”, scrive Russell in relazione al colore della propria pelle, al genere e all’età; “online invece potevo essere tutto quello che volevo”.
Russell spiega bene come l’oppressione di alcuni corpi passi anche dalla privazione di qualunque margine di manovra identitaria, dall’impossibilità di estendere il proprio Io e sperimentarlo in posture che rompano gli steccati imposti dall’esterno. Nella dissoluzione operata dal digitale, invece, il corpo ha l’occasione di tornare a una dimensione astratta e disincarnata, che permette all’Io di re-immaginarsi e ricreare sé stesso al di fuori delle etichette ereditate prima di tornare a performare la propria materialità: come nel caso di C.L., giovane femminista nera che racconta di aver sfruttato la possibilità di anonimato offertale da Twitter inizialmente solo per “nascondere la razza e semplicemente esistere”, ma che “proprio tramite Internet ha potuto abbracciare la propria identità di ‘intelligente ragazza nera’, una percezione di sé stessa nata prima online e solo dopo trasferitasi oltre lo schermo”. L’importanza dell’anonimato come strumento di liberazione della gabbia dell’Ego è un elemento presente anche in Han, che nelle ultime pagine del suo pamphlet elabora una proposta di evasione fatta di silenzio, contemplazione, ascolto, recupero di una dimensione sacrale dove “la beata dimenticanza di sé cede il passo all’eccessiva autoproduzione dell’ego” propria del mondo digitale. La soluzione alla tirannia dell’Ego, per Han, è nell’essere senza nome, in un Io anonimo e debolissimo. Anche in Russell l’Ego è ha un carattere oppressivo, ma il silenzio, la dimenticanza di sé e lo spazio per l’Altro operato e agito come sottrazione dell’Io proposti da Han, se visti dalla posizione situata di Russell sembrano soltanto un’altra forma di privilegio. La stessa morale cosale di cui Han lamenta la perdita a più riprese appare come un’esaltazione del diritto di proprietà che ha senso soltanto per coloro che storicamente hanno avuto il possesso come orizzonte di possibilità; per chi invece è sempre stata più vicina alle cose che ai suoi proprietari il discorso cambia.
Sadie Plant (insieme a Donna Haraway, il principale riferimento teorico di Russell) ci ricorda che le donne per millenni “sono state considerate alla stregua di attrezzi e strumenti, pezzi, parti, e beni destinati a essere comprati e venduti e ceduti” (in Zero, uno, Luiss University Press 2021). E quando hanno fatto il loro ingresso in massa nel mercato del lavoro, nel primo Novecento, le segretarie, stenografe, dattilografe, centraliniste che popolavano gli uffici tenendo in piedi l’infrastruttura burocratica del capitalismo erano quasi indistinguibili dagli strumenti tecnologici che operavano, dai tasti delle macchine su cui battevano incessantemente. Fa sorridere ma non sorprende, a questo punto, che per Han, invece, sulla scorta di Heidegger, “la macchina da scrivere per la quale sono necessarie solo le dita ‘sottrae all’uomo la dignità essenziale della mano’”.
Il glitch libera i corpi che dal genere sono costretti (ovvero sia, a ben vedere, tutti i corpi) rendendoli illeggibili dagli strumenti del capitalismo.
La scomparsa, lamentata da Han, delle cose come interlocutrici, dotate di una materialità confortante e affidabile e passibili di un investimento libidico che il digitale tende invece a disperdere, sembra tradire, in sostanza, il rimosso dell’identificazione tra cose e donne, l’Altro per eccellenza nel paradigma occidentale. Ne consegue, per Han, che la comunicazione digitale, legata più al tatto che alla vista, è portatrice di una dimensione triviale che annulla le distanza fra noi e il mondo, impedisce la contemplazione e “fa scomparire l’Altro come sguardo”. In Russell, invece, l’Altro non è affatto un elemento del passato ma anzi occupa tutto lo spazio, e la scomparsa del suo sguardo onnipresente e per lo più ostile è esattamente ciò che il glitch feminism persegue e auspica. Essere glitch, sostiene Russell, significa appunto sottrarsi allo sguardo dell’Altro e diventare irriconoscibili, hackerando gli strumenti della rappresentazione digitale e cercando nell’intercapedine tra i due mondi, materiale e virtuale, la propria forza generatrice. In questo senso il glitch è “un errore, uno sbaglio, una falla”, un salto imprevisto nella stringa del codice, un’identità in trasformazione che scivola, secondo l’etimologia stessa della parola, verso le alternative a sé stessa. Essendo un rifiuto del genere come “spartito, cioè come una serie di regole e requisiti” che identificano le persone e le inquadrano in categorie predeterminate, il glitch libera i corpi che dal genere sono costretti (ovvero sia, a ben vedere, tutti i corpi) rendendoli illeggibili dagli strumenti del capitalismo: l’occhio onnisciente del riconoscimento facciale e i suoi algoritmi. Per un corpo all’intersezione di diverse oppressioni, inoltre, liberarsi dello sguardo dell’Altro non è una pulsione velleitaria ma una questione di sopravvivenza:
Per un acerbo corpo Nero e queer, la doppia coscienza di cui parla Du Bois si frantuma ulteriormente, il “doppio” diventa “triplo”, la coscienza viene amplificata ed espansa dal “terzo occhio” del gender. Io guardavo tutto attraverso le lenti della razza e del genere, ma nessuno guardava me nella mia totalità […] Allora, l’atto di sovversione per il mio corpo poteva arrivare soltanto col remix digitale.
Il remix digitale di cui parla Russell è una via di fuga dalla gabbia dell’Ego alternativa, nel modo e nel metodo, alla contemplazione distante e silenziosa proposta da Han. L’anonimato teorizzato da Russell non passa infatti per un semplice e lineare processo di sottrazione dell’Io ma per una sua moltiplicazione. Le occasioni offerte dall’anonimato si trasformano nella creazione di un “[io] con io molteplici”, dove una molteplicità fluida si contrappone alla rigidità degli schemi identitari del passato per permettere una sorta di partenogenesi digitale, fatta di divisioni, fusioni, emersioni, in un continuo scambio tra online e offline, in cui lo stesso concetto di realtà viene ampliato e arricchito dalle sperimentazioni virtuali – uno dei punti cardini del ragionamento di Russell. La partenogenesi, cioè la possibilità che le donne arrivino a riprodursi senza il contributo del seme maschile (un vecchio mito del femminismo della prima ondata, nonché paura atavica del patriarcato), viene ripreso e aggiornato da Russell ai recenti tentativi di superare gli steccati di binarismo di genere, dando vita a una lettura davvero originale.
In un mondo in trasformazione, dove l’identità non è più una risorsa data e perseguirla come valore in sé porta ad esiti catastrofici, l’esplorazione di un digitale che smaterializza e apre le porte all’ibrido e alla contaminazione può costituire una risorsa inaspettata.
L’indeterminatezza propria del mondo digitale e la mancanza di punti di riferimento, che in Han vengono additati come elementi annichilenti, sono per Russell un varco aperto verso il proprio vero potenziale. In un mondo in trasformazione, dove l’identità non è più una risorsa data e perseguirla come valore in sé porta ad esiti catastrofici, l’esplorazione di un digitale che smaterializza e apre le porte all’ibrido e alla contaminazione può costituire una risorsa inaspettata. Per Han la gabbia dell’Ego è un fenomeno tutto sommato recente, che affonda le sue radici nella rivoluzione informatica degli ultimi trent’anni e nella dimensione immateriale dell’infosfera. Per Russell, invece, così come per Plant, la gabbia dell’Ego è una delle forme assunte dall’oppressione patriarcale e razziale, un dominio di lunga data legato ai corpi e alla loro materialità. Il digitale, al contrario, ha aperto spazi di possibilità. La soluzione non è allora sottrarsi al digitale, ma utilizzarlo per costruire una diaspora dell’Io verso piani spaziali e temporali differenti, dove l’identità si può dissolvere e ricomporre a piacimento e il corpo essere risignificato secondo nuovi criteri. La via digitale è una nuova via all’indisponibilità, una via che attraversa la virtualità invece di temerla e rifiutarla.
“In un panorama globale distopico”, scrive Russell, “che non lascia spazio a nessuno di noi e non offre asilo, il semplice atto di vivere – sopravvivere – nonostante un’egemonia basata su genere e razza diventa un atto politico. Scegliamo di restare vivi contro ogni aspettativa, perché le nostre esistenze hanno un valore. Scegliamo di supportarci a vicenda nell’atto stesso di vivere, perché rimanere vivi è già un modo per costruire dei mondi”. Reali e virtuali.