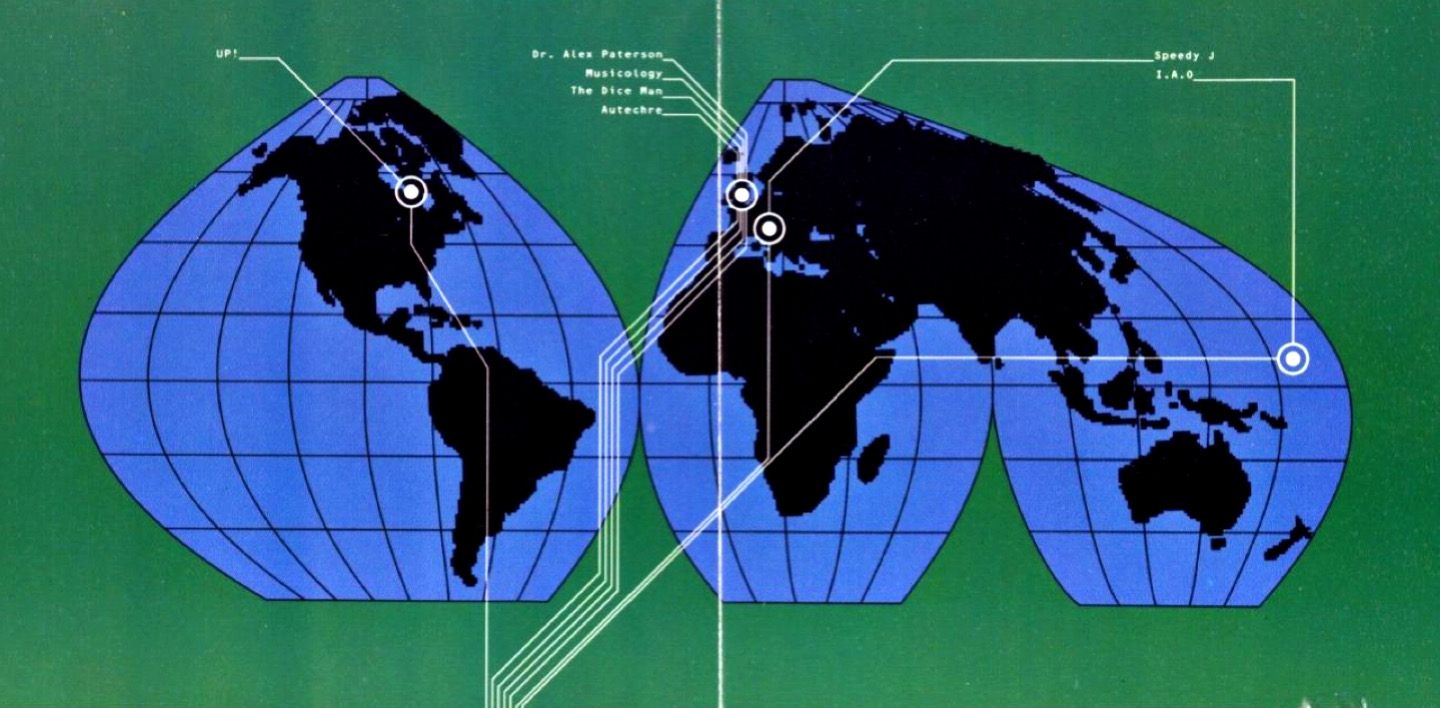
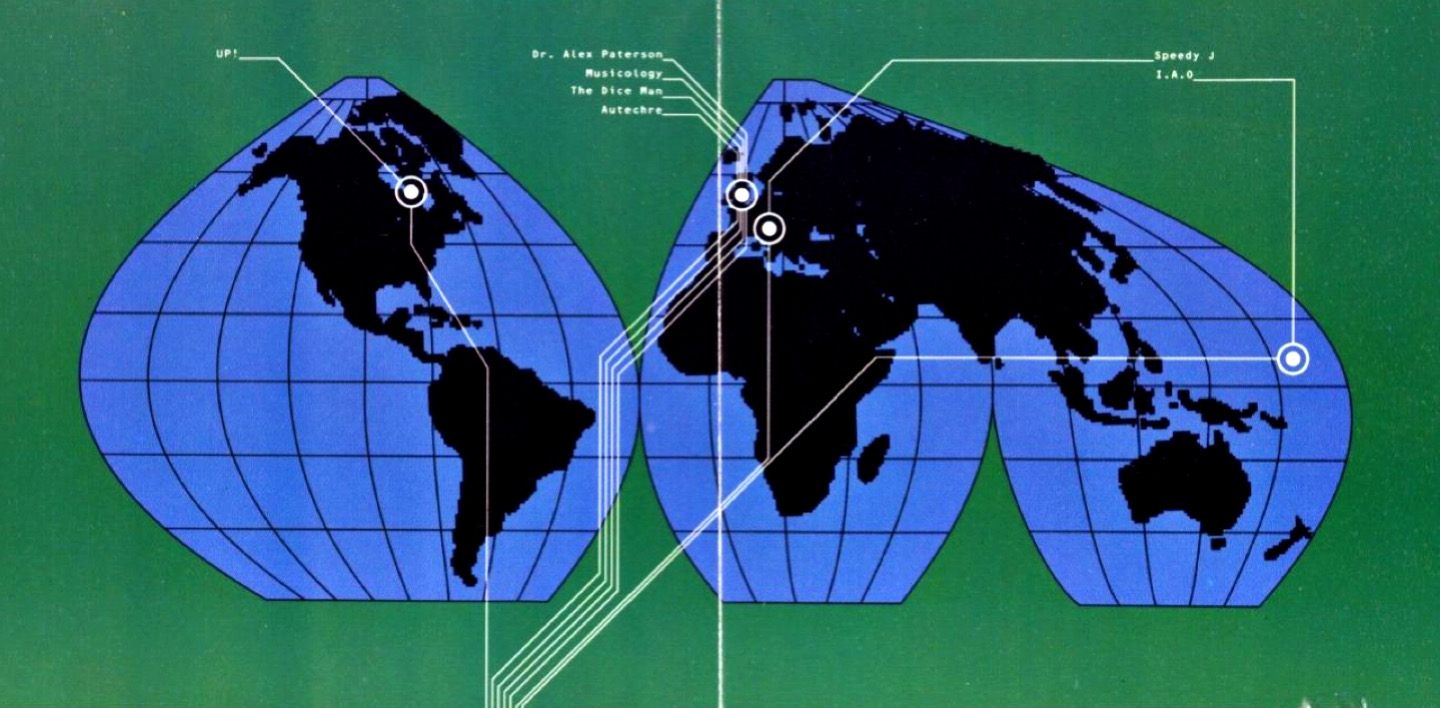
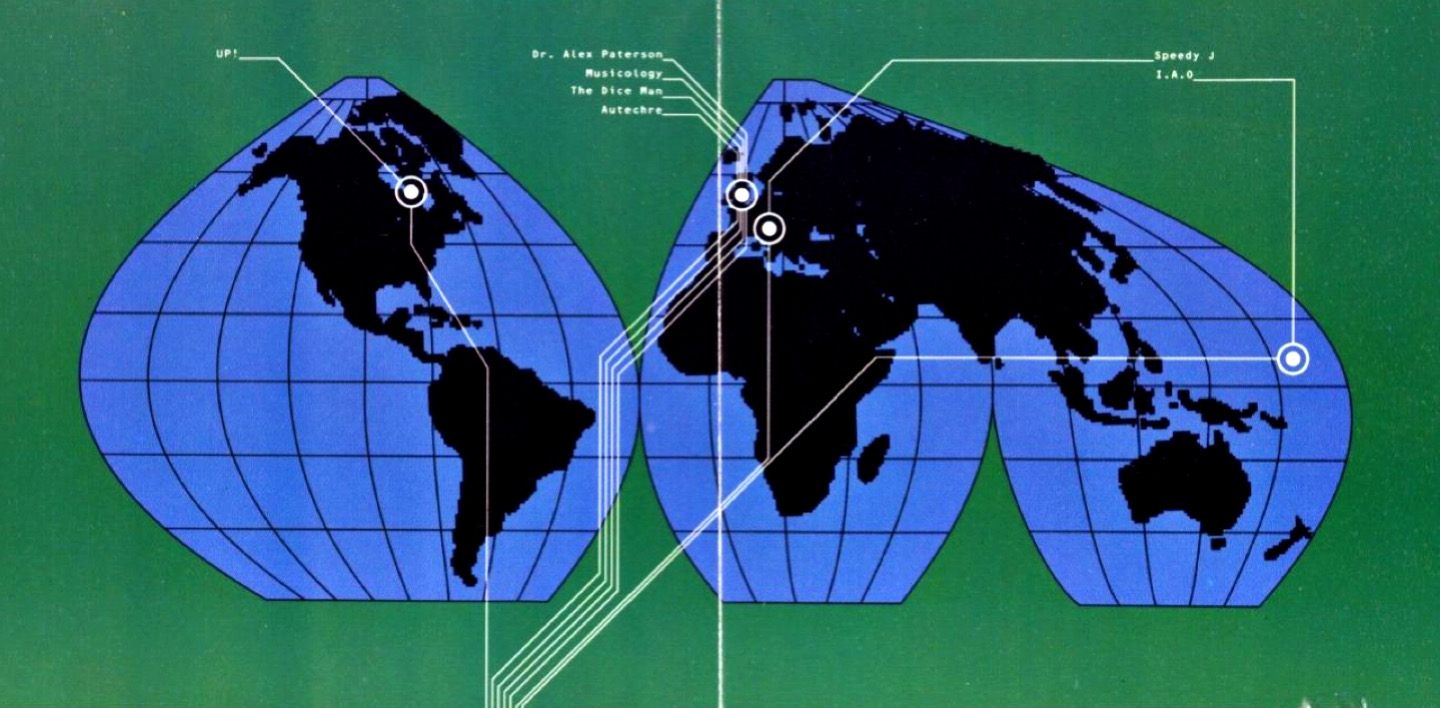
L’ idea che certi tipi di musica abbiano un rapporto speciale con il Futuro ha una lunga storia e continua a esercitare un grande fascino sulla nostra immaginazione di ascoltatori, pensatori e anche musicisti. Nei primi anni Novanta, per esempio, David Toop – critico e musicista – parlava suggestivamente di una vaga “nostalgia del futuro” che trapelava dalle registrazioni dei Black Dog, un gruppo inglese associato a un genere nascente noto per un breve periodo come “electronic listening music” e poi ribattezzato definitivamente Intelligent Dance Music o IDM. E questa idea non è diffusa esclusivamente tra i critici di professione e i paladini della musica. Nel romanzo Aidoru del 1996, ambientato nel futuro prossimo, William Gibson affida le proprie riflessioni al personaggio di Kuwayama, un pezzo grosso dell’industria dell’intrattenimento giapponese convinto che il pop sia “il banco di prova del futuro”. Nel suo classico Rumori del 1977, Jacques Attali costruiva un’intera teoria dell’evoluzione musicale basata sull’idea che la musica sia profetica. Tuttavia, più che sulle proprietà formali della musica (per esempio una maggiore tolleranza alla dissonanza, come potrebbe suggerire il titolo Rumori), il suo ragionamento si concentra sulle strutture e sulle gerarchie che la musica genera attorno a sé. Attali si focalizza sulle modalità di produzione, distribuzione e fruizione musicale, interpretandole come avvisaglie di nuove forme di organizzazione sociale.
Un discorso di questo tipo va particolarmente a genio a chi come me ha dedicato la vita a esaltare forza e significato della musica, perché stimola la mia visione patriottica della musica come area dell’esistenza umana. La mia storia personale di ascoltatore e l’epoca in cui il caso ha voluto farmi nascere mi hanno condizionato a cercare “il futuro” nella musica, e a farmi ammaliare da ragionamenti e narrazioni che la presentano come messaggera del mondo che verrà.
Ecco perché, per molti versi, sono un lettore ideale di Exmachina di Valerio Mattioli. La sua è un’impresa iper-esegetica che individua le declinazioni dello Zeitgeist nelle discografie di soli tre nomi, artisti di punta di un filone relativamente marginale della musica popolare, il già citato genere-non-genere noto come IDM. Per chi li conosce, Aphex Twin, gli Autechre e i Boards of Canada sono divinità il cui minimo scampolo di registrazione merita di essere decifrato dai devoti. Ma persino questi cultori rimarranno stupefatti dall’intensità della disamina di Mattioli e dalla portata delle sue riflessioni.
Exmachina è un’archeologia del futuro racchiuso in una musica realizzata almeno un quarto di secolo fa; un futuro che ora è il nostro presente. Un futuro che, come nella teoria di Attali, non è tanto nelle caratteristiche superficiali della musica – il gelo dei suoni sintetizzati, i ritmi meccanici predominanti – né nell’immaginario che la avvolge (spesso “futuristico” in un senso che già all’epoca era alquanto familiare e talvolta rasentava il kitsch fantascientifico). Il futurismo risiede piuttosto nella grammatica profonda della musica e nella soggettività che la musica proponeva, plasmava e sollecitava; un futuro al quale in un certo senso la musica preparava l’ascoltatore, modellandone percezioni ed emozioni.
I musicisti elettronici degli anni Novanta erano stimolati da tecnologie emergenti estranee alla dimensione sonora, alcune delle quali erano ancora poco più che voci o chimere.
Benché l’argomento del libro di Mattioli sia il futuro latente nella musica, parte della quale ha oggi trent’anni, quel futuro che è diventato la nostra quotidianità digitale, devo confessare che per alcuni versi leggerlo mi ha procurato un piacere di tipo nostalgico. Exmachina è una specie di macchina del tempo: dà la deliziosa sensazione di essere riproiettati nei primi anni Novanta, nel pieno dello stupito entusiasmo per il futuro imminente che sembrava manifestarsi nella musica elettronica, dance e non, di nuovo travolti dal febbrile clima intellettuale dell’epoca.
Nel 1992 i computer erano ormai diffusi al lavoro e negli spazi domestici, ma non dominavano ancora la nostra esistenza. Mancavano parecchi anni all’avvento della banda larga; il collegamento in linea commutata era scomodo e lento, e quando ti connettevi a internet non c’era praticamente nulla da vedere (tanto meglio, visto che le pagine ci mettevano un’eternità a caricarsi). Quasi nessuno aveva la posta elettronica, e i telefoni cellulari, in termini di diffusione e di ciò che era possibile farci, erano in una fase embrionale. Non esisteva nessuno dei “super-poteri” che oggi diamo per scontati – wi-fi, motori di ricerca, Siri, social media, eccetera – e alcuni non erano stati nemmeno immaginati. Il regno digitale era ancora confinato in una zona isolata della nostra esistenza, ma proprio per questo quelle tecnologie profumavano di futuro; un aroma irresistibile o allarmante, a seconda dei punti di vista.
Per molti, i luoghi di elezione dove avvertire in anticipo un sentore delle novità erano i videogiochi e la musica: la scarica di futuro più potente alla quale le persone comuni potessero avere accesso, in particolare per chi a sua volta si dedicava a produrre musica. Oltre a sperimentare l’inebriante flusso creativo di macchine e software che per gli standard di oggi sono rudimentali e di una lentezza ridicola, i musicisti elettronici degli anni Novanta erano stimolati da tecnologie emergenti estranee alla dimensione sonora, alcune delle quali erano ancora poco più che voci o chimere. Concetti come la realtà virtuale e la videosorveglianza offrivano immagini agli artisti techno e jungle quando la prima non era ancora entrata in commercio e la seconda non era ancora diventata onnipresente in certi paesi.
Non erano gli umani a fare la musica, era la musica a rifare – e disfare – gli umani come categoria.
La polarità realtà virtuale/telesorveglianza – da un lato il palazzo dei divertimenti artificiali, dall’altro il Panopticon – richiama la curiosa natura bipolare del dibattito sulla cultura digitale negli anni Novanta. Ingenuo ottimismo e paura esagerata erano due facce della stessa medaglia: un’euforia che si ribaltava facilmente in disforia. Leggendo autori come Arthur Kroker, Paul Virilio, Donna Haraway, Sadie Plant, Erik Davis, Mark Dery, Jaron Lanier e Kodwo Eshun (molti dei quali citati da Mattioli), bastava alterare il proprio punto di vista di un nonnulla per leggere l’esultanza come denuncia. Il frenetico fervore della prosa era lo stesso, sia nella modalità utopica che in quella distopica. Per alcune di queste figure, non si capiva se aspettassero il futuro postumano con impazienza o terrore. E certi ex predicatori si sarebbero trasformati in Geremia, scrivendo libri con titoli come Tu non sei un gadget e New Dark Age: Technology and the End of the Future.
Era un periodo elettrizzante per fare il critico, soprattutto musicale. Per persone come me, Kodwo Eshun e i giovani Mark Fisher e Steve Goodman (all’epoca membri del gruppo para-accademico Cybernetic Culture Research Unit) era raro usare riferimenti storici. Dare coordinate basandosi sulla musica precedente era impossibile, perché la nuova musica usciva dalla mappa. Il vorticoso progresso e mutamento di suoni e ritmi costringeva a elaborare concetti inediti e nuove figure retoriche, il che spiega la proliferazione di neologismi e nuovi nomi di generi. Inoltre, l’apparente atmosfera postumana della musica sembrava richiedere un’analisi spersonalizzata che attribuisse una sensibilità intenzionale allo svolgimento dei singoli brani e all’evoluzione complessiva di quei generi e quelle scene. Mattioli rivive questa prospettiva, questa impressione estaticamente paranoica che la musica sia indipendente dai disegni umani e abbia un suo oscuro programma. Non erano gli umani a fare la musica, era la musica a rifare – e disfare – gli umani come categoria. “Dobbiamo cambiare per le macchine” e “punto di vista umano ridondante”, scriveva nel 1995 il collettivo teorico/videoartistico 0(rphan)d(rift>) in Cyberpositive, un delirante collage testuale dai toni mistico-masochistici impregnato dello strazio mentale sperimentato nei locali techno grazie alla combinazione di musica assordante e allucinogeni.
Mattioli è entrato in uno stato mentale simile mentre scriveva Exmachina, ma invece del buio sovraffollato dello spazio rave è stato l’isolamento forzato del lockdown durante la pandemia di COVID a indurre in lui una paranoia creativa in cui ogni cosa trasudava significati, e pattern pulsanti fino a quel momento nascosti venivano allo scoperto. Quando, decenni prima del wi-fi, Baudrillard immaginava il cittadino teleconnesso del futuro, sostanzialmente lo vedeva condurre la sua vita in un satellite, un modulo sigillato in orbita attorno al vuoto un tempo popolato dalla società. Connesso ai network, era un nuovo sé poroso che vibrava in una perpetua “estasi della comunicazione. Tutti i segreti, gli spazi e le scene aboliti in una singola dimensione dell’informazione”. Un sé desolato che è “aperto a tutto contro la sua volontà e vive nella più grande confusione. […] diventa puro schermo, un interruttore di tutte le reti di influenza” (Jean Baudrillard, Le strategie fatali, Feltrinelli, Milano 1984, trad. Sandro D’Alessandro). Sembra quasi una descrizione della nostra vita nel 2020-2021. Mattioli ha sfruttato il trauma della pandemia per costruirsi un’avventura personale. Exmachina è la storia di dove la musica ha portato la sua mente.
Estratto da Exmachina. Storia musicale della nostra estinzione 1992 → ∞ di Valerio Mattioli (Minimum Fax, 2022).