


E nrico Gabrielli è l’uomo ovunque di una certa musica italiana. Durante la scorsa estate, ha suonato dal vivo con Calibro 35, Francesco Bianconi, Andrea Laszlo De Simone, The Winstons. Suona ance varie, tastiere e percussioni; è compositore, arrangiatore, produttore, scrittore. Diplomato in clarinetto al conservatorio, si è riposizionato nell’area “alternativa” attraverso l’avventura bolognese con Mariposa e la “famosa etichetta” Trovarobato, per poi fare di tutto, da Marco Parente e Morgan all’ingresso negli Afterhours, dalla fondazione del supergruppo Calibro 35 (2007) alla collaborazione con Capossela in Da solo, 2008. Poi Bianconi (con e senza Baustelle: Fantasma e Forever, rispettivamente 2013 e 2020) e Nada (Occupo poco spazio, 2014). Sul fronte internazionale, ha collaborato con Muse (The Resistence, 2009), Mike Patton (Mondo cane, 2010) e soprattutto PJ Harvey (in sala di registrazione e sul palco fra 2015 e 2017 per The Hope Six Demolition Project).
L’unica sortita individuale risale al 2010: un album con lo pseudonimo Der Maurer intitolato Vol. 1, dove accanto a una propria partitura ne eseguiva altre di Steve Reich, Giovanni Gabrieli e Louis Andriessen, promettendo un secondo volume mai realizzato. In compenso, nel 2014 ha ideato con Sergio Giusti l’“esperimento sociale” chiamato Unità di Produzione Musicale, impegnando per una giornata 72 musicisti in un ciclo di lavorazione all’apparenza fordista. In parallelo, insieme al “multi-percussionista” Sebastiano De Gennaro, dava forma all’ensemble Esecutori di Metallo su Carta: preambolo alla creazione dell’editrice “anticlassica” 19’40”, attiva dal 2016, anno in cui esordiva il trio “prog” The Winstons, costituito con Roberto Dell’Era e Lino Gitto.
“Sono apolide da quando avevo 18 anni”, mi dice ora che sta per compierne – il 24 ottobre – 45. Attualmente vive a Torino, dopo aver girovagato in Italia spinto da moventi artistici e sentimentali: “È una città completamente diversa da Milano, dove tuttora gravito per lavoro: qui si fa un’altra vita, più tranquilla, e per me rappresenta una specie di via di fuga. In effetti è quasi hinterland milanese, distante 50 minuti in treno, come Brooklyn da Manhattan. Piano piano sto cominciando a familiarizzarci e ho stretto rapporti con gente del posto che già conoscevo: Andrea Laszlo De Simone, i ragazzi dell’Off Topic, il giro di ‘Seeyousound’. Mi piace il suo fascino narrativo: io abito in piazza Bodoni, ho il Conservatorio sotto casa, vedo la Mole e Superga, è un panorama molto letterario. Torino è una città fatta per leggere, perciò mi affascina”. Altro luogo che lo aveva calamitato è Bologna: “Tecnicamente non ci ho mai vissuto, ma era una base di appoggio: mi piaceva quell’atmosfera da studenti fuori corso al Dams stile Andrea Pazienza, ma senza l’eroina, e con internet agli albori, da passarci le notti in bianco. Venendo da Milano, mi sembrava la capitale del fancazzismo, ma attraversava un gran momento: ‘AngelicA’ agli inizi e l’associazione Bassesfere, intorno a cui ruotavano un sacco di musicisti di rock alternativo e jazz sperimentale. A quei tempi amavo Bologna e odiavo Milano, ma ho trascorso anche quattro anni a Padova, imbattendomi in musicisti come Alessandro Graziano e Marco Fasolo, con i quali sono rimasto legato”.
Il punto di partenza è Ambra, frazione di Bucine, comune al confine tra Siena e Arezzo, “ma con il prefisso telefonico di Firenze”, precisa lui. L’ingresso nella sfera musicale avvenne là: “Fu attraverso la banda di paese: verso fine anni Ottanta era stata rifondata la filarmonica locale e i miei genitori, dopo aver tentato senza successo di farmi frequentare corsi di judo, nuoto e altri sport, insistettero per farmici entrare e mi spronarono mettendocisi anche loro: mio padre al trombone, mia madre al flauto e io al clarinetto. Non erano musicisti, impiegato comunale lui e al tempo casalinga lei, ma papà – segretario di sezione nel PCI – era un grande appassionato di musica classica, in particolare di compositori sovietici tipo Šostakóvič o Prokof’ev. Così andai da un maestro per imparare a suonare lo strumento e dato che me la cavavo fui chiamato nelle bande dei paesi vicini, fino a Montevarchi: anche se avrei preferito disegnare, la musica finì per coinvolgermi. Il passaggio decisivo fu però il liceo musicale ad Arezzo: lì mi partì la scuffia per la classica e scelsi d’iscrivermi al conservatorio di Milano, dove poi mi sono diplomato in clarinetto nel 1996, senza terminare invece il corso di composizione, essendo squattrinato”. A farlo sbandare in altra direzione fu un contrattempo: “Stavo nell’ensemble di musica contemporanea Risognanze, fondato a metà decennio da studenti del conservatorio, tra cui me, e un giorno mi capitò di arrivare tardi a una prova per un disservizio ferroviario, siccome allora facevo il pendolare fra la Toscana e Milano. Fui redarguito dal direttore e gli risposi male, al che lui disse: ‘Tu adesso non fai più parte di questo consesso!’. Quell’esclusione mi spinse a dare retta a due ex compagni di liceo, Alessandro Fiori e Michele Orvieti, che a Bologna avevano appena creato insieme a Gianluca Giusti i Mariposa: una formazione bizzarra che negli anni si sarebbe espansa a dismisura, generando inoltre l’etichetta discografica Trovarobato. Così cominciai ad ascoltare cose strane, da Zappa ai Residents, e scivolai dentro la popular music. Fino al 1999 non avevo ascoltato niente che non fosse classica e dunque del rock non sapevo nulla: Nirvana e Soundgarden li ho sentiti per la prima volta nel 2006”.
Gli domando se deriva di là l’epiteto “anti-classica” sbandierato da 19’40”. Risponde: “È uno di quei termini che uno s’inventa all’inizio di un percorso, tipo quello di un’etichetta discografica, gettandolo in pasto agli altri senza darne una descrizione precisa, in modo che ognuno possa interpretarlo come meglio crede: poi ti rimane appiccicato addosso e non se ne va più via. In partenza voleva essere una dichiarazione in aperta polemica con l’istituzione: una collana di musica classica contro l’egemonia colta. In seguito ha preso però una piega diversa, intendendo ‘anti’ nel senso di precedente, quindi una serie di futura musica classica: l’accezione più interessante, secondo me”. E a proposito dell’intestazione cronometrica, spiega: “Il 2012 era l’anno dedicato a John Cage e con Sebastiano pensammo – cageianamente – di celebrarlo nel 2013, pubblicando un disco in vinile contenente le nostre versioni di due composizioni del 1940, Bacchanale e Dance Music for Elfrid Ide: poiché volevamo che entrambi i lati durassero 19 minuti e 40 secondi, riflettendo i numeri dell’anno, aggiungemmo un paio di cover su misura di 4’33”. Ci è sembrato perfetto quando si trattava di trovare un nome per l’etichetta”.
Implicato nell’impresa, oltre a lui e De Gennaro, anch’egli musicista di formazione accademica e svezzamento nel sottobosco alternativo, è Francesco Fusaro: musicologo, discografico con il marchio MFZ Records e conduttore sulla web radio londinese NTS di “Tafelmuzik”, programma nel quale mixa brani di classica alla maniera di un Dj. A caratterizzare i lavori editi, 15 al momento, è un packaging seriale in bianco e nero che dota la collana di un impianto unitario: a collezione ultimata, i dorsi delle custodie dei Cd costituiranno la sequenza di tasti del pianoforte. Il catalogo è eterogeneo, come dimostrano le ultime uscite: dal “Pinocchio” di Fiorenzo Carpi con Francesco Bianconi voce recitante alla rielaborazione cameristica di musiche da videogiochi in Ghosts Goblins Ghouls, mentre la più recente è un’interpretazione di Fusaro dell’enigmatico Treatise, spartito redatto a metà anni Sessanta dal compositore inglese Cornelius Cardew ispirandosi al Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein. Chiedo se vi siano precetti nella selezione del materiale da pubblicare.
“Di base ci occupiamo di musica scritta nell’accezione più ampia del termine, dunque niente improvvisazione o cose simili, e alterniamo tre generi di approccio. L’esecuzione di una partitura, tipo l’Histoire du Soldat di Stravinskij; la trascrizione, modificando cioè l’originale, ad esempio le musiche di Bernard Herrmann per la serie televisiva Ai confini della realtà; infine il sabotaggio, trasfigurando il soggetto attraverso un tritacarne concettuale, come nel caso di Quadri di un’esposizione di Musorgskij, dove abbiamo considerato anche la versione ‘prog’ di Emerson, Lake & Palmer. L’idea è di dare un colpo al cerchio, vale a dire il Novecento storico, e uno alla botte, ossia la contemporaneità”.
Anti-classica è uno di quei termini che uno s’inventa all’inizio di un percorso, in modo che ognuno possa interpretarlo come meglio crede: poi ti rimane appiccicato addosso e non se ne va più via.
Tra storia e contemporaneità ci sono i due Sanremo da direttore d’orchestra. “Arrivando da un paesino di mille abitanti, la dimensione nazional-popolare mi è familiare… Il festival è essenzialmente un evento sociale, tutto esteriorità, tipo sagra di paese, e la musica non c’entra niente. Nel caso degli Afterhours fu stressante: stavo nella band, oltre a dirigere l’orchestra senza averne titolo, tant’è vero che mi scusai preliminarmente con gli orchestrali e riuscii così a farmi prendere in simpatia. Quando tornai invitato da Silvestri, che portava un pezzo molto forte per quel contesto, fu invece una prestazione più professionale, ma quell’anno suonai pure nei Calibro 35 da backing band di Ghemon nella serata dei duetti: un Sanremo con i controfiocchi”. Altra orchestra e soggetto differente, quella della Scala e Bella ciao: è stato un modo per chiudere il cerchio con la figura del babbo comunista? “Ad Ambra è stato un motivo di orgoglio pazzesco, soprattutto per la banda: in provincia la Scala rimane un simulacro, un po’ come nel film di Steno Totò a colori. E ancora di più per mio padre, che s’impegna a perpetuare la memoria storica della Resistenza e organizza commemorazioni degli eccidi compiuti in zona dai nazifascisti. Mi ha trasmesso lui l’importanza del 25 aprile, una festa che sento tuttora mia, e quindi ho accettato immediatamente quell’incarico, anche se lavorare su Bella ciao è stato difficile, essendo un tema molto popolare e ripreso già in un’infinità di maniere differenti”.
Provo a scendere in profondità, a questo punto, ripensando allo pseudonimo Der Maurer (“il muratore”, in tedesco) e all’esperienza con l’Unità di Produzione Musicale: ti consideri un lavoratore della musica? “Mi definirei ‘operaio soddisfatto’: la musica è una fatica gioiosa, anche se ho attraversato fasi in cui era più un mito romantico. Una parte di me incarna la nobiltà proletaria, tipo ‘testa bassa e lavorare’, ereditata dall’impegno militante di mio padre e dunque opposta all’idea aristocratica della rockstar: non ho mai smesso di studiare, riflesso tipico di chi non si sente arrivato. Inoltre nel periodo fra il 2010 e il 2015 l’attività con i Calibro 35 era massacrante, sempre in giro per l’Italia e l’Europa in furgone: mi sentivo davvero un lavoratore della musica, persino un po’ alienato, e quegli sfoghi rappresentavano il mio modo di esorcizzare quella condizione”. Essendo “uomo squadra” anziché “primadonna”, in quale forma si manifesta la tua identità espressiva? A conti fatti, hai pubblicato appena un album da solista… “Banalmente, credo che la ‘mia’ musica, svincolata da relazioni, contesti, luoghi e occasioni, sia interessante solo per me: scrivo tantissimo in privato e ho fatto addirittura un disco di canzoni per bambini destinato a figli, nipoti e conoscenti, ma non mi è mai venuta la voglia di esporre me stesso rendendo pubbliche quelle composizioni. Trovo molto più stimolante e divertente accendere la miccia di meccanismi collettivi, che sia una band o un’etichetta discografica, in grado di vivere poi una vita propria: la cosa importante è trovare persone affini in funzione del progetto, perché non si può fare tutto con tutti. Detto ciò, se mi commissionano lavori, la colonna sonora di un film o un’opera lirica, la firmo Enrico Gabrielli. Ma a produrre un disco mio non ci penso affatto”.
Strada facendo ha avuto numerosi incontri con “primedonne”: Morgan, Agnelli, Bianconi e Capossela, fino a PJ Harvey… “I contenitori di sé stessi”, li chiama lui. “Sicuramente devo tanto a Morgan, nel periodo da Non al denaro… a Da A ad A: oltre a scovarmi, mi ha insegnato a sperimentare su tutto, e intendo davvero tutto quanto, chimica inclusa. Grazie a lui ho imparato un mucchio di cose: ad esempio l’esistenza dell’Eko Tiger, strumento che utilizzo ormai abitualmente nei Calibro 35, e lo sterminato repertorio di canzoni italiane che conosceva a menadito e padroneggiava benissimo. Ma parlo anche di suggestioni letterarie: mi regalò Il terzo poliziotto di O’Brien e Gödel, Escher, Bach di Hofstadter, consigliandomi di vedere le Teche Rai su Buzzati. Marco era veramente molto avanti… Per capire invece i meccanismi e le relazioni umane all’interno di una band, suonare negli Afterhours è stata un’esperienza determinante, mentre per conoscere il mondo, in senso letterale, non posso non ricordare le 99 date del tour intercontinentale con PJ Harvey, durante il quale ho assistito al crollo dell’impero angloamericano, da Brexit a Trump. Ricordo che i risultati del referendum britannico arrivarono quando eravamo in Olanda: vidi Polly e John Parish piangere disperati abbracciandosi nel backstage. Conservo un diario di quella tournée, scritto giorno per giorno…”.
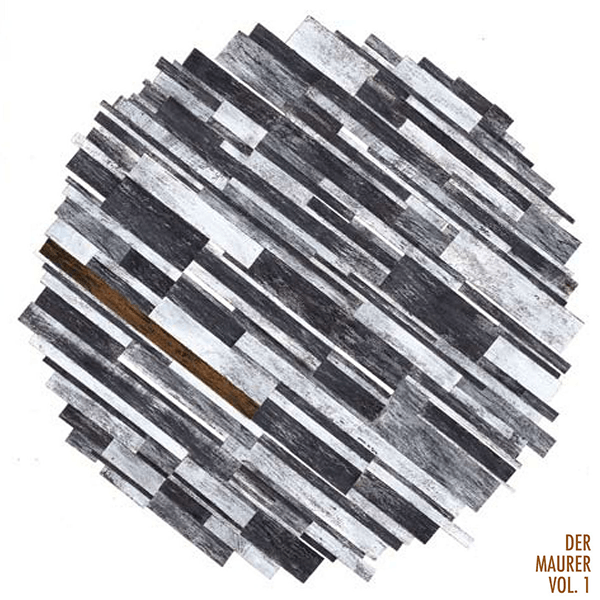
Da 14 anni in qua elemento costante nel suo multiforme tragitto artistico sono i Calibro 35: nati come passatempo a suon di vintage “poliziottesco” e divenuti poi un caso di proporzioni internazionali grazie ai campionamenti di loro brani da parte di pesi massimi dell’hip hop statunitense quali Jay-Z e Dr. Dre. Quando avete capito che stava diventando una cosa seria? “È successo abbastanza presto: personalmente mi sono reso conto che saremmo andati lontano dopo una manciata di concerti, vedendo brillare gli occhi a Tommaso Colliva, che ha il merito di aver immaginato originariamente il progetto ed essere stato determinatissimo nel perseguirlo. La sua figura di produttore gli permette di avere uno sguardo esterno sulla band, requisito preziosissimo per noi”. Possiamo considerarlo allora il fulcro della tua attività attuale? “A essere sincero, negli ultimi anni non è la cosa che mi assorbe di più, né rappresenta il perno della mia carriera musicale, ma si tratta della migliore equipe di lavoro che potessi immaginare di avere. Tutte e cinque le persone coinvolte hanno individualità molto forti e una vita professionale intensissima, per di più sviluppata in direzioni diverse. È una storia alla DC Comics: un capo in sala macchine, ossia Tommaso, e quattro supereroi che uniscono le forze per andare in missione ogni volta che serve. Alla fine, più dei singoli, ciò che conta davvero è il marchio: capita sovente che chi m’invita a fare qualcosa scopra solo dopo che faccio parte di quella band”.
Quinto e terzultimo album dei Calibro 35 è S.P.A.C.E., zeppo di allusioni alla fantascienza: altra chiave d’accesso al composito mondo di Enrico Gabrielli. “Da ragazzo non è che leggessi molto e il mio approccio iniziale alla letteratura è stato con quella di genere, i libri delle collane di giallistica e fantascienza che entravano in casa come allegati a L’Unità quando era direttore Veltroni. In particolare, i primi titoli furono Cronache marziane di Ray Bradbury e il Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov. Quell’impronta mi rimase addosso e nel periodo milanese sprofondai in Philip Dick: Utopia, andata e ritorno, Ubik, La svastica sul sole… Era un momento di rinascita della fantascienza in Italia, dovuto forse al successo di Valerio Evangelisti. Da teledipendente, poi, mi appassionai alle vecchie serie televisive, tipo The Twilight Zone e Tales of the Unexpected di Roald Dahl, o certi oscuri sceneggiati Rai in bianco e nero come E.S.P. o La traccia verde. Così alla fine è scaturito il desiderio di scrivere. A dire il vero, ci fu un evento scatenante: era il 2013 e abitavo a Milano, in viale Gorizia, salivo in ascensore al terzo piano e uscendone vedevo da una finestra un appartamento dove c’era un tizio seduto sistematicamente in poltrona davanti al televisore, qualunque ora fosse, dal mattino presto a notte fonda, sembrava un manichino… Fu la scintilla che accese l’ispirazione per il primo racconto dei 23 da cui sono stati selezionati i 17 inclusi nella raccolta Le piscine terminali, alla quale ho lavorato con i ragazzi della rivista specializzata ‘Parallàxis’, il cui fondatore Giorgio Majer Gatti, filosofo spinoziano, è stato editor del libro. E da lì ho continuato, scrivendo pure un romanzo, che tengo nel cassetto, e un feuilleton in 15 puntate dedicato a Captain Future, il personaggio creato negli anni Quaranta da Edmond Hamilton, uscito sul mio blog per-iscritto.com, che ha avuto eco in Francia sul sito dei fan di Capitaine Flam, come lo chiamano là”.
In tutto questo, che fine ha fatto la passione originaria per il disegno? “Ero abbastanza bravo, ma non mi ci sono mai applicato veramente, anche se continuo a praticarlo come hobby usando la penna o gli acquerelli. Ogni volta che affronto un lavoro, per chiuderlo creo una copertina: ad esempio ho realizzato un fumetto a china sui Winstons. La carta rimane il mezzo con cui mi esprimo meglio, proprio perché sono un disegnatore mancato”.
