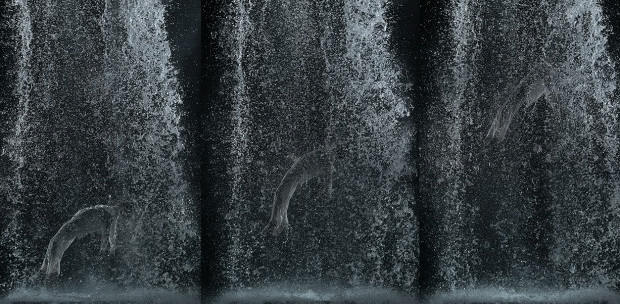
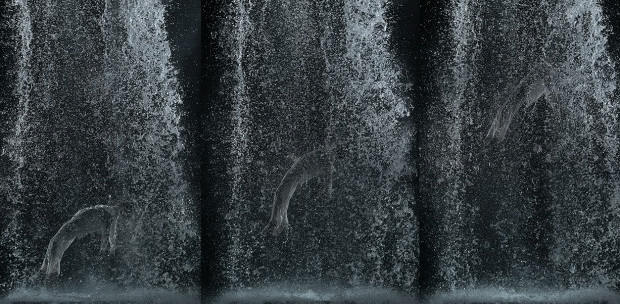
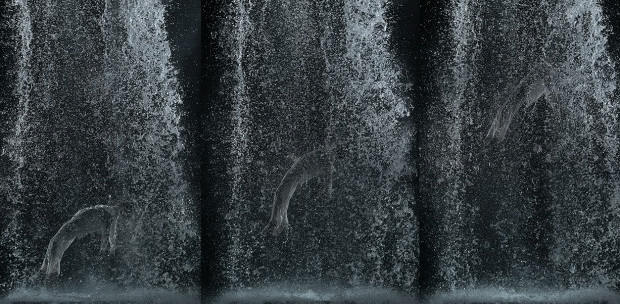
S ono sempre stato affascinato dal Tardo Stile, le ultime opere degli scrittori, dei pittori, ma soprattutto dei musicisti. Non sarà casuale che la stessa espressione è più ricorrente nei libri di storia della musica che altrove, e la si adopera canonicamente per riferirsi alle ultime sonate per pianoforte e agli ultimi quartetti per archi di Beethoven, alla Missa Solemnis e alla Nona sinfonia, insomma a quel gruppo variegato di lavori composti nell’ultimo decennio di vita del maestro di Bonn. Così, in base a una semplice curiosità (“qual è stata l’ultima composizione di Chopin?”) ho passato alcuni giorni a ascoltare e riascoltare questi lavori, alcuni dei quali, come il Quartetto in fa min. op 80 di Felix Mendelssohn o le ultime mazurke di Chopin, scritti a pochi mesi dalla morte. Perché mi domando: ne erano coscienti? Sapevano che stava per finire? Se sì, questa consapevolezza come si incarna, o da cosa trapela? E si può, fissando l’appressarsi della morte, riuscire a buttare giù note su un pentagramma? Cosa produce la doppia visione di questo e dell’altro mondo?
Tali opere terminali rappresentano, oltre al valore artistico, delle specie di NDE, Near Death Experiences, esperienze di pre-morte, e non c’è dubbio che questo aspetto, se si vuole un po’ necrofilo, mi attragga non meno (e forse più) di valutazioni e confronti di tipo stilistico o storico-estetico, complessivamente riconducibili a un’osservazione del musicologo Carl Dahlhaus: “la modernità dell’‘opera tarda’ non consiste nel fatto che anticipa un pezzo di futuro: la modernità di Bach, Beethoven e Liszt è stata scoperta solo dopo che il futuro che essa anticipava era divenuto da tempo presente”. Affermazione che avanza una pretesa di validità universale anche se, per citare un caso esotico quanto si vuole e, certo, non alla veggente altezza di Bach, Beethoven o Liszt, il futuro dell’Opus Clavicembalisticum di Kaikhosru Sorabij che, pur essendo stato completato a quasi sessant’anni dalla morte dell’autore, nasce già inseguendo un miraggio di Tardo Stile, è decaduto nel passato senza mai lambire il presente. “Può esistere un artista che non trova la sua epoca, e un’epoca che non trova il suo artista” diceva Burckhardt, e può accadere che l’allineamento, come tra corpi celesti incommensurabilmente distanti, non si verifichi mai. Il Tardo Stile è il cosciente, più radicale e misterioso tentativo di un artista di disallinearsi da tutti gli altri corpi orbitanti nel cielo della sua epoca.
Beethoven
A giustificare questa ricerca, del resto, è la stessa storia della musica che, di rado, occupandosi di un musicista, lo tratta come un’identità compatta e continua. A dispetto del durevole successo dell’impostazione prevalentemente biografica che, a rigore, non è che il racconto di una vita, l’esistenza di Beethoven è, notoriamente, spezzata in tre figure: il giovane, il maturo (o di mezzo) e l’ultimo, che vengono fatte giocare tra loro secondo le dialettiche più disparate ma mai discusse nelle premesse. Ad esempio si può impostare la tripartizione in termini freudiani, presentando tre istanze dove però la successione psichica è in questo ordine: primo Beethoven = Super-io; Beethoven di mezzo = Es; Beethoven tardo = Io; quest’ultimo specificandosi come un Io confessionale, autobiografico, che “ci introduce nel laboratorio delle sue idee” come ha detto il compositore Salvatore Sciarrino, attitudine intimistica impensabile per le due istanze precedenti, se non, velatamente, in alcune sonate per pianoforte, dove però l’asserita corrispondenza a un journal intime, sostenuta anche dalla circostanza che l’esecuzione delle sonate era affidata a un dedicatario (spesso una dedicataria), che le avvolge in un alone di messaggio privato, è in realtà più un’armatura formale, e talora convenzionale, a paragone della viscerale, sfrenata esplosione di tutte le forme – sonate, quartetti, messa cantata, sinfonie, bagatelle – dell’ultimo periodo, nel quale solamente è giustificato vedere, in quel compositore così straordinariamente consapevole delle sue risorse e della sua importanza che fu Beethoven, un cuore messo a nudo.
Apparentemente istupidite, verrebbe da dire intontite, inghirlandate da ebbri trilli interminabili, le melodie lasciano la scena a una nuova stagione di quell’antico, supremo magistero musicale che è il contrappunto.
Al giovane, irruento, virtuoso improvvisatore erede di Mozart, appartengono la fresca compiutezza delle prime sonate e quartetti per archi, nonché la sbalorditiva riuscita delle prime due sinfonie, così guizzanti, brillanti, tanto spregiudicate quanto levigate, e ancora fiduciose delle possibilità incantatrici della melodia; al Beethoven “di mezzo” la sonata per pianoforte Appassionata, la Quinta sinfonia, opere burrascose in cui la sezione di sviluppo, all’interno della forma sonata di matrice classica, diventa il fuoco dell’attenzione, astringendo le melodie, con indomita sprezzatura, a meri incisi o motti, per non dire effetti, e il Fidelio, dove l’energia sinfonica e la forma teatrale cozzano producendo, di nuovo, un risultato marcatamente non apollineo; quanto all’ultimo Beethoven, quello del Tardo Stile, la sua caratteristica saliente (come spesso nel Tardo Stile, talché non le singole opere ma tutto il Tardo Stile è il venire alla luce di un opus abbracciabile in un solo sguardo, come in Bach un unico blocco sono Messa in si min., Offerta musicale e L’arte della fuga) è una cesura imprevedibile con quanto stilisticamente lo precedeva, un vero e proprio bruciarsi i ponti alle spalle che nella musica di Beethoven si concreta nella sconcertante – per gli ascoltatori del suo tempo e non solo – constatazione che perfino lo sviluppo è diventato una risorsa esaurita (celebre, al tempo in cui la musicologia era una dottrina presa sul serio, la polemica di Adorno circa la Missa Solemnis proprio per l’assenza di sviluppo, da lui considerata non solo un’impotenza musicale ma anche un regresso ideologico, e non già la sazietà di un creatore che, quella tecnica, l’aveva dilatata e manipolata fino alla rottura e che ormai si era deciso alla drammatica cesura del Tardo Stile), mentre d’altro canto le melodie, già liquidate nella seconda fase, quasi fluttuanti relitti o reliquie prelevate dalla prima, si riaffacciano in fugaci scorci estatici come nel perlaceo Santo Canto di Ringraziamento nel terzo tempo del Quartetto n. 15 in la min. (a proposito del quale non ci stancheremo mai di raccomandare agli interpreti di rifuggire da ogni enfasi, di evitare il tono stentoreo da elogio funebre uniformemente sostenuto per tutto il brano) oppure, apparentemente istupidite, verrebbe da dire intontite, inghirlandate da ebbri trilli interminabili, le melodie lasciano la scena a una nuova stagione di quell’antico, supremo magistero musicale che è il contrappunto, riprendendo il discorso là dove Bach si arrestò con l’incompiuta fuga tripla dell’Arte della fuga, discorso arcaico e anacronistico – dunque disallineato rispetto all’epoca – espresso per l’appunto nelle famose fughe beethoveniane che, è stato detto da più voci (ma non da quella di Stravinskij che definì la Grande fuga “musica contemporanea che rimarrà contemporanea per sempre”) e in più luoghi, al tempo di Beethoven come ancora oggi, “egli non era in grado comporre”.
Mozart
Ma se Beethoven è il più prelibato spezzatino della storia della musica, anche agli altri compositori la storiografia musicale, e la percezione degli ascoltatori di generazione in generazione, non riserva trattamento diverso. Tutti hanno offerto un loro testamento musicale, un esempio di Tardo Stile, anche loro malgrado (se non altro perché non da tutti la morte era sospirata come una liberazione, come è stato presumibilmente, invece, il caso di Haydn, Mendelssohn o Chopin). In Mozart, l’esperienza di pre-morte è diventata iconica con lo ieratico, incompiuto Requiem. Un’opera dall’influenza culturale enorme (che altro compone Arvo Pärt se non chiose, più o meno frammentarie e speziate di liturgici esotismi, all’ultimo, incompiuto capolavoro di Mozart?) che ha definitivamente cancellato la vecchia immagine, ancora attuale nel primo Novecento, del Mozart frivolo, galante, salottiero, quello insomma del “rondò alla turca” della Sonata per pianoforte n. 11 o delle arie più salaci delle Nozze di Figaro. Quale il collegamento psicologico tra i due Mozart? Anche qui, se anche non la dichiarino esplicitamente, le storie della musica assumono l’idea che si stia parlando di due persone diverse, o comunque, di due identità enormemente difformi, benché avesse ragione il direttore austriaco Karl Böhm allorché sosteneva che l’Andante della Prima sinfonia, scritta quando Mozart aveva otto anni, è già un cartone del Kyrie con cui il Requiem spalanca le sue porte di inconsolabile dolore: lo stesso incedere singhiozzante, spasmodico, e quella miracolosa capacità di evocare con tratti parchi e accuratissimi una malinconia già psichiatrica.
Per inchiodare il Tardo Stile di Mozart, non bisogna imboccare quel labirinto inestricabile di vero e falso, di gravità e levità che sono le opere destinate alla rappresentazione scenica.
E se amputassimo il Don Giovanni del suo lieto fine convenzionale (un celebre caso di passo falso per via di un “doppio finale”) apposto come se Mozart, al contrario del replicante di Blade Runner, si fosse detto: “ancora non è tempo di morire” o meglio: “ancora non è tempo di aduggiare il pubblico al quale, con una scommessa azzardata, ho affidato il mio sostentamento”, anche in quel “dramma giocoso” l’erma bifronte si trasformerebbe in un’unica maschera tragica. Ma il discorso sul teatro musicale di Mozart richiederebbe di essere separato dalla musica puramente strumentale, e il Tardo Stile più propriamente applicato a questa che non a quello, dove nell’ultima opera, Il Flauto Magico, non tanto i futili enigmi del libretto irto di pacchiane allegorie massoniche, ma quelli ben più drammatici e profondi annidati nella partitura, sono tali che più che di Tardo Stile si dovrebbe parlare di sublime, sconcertante centone, trapunto da un capo all’altro di oratori di Händel e corali di Bach, cosparso dell’energia cinetica della scuola strumentale italiana come delle oasi cantabili di Paisiello, degli artifici della scuola di Mannheim e delle formule di Haydn, senza dimenticare gli omaggi a se stesso con autocitazioni quasi letterali; irripetibile esperimento del resto favorito dal genere del Singspiel, ma da nessuno prima di Mozart così smaccatamente conseguito. Tirando le somme: per inchiodare il Tardo Stile di Mozart, non bisogna imboccare quel labirinto inestricabile di vero e falso, di gravità e levità, di taverna e circolo esoterico, di proprio e altrui che sono le opere destinate alla rappresentazione scenica. Se non per altro, per questo solo critici e interpreti dovrebbero essergli grati di averci lasciato quel monumento grezzo di Tardo Stile che è la Messa di Requiem che, di là dai valori musicali, fa piazza pulita di confusione, ambiguità e fraintendimenti che sospettiamo avessero nauseato lo stesso genio salisburghese.
Chopin
Tuttavia è in altri compositori, meno platealmente divisi e divisibili in periodi primi, centrali e ultimi, che il Tardo Stile rivela i suoi segreti più riposti, le tracce psichiche più sottili. Chopin, ad esempio, un uomo la cui breve esistenza sembra tutta avvolta in un dignitoso atteggiamento di condoglianze. Quanto di più incongruo immaginare da lui il congedarsi dalla vita con le scosse telluriche di un Requiem, e per giunta incompiuto (per disdegno o per mancanza di tempo, la questione tra gli studiosi di Mozart è ancora aperta). Le ultime opere di quel gentile misantropo sono, invece, due mazurche: la op. 68 n. 4 in fa min. e la op. 67 n. 2 in sol min., composte nella sua ultima estate, dunque di tre anni posteriori all’ultima composizione pubblicata in vita, la sonata per violoncello e pianoforte in sol min. Vediamole più da vicino, queste due incantevoli gemme, lacrime di un pianto “come una pioggia silenziosa”, o “briciole di sogni”, come scrive in un suo racconto davvero chopiniano Sait Faik. In primo luogo sono scritte in modo minore, requisito che sembra quasi tassativo per tutte le opere del Tardo Stile, le quali, in questo caso, sono anche postume (vennero pubblicate sei anni dopo la morte di Chopin, nel 1855). Il fatto che il Tardo Stile parli di frequente il modo minore – e anche in questo, Beethoven, che adoperò gloriosamente il Sib maggiore, fa scuola a sé – è un segnavia che può essere disorientante, soprattutto considerando che Chopin sembra aver conquistato con sbalorditiva precocità lo stampo che renderà tutte le mazurche riconoscibilmente, inconfondibilmente sue, con l’unico avvertimento che le prime, e nemmeno tutte, sono più radicate, non solo nei ritmi e nei temi, ma nella concezione stessa, nelle danze tradizionali e contadine polacche in tempo ternario (e non solo polacche: la peculiare asimmetria, quell’accentuazione variabile delle note nella stessa battuta proprio alle mazurche, è anche slava, bulgara, romena); una radice che presto Chopin troverà limitativa e della quale si libererà, sull’esempio di Bach che aveva stilizzato e purificato la suite di danze barocca, non svellendola, ma per così dire sfibrandola, disseccandola in tempi certo ancora futuristicamente ballettistici, ma non più confortevolmente ballabili.
Chopin tremò nell’imminenza della morte, lasciando pagine tremule, in cui solo l’energia mentale e il gusto più fine, come candele inestinguibili, sovrastano lo sconquasso fisico.
Così, nella mazurca op. 7 n. 2 in la min., se non sapessimo che fu scritta a vent’anni, coagulando da stesure ancora precedenti, si attestano la stessa rarefazione espressiva, la perlacea contestura di melodia e accompagnamento che, quasi lasciate al loro destino di rassegnata modestia e inappuntabile discrezione – genuina incarnazione musicale del momento mortale –, segnano le ultime due mazurche. In altre parole, in Chopin più che in ogni altro compositore il sostegno della notizia biografica è indispensabile a discernere il Tardo Stile, perché, salvo eccezioni troppo clamorose per essere significative, davvero il compositore polacco fu indugiante sulla soglia per tutta la sua breve esistenza. E tuttavia, confortati dal dato biografico, ecco che le ultime due mazurche, rispetto alle molte altre scritte nel modo minore, si stagliano con peculiare rilevanza. Qual è, oltre al fatto di essere scritte in minore, il segno distintivo del loro rappresentare l’estremo congedo? Dove si rinviene il gelo, il tremito in tutte le membra, l’affanno che impediva a Chopin, nell’ultimo anno della sua vita, di alzarsi dal letto, se non eccezionalmente, squassato dalla tosse, per manifestarsi come un ectoplasma tra il pubblico dell’Opéra dove cantava l’amica mezzosoprano Pauline Viardot? Due sono le risposte possibili, una accettabile ma nemmeno del tutto sincera, l’altra più veritiera ma deludente, se non futile. La prima: la frammentarietà. Anche se non sapessimo che l’op 68 n. 4 così come l’ascoltiamo è la decifrazione di appunti difficilmente leggibili e il collegamento di melodie forse non destinate al congiungimento – opera dell’amico Auguste Franchomme, che inviò il materiale alla sorella del compositore –, la friabilità intrinseca, la volatilità eterea del pezzo ci risulterebbe comunque evidente. Qui tutto: temi, modulazioni, ornamenti, dinamiche, è fugace come un ricordo agro o come immagine balenante su acque sconvolte. Infallibile apparenza. Questa è musica rammemorata, non passibile di attenzione e di essere fissata in esecuzione, è improvvisazione di un’improvvisazione, musica che aspirerebbe a distruggersi, come il convenzionale messaggio segreto, subito dopo l’ascolto. Ma la seconda risposta possibile cancella paradossalmente tutto quanto abbiamo appena sostenuto: essendo la frammentarietà fortemente sospetta di rivelarsi mera incrostazione ermeneutica ex post, l’unica prova attendibile del Tardo Stile di Chopin sta nella notizia biografica, e dunque, musicalmente stricto sensu, non esiste alcun Tardo Stile di Chopin, il che equivale a sostenere che egli sempre (e non occorre scomodare la celeberrima marcia funebre dalla Sonata n. 2 per pianoforte, scritta non ancora trentenne) è compositore del Tardo Stile: per lui non è mai esistito altro, non è mai esistito il tempo. Il fluire del tempo del mondo, in Chopin, è integralmente sostituito da quello musicale, che a sua volta prende in prestito qualcosa dell’arbitrio, delle sospensioni, del rubato dell’esperienza del tempo nella vita. Appurato questo, se il suo Tardo Stile non pervenne mai alle quote visionarie di Beethoven, non si può fargliene una colpa.
Nel fantasmatico teatro di apparizioni che la sua musica evoca, un turbamento come quello degli ultimi quartetti per archi di Beethoven sarebbe stato non imboccare il ripido sentiero del Tardo Stile, ma quello vertiginosamente discendente della follia. Chopin tremò nell’imminenza della morte, lasciando pagine per l’appunto tremule, in cui solo l’energia mentale e il gusto più fine, come candele inestinguibili, sovrastano lo sconquasso fisico, gli occhi brucianti come torce dalla tisi; Beethoven imboccò un’audace e solitaria fuga dal mondo, trovando lungo la via che imbruniva, intatte, forze che nessuno prima di lui aveva scoperto. Ma se Chopin, a differenza di Beethoven o di Liszt, con le sue ultime opere non ha disarticolato le forme, anzi le ha delicatamente rispettate e onorate, ciò non toglie che di questi piccoli, agili vascelli, sui quali aveva navigato per tutta la vita, si servì in ultimo gettando in mare ogni accattivante convenzione, ogni abbagliante consuetudine – eppure insensibilmente conservando ciò che di vivo c’è nella convenzione e nella consuetudine come cristallizzazioni di una maestria –, lasciandoli migrare leggerissimi nel post mortem quali modelli ideali.
Schumann e Liszt
Una continuità, mai indagata per quel che so, lega il Tardo Stile di Schumann e Liszt alle loro prime opere. Che essi abbiano un Tardo Stile ben delineato, non c’è dubbio; nel caso di Liszt, almeno dall’ultimo quarto del secolo scorso i più importanti pianisti – Maurizio Pollini, Alfred Brendel su tutti, ma in misura minore anche Sviatoslav Richter – si sono cimentati in pagine come Nuages gris, La lugubre gondola (nelle due versioni per pianoforte), Unstern!. Sono pezzi brevi, che fecero dire a Arnold Schönberg che il suo autore non era un compositore, ma un profeta. Come sempre, l’intelligenza adamantina dell’inventore della dodecafonia colse un aspetto ineludibile del Tardo Stile: è profetico. Verrà suonato non anni, ma decenni dopo la morte del compositore, e questo semplice fatto eleverà l’autore al rango di profeta. Il Liszt precedente, quello virtuoso, atletico, quello che secondo Glenn Gould “non capiva nulla del pianoforte” perché incapace di comporre equilibrando i registri gravi e quelli acuti, perfino quello “di mezzo” della Sonata in si min. (che, per ragioni che pochi hanno compreso, si trova spesso attratta ai pezzi del Tardo Stile, quasi quest’ultimi ne fossero le macchie solari) viene così nettamente separato, forse ancor più recisamente di come si fa con Beethoven, da questi ultimi pezzi di pochi minuti che si somigliano per tetraggine, scrittura scarna, e perfino per programma poetico: lamento, meditazione della morte statica e paludosa, in qualche caso agitazione inquieta, di nuovo rassegnato insabbiarsi. Musica “a programma” dunque, proprio come quella, pianistica o orchestrale, che Liszt componeva quando, nel fiore dell’età, furoreggiava nei salotti europei o alla corte del granducato di Weimar.
Mistico astrattismo e tranquilla ingenuità rasentante la follia, nel Tardo Stile romantico di Schumann e Liszt, si toccano.
La differenza sta nel fatto che, a un certo punto, intorno agli anni della morte di suo genero, Richard Wagner, nel 1883, il programma non sarà più Faust, Margherita o Mefistofele, i giochi d’acqua a Villa d’Este, i sonetti del Petrarca, i paesaggi italiani o svizzeri; ma, proprio come avverrà per l’altro grande compositore di musica a programma nella storia dell’Occidente, Richard Strauss, la fine concepita come catastrofe. La catastrofe diventa “la storia” da raccontare, ed è proprio il “personaggio della catastrofe” o “lo spettacolo della catastrofe” che riuscirà, come una nuova forza elementare, a estendere la musica fin oltre la soglia dell’astrattismo, che in musica può voler dire atonalità – come nel classico parallelismo tra la pittura di Kandinskij e le composizioni di Schönberg –, ma può anche assumere le sembianze, com’è il caso delle Geistervariationen di Schumann, sua ultima opera scritta poco prima e poco dopo il tentativo di suicidio gettandosi nel Reno semivestito, di un’angelica ingenuità infantile, un’apparente regressione naïf ma scevra di tormenti, leise, tranquillo, come prescrive l’indicazione del tema. Ma mistico astrattismo e tranquilla ingenuità rasentante la follia, nel Tardo Stile romantico di Schumann e Liszt, si toccano. Gli elementi comuni sono vari: chiarezza del dettato, immediatezza, rinuncia di espedienti retorici o sofismi contrappuntistici (al massimo uno svolgimento a canone, tipico del mondo infantile, come nella seconda delle Geistervariationen), la tesi che la vita è un gioco ed è tragica perché anche il gioco più spensierato finisce: altra saggezza non è data. Estetica e filosofia della musica non sono più e non sono ancora di casa, qui. Schumann e Liszt, che le avevano frequentate entrambe, ora ne sono nauseati: significativo punto di contatto con la diffidenza se non il disgusto che Beethoven aveva non solo delle dottrine di Kant o Hegel, ma perfino della filosofia non accademica di Goethe. L’unico scopo del compositore è comunicare all’ascoltatore, nel modo più diretto e disadorno possibile, un messaggio ricevuto dall’aldilà, sia pure l’aldilà interno alla propria coscienza. E sembra che a suonarlo non sia un compositore adulto o addirittura senescente, ma un bambino sconsolato che sa che la sua supplica non sarà mai esaudita e, inavvertito, pesta il pianoforte nella più nera malinconia.
Non è la fine della vita, ma la fine del desiderio, delle credenze diventate illusioni. Chi, come me, ha qualche difficoltà a penetrare il mondo scintillante, scalpitante, bamboleggiante delle opere non tarde di Schumann e Liszt, perché respinto da un soggettivismo troppo capriccioso e arbitrario, irto di troppe Träumereien ricercate in maniche di camicia, per non parlare del vorticoso virtuosismo del Liszt più battagliero, accoglie invece con grande sollievo questo riduzionismo, questo raffreddamento degli ultimi anni. La roccia in ombra del Tardo Stile. È vero, siamo già a pochi passi da Webern e da Beckett, se non fosse che, da specialisti di musica a programma quali furono tanto Schumann che Liszt, ancora in queste loro pronunce estreme ci si preoccupa di intonare un sentimento, uno stato emotivo predominante: il candore preadamitico nel primo, lo sguardo invariabilmente fosco e mesto dello stato depressivo nel secondo. Dopo di loro – e già in parte nelle Metamorphosen di Richard Strauss, e ancora prima in quel capolavoro sbalorditivo che sono gli Undici preludi corali per organo di Johannes Brahms –, il Tardo Stile perde anche questo obbligo caratterizzante e la Stimmung, l’atmosfera, si fa ancora più disincarnata, rarefatta, talché il cuore umano non è più il centro, il protagonista dello spettacolo della fine e della catastrofe. La musica vuole l’aldilà non del singolo, ma del tutto. Lo spettacolo della morte e della dissoluzione diventa un destino cosmico, e nel suo svolgimento aprirà le porte della spengleriana “seconda religiosità”, oggi dilagante, per cui tutti, usciti dall’adolescenza, anagrafica o prolungata, prendono coscienza di una verità terribile, insopportabile, che rende futili anche le loro emozioni spontanee e naturali, per non parlare delle loro deduzioni razionali, e meditano, pregano, vanno in terapia, parteggiano più o meno brutalmente per la (ennesima) rivoluzione psichedelica che li disciolga dalle catene dell’Io. Se dunque c’è un insegnamento, anche nell’accezione religiosa della parola, che si può trarre dall’ascolto delle composizioni che ho nominato (e altre che ho omesso o dimenticato di citare) è che il Tardo Stile è un concetto, per dir così, teologico e che, al di fuori di un’escatologia (e dunque di un’antropologia) prettamente occidentale sarebbe difficilmente non dico comprensibile, ma possibile. Oggi che quell’escatologia si è inaridita, restano i reperti, gli ossami di un appressarsi alla fine che ancora riconosciamo come parti dell’uomo, ma che contraddittoriamente chiedono all’uomo di essere qualcosa di diverso, di alieno, di etereo. Come se la realtà, una qualche realtà tra le infinite, potesse non essere infelice.