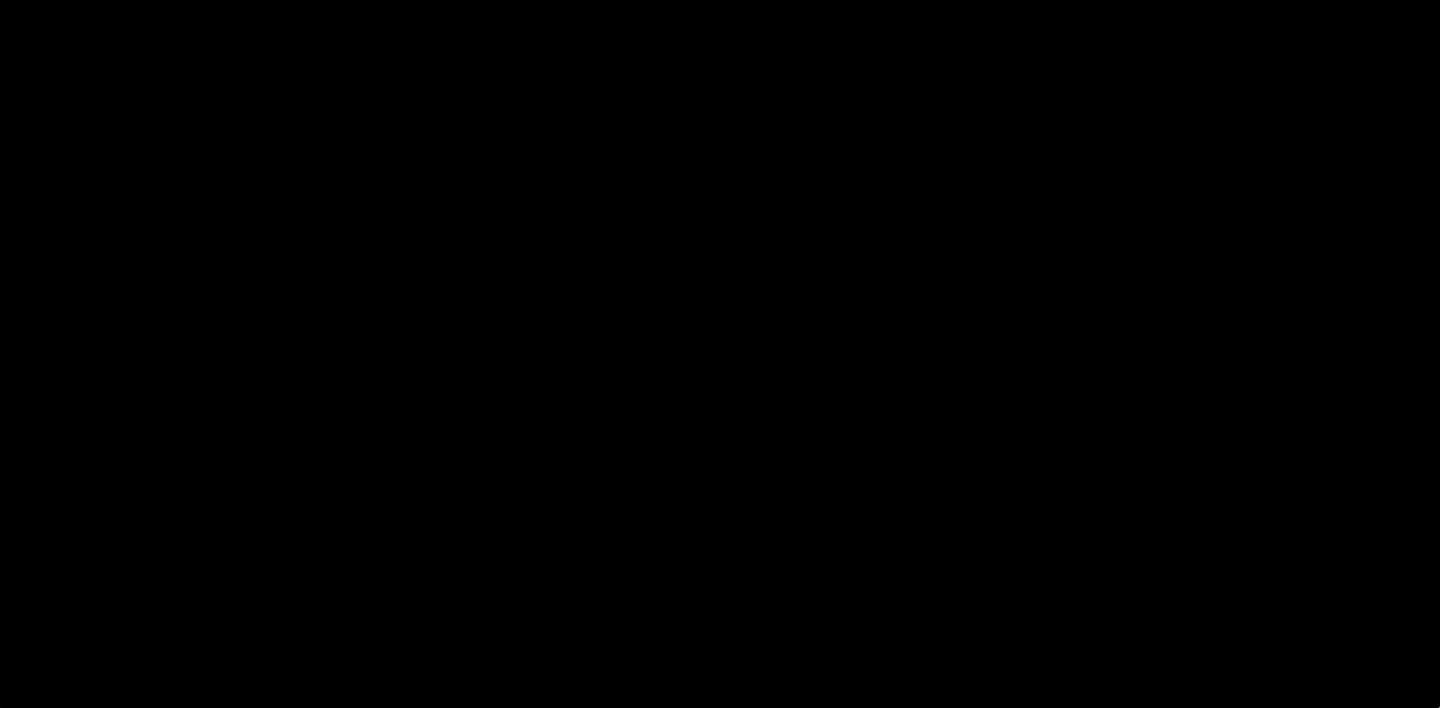
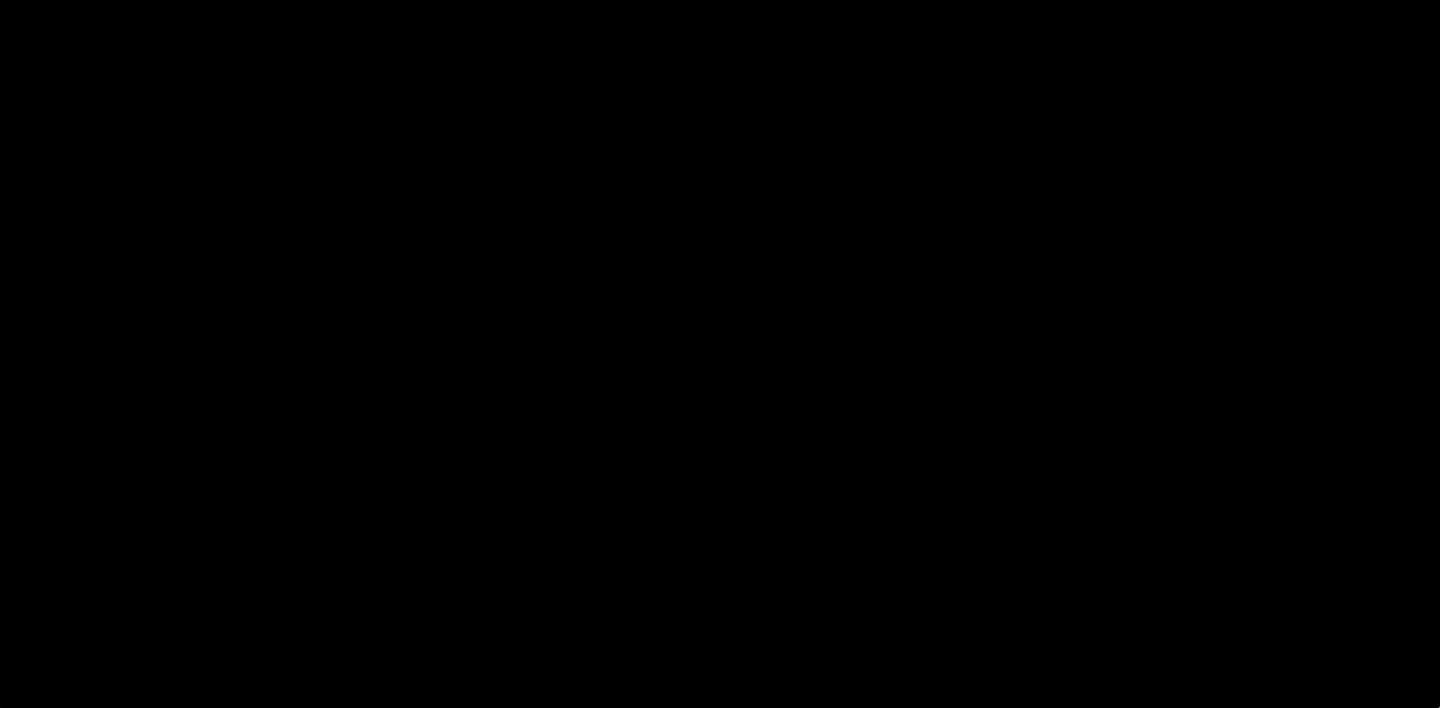
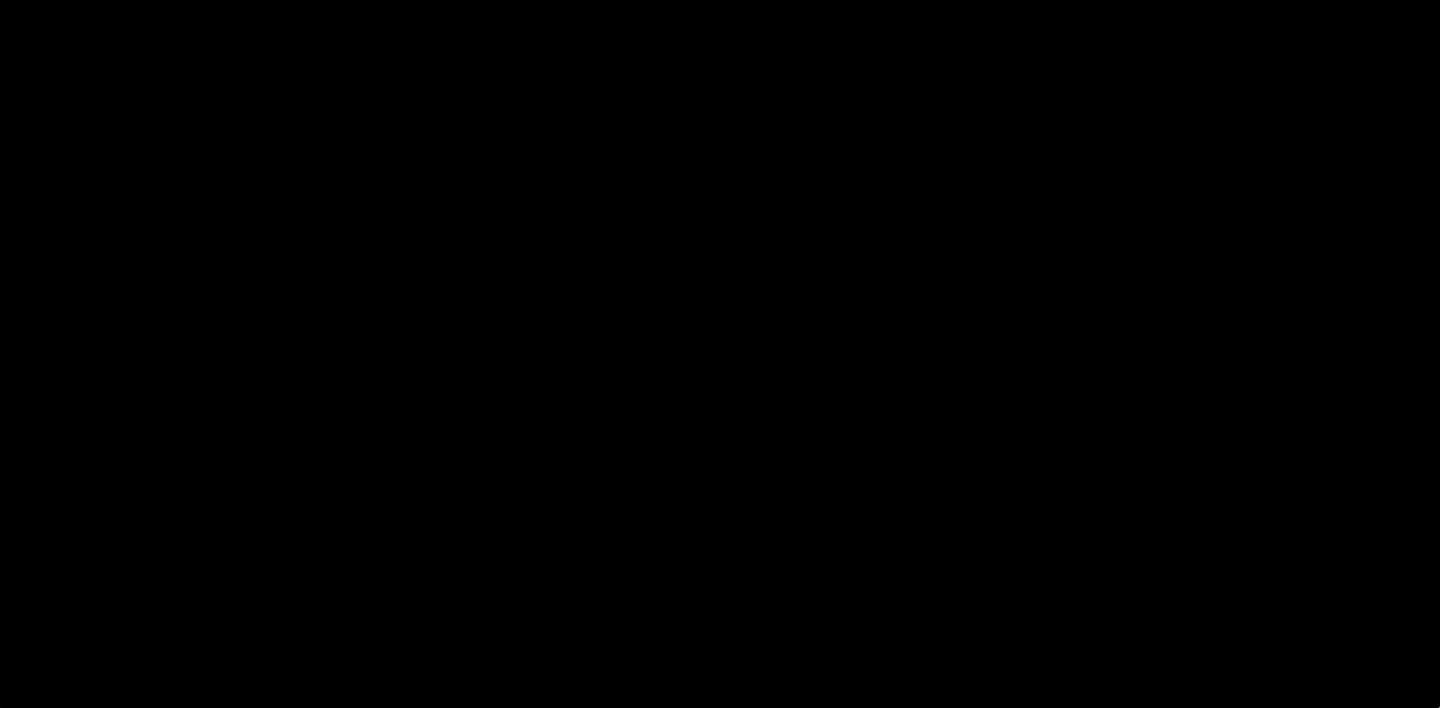
Q uindici anni fa per un reportage di viaggio commissionato da una rivista mainstream, mi ritrovai insieme a un amico a Tijuana. La tappa precedente era stata San Diego. Arrivare a Tijuana da San Diego esaudiva esattamente le nostre aspettative in fatto di “vita vera”, “decadenza” e “pericolo”. A Tijuana tirai fuori la macchina fotografica per ritrarre delle prostitute giovanissime, palesemente minorenni, ragazzine, che adescavano clienti in strada sotto lo sguardo connivente della polizia, nonché il nostro, ossia quello dei turisti. Nel mio ruolo improvvisato di fotoreporter mi sentivo particolarmente audace perché avremmo potuto consegnare alla rivista non solo le immagini dell’on the road per gli Stati Uniti, ma anche quello spaccato di neorealismo messicano. Le cose andarono diversamente. Nel giro di qualche minuto, fui avvicinata da un poliziotto che mi sequestrò la macchina fotografica. A dirla tutta, cominciò anche a insinuare che avessimo dietro della droga (non avevamo niente), poi l’insinuazione divenne un’accusa e il messaggio esplicito. Finimmo per dargli dei soldi (mi sembra cento dollari), e ci lasciò stare, ma mi costrinse a cancellare le foto che avevo fatto alle prostitute. Fu uno strano momento quello in cui io e un uomo in divisa guardavamo insieme sullo schermo di una macchina digitale i corpi fotografati di quelle ragazzine seminude per poi eliminarne l’esistenza.
Benché fosse un palese atto di corruzione da parte della polizia messicana, oggi devo dire che sono felice di aver cancellato le foto. Che stavo cercando di fare? Ritrarre quelle ragazze non faceva parte di alcun lavoro di denuncia o inchiesta (e anche in quel caso: sarei stata legittimata a farlo?), corrispondeva piuttosto al desiderio narcisista di avere delle immagini “forti”, e in un certo senso “più esotiche” da consegnare a un giornale. Non mi ero minimamente posta né il problema di avere il consenso da parte dei soggetti fotografati, né mi ero fatta domande su quale fosse in quel momento il mio “sguardo” su quei corpi. In effetti non mi ero proprio fatta domande in generale.
Nel suo celebre saggio Davanti al dolore degli altri, Susan Sontag scrive:
Attraverso la voce della Magnum, la fotografia si dichiarava un’impresa a carattere globale. La nazionalità del fotografo e quella della testata a cui era affiliato erano, in linea di principio, irrilevanti. Il fotografo poteva avere qualunque origine. E la zona di sua competenza era il “mondo”.
Ovviamente non mi sentivo una fotografa della Magnum, ma era chiaro che il mio immaginario rispetto al reportage fotografico fosse costituito da quel tipo di narrazione. È interessante, d’altro canto, notare come il saggio di Sontag, che si propone, in un certo senso, di decolonizzare questa idea di racconto e sia un saggio relativamente recente (2003), finisca per avere come riferimenti iconografici – sia in positivo che in negativo – quasi esclusivamente fotografi che afferiscono a quell’immaginario. In un’altra parte del libro Sontag scrive:
Percepire la vitalità dell’iconografia cristiana in alcune fotografie che documentano guerre e disastri non è una proiezione sentimentale. Sarebbe difficile non individuare gli stilemi della pietà nella foto scattata da W. Eugene Smith a Minamata in cui è ritratta una donna nell’atto di cullare la figlia cieca, sorda e deforme.
E poco più avanti dirà:
Tuttavia la percezione di tali analogie – che conferiscono aura e bellezza – è forse destinata ad affievolirsi.
La perdita di questa percezione – per Sontag che cita uno studio della storica tedesca Barbara Duden – sembra derivare più da un processo di secolarizzazione che da un’esplicita volontà di non ricorrere a quell’iconografia.
Eppure se pensiamo alla foto di Samuel Aranda che ha vinto l’edizione 2012 del World Press Photo ritroviamo un affresco della pietà mediato dalla raffigurazione di Michelangelo. Nelle prime pagine del suo saggio Contro l’impegno, Walter Siti scrive: “Un Prigione di Michelangelo può essere gradevole alla vista quanto uno splendido copricapo di piume dei nativi americani: ma ha dentro più cose, più tecnica, più filosofia, più coerenza, più cultura sedimentata”. A che serve un paragone del genere? Perché mai una statua dovrebbe essere paragonata a un copricapo? E le “cose” in più che il Prigione di Michelangelo ha dentro, chi ce l’ha messe? Non sono forse date dai codici di chi oggi guarda quella statua?
Nel suo saggio Decolonising The Camera: Photography in Racial Time, Mark Sealy fa giustamente notare che per decolonizzare lo sguardo non basterà ampliare lo spettro di chi fotografa, ma anche di chi interpreta: studiosi, accademici. Un critico d’arte del Mali avrà riferimenti culturali, religiosi ed estetici diversi da uno statunitense, e quindi troverà “dentro” le opere “altre cose”, un diverso tipo di “cultura sedimentata”.
Nei diversi saggi che compongono Contro l’impegno, Siti rivendica una complessità della letteratura contro una letteratura ridotta a didascalismo e pedagogia. Nel secondo capitolo, Siti accusa Saviano di aver messo la letteratura a servizio delle fotografie nel libro In mare non esistono taxi, edito da Contrasto, relegandola a un ruolo ancillare. “Il ragionamento di Saviano” spiega Siti, “si basa su un postulato tanto diffuso quanto indimostrabile: che l’immagine sia più efficace delle parole, che ‘prenda più allo stomaco’”. Per sfatare questo postulato indimostrabile, Siti mette a confronto una foto “iconica”, riprodotta da Saviano, di un bambino “africano rannicchiato e morente mentre un avvoltoio sta sinistramente aspettando che il cadavere sia disponibile” con un breve racconto di Parise in Sillabario n.2, dove c’è un “altro bambino africano accoccolato e intento ad arrostire, con fatica, un topo che poi mangerà”. Nel racconto, ci dice Siti, c’è un momento “in cui passa uno sguardo di reciproca vergogna tra il bambino e il reporter, e per tenere fede a quella vergogna Parise lima il suo stile fino a una sobrietà nitida e disumana”. La conclusione è che: “non c’è immagine al mondo che possa valere questa meditazione sul mestiere”. Be’, mi verrebbe da obiettare, ci sono un mucchio di immagini che valgono quella meditazione sul mestiere, se solo non si affidasse alla fotografia il ruolo di dover appunto “prendere allo stomaco”, di essere di per sé un mezzo più “potente” perché in fondo “più semplice” e “più immediato”, incapace della polisemia letteraria tanto cara a Siti. Quello di cui Siti accusa la letteratura del neo-impegno rispetto a una letteratura più complessa è la stessa accusa che si può rivolgere a tanta fotografia pensata per trasmettere un messaggio, con l’aggravante che spesso questo messaggio viene trasmesso da fotografi appartenenti a mondi privilegiati chiamati a raccontare il tormento dei vari “bambini africani” rannicchiati, accoccolati e denutriti che se la vedono con avvoltoi o topi.
In una breve analisi di Broomberg & Chanarin del 2008 sulle immagini che partecipano al World Press Photo, i due artisti passano in rassegna una serie di cliché legati alla rappresentazione tipica del fotogiornalismo, dove a parte le pietà michelangiolesche si possono ritrovare: donne partorienti, bambini che giocano con pistole giocattolo, aghi infilati nelle braccia di tossici, riflessi nelle pozzanghere, ragazzini palestinesi che tirano pietre, ecc.
Come cambierebbe questo repertorio e come cambierebbero i soggetti fotografati se si ampliasse sempre di più la provenienza e il background – quindi le intenzioni e la consapevolezza – sia di chi fotografa che di commissiona o seleziona quelle immagini?
Ho provato a ragionare su queste questioni con alcune personalità che da anni si occupano di linguaggio fotografico.
Johanne Affricot: culture curator e direttrice artistica di GRIOT
Renata Ferri: giornalista e photo editor di Io Donna
Elisa Medde: editor in chief di Foam magazine
Chiara Nonino: photo editor di Vogue Italia
Giulia Ticozzi: fotografa e photo editor freelance
[N.d.A. Ho preferito lasciare ogni definizione legata all’appartenenza etnica così come mi è stata proposta dalle intervistate. Uniformare richiede una norma redazionale e grammaticale che è di per sé problematica].
LA CADUTA DEGLI DEI: IL MITO ROMANTICO DEL FOTOREPORTER
Ferri: Il colonialismo fotografico è stato una pratica molto forte anche nei grandi maestri, prendi Eugene Smith. L’idea di andare in un’altra cultura e trarne delle sintesi sociologiche e antropologiche oggi è messa in discussione. Le nuove generazioni di fotografi sono anche più colte e consapevoli di un tempo. Non hanno più bisogno dell’aura che ha circondato la figura del fotoreporter fino agli anni ’80 e ’90, dove c’era sempre una certa smania di azione: “andare, fare, andare, fare, vedere”, un senso di avventura. La sfida non è più così “muscolare” se per arrivare in un posto ti basta prendere un low cost e vedere come va. E spesso non è più l’azione in sé che ti interessa. È decaduto quello che è stato un pilastro, nonché “l’incipit” di ogni lavoro di reportage. Mi ricordo che da un certo punto in poi, negli anni ’90, ricevevo telefonate dai fotografi, arrivati sul posto, che erano frustrati perché “non stava succedendo niente”. L’assenza di azione. Ma oggi è questo a essere interessante, se prima il vuoto sembrava pericoloso, adesso è visto come un terreno fertile, il “vuoto” ti permette di entrare in un luogo e conoscerlo, esplorarlo piano, assumerti la responsabilità del racconto.
Ticozzi: Il racconto della fotografia di guerra corrisponde a un codice di per sé militaresco, era una richiesta da parte del mercato avere quel tipo di immagini, come se il fotografo stesso fosse una specie di soldato. Il modello era maschile, muscolare, quello di uomo in prima linea. Non è un caso che siano poche le fotografe di guerra. C’è anche da dire che il lavoro del fotoreporter classico è molto più collettivo di quello che si tende a credere. Il fotografo torna con la sua sfilza di immagini e c’è qualcuno, anzi nella maggior parte dei casi qualcuna, che trova un ordine al caos. Non so perché ci siano così tante photo editor donne, mi viene in mente un rapporto del genere: il fotografo è quello che torna con il cervo scuoiato, e la photo editor quella che glielo pulisce e glielo incarta.
Medde: La figura del giornalista d’assalto che va tre mesi in Africa a fotografare i bambini per le ONG e o a fare reportage per smuovere le coscienze dei bianchi sta finalmente tramontando in molti ambienti. Oggi sappiamo anche che quell’idea eroica di fotoreporter poteva essere una “costruzione”. Pensa a Robert Capa. Il suo vero nome era Endre Ernö Friedmann. È stata la sua compagna, Gerda Taro, anche lei fotografa, a inventare un nome e un’identità fittizia funzionale alla carriera di Capa. Un nome che fosse immediatamente riconoscibile, con una pronuncia facile per una rivista come Life. In fondo era un caso di subalternità nei confronti della cultura americana, e ancora oggi dobbiamo vedercela con questa subalternità.
NON SOLO IL COME, MA IL CHI. FOTOGIORNALISMO E ARTE
Ferri: Se ragioniamo come venti, trent’anni fa, “una bella storia fotografica” non basta più. Io oggi voglio sapere come, chi l’ha realizzata, quali erano le intenzioni, qual è il grado di consapevolezza con cui si è avvicinato al racconto. Il produttore diventa importante quanto il manufatto.
Medde: Nell’ambito del fotogiornalismo che diventa artistico, questo discorso si unisce a come viene percepito all’interno delle istituzioni museali. Chi è che beneficia di una determinata storia? La persona da cui quella storia viene, la sua comunità o un pubblico di fruitori costituto da bianchi occidentali?
Ferri: Molto fotogiornalismo degli anni ’80 e ’90 è oggetto di rivisitazione dal punto di vista artistico. Mi sembra ci sia una necessità di rileggere “la fotografia del reale” in una prospettiva più artistica, o anche un fermarsi a riflettere su ciò che si è fatto nella propria carriera, come dire: hai visto l’orrore e ora provi farne una rilettura diversa. Se la strada era il teatro dove mettere in scena la rappresentazione – e ci sono voluti anni per chiamarla rappresentazione e non testimonianza – è pur vero che certe immagini avevano un valore di documentazione che perde forza in un tipo di “istituzionalizzazione” diversa. A volte mi sembra una forzatura: non sempre la “decontestualizzazione” a uso museale funziona, altre volte è interessante, penso alla rivisitazione che si sta facendo dell’opera di autrici come Letizia Battaglia o Lisetta Carmi. Si (ri)costruiscono percorsi e periodi storici, si valorizza un approccio, si scava e si traduce nell’immaginario della memoria.
IDENTITY POLITICS: AUTO-NARRAZIONE E DECOLONIZZAZIONE DELLO SGUARDO
Medde: Oggi è molto più evidente il carattere politico delle nostre scelte, ci sono comunità demografiche che hanno accesso per la prima volta a certi discorsi. Stiamo capendo che non possiamo parlare di tutto solo perché abbiamo il talento per farlo, o comunque stiamo capendo che non sempre sia la scelta migliore. Io cerco di adattare la mia professionalità e di tirarmi indietro se sento di non avere l’autorità morale e intellettuale rispetto a qualcosa. Nessuno ne è esente, i sistemi in cui siamo cresciuti hanno a che fare sempre con un privilegio, in una dialettica tra dominanza e subalternità, ma se non cominciamo a rendercene conto sarà impossibile fare una diagnosi onesta. È stato anche il limite del femminismo quando non ha fatto i conti con l’intersezionalità.
Ferri: Per me uno spartiacque nella rappresentazione, ad esempio, della comunità afroamericana è stato il lavoro di Gordon Parks. Parks si è inserito all’interno di una famiglia e ne ha raccontato la storia con un’empatia che non sarebbe mai stata possibile da parte di una persona fuori della comunità. Se devo pensare a un lavoro più artistico, più visuale, trovo bellissimo quello che ha fatto Carrie Mae Weems con Kitchen Table.
Affricot: Se nasci in un contesto che ti ha sempre nutrito con un solo colore, con un pensiero che diventa sistema, è molto difficile decolonizzare lo sguardo. Non è solo un discorso di colonizzatore/colonizzatrice e colonizzato/colonizzata, di Occidente ed ex-colonie, di padrone/padrona e subalterno/subalterna. È un discorso lungo e complesso legato al locus sociale – e di privilegio quindi – di certi gruppi rispetto ad altri, come scrive la filosofa brasiliana Djamila Ribeiro. Le arti visive, audiovisive e performative rappresentano lo strumento più potente per attuare un processo di “decolonizzazione” dello sguardo. Ma non è semplice perché anche quando offri il tuo spazio, bianco, con tutte le migliori intenzioni, quello spazio non è neutro, è radicato in un pensiero-sistema.
C’È IL RISCHIO CHE UNA COMUNITÀ FINISCA PER RACCONTARE SEMPRE SE STESSA? COME TORNARE A PARLARE DELLO “STILE”?
Nonino: L’insularismo può essere un rischio, ma siamo talmente tanto lontani da una reale uguaglianza nella rappresentazione, che ora mi sembra un falso problema. Raccontava in un’intervista Campbell Addy – uno che ha fondato la Nii Agency e ha ampliato lo spettro di diversity nelle immagini stock di Getty – di aver ricevuto mail in cui gli si chiedeva se fosse in grado di fotografare anche modelle bianche. Il progetto Black nonsense, di Tyler Mitchell e Jeremy O. Harris, ispirato ai dadaisti, va in questa direzione: si vuole rivendicare il fatto di essere artisti e artiste black senza per forza un intento pedagogico o da attivisti. Che poi è un problema che abbiamo ancora nella questione di genere, se sei una donna la tua arte non è mai arte e basta, ma deve essere etichettata come femminista per legittimarsi.
Affricot: Cosa intendiamo per comunità? A chi ci riferiamo quando parliamo di “una comunità”? Se procediamo per categorizzazioni, la comunità bianca ha sempre raccontato se stessa e il resto, definendo e imponendo una norma, ma mai definendosi come una comunità.
Negli ultimi anni in Africa e nella diaspora africana sono sorte tantissime pubblicazioni, indipendenti e non, di cui abbiamo parlato su GRIOT: “The New Black Vanguard. Photography Between Art and Fashion”, “Supreme Models. Iconic Black Women who Revolutionized Fashion”, e “Ìrìn Jourmal”, per citarne alcune. Protagonista è il soggetto Nero, che però troviamo anche dietro la lente e nel ruolo di curatela. Ecco, è qui forse che per la norma si crea un cortocircuito, che si inizia a parlare di “rischio” e “comunità”, perché il soggetto subalterno diventa attivo e occupa uno spazio che fino a poco tempo prima era stato occupato dalla norma, che non aveva mai interrogato la sua posizione.
Torniamo allo spinoso discorso di cui sopra, legato alla decolonizzazione, al locus sociale, allo spazio non neutro: Chi definisce chi e cosa? Chi detta i tempi, i processi, i contenuti, la qualità, lo stile?
Medde: Esiste un problema di committenza. Se la carriera di una persona che fotografa ghetti viene consolidata attraverso la stampa “bianca”, i photo editor continueranno a commissionarle i ghetti, finché non arriverà qualcuno che le chiederà: “Scusa, ma in realtà tu che vorresti fotografare?”, o finché la persona in questione si rifiuterà di farlo.
Ticozzi: Ora il World Press Photo insiste molto su programmi legati all’inclusione e la diversity. Ma rimane comunque un’istituzione di una capitale occidentale. Io credo che questo immaginario si stia esaurendo e non saremo più noi a dover rispondere a queste domande. Per me la questione dello stile e di un determinato sguardo resta importante, per cui apprezzo una come Dana Lixenberg, olandese, bianchissima, che fa un lavoro lungo e complesso sulla periferia di Los Angeles, ma il punto è proprio ampliare la possibilità di questo sguardo “esterno”, così come di un lavoro personale sul linguaggio fotografico, affinché lo stile non diventi sinonimo di privilegio.
COSA NON SI PUÒ PIÙ FARE
Medde: Parlando della mia esperienza, io sono sarda, fino agli anni ’80, ‘90 sembrava ancora simpatico chiamarmi “sardignola”, che è un termine offensivo perché è il nome di un asino. Oggi uno se lo sogna di chiamarmi così – ed è nulla rispetto a quanto devono sopportare le persone Nere in Italia, insulti mascherati da un presunto diritto di satira e di parola. Che gli italiani Neri esigano lo stesso rispetto riservato a un bianco non è una posizione bigotta o estremista: è il minimo indispensabile. C’è una grande confusione su cosa sia l’estremismo. Secondo me bisognerebbe partire da una definizione condivisa di cancel culture, che è solo un presunto movimento censorio nato all’interno della destra anglosassone, come contrasto alla crescente attività e richiesta di responsabilizzazione. Se ci fosse la garanzia di un dibattito serio, di conseguenze, non ci sarebbero nemmeno le shit storm su internet. Se però l’unico modo per farmi ascoltare e per spingerti a responsabilizzarti è provare a rovinarti la carriera, be’, allora potrei farlo.
Ticozzi: Mi vengono in mente due esempi recentissimi: il primo è la cover di L’espresso, dove è finita una coppia di ragazzi bianchi in quella che doveva essere la storia di copertina sulle manifestazioni italiane per Black Lives Matter. Il direttore si è giustamente scusato, non si era reso conto. È stato un terribile autogol dato non dalla malafede, ma da una mancanza di riflessione. Il secondo esempio è il libro London del fotografo Butturini, ripubblicato da Martin Parr. Butturini era un fotografo degli anni ‘70, anche molto politicizzato, ma in quel libro c’era una doppia pagina con una foto di una donna nera dietro il gabbiotto della metro dove si vendono i biglietti e accanto la foto di una scimmia in gabbia. È stata una Mercedes Baptiste Halliday, una ragazza universitaria nera, a far notare la cosa accusando Parr di razzismo e analfabetismo visivo. Le copie del libro sono state ritirate e Parr si è dovuto dimettere da direttore del Bristol Photo Festival.
Che fare in questi casi? Ovviamente non si possono distruggere le opere del passato, ma forse sarebbe bastata una ricontestualizzazione, prendersi quel momento in più di riflessione su quelle due immagini ravvicinate.
Nonino: Considerando che ormai qualsiasi cosa tu pubblichi o pubblicizzi è potenzialmente accessibile globalmente, non ci si può più permettere di non conoscere la storia iconografica delle altre culture – a maggior ragione se con quelle culture ci vuoi lavorare. Ad esempio non ci si può permettere di non sapere cosa rappresenti la blackface, e l’immaginario a cui rimanda, come è successo a numerosi brand del lusso che hanno dovuto imbastire in fretta e furia dipartimenti di “Diversity, Equity and Inclusion” per evitare futuri errori. L’alfabetizzazione visuale interculturale dovrebbe essere prioritaria sin dalle elementari.
ROMPERE GLI AUTOMATISMI
Ticozzi: Quando lavoravo a La Repubblica, a un certo punto ci siamo resi conto che nel momento in cui accadeva qualcosa erano sempre gli stessi a essere chiamati e intervistati, ovvero se si trattava di politica e attualità: uomini, bianchi, non particolarmente giovani. I nostri strumenti, le nostre rubriche, non erano aggiornati. Ci siamo detti: proviamo ad allargare la cerchia dei contatti. Con la fotografia è la stessa cosa: ci vuole uno sforzo di volontà per evitare di appaltare i lavori sempre agli stessi nomi. E in Italia, di sicuro, esistono ancora dei condizionamenti legati al genere. Durante il lockdown, a parte pochissimi esempi di reportage, tutto quello che è vita pubblica è stato fatto da uomini, tutto quello che è più intimo da donne.
Nonino: Il Black Issue del 2008 di Franca Sozzani è stato una pietra miliare nella storia di Vogue, un numero rivoluzionario che ha creato enorme scalpore in America, tanto che Condé Nast Italia ha dovuto ristamparlo al volo per soddisfare la richiesta: una cosa che non succede praticamente mai con un mensile. Era un numero completamente dedicato alla bellezza nera. Non era mai successo prima. Non sono mancate le polemiche, perché comunque il fotografo coinvolto era Steven Meisel, bianco, e perché si temeva che concentrare la questione tutta in un numero significasse rappresentare un’eccezione senza integrare poi la pratica nella normalità. Ma dal 2008 a oggi, nel mondo della moda, le cose sono cambiate drasticamente, il modello aspirazionale di bellezza caucasico, giovanissimo, magrissimo e middle class non è più l’unico riferimento. Lo spiega bene Antwaun Sargent in The New Black Vanguard, un lavoro tra arte e moda che mette insieme un corpus iconografico dove la blackness è rappresentata in maniera altrettanto universale che la whiteness.
CHE COS’È LO STANDARD? NON ESISTE LA NEUTRALITÀ
Ticozzi: Per anni abbiamo usato le immagini di stock per rappresentare determinati concetti: “famiglia”, “lavoro”, “amicizia”, “allegria”, pensando che quell’immaginario fosse neutrale. Qui è ben sintetizzato il dibattito.
Su Getty ora esiste, ad esempio, il filtro “etnico” per scegliere l’immagine che ti serve. Si pensa che in rete siamo liberi di cercare quello che ci pare, ma non è vero. Sono le agenzie che impostano gli standard di immaginario, che cercano una medietà per vendere di più, e questa mediazione è data da multinazionali. Esiste questo lavoro molto interessante di Taryn Simon e Aaron Swarzt, Image Atlas, che fa vedere quanto cambiano le immagini che ti compaiono nei motori di ricerca su un dato argomento a seconda del Paese da cui le cerchi e del suo Pil. Oppure pensa alla gaffe di Orban quando per la sua campagna sulla famiglia tradizionale sceglie un’immagine stock in cui ci sono gli stessi attori del famoso meme del “distracted boyfriend”. È ovvio che quell’immagine non sia più “neutra”.
GIOCARE CON GLI STEREOTIPI PER ROVESCIARLI
Nonino: Naturalmente esiste il “tokenism”, praticare un’inclusività di facciata, solo per spuntare una casella. Così succede spesso che includere la diversità significhi comunque includerla come uno stereotipo. Pensa alla disabilità, è raccontata sempre tra i due estremi: o estrema pietà o estremo eroismo. L’anno scorso Alessia Glaviano ha diretto il progetto “The Gucci Beauty Glitch” in cui il concept era proprio raccontare e normalizzare bellezze diverse. Una dei protagonisti era Ellie Goldstein, modella con la sindrome di Down, che è diventata la star della campagna e ha raccontato la sua esperienza nel mondo della moda alla stampa internazionale. Oppure il progetto “Everyday Africa”, nato nel 2012, al tempo dirompente: se i media, rispetto all’Africa, ti mostravano solo guerra, distruzione e bellissimi animali, questo account Instagram provava a raccontare un continente e un immaginario nella sua quotidianità, con le immagini di chi quella quotidianità la viveva, non del fotogiornalista di passaggio.
Ferri: Alexandra Bell gioca proprio con l’utilizzo dei codici condivisi smascherandone gli automatismi. Il suo è un lavoro estremamente interessante e intelligente di rielaborazione di articoli dove manipola e smonta gli stereotipi usati dai media nel raccontare gli omicidi.
Ticozzi: In Episode 3 del progetto Enjoy Poverty, Renzo Martens parte da questo paradosso: nelle regioni più povere del Congo, la “povertà” esportata è una delle principali ricchezze del Paese. I fotografi ingaggiati dalle ONG per raccontare la povertà in tutta la sua aberrazione (morti, mutilazioni, bambini scheletrici) guadagnano cifre spropositate rispetto ai fotografi locali che invece descrivono i momenti lieti della loro vita: feste, matrimoni… Martens mette in atto un esperimento sociale che naturalmente è anche una provocazione: permettere ai poveri di “sfruttare” la loro più grande ricchezza, cioè la povertà. Utilizzare “gli stereotipi” della loro rappresentazione per fare soldi.
GATEKEEPER. SOCIAL MEDIA E NUOVE PIATTAFORME.
Medde: L’accessibilità ai posti di potere resta l’ultimo blocco. In Italia la situazione è più arretrata rispetto ad altri Paesi. Louis Pisano, che fa dirette su questi temi sui suoi canali social ed Edward Kobina Enniful, come editor in chief a Vogue UK, hanno un peso e un impatto molto diversi pur essendo entrambi necessari. Poi c’è la questione del “diversity hire” che però può trasformarsi in uno strumento ambivalente. Spesso la persona assunta così si ritrova in un ambiente “non safe”, insalubre e tossico, perché comunque connotato da razzismo sistemico. Diventa da una parte la responsabile per tutti i temi più scivolosi e controversi, dall’altra sente una pressione enorme trovandosi nella posizione di non poter sbagliare mai. Non è raro quindi che le persone non accettino quegli incarichi, e decidano di creare delle piattaforme autonome, come è stato nel caso di GRIOT magazine.
Affricot: Per me la creazione di GRIOT nasce da un’esigenza personale, quella di vedere una rappresentazione e una narrazione che erano assenti nel mio mondo, nella mia quotidianità. Ero abituata a non vedermi, se non in forme stereotipate o discriminanti, ridotta a macchietta per dare colore, nei media in particolare. Venendo dal mondo delle agenzie creative o da organizzazioni in cui mi occupavo principalmente della parte culturale, creativa e artistica, ero sempre l’unica, sia dal punto di vista di team progettuale, sia da un punto di vista dei contenuti e persone coinvolte nei progetti, tranne nei casi in cui gli artisti e le artiste venissero dall’estero. A fine del 2014 quindi sapevo già che GRIOT sarebbe diventata la mia principale attività, legata alla mia storia, alla mia vita, e non semplicemente un blog o un magazine.
Ticozzi: Sono cambiati i circuiti e le possibilità di accesso: prima dovevi far vedere fisicamente il tuo portfolio a qualcuno, oggi i photo editor scoprono tanti fotografi e fotografe tramite internet. Ma c’è anche un’altra questione, perché oggi a un ragazzo di seconda generazione di Buccinasco, per dire, dovrebbe interessare pubblicare sui giornali mainstream? Il mondo dell’autorappresentazione autoriale viaggia su altri canali. Il mainstream è vecchio.
Nonino: Negli ultimi cinque anni, sicuramente anche grazie ai social media, i cambiamenti rispetto al potere della rappresentazione e a chi può detenerlo sono avvenuti in modo molto rapido. Restituire le immagini di qualcun altro, raccontarne la storia, sono atti che portano con sé un potere enorme, con tutte le conseguenze del caso. Non solo tutti dovrebbero potersi sentire rappresentati, ma tutti dovrebbero potersi raccontare. E questa è una delle lotte più importanti della nostra generazione.