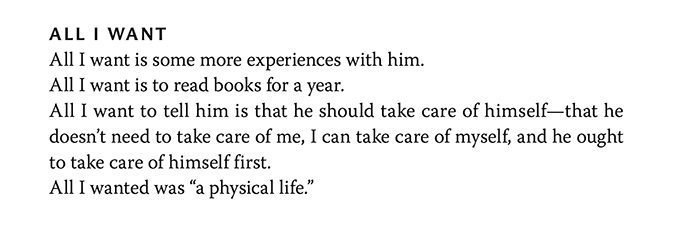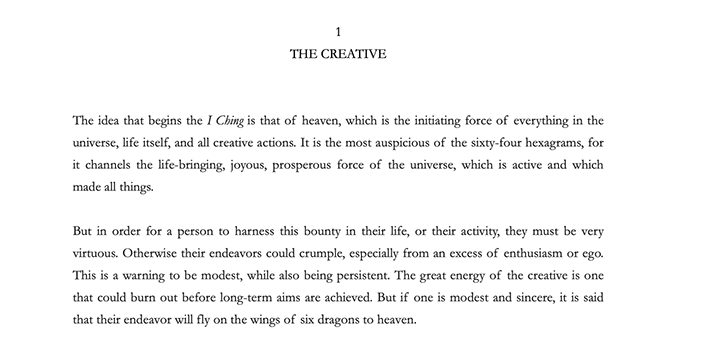C
’è una incomprensione alla base della discussione sui libri che parlano di sé, di passato e identità, tutta quella costellazione di opere che vengono definite l’autofiction, memoir, saggi personali, senza che una definizione escluda o sostituisca del tutto l’altra – ed è l’idea che il mondo abbia bisogno di più storie per funzionare o che una storia possa cambiare le cose, aggiungere quel tassello necessario a spostare la percezione della realtà. Per quanto inedite, rivoluzionarie o semplicemente tragiche, le storie, però, come le fotografie, occupano il tempo che trovano, si dimenticano, vengono sostituite da altre: la lingua, come l’immagine, si è rivelata uno strumento limitato per produrre un senso di empatia. Una certa fiducia nel sentimentalismo come chiave di volta di molte delle questioni morali e politiche che andrebbero affrontate collettivamente si è rivelata evidentemente mal riposta; confusione nata dall’assunto che si debba scrivere di quello che si conosce – e l’io è il soggetto più a portata di mano: a guardare bene ognuno di noi ha dentro una storia, che può rendere interessante abbastanza, se si impegna abbastanza.
Se viene chiamata “industria della prima persona” è sottinteso che da qualche parte sia iniziata una professionalizzazione di quella nebulosa di testi che ruotano intorno al saggio personale: è forse il frutto dell’idea che ognuno ha una storia da raccontare dentro di sé (il materiale a portata di mano per un corso di scrittura creativa) e della manutenzione quotidiana della propria persona, per cui con un po’ di studio ognuno può diventare brand ambassador di se stesso. Negli ultimi tempi infatti mi sembra che in gran parte dei libri contemporanei che mi capitano sotto mano la traduzione di questo processo (“scrivi di quello che sai”) in termini pratici somigli non a una indagine, ma a una presentazione di sé, a libri senza mistero e senza ambiguità, in cui tutto è disposto perché sia immediatamente comprensibile, interessante e, soprattutto, del tutto inattaccabile. Inattaccabile, mi viene da aggiungere, in un contesto culturale in cui la critica è estremamente marginale, in cui raramente le riflessioni sulla lingua e la letteratura creano dibattito. Certo esistono le stroncature, ma sono comunque rare e spesso partono da assunti o si muovono su discorsi che hanno, in fin dei conti, ben poco a che fare con il libro in sé. È la persona pubblica ad essere sempre più al centro, a essere l’oggetto di interesse e di eventuale controversia ed è in questa funzione, o comunque tenendo ben in conto questa variabile, che viene pensato il libro – perché a non venire attaccato sia chi lo scrive, non la scrittura.
Certo questa discussione, che qui faccio in maniera un po’ sbrigativa, meriterebbe un approfondimento, prima di tutto da parte mia perché ho bisogno di spiegare, anche a me stessa, una certa disaffezione per un genere su cui pure si fonda gran parte della mia formazione letteraria, cioè la nebulosa del saggio personale, la scrittura che usa in maniera estensiva la prima persona. Gli ultimi anni mi sembrano pieni di libri personali e senza alcun coraggio – o dal coraggio insufficiente – che lasciano fuori porzioni specifiche di sé, che provano a controllarne la ricezione, le conseguenze, perché non combaciano con l’idea che si vuole rendere della propria persona, perché espongono a critiche che sono sempre personali, quasi mai legate alla qualità letteraria.
La scrittura di sé non prevede la trasparenza totale, né di rendere ogni elemento della propria vita significativo abbastanza da essere citato, ma è facile presentire quando un libro è anche un comunicato stampa. Cioè, una cosa è separare elementi della propria vita privata, un altro operare attraverso la pulizia metodica di ogni elemento che non sia collettivamente accettato, perché l’impressione è che si dica: ecco il caos della mia vita, ecco cosa la rende unica, e poi invece non c’è nessun caos, come le persone che si scusano per la confusione in case preparate per ricevere ospiti, perché si noti l’ordine, la pulizia. Mentre invece non c’è bisogno di sottolineare quanto unica sia la propria esperienza (se tutte sono uniche, una vale l’altra, no?) e perché è proprio attorno ai nodi, attorno ai dubbi, alle incertezze, alle ambiguità che si scrivono opere saggistiche che si interroghino sul presente, per far chiarezza. La riduzione di sé a personaggio, a personaggio leggibile, che occupi tutto lo spazio possibile su un certo fronte o un certo argomento è di fatto la contraddizione dell’assunto di complessità da cui tutti questi libri partono. Per certi versi, l’ultima raccolta di saggi di Zadie Smith – che io ritengo essere una delle migliori saggiste, non solo tra le contemporanee – si muove in questa direzione: la sua proverbiale incoerenza (Cambiare idea è il titolo della sua prima raccolta di saggi) diventa un meccanismo narrativo, più che un affondo nella propria ambiguità, tanto che Smith a tratti sembra interessata solo a dimostrare che anche a essere imperfetta è la migliore tra noi. È come se portasse la sua persona pubblica al centro del saggio, come se parlasse da quel punto di vista e meno come scrittrice.
Questa lunga introduzione mi serve a chiarire perché la scrittura di Sheila Heti al contrario è sempre capace di elettricità, di scaturire in chi la legge la sensazione di ascoltare un pensiero, non un TED talk: se non è unica, né innovativa nell’uso estensivo e intensivo la prima persona singolare, di certo ha saputo farlo attraverso generi, punti di vista, temi diversi con successo. La trasparenza della voce con cui scrive – il senso, cioè, di assoluta identità tra voce e scrittore – assomiglia più a uno strumento narrativo, a una tecnica di comunicazione che al resoconto della persona che è Sheila Heti, di cui mi rendo conto di non sapere molto, nonostante la legga da sempre. Questo è vero persino del romanzo La persona ideale, come dovrebbe essere? (Sellerio, traduzione di Martina Testa), un libro che innalza il personale a vicenda universale, che usa persone ben identificabili, come l’amica Margaux Williamson, per trasformarle in personaggi, che racconta la confusione e l’indecisione dei vent’anni, non per dimostrare qualcosa, ma perché è in quella interrogazione continua dei propri desideri che sta la sua essenza di scrittrice.
Maternità (Sellerio, sempre tradotto da Martina Testa), di cui avevo scritto qui su Il Tascabile, rende questo meccanismo palese: la voce narrante sembra appartenere a Sheila Heti, ma non c’è nessun elemento identificativo – porosa e esposta, quella voce è messa a disposizione del lettore, perché insieme si pongano la stessa domanda, cos’è un figlio?, ancora e ancora – è un romanzo, anche se tutto porta a dimenticarlo. Lei stessa si era trasformata in personaggio nel libro di Leanne Shapton Importanti oggetti personali e memorabilia dalla collezione di Lenore Doolan e Harold Morris (Rizzoli, un libro sorprendente e purtroppo fuori catalogo), in cui interpretava proprio la protagonista, Lenore Doolan, in un catalogo d’asta che raccontava inizio svolgimento e fine di una relazione attraverso foto e oggetti. Se sei disposta a prestare la tua faccia a un personaggio del libro di qualcun altro, vuol dire forse che non ti curi di essere poi così tanto identificata con il tuo ruolo pubblico.
Qualche mese fa Heti ha annunciato di star lavorando a un progetto usando i suoi diari: lo aveva già fatto nel 2010 – qui si trova l’articolo – mettendo in ordine alfabetico alcune delle annotazioni dei cinque anni precedenti. Ho letto e riletto quel pezzo in momenti diversi della mia vita, traendone sempre una qualche lezione, quasi fossero testi sapienziali che potevo consultare. Quando l’ho detto a Heti, mi ha inviato la nuova versione a cui sta lavorando, quella che copre il periodo tra il 2011 e il 2020, e abbiamo iniziato a discutere di come quella relazione di cooperazione tra il lettore e l’autrice avesse senso all’interno della sua produzione, che funzione ed effetti avesse – quando mi ha detto che sta lavorando anche a una sua interpretazione dell’I Ching, altro testo partecipatorio e sapienziale, non mi è parso un caso (ne parliamo anche in questa lunga intervista). Sheila Heti è una grande coscienza che si interroga su se stessa e che in questo processo crea spazio per il lettore, domandando e dando risposte. Da qui, l’elettricità dei suoi testi, la loro struttura circolare più che lineare, la mancanza di conclusione e di pacificazione che li rende interessanti, imperfetti a tratti, ma vitali. Opposti, in un certo senso, al processo di manutenzione continua di quelli citati prima, eppure partecipi di uno stesso genere, di uno stesso uso di meccanismi di finzionalizzazione, di uso del sé come strumento di indagine.
Vorrei partire col chiederti di raccontarmi il tuo progetto legato ai diari – come hai raccolto prima cinque e poi dieci anni di annotazioni, organizzate per ordine alfabetico. Da dove è arrivata l’idea? E come si è realizzata concretamente – anche da un punto di vista puramente tecnico, come hai lavorato sui testi?
Ho iniziato a lavorare a questo progetto dopo aver finito di scrivere
La persona ideale, come dovrebbe essere? e prima di iniziare a capire come approcciarmi al mio libro successivo,
Maternità. La domanda che mi stavo ponendo era:
come sono stati i tuoi ultimi dieci anni di vita?
Sei cambiata? Avevo poco più di trent’anni al tempo e stavo cercando di dare un ordine a tutto quello che mi era capitato: gli uomini, il desiderio e l’affannarmi per il successo, non sapere in quale città vivere. Credo che volessi solo osservare tutto quello che mi aveva assorbito, cosa avevo avuto per la testa. Mi pareva che organizzando i miei diari in ordine alfabetico avrei potuto individuare le ripetizioni. Era un tentativo di avere un approccio scientifico, metodico, distaccato, di mettere in ordine alfabetico tutte le domande che mi ero posta negli ultimi dieci anni.
Perché li scrivo sul computer, ho potuto accorpare tutti i diari in un unico file di testo e poi, usando la funzione “trova e sostituisci”, dividerli in singole frasi, una riga alla volta e poi importarle tutte su Excel e qui usare lo strumento per ordinarli alfabeticamente. Detto così sembra più facile di quanto non sia stato.
Poi, negli ultimi dieci anni, ho editato i diari per ridurli alla loro essenza. Per lungo tempo non sapevo come fare – o se li avessi dovuti editare in senso assoluto. Non ero sicura di quali fossero le regole. C’è un libro di Kenneth Goldsmith che amo che si chiama Soliloquy, in cui ha trascritto tutto quello che ha detto per una settimana. Il libro è diviso in sette sezioni, una per ogni giorno. Non ha fatto nessun tipo di editing, il che ha senso da un punto di vista artistico, ma per me non funzionava, non editare non era una soluzione: non erano abbastanza interessanti da leggere. Troppo editing d’altra parte avrebbe distorto l’aspetto originale del testo a un punto che il lavoro di indagine iniziale si sarebbe perso nella narrazione. Quindi sono passata da bozze a cui mettevo moltissimo mano a bozze in cui l’editing era minore.
A un certo punto mi sono resa conto che dovevo creare una serie di personaggi in modo che, se mai fossero stati pubblicati, nessuno avrebbe potuto capire chi era chi. Non è stato semplice capire quali nomi di finzione dare loro, né che forma dare al libro. Per molto tempo ogni frase era su una riga, poi Lisa Naftolin, una designer, ci ha messo mano e ha reso ogni capitolo (che equivale a una lettera) un lungo blocco di testo unico, cosa che dopo dieci anni di formattazione in un altro modo, mi è improvvisamente sembrata una scelta migliore; assomigliava più a un romanzo che a un esperimento scientifico.
Il mio ragazzo lo chiama il mio ‘progetto della procrastinazione”. È vero che di solito mi ci dedico quando non ho voglia di lavorare ad altre cose.
Un progetto per procrastinare… Mi interessa capire se abbia un rapporto con la tua produzione di fiction, cioè con i romanzi. Ho letto che hai un laboratorio in cui insegni tecniche per sbloccarsi, dal punto di vista artistico (un altro bellissimo titolo: “Non importa cosa scegli”) – mi chiedo se il lavoro sui diari non sia una delle tua tecniche per capire verso cosa vuoi andare.
Questo libro ha ben poco a che vedere con i miei romanzi, perché con i romanzi cerco qualcosa, ho domande molto più complesse, c’è molto lavoro di finzionalizzazione, sulla struttura, c’è più scrittura, più fatica, ci sono più momenti di beatitudine, più flusso e misteri da dipanare, gioia e disperazione. Questo progetto invece è qualcosa a cui torno da più di dieci anni quando mi sento in un certo modo; non c’è niente in me che mi spinge usarlo come valvola di sfogo: non c’è niente che sto cercando qui, se non una risposta alla semplice domanda: a cosa pensavo? Il processo di scrittura di questo libro non assomiglia affatto a quello di un romanzo. La posta in gioco è molto bassa. Non so neanche se lo pubblicherò mai. Ho avuto varie opportunità, ma alla fine le ho sempre rifiutate. Non so se lo voglio là fuori.
Quello che mi colpisce è quanto i diari siano pervasi da quelli che io definirei i tuoi temi: la dedizione al lavoro, il desiderio nei confronti degli altri e di quello che non sei tu in generale; l’amicizia, il sesso, quello che definisce l’identità, la contraddizione tra la voglia di abbandonarsi e di trattenersi da qualcosa, la natura oscillatoria dei tuoi desideri – nel senso che mi sembra che ti osservi al microscopio, per cercare di capire cos’è che davvero vuoi. E questo accade in ciascuno dei capitoli, cioè delle lettere: c come cancellare, controllare, compassione, f come frequentare, i come io, e così via. Lavorare sui diari ha cambiato la percezione di quello che stavi cercando, lo ha reso più chiaro?
Non avevo mai pensato al fatto che i diari riflettessero gli stessi temi che tratto nei romanzi, ma è bello che lo facciano! Il libro a cui stavo lavorando in modo più intensivo durante il lavoro di editing dei diari è
Maternità e penso che l’unico punto in cui questi due progetti si intersecano è che volevo essere sicura che nessuna frase che compariva in uno comparisse anche nell’altro; quindi qualche anno fa ho cancellato tutte le riflessioni che si trovavano dei diari sull’essere o no madre, sul desiderio o no di maternità, perché ho pensato che era meglio mantenere tutte queste domande nell’altro libro e che i diari dovevano presentare un’altra versione di me stessa: una che non era interessata a queste questioni, forse leggermente più giovane. Quindi alcune vere frasi dei miei diari sono finite in
Maternità, ma mi sono accertata che nessuna si trovasse nell’altro progetto.
Più mi allontano dagli anni dei descritti nei diari, più sono capace di scorgervi un personaggio – me stessa come personaggio. Riesco a vedere chi sia, quale sia il suo profilo, e non mi assomiglia quasi più. Anni fa, avrei aggiunto nuovi diari al progetto, ma, dopo un po’, il progetto stesso ha fatto sì che perdessi interesse nello scrivere diari. Non è una cosa che ho mai fatto con regolarità, scrivere diari, solo quando ne sentivo l’urgenza. Da quando lavoro al progetto, sento questa urgenza due o tre volte l’anno. Penso che più mi allontano dalla persona che ha scritto quei diari – che ora sono il progetto dei diari – più sono capace a guardarlo come a un libro, comprenderlo come un testo separato da me, vederne il personaggio – e così anche pubblicarlo.
![]()
La forma diaristica è strettamente legata al concetto di autobiografismo, ma per ragioni di forma, più che di puro contenuto, perché non posso di certo sapere quanto sia vero, quando sia inventato o editato quello che leggo. Questo per me vale per gran parte dei tuoi libri, per la forma in cui vengono offerti, per l’uso di una prima persona molto ravvicinata. Ho la sensazione che sia proprio attraverso questo uso intensivo dell’io che tu crei spazio per il lettore, che lo rendi parte della storia, che lo fai scivolare in una coscienza diversa, essendo appunto così personale. Come in Importanti oggetti personali e memorabilia… di Leanne Shapton, dove tu interpretavi la parte di Lenore Doolan: in quel caso era la presenza delle foto (erano la prova che qualcosa era successo) a rendere la storia molto specifica, dunque universale, più porosa. Ho provato qualcosa di simile leggendo Maternità, in cui le domande che si pone la protagonista, diventano quelle del lettore – è come se tu facessi lo sforzo per entrambi, crei questa opportunità. È qualcosa che cerchi deliberatamente o un prodotto secondario di una letteratura basata sul frammento – in cui ogni crepa, ogni spazio permette di formare una narrativa personale?
Di sicuro è qualcosa che volevo ottenere con Maternità. Volevo che la mente del libro fosse o sembrasse anche quella del lettore e che il lettore inframezzasse le sue domande con quelle del libro. Di sicuro per me era importante non descrivere troppo il personaggio, per esempio, perché se era troppo definita, il lettore poteva dire “non sono io” e perché (almeno per me) lo spazio di riflessione, quello in cui penso sento che è staccato, separato da quello reale, fisico – dal corpo. Sono contenta che citi Leanne Shapton: stavo lavorando a questo libro quando ho iniziato Women in Clothes, un libro che ho editato insieme a lei e Heidi Julavits, e in quel caso Leanne aveva deciso che non dovevamo includere i ritratti delle donne che avevano risposto alle interviste, perché così le loro parole non sarebbero state legate a un’immagine di donna che il lettore poi avrebbe considerato altra rispetto a sé. Senza le immagini, le parole diventavano anche del lettore. Avevo questo in testa, credo, quando ho iniziato a immaginare la struttura di Maternità. Ovvio che la narratrice di Maternità è un personaggio, ma volevo che lo fosse il minimo indispensabile. È un libro di sole riflessioni, speculativo – un libro filosofico, per dirlo altrimenti. Volevo che il narratore fosse, allo stesso tempo, un personaggio, il lettore, una voce filosofica, un’occasione per il lettore per far emergere i propri pensieri: uno stimolo per pensieri che dovevano ancora formarsi.
In una delle nostre prime conversazioni, ti ho detto che ho sempre letto i tuoi diari come se si trattasse dell’I-Ching, perché hanno una certa qualità sapienziale, che trovo ancora più forte in Maternità, che è una meditazione incessante su un unico soggetto, cioè i figli (averne uno, esserne una). Quel libro in particolare è sviluppato non in modo lineare, ma circolare, è un romanzo filosofico insomma, i cui meccanismi sono celati dal suo apparente autobiografismo: se La persona ideale, come dovrebbe essere? elevava il personale a universale, Maternità inventa una persona reale per parlare di universali. È un modo di scrivere che ha una ascendenza religiosa: sembra quasi che tu scriva una preghiera buddista o una meditazione ortodossa, è una ripetizione infinita della stessa frase, della stessa domanda. Come Franny Glass che ripete “Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, peccatore”, così tu ti chiedi “devo avere un figlio?”: è dalla ripetizione della domanda stessa che si produce la conoscenza, anche se non è chiaro se si arriverà mai a una risposta.
È tutto molto vero! Volevo che la domanda “devo avere un figlio?” funzionasse come una domanda che potesse condurre a tutte le questioni più importanti, nello stesso modo in cui Camus dice che chiedersi se suicidarsi o continuare a vivere sia da considerarsi la questione centrale della filosofia. No, ho pensato, la questione centrale dovrebbe essere se portare un’altra vita al mondo oppure no – ma di certo non lo è stata perché la tradizione filosofica è soprattutto una tradizione declinata al maschile. Ma “dovrei avere un figlio?” è una domanda che dovrebbe porsi chiunque, soprattutto ogni donna, e volevo dimostrare che è un argomento filosofico e spirituale, non una questione di stili di vita; e forse la domanda più importante che ci sia. Non è trattata così, però. Se una donna interroga la sua vita è vista come narcisista, egoriferita, non come una filosofa; mentre se lo fa un uomo, tutto quello che si chiede sembra importante per tutti, universale. Volevo dare lo stesso peso, importanza e portata anche a questo interrogarsi femminile.
Nella sua trilogia, Rachel Cusk insiste sul valore della passività: non creando un personaggio definito nei suoi romanzi, offre ai suoi interlocutori un palco da cui parlare. L’opacità del carattere di Faye la rende così più una testimone (nello specifico, del fallimento degli altri di essere persone, di avere una personalità) che una protagonista. Il fatto che non provi più quell’urgenza di esprimersi è quasi un sollievo, la sua mancanza di desiderio sembra così una caratteristica dell’età adulta: non dice mai io perché non ne ha più bisogno. Più penso a quei libri, però, più sono attirata da voci cariche di desiderio, di conflitto. E il tuo progetto con i diari mi pare esattamente così, al capo opposto di questo spettro: è una lista di desideri, di frasi contraddittorie, di speranze. Che rapporto ha il desiderio rispetto alla scrittura per te? Sono due forze, due istanze legate?
Trovo questa cosa che dici illuminante: “Il fatto che non provi più quell’urgenza di esprimersi è quasi un sollievo, la sua mancanza di desiderio sembra così una caratteristica dell’età adulta”. Forse il punto è la differenza di età tra le due protagoniste: nella trilogia Faye ha cinquant’anni. Nei miei diari chi parla è una ventenne. Penso che i desideri, le speranze, i sogni per il futuro, le pretese siano tutte caratteristiche della giovinezza, più che di altre età, in cui poi si inizia ad accettare un senso di rassegnazione, ci si stufa dell’ego, di sé, dei propri desideri, necessità, volontà. Lo sento anche io, sempre più: sono stanca di me, mi chiedo cosa verrà poi. Nel caso di Rachel, sono gli altri a sostituire l’io. Non so se questa è o sarà una risposta che varrà anche per me.
Allo stesso tempo – non so se sia ovvio o paradossale – tutte e due avete poca fiducia nella possibilità di una trasformazione personale definitiva, come se la vita fosse una evoluzione continua… poi verso cosa? viene da chiedersi. Organizzando i tuoi diari in ordine alfabetico dici che ti sei scoperta se non uguale, molto più permanente, più simile nei desideri e nei conflitti: quando abbiamo parlato per Inquiete Festival hai detto che forse le persone sono come oggetti, illuminate ogni volta da luci diverse – cambiano sempre, ma occupano la sempre lo stesso spazio. Mi pare che le vostre posizioni, tua e di Cusk, siano insieme deprimenti e rassicuranti.
Immagino siano entrambe le cose: è deprimente restare identici, è rassicurante restare identici. Di sicuro ho visto molto “stesso” nel rileggere dieci anni di diari: non è stato più possibile per me, una volta riorganizzati in ordine alfabetico, capire quale frase appartenesse a quale anno. Mi è sembrato tutto lo stesso eterno momento, non una progressione di dieci anni. Le frasi hanno senso – o almeno lo hanno abbastanza – in ordine alfabetico. Questo mi induce a pensare che tra un anno e l’altro le cose cambino poco. Non è che sia deprimente o rassicurante in sé. Penso che i cambiamenti avvengano molto più lentamente di quanto immaginiamo: forse in cinquant’anni ne vediamo uno, non in dieci.
È un po’ strano parlare del tuo lavoro di scrittrice attraverso progetti a cui stai ancora lavorando, ma stavo leggendo How to be
Good When You’re Lost, la tua interpretazione dell’I Ching illustrata da Ted Mineo (in parte pubblicata in Where you are? e qui) e il fatto che tu ti stia occupando di riscrivere ciascun esagramma mi pare che abbia moltissimo senso all’interno della tua opera, del tuo approccio alla scrittura. Usi l’ I Ching moltissimo anche in Maternità, ma vorrei sapere come è nato How to be
Good When You’re Lost.
Sto provando a scrivere queste mie interpretazioni dei sessantaquattro esagrammi dell’I Ching ormai da dieci anni, insieme a Ted Mineo, il mio collaboratore, che sta lavorando alle rispettive illustrazioni. Non so perché abbia iniziato a scriverne una mia versione – forse perché per me scrivere è un modo per capire e volevo arrivare a comprendere questo libro così denso e profondo. Per un po’ mi sono limitata a comprare ogni traduzione (o interpretazione) dell’I Ching che riuscivo a trovare. Se fai così ti rendi conto che chiunque lavori a una sua versione dell’I Ching ha un modo tutto suo di intepretarlo. In inglese, il testo fondativo è quello di Richard Wilhelm (con una introduzione di Carl Jung). Quello che volevo fare era leggere una dozzina di versioni di ciascun esagramma e poi, con tutta la saggezza che potevo trarne, scrivere le mie. Le avrei scritte per superare un momento difficile che stavo attraversando a quel tempo. Poi, l’ora di riscriverle o editarle sarebbe arrivata successivamente, nel momento in cui dovevo affrontare un altro problema, così la riscrittura avrebbe fatto sì che quella versione si potesse adattare anche alla situazione che stavo attraversando. La genialità dell’I Ching è che la sua saggezza si applica a ogni occasioni e tutto quell’editing e quelle riscritture erano fatte per questo obiettivo. Il lavoro sull’ I Ching mi ha insegnato come vivere e come affrontare la vita in modo diverso – con più pazienza, meno forza, con più capacità di accettare e riconoscere che ogni tanto bisogna passare momenti difficili, che non c’è niente che si possa o si debba fare in quei momenti, se non restare quieti e attraversarli con accettazione e fermezza, sapendo che passeranno.
![]()
A me piacciono i tarocchi, una passione che collego al fatto che mi interessa la narrativa: hai una serie di carte e il tuo ruolo è renderle una storia. È un lavoro di cooperazione tra te e il mazzo. Per me lo stesso vale per i tuoi diari, alcune delle frasi è come se avessero una scintilla e selezionandole e mettendole in relazione è come se potessi renderle una lettura (nel senso che si usa per i tarocchi). Per questo dico che il tuo lavoro sull’I Ching ha molto senso ed è come se mi facesse rileggere la tua produzione in un altro modo: in tutti questi casi l’uso di un pronome personale (l’io dei diari, il tu dell’I Ching) congiunge l’universale al personale attraverso un uso intensivo di una pronome personale. È narrazione e cooperazione, narrazione personale attraverso temi universali. Vale lo stesso per te?
Sì, mi piace l’elemento partecipatorio di queste forme per cui il lettore è coinvolto in modo attivo in una modalità diversa di guardare a una storia che avviene di fronte a lui. Nel caso dell’I Ching o dei tarocchi, la disponibilità, l’apertura verso chi riceve una lettura deve essere ancora maggiore – la storia deve avere maglie abbastanza larghe da avere poi punti di contatto o di relazione con chi vi cerca una risposta. È la storia che si deve adattare alla persona che vi arriva, che la legge. Mentre nella maggioranza delle forme narrative, è il lettore che si deve adattare alla storia, che deve trovare il suo posto all’interno della narrazione. È per questo che mi piacciono le forme divinatorie, perché funzionano al contrario. Scrivere così è una sfida.
Per citare due passaggi del tuo I Ching, da Il Creativo, che apre la raccolta: “Ma affinché una persona possa sfruttare questo dono [della creatività, ndr] nella sua vita, o nella sua pratica, deve essere molto virtuosa. Altrimenti i loro sforzi potrebbero essere vani, soprattutto a causa di un eccesso di entusiasmo o di ego. È un monito a essere modesti, ma anche a continuare a insistere”. O da Difficulty at the beginning, il quarto esagramma: “All’inizio bisogna aspettarsi delle difficoltà, quando così tanti elementi ancora fanno fatica a prendere forma. Il mondo ora può sembrare molto caotico – perché in effetti è molto caotico”. Sembrano quasi consigli di scrittura, o per artisti, no?
Sì, quando li stavo scrivendo, avevo in mente soprattutto artisti e scrittori – la questione di creare qualcosa a lungo termine. Molte persone usano i tarocchi o l’I Ching se hanno i problemi di cuore, io volevo fare qualcosa per i problemi con l’arte e la creatività, che poi tutto sommato non sono così diversi dai problemi di cuore.
Mi torna in mente anche un altro non-diario, cioè Tra le pieghe dell’orologio di Heidi Julavits, che prima citavi. Lì lei riorganizzava due anni di diari in un ordine temporale impossibile da riconoscere – ogni annotazione inizia con Oggi io. Ogni giorno rappresenta un possibile inizio, una trasformazione non consequenziale, un io potenziale, senza dover credere per forza all’idea di evoluzione personale. È una ipotesi un po’ spaesante, ma persino liberatoria, quella di vivere in un eterno presente in cui la memoria è sempre fallimentare, persino inutile. Che rapporto hai con quel libro?
Credo che stessimo lavorando ai nostri progetti nello stesso momento. Amo quel libro – a un certo punto aveva inframezzato i paragrafi con dei disegni di un rubinetto che aveva trovato a un mercatino. Erano disegni assurdi e lei ne aveva fatto uno al giorno. Mi sarebbe piaciuto li avesse tenuti nella versione finale, ma credo che la sua editor pensasse che non c’entrassero molto. Comunque sì, entrambi i nostri progetti sono scettici rispetto all’idea che la consequenzialità del tempo sia significativa, così come esprimono scetticismo rispetto all’idea di progresso personale.
C’è un terzo modo di guardare al rapporto tra sé e tempo: che forse esistiamo nella possibilità, che siamo anche quello che non abbiamo fatto o che avremmo fatto, siamo insieme le vite che abbiamo desiderato e quelle che abbiamo vissuto: che sottovalutiamo quello che può fare il desiderio, come forma, dirige le nostre vite in un modo che è sotterraneo e quindi forse anche più permanente. Se penso alla tua scrittura mi pare un’operazione di intensa concentrazione, osservarsi abbastanza a lungo per capire quanto spazio si occupa.
C’è questo libro di Adam Phillips, che amo e ho recensito per il
Times, che si chiama
Missing Out (
In lode alla vita non vissuta, Ponte alle Grazie): Phillips lavora per quattro giorni alla settimana come psicoterapeuta freudiano e il mercoledì scrive. Questo libro parla delle nostre vite non vissute e Phillips osserva quanto sia buffo e strano che ci sembra sempre di conoscere meglio quello che ci siamo persi piuttosto di quello che stiamo vivendo. È vero: nella mia testa ho tutte queste vite alternative, narrative che sono sicura che avrei vissuto se avessi fatto altre scelte. È un’illusione, ma un’illusione molto potente! Cosa ne sarebbe stato della mia vita se avessi scelto quest’altro uomo, per esempio: lo vedo così chiaramente! Per rispondere alla tua domanda, mi piace pensare che siamo le creature che siamo e anche quelle che non siamo, quelle che abbiamo anche solo immaginato o che saremmo potute essere. Penso che l’io le contenga tutte, non solo quello che abbiamo vissuto o fatto. Tutti i nodi che non si riescono a dipanare fanno parte di noi. Come Cusk, anche io sono sempre meno interessata a chi sono o allo spazio che occupo, rispetto a quanto lo ero prima – quando scrivevo i diari. Non mi sembra più importante, forse perché l’ho fatto per tanto tempo e adesso voglio fare altro, o perché ho trovato le mie risposte o perché le risposte che ho mi soddisfano abbastanza e adesso voglio andare avanti. Quello che voglio veramente è occupare ogni stadio della vita, ogni
io che sono stata, più pienamente che posso – o almeno questo è quello che ho voluto fare per vent’anni – ma adesso, forse perché non riesco a vedere così tanto cambiamento nella mia vita, questo compito mi pare sia stato concluso.
Sarah Manguso ha detto di aver smesso di sentire la necessità di scrivere i diari dopo averli distillati in quel brevissimo libro che è Andanza. Non ha spezzato un incantesimo, forse è più un passaggio di stato, qualcosa che vale per te, per Cusk e per lei – il momento in cui l’io lascia spazio all’altro. Nel caso di Manguso coincide poi con la maternità, in cui dice di scoprirsi sfondo di un’altra persona, di un’altra linea temporale.
Mi sembra di iniziare a capire che questa sia la mezza età. Dopo esserti creata un io nella giovinezza, preparandoti alla vecchiaia e alla morte, che è l’abbandono dell’io, ci sono gli anni di mezzo, che sono dedicati ad altro. Non so esattamente cosa sia questo altro, ma non sto più creando il mio io, non credo almeno, ma non è ancora il momento in cui inizio ad abbandonarlo definitivamente.