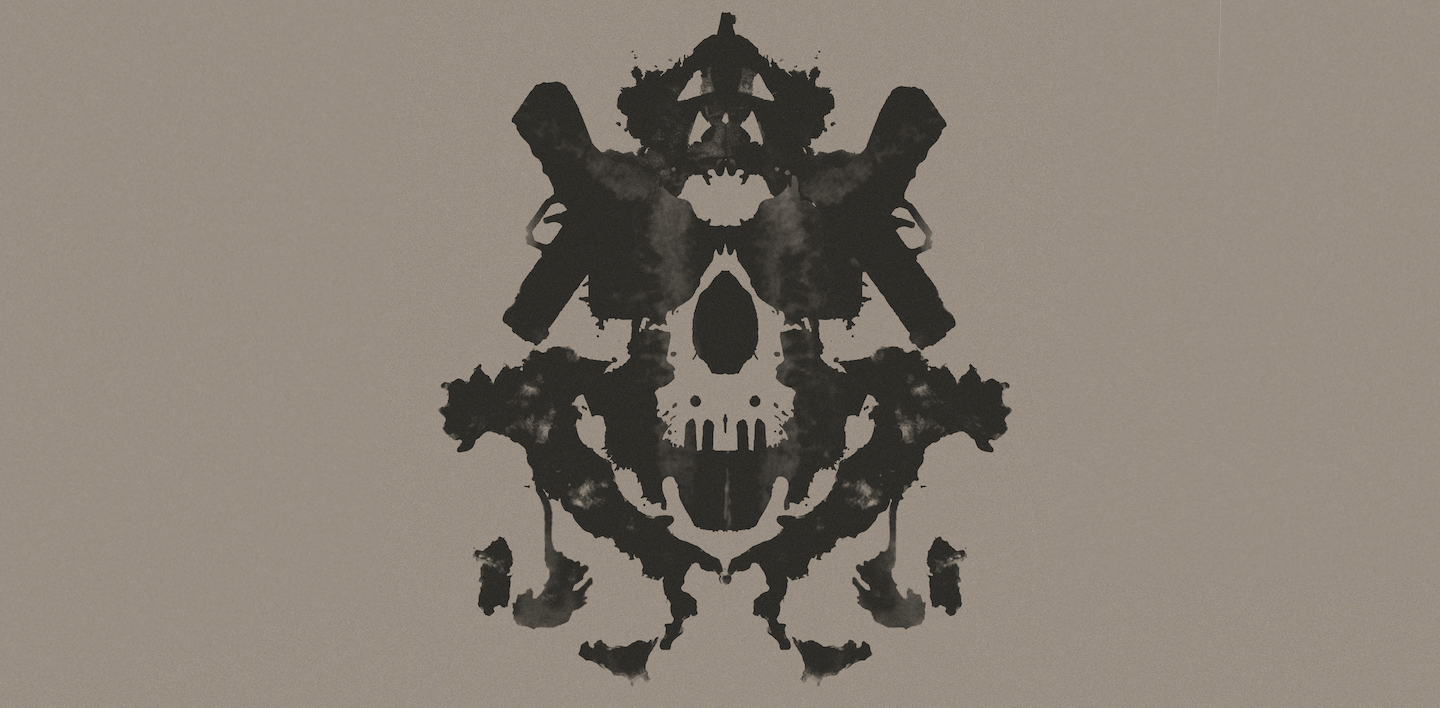
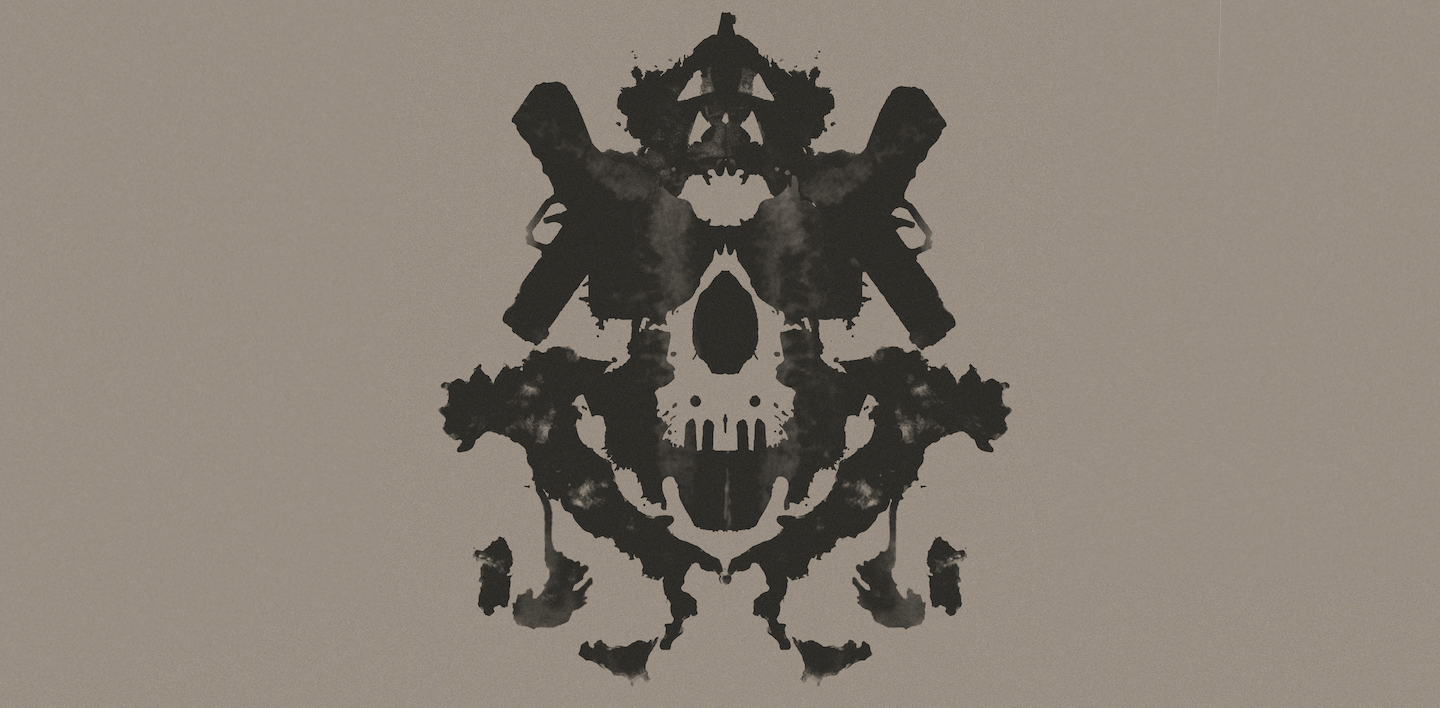
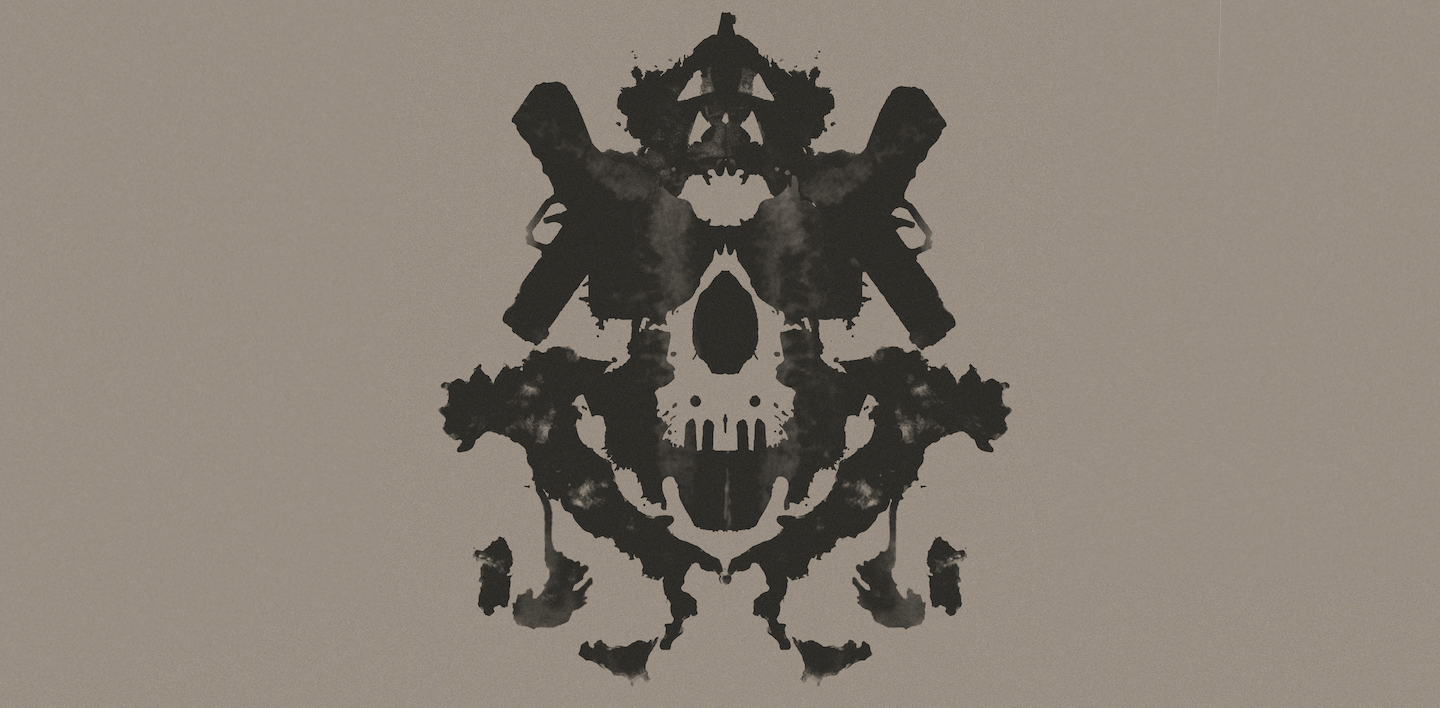
I l giorno in cui Simão Bacamarte, il più grande medico di Brasile, Spagna e Portogallo, capì che non avrebbe avuto figli da donna Evarista, decise di dedicare il suo ingegno allo studio dei matti, e che sarebbe stato ricordato per sempre per la più nobile delle occupazioni: la salvezza dell’anima.
Fu così che, a Itaguaí, venne costruita la Casa Verde. In quel sontuoso manicomio, l’alienista ricoverò furiosi, calmi, monomaniaci, poveri di spirito e, in quattro mesi, la Casa Verde divenne un villaggio gigantesco: c’era chi credeva di essere la stella del mattino, chi raccontava a un muro la sua genealogia. Decise di internare i cittadini più stimati e ricoverò chi protestava. Tra i più preoccupati c’era Mateus, che ogni mattina rimirava la sua casa principesca. Bacamarte pensò che avesse il mal d’amore per le pietre, ricoverò anche lui. E poi altri, e altri ancora. Finché a Itaguaí non si capì più chi era sano e chi era pazzo.
La popolazione insorse, arrivarono le milizie per sedare i rivoltosi. I ribelli furono trattenuti in manicomio e Bacamarte convinse il viceré di essere nel giusto. Non si salvò nessuno: gli avari, i pigri, gli appassionati di enigmi, gli inventori di sciarade, i maldicenti. Fu ricoverata perfino donna Evarista. All’improvviso un dubbio assalì l’alienista: aveva internato quasi tutta la città, riesaminò le sue tesi e concluse che la vera dottrina era quella che predicava esattamente il contrario. Doveva considerare normale lo squilibro delle facoltà di mente e malattia i casi in cui l’equilibrio fosse ininterrotto.
I reclusi furono dichiarati sani e liberati. La gratitudine fu smisurata e donna Evarista, che voleva separarsi, cambiò idea per non perdere la compagnia di un così grand’uomo. Le porte della Casa Verde si aprirono per i modesti, i semplici, i tolleranti, i leali, per i magnanimi. Bacamarte li curò cercando di inculcargli il sentimento opposto. “Davvero erano pazzi e li ho guariti? Oppure ciò che mi è parsa guarigione altro non è che la scoperta di un assoluto squilibrio cerebrale?”, si chiese l’alienista, di nuovo sopraffatto dagli scrupoli.
Continuò a studiare, un giorno chiese ai suoi amici quali difetti gli riconoscessero. Non trovavano alcun difetto, uno di loro gli spiegò che non era in grado di vedere le sue qualità per via della modestia. Se era lui l’unico corretto e sano, non aveva alternative. Simão Bacamarte si ritirò nella Casa Verde per dedicarsi alla cura di se stesso e diciassette mesi dopo morì senza aver ottenuto nulla. Qualcuno disse che, in tutta Itaguaí, non c’era stato nessun matto all’infuori di lui.
Se da un lato i progressi della scienza hanno consentito di migliorare la prevenzione e l’assistenza a nuove forme di disagio, dall’altro l’operazione di incasellare ogni comportamento umano rischia di rendere malattia la normalità.
Joaquim Maria Machado de Assis scrive il romanzo del dottor Bacamarte nel 1881. L’alienista è la rilettura surreale di una pretesa irraggiungibile – segnare il confine che separa follia e normalità – e dell’inguaribile fiducia nel primato della ragione, della presunzione di comprendere ogni comportamento umano. Temi al centro del dibattito scientifico moderno. Nel ventunesimo secolo, i trattati sui disturbi mentali ripercorrono la strada che fu di Bacamarte: il tentativo di spiegare tutto.
Le ricadute sociali e culturali di quest’ambizione sono enormi, incidono su chi va considerato sano e chi malato, su quali terapie utilizzare, su chi può essere assunto in un’azienda, su chi può adottare un bambino o guidare un’automobile, chi può essere rimborsato in caso di incidenti o chi può tenere un’arma in casa. Ma se da un lato i progressi della scienza hanno consentito di migliorare la prevenzione e l’assistenza a nuove forme di disagio, dall’altro l’operazione di incasellare ogni comportamento umano rischia di rendere malattia la normalità.
Il sistema di classificazione più utilizzato al mondo, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, è passato da circa cento malattie elencate nella prima edizione pubblicata nel 1952 a oltre quattrocento nella quinta, del 2013. Le reazioni della comunità scientifica sono state critiche e si sono concentrate su due aspetti principali: il rischio di nuove epidemie di disturbi mentali artificiali che, più che scoperti dalla scienza, sono decisi a tavolino, e l’uso indiscriminato di trattamenti farmacologici estesi a pioggia su condizioni esistenziali che malattie non sono, in nome del principio per cui se tutto è malattia, tutto va curato.
Uno dei cortocircuiti più pericolosi si realizza quando questa smania diagnostica s’incrocia con il crimine. Da un lato, le strategie difensive degli autori di reato insistono sull’infermità di mente invocando disturbi indimostrabili, dall’altro la psicopatologia è chiamata in causa per ogni gesto che sfugge all’immediata comprensione. Se un infermiere uccide la famiglia a Napoli, deve essere per forza matto. Come deve essere matto il padre di famiglia che, in provincia di Milano, ammazza moglie e figlio e, prima di chiamare la polizia, va al pub per vedere la partita con gli amici. Matti sono gli islamisti radicali, i serial killer, i sicari, i boss e i terroristi.
Quando un comportamento ci turba, ci interroghiamo sulle cause e cerchiamo le risposte: “Dava segni di squilibrio”, “Era strano”, “Era fuori di testa”. In ordine sparso, questa sequenza di commenti si accompagna a un pensiero recondito, quasi a una speranza: “Era pazzo, non c’è altra spiegazione”. Perché, per certi versi, è meglio che un gesto difficile da interpretare – un omicidio, per esempio, che non si spiega con i criteri della razionalità – sia frutto di follia.
Ci sono volte in cui le grandi vicende criminali sfuggono a una motivazione razionale: timori di abbandono o tradimento che devastano il pensiero fino a diventare delirio vero e proprio, depressioni oppure altri gravi disturbi della sfera affettiva o della personalità che condizionano i comportamenti. Eppure rabbia, disperazione, incapacità di tollerare stress e frustrazione, sensazione di non avere alternative, odio e vendetta, mancata accettazione della fine di un rapporto oppure uno stile di pensiero rigido non sono necessariamente il prodotto di una mente malata. Liquidare tutto come l’azione di un folle, invece, equivale a dire che una spiegazione esiste. E la spiegazione rassicura.
Quanto più un comportamento umano è lontano dalla normalità, tanto più è intenso il tentativo di ricondurlo in un sillogismo psicologico: “Solo un pazzo può aver fatto quella cosa, io non sono pazzo. A me non accadrà mai”. Un modo, autoconsolatorio, per illudersi di avere il controllo della situazione. La follia funziona da ansiolitico sociale, placa le angosce quotidiane, crea un falso sentimento di sicurezza. E trova terreno fertile in una società disposta a far diventare depressione la tristezza, un disturbo da abbuffata compulsiva la golosità eccessiva, un disturbo cognitivo le dimenticanze ripetute, un disturbo d’ansia l’insicurezza percepita. In questo modo, ogni vizio, ogni singolarità viene bollata.
A ben vedere, la follia, per definizione, è incomprensibile. Invocarla immediatamente come chiave di lettura vuol dire rinunciare in partenza a qualsiasi spiegazione. Proprio come quello tra Bacamarte e le sue teorie pseudoscientifiche, il rapporto tra crimine, potere e malattia mentale è basato sulla ricerca continua della giusta vicinanza.
Le strategie difensive degli autori di reato insistono sull’infermità di mente invocando disturbi indimostrabili, mentre la psicopatologia è chiamata in causa per ogni gesto che sfugge all’immediata comprensione.
È pazzo Enver Hoxha che è ossessionato dal rischio di invasione dei comunisti cinesi, russi e slavi, con cui ha rotto, e riempie la sua Albania di bunker? È pazzo Gheddafi, che ripete ossessivamente: “La mia gente mi ama”? A loro, uno psichiatra potrebbe diagnosticare un delirio. Ma delirio non è la parola giusta, perché forse quelli come Hoxha e Gheddafi non sono in contatto con la realtà secondo un test psicodiagnostico, ma lo sono dal punto di vista politico.
È malato Donald Trump quando crea scompiglio, quando fa a gara a chi la spara più grossa, quando sembra una scheggia fuori controllo? O è solo molto abile a sfruttare le tecniche di comunicazione persuasiva? La Società Americana di Psichiatria ha diffidato gli psichiatri dal parlare di una sua vera o presunta psicopatologia.
È folle Saddam Hussein, quando incendia i pozzi di petrolio mentre si ritira dal Kuwait? Ha un concetto di sé così elevato, e così tipico di ogni dittatore, che quando qualcosa mina l’integrità dell’immagine che ha costruito ai suoi occhi si lascia muovere solo dalla rabbia. E i gendarmi nazisti? Né psicotici né bipolari, bensì criminali. Normali. Lo raccontano le cartelle cliniche del Processo di Norimberga. Lo stesso vale per la maggior parte degli islamisti radicali e dei mafiosi.
Parlare di disturbi mentali, in questi casi, è pericoloso. Farlo significa lasciare intravedere una giustificazione per comportamenti, al contrario, profondamente umani. Perché se è vero che malattia mentale e responsabilità non vanno necessariamente insieme, è altrettanto vero che l’immaginario collettivo considera il matto non responsabile delle sue azioni.
La malattia mentale è un potente strumento per il raggiungimento dell’impunità e la storia è piena di finti pazzi, con esempi di manipolazione perversa della medicina. Nel 2000 viene revocata ad Augusto Pinochet l’immunità parlamentare ma il processo per complicità sulla cosiddetta “carovana della morte”, attraverso cui decine di oppositori furono sequestrati e uccisi nelle settimane successive al colpo di stato dell’11 settembre 1973, è sospeso per motivi medici. L’ex dittatore sarebbe affetto da una demenza vascolare che ha determinato “un significativo deterioramento del modo di agire che gli impedisce di organizzare azioni relativamente complesse”.
La moglie spiega agli psichiatri che il marito confonde le date, confabula (cioè riempie con bugie più o meno consapevoli le lacune di memoria), non riconosce chi lo visita, dimentica eventi importanti, ha perso la capacità di ragionare e risolvere i problemi. Pinochet non è in grado di programmare, organizzare, eseguire azioni in sequenza, rispondere ai problemi posti per mettere alla prova il suo giudizio.
Eppure, analizzando stampa e immagini televisive, l’ex dittatore dedica un’ora al giorno a firmare autografi e a farsi fotografare con il suo popolo, e non mostra i segni tipici della demenza: alterazioni del linguaggio (afasia), incapacità di identificare determinati oggetti e forme (agnosia) e di compiere azioni volontarie (aprassia). Né quelli del morbo di Parkinson che gli è stato diagnosticato.
I figli dicono che ricorda tutto, alcuni giudici che l’hanno interrogato hanno escluso disturbi psichici. Fa shopping per i nipoti, scrive lettere. Una la invia a Margaret Thatcher, e si dice preoccupato per gli acciacchi. Nel giorno dell’anniversario di matrimonio chiacchiera con gli invitati, riconosce tutti, parla normalmente. Nel giugno 2002 frequenta da protagonista il circolo militare Lo Curro e, meno di un mese dopo, la Corte respinge i procedimenti a suo carico: “È un uomo malato con le apparenze di una persona sana”.
Pinochet ha qualche problema fisico, ma la sua memoria è perfetta. Quando decide di dimettersi in Senato scrive di suo pugno il testo della lettera, e ha un’agenda fittissima di appuntamenti. Telefona al comandante dell’esercito per informare le istituzioni sulle motivazioni del suo gesto. Non vi è nel Generale alcun segnale di apatia, un’altra indicazione classica di danno cerebrale. Il 12 luglio 2002 si trasferisce nel nord del Cile per trascorrere l’inverno. È di buon umore, risponde ai saluti. Ancora una volta il malato cammina, sorride, va in chiesa la domenica.
Considerando il suo comportamento e la sentenza che lo considera incapace di partecipare al processo, c’è una contraddizione: o le informazioni mediche sono state falsificate, oppure Pinochet si è completamente ripreso da una malattia incurabile. La farsa imbarazza governo e tribunali, che devono delle spiegazioni ai parenti delle vittime, dei desaparecidos, delle persone torturate e giustiziate nei diciassette anni di governo. Due anni dopo, nel 2004, la Corte d’Appello di Santiago vota per revocare il suo stato di demenza e, quindi, la sua immunità.
È pazzo Enver Hoxha che è ossessionato dal rischio di invasione dei comunisti cinesi, russi e slavi, con cui ha rotto, e riempie la sua Albania di bunker? È pazzo Gheddafi, che ripete ossessivamente: “La mia gente mi ama”?
Il dottor Bacamarte fa e disfa. Rinchiude il paese e poi libera tutti. A Itaguaí, chi è sano di mente forse è impazzito, chi è matto sembra il più saggio dei cittadini. La follia può diventare un gioco di ruolo. Se trasformare un comportamento in patologia apre la strada dell’impunità, l’infermità può essere un controsenso irrisolvibile per chi rivendica la proprietà psicologica delle sue azioni. Perché, in ultima analisi, accettare la malattia come via di fuga dipende da quanto si è disposti a disconoscere se stessi.
(…)
L’alienista racconta il tentativo del potere politico di venire a patti con la psichiatria. Chi guida la rivolta contro la Casa Verde avvicina il dottor Bacamarte, lo blandisce, ci si accorda sottobanco e lo trasforma in paladino armato contro ogni dissidenza. A Itaguaí, la follia diventa strumento di controllo per chi non si uniforma alle norme sociali. A Itaguaí, come ad altre latitudini meno letterarie, la psichiatria cade nel tranello di sentirsi dipendente dai contesti politici del tempo.
Radovan Karadžic´ è uno psichiatra un po’ maldestro, di formazione junghiana. Vivacchia in ospedale, fra consulenze compiacenti e certificati falsi per anticipare il pensionamento di qualche collega. Viene ingaggiato dalla squadra di calcio Stella Rossa di Belgrado, da cui è cacciato pochi mesi dopo e bollato come ciarlatano. Prima di essere condannato per genocidio, per il massacro degli ottomila musulmani di Srebrenica nel 1995, e per crimini di guerra e contro l’umanità, con le sue tesi sulla razza offre il sostegno teorico al nazionalismo serbo.
Stabilisce a tavolino il progetto di distruzione psichica del nemico attraverso gli stupri. Che in BosniaErzegovina non sono una conseguenza del conflitto, ma un programma strategico di pulizia etnica. Gli stupri devono dimostrare alla comunità musulmana bosniaca l’incapacità del maschio di difendere la donna. Devono annientare la cultura del territorio, intrisa di religione, del valore sacro attribuito alla famiglia e dei concetti di onore e dignità personale.
Queste teorie macere di psicologia, storia e genetica, sostengono chi uccide e sevizia, sono l’ombrello che ripara dal peso morale delle atrocità commesse. Diventano il parafulmine per Željko Ražnatovic´, noto anche come Arkan, quando guida le milizie paramilitari, le sue “tigri”. Pasticciere, tifosissimo della Stella Rossa, una vita tra le galere di mezza Europa compreso San Vittore a Milano, si serve di delinquenti sadici e violenti selezionati con cura nei manicomi criminali, e utilizza le caratteristiche più perverse della personalità come arma per ogni tipo di sopruso.
Psichiatri sono Werner Heyde, il direttore del progetto di eutanasia nazista, e Irmfried Eberl, il capo di Treblinka, l’unico medico messo alla direzione di un campo di sterminio. Psichiatra è Ernst Rüdin, che applica i principi dell’eugenetica alla psichiatria. Julius Wagner-Jauregg, Premio Nobel per la medicina, sostiene la sterilizzazione dei malati di mente.
Teorie macere di psicologia, storia e genetica, sostengono chi uccide e sevizia, e sono state, nel secolo scorso, l’ombrello che ripara dal peso morale delle atrocità commesse.
Gli alienisti del Terzo Reich svolgono un ruolo cruciale nel successo della politica nazista. Fondano le loro azioni su una pratica pseudoscientifica che rinnega ogni conoscenza della psichiatria, lasciano che il mito del superuomo e la difesa della razza occupino il campo medico e partecipano attivamente all’Aktion T4, il programma di sterminio dei disabili.
Gli esperti della mente segnalano pazienti, pianificano attività, coordinano i trasferimenti nelle camere a gas dei pazienti di sei istituti psichiatrici sparsi sul territorio: Brandeburgo, Grafeneck, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg e Hadamar, manomettono i certificati di morte degli scarti della società. In nome dell’igiene razziale, cercano di impedire la diffusione della malattia mentale che mina il programma della purezza ariana. Riducono il sovraffollamento degli ospedali psichiatrici, tentano di frenare la trasmissione genetica della follia. Ma la principale motivazione che li orienta ha poco di sanitario e molto di economico: la propaganda nazista spiega, infatti, che per mantenere fino a ventidue anni una “vita indegna” nata in manicomio serve l’equivalente necessario a sostenere quaranta famiglie povere e con molti figli.
Alcuni docenti si lamentano della cremazione veloce dei cadaveri. Meglio prelevarne prima i crani per consentire le ricerche di quello che non era riuscito a trovare il dottor Bacamarte a Itaguaí: la sede della malattia mentale. Gli psichiatri sono tanto interessati agli studi di eugenetica di Joseph Mengele che fanno la fila per lavorare o assistere agli esperimenti, e la Wehrmacht è costretta a richiamarli all’ordine.
Protestano in pochi. Gottfried Ewald lo fa apertamente: durante una riunione convocata per acquisire la disponibilità degli psichiatri più influenti della Germania, spiega che i pazienti schizofrenici, i candidati all’eutanasia, avrebbero potuto trarre beneficio da nuove terapie. Ma si tratta di resistenze silenziose e di iniziative singole che consentono solo a pochi pazienti di salvarsi.
Il programma Aktion T4 è interrotto improvvisamente a metà del 1941, quando l’obiettivo originario, l’uccisione di settantamila persone, è stato superato di 273 unità. Ma il genocidio di pazienti prosegue, anche in Italia. Nell’autunno del 1943, Trieste diventa una centrale dell’Olocausto e l’anno successivo, quando in città arriva l’ex capo di Treblinka, Franz Stangl, Venezia si trasforma in uno degli ultimi luoghi di annientamento di malati ebrei.
Il genocidio dei pazienti con disturbi mentali in Germania è il più grande atto criminale nella storia della psichiatria. Anche per la banalità demoniaca degli psichiatri nazisti vale quella miscela che guida chi abbraccia la svastica e che, forse, non potrà essere mai compresa fino in fondo: non la coercizione in senso stretto, ma una dinamica legittimata dal contesto, il peso delle conoscenze scientifiche dell’epoca, la pressione esercitata dai colleghi, l’etica sovvertita dall’ideologia, la promozione di interessi personali, un certo antisemitismo radicato nella società tedesca, il rischio – intrinseco nella professione di psichiatra – di disumanizzare i pazienti e quello, sempre presente, di impregnazione ideologica della professione.
Estratto dall’introduzione di Italian Psycho. La follia tra crimini, ideologia e politica. (minimum fax, 2021).