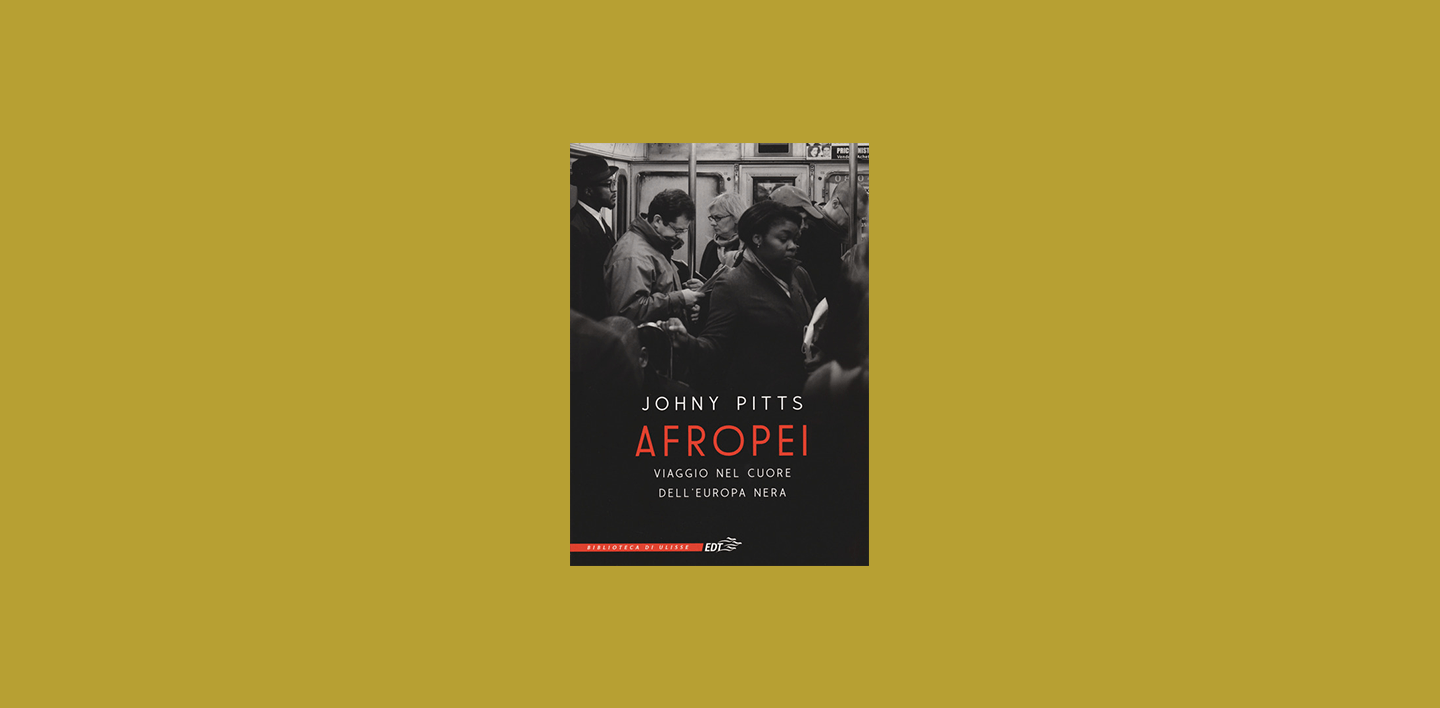C
os’è Afropea? È un’utopia. Un luogo della mente e fisico, culturale ed artistico quanto politico e sociale. Originariamente è un neologismo coniato negli anni novanta dalla cantante belga-congolese Marie Daulne e da David Byrne per descrivere il suono dei musicisti europei afrodiscendenti. Johny Pitts, nato in Inghilterra da madre inglese e padre afroamericano, spiega come il concetto lo abbia “incoraggiato a vedermi come un’entità integra e senza trattini […] uno spazio in cui la tradizione nera contribuiva a dare forma all’identità europea. Indicava la possibilità di vivere in, e con, due concetti diversi: l’Africa e l’Europa, o per estensione il Sud del mondo e l’Occidente, senza sentirsi misti, mezzo quello e mezzo questo”.
Johny Pitts è un fotografo, giornalista, presentatore e musicista inglese. Una profonda crisi personale (la fine di una lunga relazione, con il conseguente ritorno da Londra alla casa d’infanzia nel nord operaio dell’Inghilterra) si sovrappone a una “crisi” che lo accompagna da tutta la vita e che condivide con qualche milione di persone: Pitts è infatti un cittadino nero che abita in Europa. Per provare a rispondere alle innumerevoli domande, personali e non, che la sua esistenza racchiude, insomma semplicemente per “dare un senso a questo fatto […] una fredda mattinata d’ottobre sono partito in cerca degli Afropei”. Quello di Pitts non è un saggio o un rigoroso lavoro accademico – e non ha pretese di questo tipo. È un reportage di un viaggio attraverso il vecchio continente durato quasi sei mesi, visitando e pernottando in otto nazioni diverse e altrettante città: Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Berlino, Stoccolma, Mosca, Marsiglia, Lisbona (con un fugace passaggio romano). Pitts presta il suo sguardo ai lettori, fornendo continuamente prospettive inedite da cui osservare il continente Europeo e non solo. Il conflitto è continuo, quasi estenuante: conflitto nei confronti della narrazione Europea dominante, certo, ma spesso anche con le diverse narrazioni nere e perfino con quella personale ed interna all’autore.
Il fatto che un viaggio del genere in qualche modo parta dalla musica è tutto meno che casuale. Il padre dell’autore è un musicista afroamericano arrivato in Inghilterra negli anni sessanta, trovando qui più successo che in patria. Un destino comune a molti musicisti americani, durante gli anni ’60 e ’70, sulla scia della voglia matta di black music da parte della classe operaia del Regno Unito – The Commitments (libro e film) di Roddy Doyle nella sua leggerezza è indicativo del fenomeno. Per Pitts “la musica è uno strumento potentissimo: convoglia informazioni astratte, suggerisce un modo di stare al mondo, uno stile di vita. […] Abbiamo bisogno di situazioni in cui incontrarci.” È insomma uno strumento entro cui interagire a tutte le latitudini. Da un punto di vista di storia e grammatica musicale, la maggior parte dei generi musicali più influenti e popolari del ventesimo e ventunesimo secolo sono di derivazione africana (dell’ovest nello specifico), caraibica ed afroamericana. Spesso quindi la musica è stato il principale, seppur non unico, media a convogliare ed introdurre nel discorso mainstream le istanze culturali, sociali e politiche di questi gruppi: dall’Harlem Reinaissance alla négritude, il panafricanismo, la créolité, il Black Arts Movement (BAM), più in generale ancora l’arte e la letteratura postcoloniale. La storia di generi come reggae, jazz, afrobeat, hip-hop è spesso intrecciata a queste correnti. Spesso poi artisti e musica si sono spinti ancora più in là, suggerendo e provando a sintetizzare un’identità nera transnazionale primeggiante, impenitente e coesa nel suo essere diasporica.
L’universo afroamericano, non ultima la musica e la sua iconografia, spesso continuano ad essere il punto di riferimento per le comunità nere europee.
Tutto ciò oggi sembra apparire chiaro osservando gli Stati Uniti (la musica, le mode), lo è meno quando guardiamo l’Europa. Lo stesso Pitts mentre si trova a Parigi, prima tappa del viaggio, nota come “l’America esporta la propria tradizione nera, l’Europa no.” Nella capitale parigina una visita guidata insieme ad una coppia di afroamericani diventa l’occasione per stabilire la netta differenza che intercorre tra mentalità americana ed europea. In questo modo il discorso si dirige sottilmente su dei binari che intrecciano quasi tutti gli studi culturali e postcoloniali, cui Pitts spesso si appoggia nel suo discorso: quelli della lotta di classe. La storia e la cultura afroamericana hanno egemonizzato lo spazio culturale e politico nero contemporaneo, valicando di gran lunga i confini razziali. Leggendo Pitts ci viene ricordata una cosa scontata: gli afroamericani sono prima di tutto americani, solo dopo neri – un tratto sottolineato a modo loro da diversi intellettuali afroamericani come Amiri Baraka o più recentemente Margo Jefferson.
Per un americano quindi, Parigi deve essere il souvenir che gli viene venduto in patria. La città romantica dei film e delle poesie, con i caffè sempre aperti, l’arte scrupolosamente catalogata nei suoi musei. Per un afroamericano benestante poi, Parigi è anche la città solo apparentemente priva di razzismo che durante il novecento ha accolto molti esuli illustri, sfiancati dagli abusi statunitensi: James Baldwin, Richard Wright, la maggior parte delle leggende del jazz e della musica afroamericana. Non può essere quindi Chateau Rouge e Barbès Rochechouart, con la loro esplosione di vita multicolore e disorganizzata; non può essere la segregazione legale delle banlieux, sparse come sgraziata vegetazione spontanea a qualche chilometro dal centro. L’incomunicabilità culturale ed i rispettivi stereotipi tra Stati Uniti ed Europa non fanno sparire il cortocircuito. L’universo afroamericano, non ultima la musica e la sua iconografia, spesso continuano ad essere il punto di riferimento per le comunità nere europee. Quando Pitts ha l’occasione di parlare con un attivista mentre si trova a Clichy-sous-Bois (un comune ad appena quindici chilometri dalla capitale, il luogo da cui sono partite le rivolte delle banlieu nel 2005) questi ribadisce a più riprese come l’America “è ancora un modello da seguire. […] le varie comunità hanno un potere economico, alla fine è quello che conta davvero.” È lo stesso Pitts a rimanere interdetto da questo sguardo costantemente rivolto al di là dell’Atlantico.
Trovo preoccupante l’ossessione per l’America degli attivisti neri in Europa. Quasi tutti si concentrano sull’inserimento dei neri in un sistema neoliberista, dimenticandosi che quella forma di capitalismo è stata costruita sull’assoggettamento delle comunità nere. Il capitalismo è per sua stessa natura razzista: ha trasformato gli afroamericani in una merce e ha fatto altrettanto con la loro cultura.
Certamente non tutti gli attivisti francesi o europei smaniano per competere in un sistema neoliberista che sembra essere sempre sul punto dell’implosione. L’esperienza di Pitts è preziosa ma non assoluta. Ma è proprio nel suo essere parziale, a volte lacunosa, che manifesta la sua importanza. Johny Pitts è un mosaico astratto di identità diverse: inglese, quindi europeo ma ormai non più facente parte dell’UE; detentore del passaporto inglese ed americano; troppo nero per essere bianco, spesso troppo bianco per essere nero; di estrazione operaia e periferica ma con una bella e difficile carriera “creativa” nella capitale inglese. Il suo sguardo, o meglio, il suo intreccio di sguardi, è il primo e più caotico elemento d’interesse di un libro che nel caos prospera e diventa sempre più interessante, ingarbugliato – a tratti controverso.
Data la dichiarata identità composita (e la sofferenza che ne deriva), appare chiaro perché Pitts sia affascinato e parta alla ricerca di un concetto unificante quanto inesistente come quello di afropeo. È quasi straziante infatti come questa visione utopicamente unita della realtà nera europea sia messa a durissima prova fin dai primi passi del suo viaggio. Lo stesso attivista francese gli fa notare come ovviamente in Francia “non c’è un’identità nera collettiva: gli africani occidentali se ne stanno per i fatti loro, così come i caraibici e i magrebini” un concetto che viene ribadito da personaggi diversi in ogni paese che Pitts attraversa. L’idea ingenua e intrinsecamente razzista cui potremmo andare incontro all’inizio infatti, è quella che ogni persona afrodiscendente incontrata da Pitts nel suo viaggio sia come il pezzo di un puzzle che deve semplicemente essere messo insieme; o meglio, che aspettava qualcuno per essere messo insieme agli altri. Una cornucopia di figure con in comune il colore della pelle, che altro non devono fare se non incontrarsi per stabilire un fantomatico senso di comunità istantanea. La realtà dei fatti incontrata da Pitts, e noi con lui, è ovviamente un’altra. I pezzi non combaciano quasi mai: a volte per un nulla, altre per un abisso di differenze culturali ed economiche: “ero frustrato dalla corruzione e dalla ridicola disorganizzazione dei consolati africani in Europa, e scioccato dalle spaccature interne al mondo arabo; dal disprezzo dei turchi per i curdi, dall’odio fra etiopi ed eritrei, o fra marocchini ed algerini.” È di nuovo la musica che gli viene in soccorso. Mentre si trova in Belgio l’autore assiste ad un concerto di Marie Daulne, artista di origini congolesi; in mezzo all’entusiasmo del pubblico composito e stratificato, etnicamente quanto socialmente, realizza che “all’inizio del viaggio in Europa avevo sperato di trovare Afropea in una realtà geografica, ma dopo aver assistito allo spettacolo, e visto l’effetto che aveva avuto sul pubblico, compresi che il sogno dell’utopia afropea doveva prima di tutto nascere nel reame delle idee.”
Nel reame delle idee, certo, ma dei luoghi fisici ci sono eccome: le periferie. È il leitmotiv del viaggio di Pitts in tutte le città che visita. Dopo un’annusata al centro cittadino, la sua ricerca delle comunità nere assume immancabilmente un moto centrifugo che lo porta a diversi chilometri di distanza dalle attrazioni principali. Viene alla mente Remoria di Valerio Mattioli, un libro fondato proprio sulla contrapposizione ideologica tra il concetto di centro e quello di periferia. Il senso è, come ribadiva Mattioli in un’intervista, che “il centro è innanzitutto un’ideologia, a partire dall’idea che a definire il centro è il confine, il limite. Dentro quel confine puoi aspirare allo status di cittadino e di appartenente a una comunità che si autoqualifica come unica portatrice di ciò che è legittimo e ciò che non lo è; fuori da quel confine sei solo merda, rifiuto, scarto. […] Prima ancora che ‘i quartieri di periferia’ in senso urbanistico-geografico, la periferia è il negativo dell’ideologia del centro.” In che cosa si identifica l’ideologia del centro ed il suo negativo, nel senso del viaggio intrapreso da Pitts ed in quello delle contemporanee città giocattolo?
Nell’ideologia coloniale, come non manca di ricordarci l’autore dall’inizio alla fine. Il centro è il colonizzatore, le periferie le sue colonie. Così come per centinaia di anni paesi hanno prosperato grazie alle risorse prime e la mano d’opera delle colonie avendole spesso alla giusta distanza (in una versione degenerata del detto “lontano dalla vista lontano dal cuore”), così gli appartenenti alle ex colonie – e allargando in generale, ogni tipologia di immigrato – viene comodamente sistemato lontano dalla vista. Lontano dal centro insomma, spesso utilizzato per le mansioni più umili (ma indispensabili) e tagliato fuori da tutto il resto. Anche questa una storia “vecchia” e transnazionale, quasi sicuramente ciascuno di noi o vive questa condizione o ha esempi nella propria storia famigliare. Mentre si trova in Svezia, Pitts alloggia in un ostello insieme a Saleh, un buttafuori tunisino che ad un certo punto sbotta: “gli svedesi hanno gli schiavi […] hai visto la signora curda che fa le pulizie qui dentro? Non la troverai mai di giorno, in giro per negozi o in un caffè, perchè serve solo a questo scopo”. Cova de Moura invece è una favela alle porte di Lisbona, nata in modo spontaneo e grazie a mezzi di fortuna “una favela illegale con la sua economia sommersa, dove rinchiudere, lontano dalla vista, le famiglie e i discendenti dei manovali capoverdiani sottopagati. […] un luogo nascosto che ti costringe a mettere in dubbio l’identità e le strutture che si celano sotto la visione grandiosa di Lisbona” un luogo autosufficiente e “rassicurante” nelle sue disfunzionalità, dal quale gli abitanti non si sposterebbero neanche se potessero. Nell’introduzione al Discorso sul Colonialismo di Aimé Césaire, Miguel Mellino ricorda come “il mondo coloniale è un mondo asfittico, paralizzato – alienato, oggettivato, senza tempo né movimento”, un mondo di “straordinarie possibilità soppresse”: in pratica una definizione che, se provate a fare mente locale, avrete sicuramente sentito usare a più riprese nella descrizione delle grandi periferie.
La forma del diario di viaggio permette di operare un sistematico e brutale smascheramento della mentalità coloniale che imperversa oggi in Europa, della sua evoluzione negli ultimi decenni.
Non esiste colonialismo buono. Le periferie sono parte di questo discorso più ampio, che insieme alla critica al sistema capitalistico neoliberale costituisce il fil rouge del libro. La forma del diario di viaggio permette di operare un sistematico e brutale smascheramento della mentalità coloniale che imperversa oggi in Europa, della sua evoluzione negli ultimi decenni. Procedere assieme a Pitts significa osservare i monumenti delle principali città europee illuminati da una lampada ad infrarossi che evidenzia tutto il sangue di cui sono realmente ricoperti. Com’è noto a tutta la critica post-coloniale, si tratta di un processo necessario e doloroso, in modo diverso per coloni e colonizzati “fa sgretolare le fondamenta su cui ti reggi”. Ad esempio Jessica de Abreu, attivista olandese, fa notare a Pitts come “gli olandesi bianchi pensano non solo di essere liberali, disponibili e aperti, ma anche immuni al razzismo, e che quattrocento anni di impero coloniale non abbiano lasciato tracce.” Lo stesso Pitts, dopo l’incontro in treno con un gruppo di razzisti inglesi, ubriachi ed aggressivi, riflette su come per “chi è avvezzo ad un certo tipo di privilegio, l’eguaglianza può sembrare una forma di oppressione”, una frase che se pensiamo ai disturbanti teatrini social giornalieri risuona ancora più macabra. Lo sguardo di Pitts potrebbe apparire spietato nel suo essere invece semplicemente realistico. Ogni mito, da quello di nazione a quello di colonialismo “buono” (“italiani brava gente”), le associazioni umanitarie, i partiti progressisti e tanto altro; tutto implode sotto delle analisi neanche così raffinate, che prendono semplicemente atto di fatti storici comprovati. Quando ci troviamo in mano la polvere di queste cartoline europee bruciate, non proviamo tristezza, ma sollievo. Sarebbe da lanciare in aria quella cenere e ballare sotto i lapilli, festeggiando la liberazione di tutti da una narrativa limitata, ingiusta, falsa, castrante.
Fra gli innumerevoli “luoghi storici trasformati in gingilli”, a Bruxelles Pitts visita quello che suo malgrado diventa il monumento al monumento del pensiero coloniale, il Musée Royal de l’Afrique Centrale – prima della sua restaurazione nel 2018. Un luogo grottesco, in cui la storia degli oppressi è come sempre scritta dagli oppressori e che per un centinaio di anni è stata la destinazione di belgi ed europei per educarsi in modo distorto sulla conquista coloniale del Congo. Tra i corridoi impolverati Pitts cammina in mezzo a vecchissimi animali imbalsamati, fotografie in bianco e nero usate per la propaganda coloniale, cimeli rubati e mai restituiti; fino a scendere nei sotterranei, un sottosopra se possibile ancora più grottesco. Oltre al generale disgusto, Pitts perde le staffe “per la singolarità dei cartelli esplicativi. Dicevano molto, eppure non dicevano nulla. Per esempio non c’era nessuna menzione dei 267 africani non imbalsamati, ma vivi e vegeti, che erano stati importati dal Congo per l’inaugurazione del museo durante l’esposizione internazionale nel 1897. […] Uno dei tanti ‘zoo umani’ che esistevano in Europa nel periodo coloniale.” Pitts cita Henri Cordier “hanno scritto la storia del loro piccolo mondo con la convinzione di scrivere la storia del mondo”. E questo tema, della rappresentazione storica ed artistica (e della potenza della manipolazione a cui sono sottoposte) è ovviamente ricorrente, ed al centro delle pochissime pagine dedicate all’Italia, nello specifico Roma. Qui Pitts si concede un paio di giorni da turista; non può però fare a meno di riflettere, visitando i Musei Vaticani, su quanto sia radicata in lui la rappresentazione divina in forma di uomo bianco con capelli castani ed occhi azzurri; o di come la chiesa cattolica ed i pontefici, committenti di quelle rappresentazioni “avevano concesso la loro benedizione alla prima tratta atlantica degli schiavi”. Il benestare concesso dalla chiesa, tramite una bolla papale (la “Dum Diversa” del 1452 e la sua revisione due anni dopo), spazzò ogni controversia morale sulla pratica dello schiavismo, associandolo al concetto di razza e iniziando in questo modo una stagione di assoggettamento psicologico e spirituale oltre che materiale – i cui meccanismi e danni sono, inutile a dirlo, vivi e vegeti ancora oggi. Di tutte le bolle papali che siamo costretti a subire ed imparare a memoria durante la scuola dell’obbligo, questa sembra sempre sfuggire.
Insomma, il libro di Pitts non si stanca mai di prendere in contropiede il lettore (bianco, si intende), di farlo sentire ingenuo, stupido, in colpa. Episodio emblematico è quello in cui l’autore si trova a Berlino, nel mezzo di una delle più importanti manifestazioni Antifa – nello specifico l’evento annuale in ricordo di Silvio Meier, militante della sinistra extraparlamentare accoltellato a morte nel 1992 da un gruppo di estrema destra. Qui siamo catapultati nel turbinio di emozioni provate da Pitts, che si dichiara a priori socialista: dalla diffidenza verso la massa di Antifa (“se mi avessero chiesto di immaginare un raduno di neonazisti, avrei descritto proprio la scena che avevo davanti agli occhi: centinaia di teste rasate vestite con uniformi nere e stivali con la punta d’acciaio, e bandiere con i colori del nazionalsocialismo”) allo sconcerto dopo aver intuito che “i manifestanti fossero lì soprattutto per divertirsi”, visti i camion con Bob Marley a volume altissimo, l’alcol, le esplicite provocazioni nei confronti degli agenti, la certezza di successivi scontri con la polizia ed il “terzo tempo” alcolico e festaiolo già organizzato. Agli occhi di Pitts il tutto appare come “uno spazio sicuro in cui flirtare con il proibito” in cui sono sbandierati a perdita d’occhio slogan antirazzisti ma è “palese l’assenza della comunità nera” dal momento che “l’atmosfera della manifestazione sembrava scoraggiarne la partecipazione”. Molto banalmente, una persona nera non può permettersi di protestare in questo modo, non c’è spazio per la leggerezza, come spiega efficacemente Pitts:
Tutte le volte che mi sono ribellato, anche se è accaduto nell’”illuminato” ventunesimo secolo, ho avuto l’impressione di portarmi appresso il fardello di un intero popolo. […] Gli atti di resistenza sono considerati legittimi se vengono effettuati dai bianchi, ma assumono una connotazione radicale e pericolosa se vengono compiuti dai neri.
Il tumulto che prova Pitts è quello di una persona che sa di vivere in una società che tutt’oggi giudica con due pesi e due misure la gravità della violenza fisica, a seconda del grado di melanina presente nella pelle della vittima. Se sai di rischiare il pestaggio (o molto peggio) anche solo ad un controllo di routine della polizia, o incontrando durante una passeggiata un razzista su di giri, una manifestazione come quella descritta deve apparire terrificante e fuori da ogni ragione. I cartelloni contro il razzismo e la musica di Bob Marley diventano un mero gioco estetico, un tratto identitario vuoto al limite dell’offensivo – tutto fuorché inclusivo o mirato ad ottenere veramente ciò che i cori fanno riecheggiare per le strade blindate.
Johny Pitts non trova Afropea. Sente di andarci vicino mentre si trova a Marsiglia, una città entro cui “gli ingredienti separati hanno marinato nelle stesse spezie nord-africane, sotto lo stesso tetto.” Ma ovviamente non esiste una cultura nera ed europea univoca, chiusa e definita. Seguendo il più stanco degli stereotipi qui non è tanto la destinazione ad importare, quanto il viaggio stesso. Pitts trova infatti “frammenti sparsi dell’esperienza afropea, un mosaico non monolitico, ma neanche amorfo”. Il suo personalissimo viaggio non è esente da semplificazioni – ad esempio c’è poco su uno dei temi al centro della politica europea degli ultimi decenni, l’immigrazione; o sullo stato dei rifugiati politici e delle politiche in merito; o ancora sulla distinzione netta tra questi e gli immigrati di seconda e terza generazione. Ha però diversi meriti: forse il più esplicito, oltre alla sistematica ed efficace decostruzione coloniale, è quello di ben allineare quel discorso alla lotta di classe, ricordando come, soprattutto negli ultimi decenni “la presenza dei neri sia stata trasformata in una minaccia anziché un’opportunità per rafforzare la classe operaia”, qualunque cosa voglia dire classe operaia nel 2021. È anche un promemoria fortissimo, simile a quello invocato da D. Hunter nel suo “Chav. Solidarietà Coatta”: le modalità di resistenza le devono decidere gli oppressi e le minoranze che sono direttamente colpite dagli abusi di qualunque tipo. Bisogna ascoltare loro, non imporsi anche se sotto forma di alleati. Altrimenti il tutto diventa l’ennesima esercitazione di un privilegio autocompiacente. Il libro di Pitts seppur da non prendere come un testo infallibile, possiede delle qualità didattiche naturali e non pesanti, e per questo sembra destinato più che altro ad un pubblico “bianco”. Soprattutto nel suo diventare una ricca e preziosa bibliografia di diversi autori e studi (che Pitts cita ad ogni pagina), lasciando trasparire l’enorme profondità delle diverse correnti di pensiero da cui attinge. Correnti che sono sistematicamente ignorate, nascoste o presentate come non rilevanti all’esperienza europea caucasica.
Afropei è in fin dei conti un libro umano, intriso di umanità, anche grazie alle belle foto scattate dall’autore:
Era uno dei motivi per cui avevo deciso di viaggiare in inverno: affinché le mie fotografie fossero diametralmente opposte alle baggianate tropicali che troppo spesso vengono associate alla cultura nera. Non volevo solo feste in strada e carnevale, ma pendolari stanchi e la banale umanità della vita quotidiana, che è più vicina alla realtà dell’esperienza nera in Europa: non passiamo tutto il tempo a ballare, cantare e sorridere.