


I n questa recensione definirò Yoga, il nuovo libro di Emmanuel Carrère, un libro fallito, e cioè un libro che viene meno alle proprie premesse. È fallita anche questa recensione, nella misura in cui la premessa di una recensione è quella di offrire uno sguardo il più possibile obiettivo su un libro, cioè in grado di discernere ciò che è da ciò che sostiene di essere.
Due giorni fa, Helène Devynck, ex moglie di Carrère, ha pubblicato su Vanity Fair un articolo intitolato “Diritto alla risposta” in cui parla di Yoga. In Yoga Devynck appare solo lateralmente, ma in un modo comunque molto influente. La depressione raccontata nella parte centrale del libro era legata al suo divorzio da Carrère, per ragioni che l’autore passa sotto silenzio perché “riguardano altre persone”.
Nel suo articolo Devynck spiega innanzitutto che questo riserbo, che Carrère motiva col tatto, era in realtà una condizione legale del loro divorzio, in cui Devynck ha chiesto di stipulare, giustamente, che la sua vita privata non fosse più in mano alle fantasie letterarie del suo ex. Poi racconta che, per dare mostra di rispettare questo vincolo, Carrère le aveva inviato un manoscritto di Yoga prima della pubblicazione, spiegando che alcune cose aveva dovuto dirle comunque perché il libro non avrebbe avuto senso “senza contesto”.
Scrive Devynck: “Il contesto ero io.”
L’articolo di Devynck contiene varie rivelazioni che gettano una luce pessima su Carrère, per ragioni diverse. Il silenzio che orgogliosamente rivendica come prova di sensibilità – lui che scrive sempre tutto, stavolta tace! – si rivela imposto da un giudice. L’intimità di una ex moglie risulta comunque violata da svariati passaggi che si è rifiutato di espungere, pur essendosi impegnato a non farlo (e Devynck, molto sensatamente, inquadra questo episodio nella cornice del consenso: lei lo aveva dato e poi lo ha tolto, ma l’uomo che ha sentito un sì non accetta più un no). Varie parti del libro, presentato come non-fiction, si rivelano rimaneggiate quando non inventate di sana pianta. Il racconto “straziante” e “onesto” della depressione ha omesso gli episodi di aggressività, e le manie di grandezza, e la presenza costante della moglie. I due mesi passati in Grecia a fare il volontario in un campo profughi, a cui Carrère dedica quasi duecento pagine, si rivelano essere stati pochi giorni. Devynck era anche lì. Nel libro non c’è.
La cancellazione di una donna dalla storia; la sopraffazione dei suoi desideri; la violazione della sua intimità sarebbero di per sé ragioni per rivalutare profondamente la figura morale di Carrère. Le menzogne spudorate in una sezione di reportage – peraltro su un tema politicamente sensibilissimo come la condizione dei migranti – aggiungono alla violazione una gravità letteraria.
Alla luce di tutto questo appare per molti versi fuori bersaglio la recensione che segue, che pur rilevando alcune debolezze di Yoga ne prendeva per buone le premesse cruciali, quelle che Devynck ha mostrato essere false. Eppure, in quanto recensione fallita, può risultare interessante in quanto documento del proprio fallimento. Parlando dell’articolo di Hélène Devynck poco dopo la sua uscita, Claudia Durastanti mi ha detto che in fondo i lettori “sapevano” già, e si bevevano comunque la non-fiction di Carrère per via di una sorta di “insider trading psichico”.
Io ho controbattuto che no, non sapevo. A posteriori non mi sorprende: non ho mai dovuto imparare a diffidare di un uomo che dice “Ti giuro, è tutto vero.” La mancanza di onestà di uno scrittore che ha fatto della propria schiettezza una cifra letteraria non potrà non portare a una rilettura della sua opera passata. A questo punto può essere utile, a ritroso, cominciare con quest’ultima.
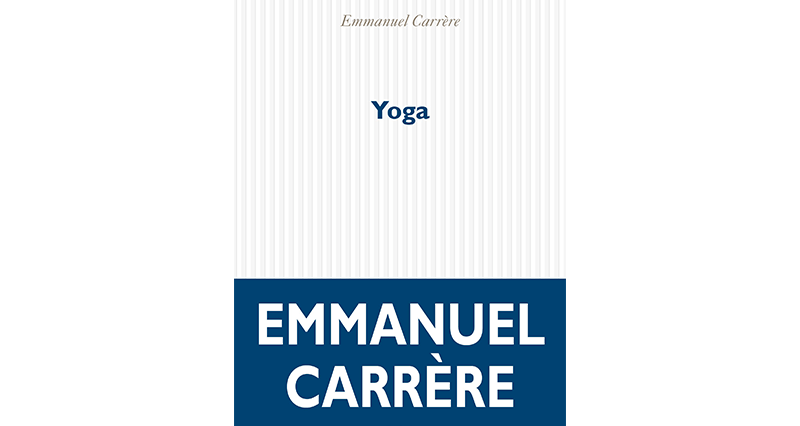
“La letteratura è il luogo in cui non si mente,” scrive Emmanuel Carrère in Yoga, l’unico libro autobiografico, che io sappia, in cui mente. “La meditazione,” scrive anche, in una delle ventiquattro definizioni alternative che propone, “è scoprire che sei qualcosa di diverso da quella parte di te che dice solo io! io! io!“. Nella prima frase del libro, la parola “io” appare otto volte.
Queste contraddizioni saltano immediatamente all’occhio alla lettura di Yoga, che in molti hanno tacciato di ipocrisia o di ingenuità. Ma in qualche misura questo significa travisarne il ruolo, che è un ruolo consapevole e deliberato. La parola “yoga” condivide una radice con l’italiano “giogo”, e l’immagine è esattamente la stessa: se la mente e il corpo sono due cavalli selvaggi, lo yoga è il giogo, l’imbrigliatura, che fa sì che procedano armoniosamente nella stessa direzione. È naturale che a praticarlo (e a scriverne) sia specialmente chi sente che bizzano e recalcitrano e tirano in direzioni diverse.
In Yoga, i cavalli di Carrère imbizzarriscono.
Yoga si apre col racconto di un ritiro di Vipassana, una scuola di meditazione che prevede che si passino dieci giorni completamente scollegati dal mondo esterno, meditando sempre, senza parlare mai. In maniera simile a quanto fatto col cattolicesimo nella folgorante prima parte de Il regno, Carrère invita il lettore a “prendere la meditazione sul serio”: non come moda da gentrificatori né come pratica di benessere né come espediente per migliorare le proprie prestazioni, ma come percorso di maturazione interiore e di ricerca della pace. Anche il tono è simile, senza l’afflato sapienziale dei guru né l’ottimismo sberluccicante dei libri di crescita personale, ma con una combinazione di autoironia, didascalismo e stupore. Viene usata, senza sarcasmo, la parola “nirvana”.
Carrère è immerso nel silenzio trasognato del Vipassana da quattro giorni quando la redazione di Charlie Hebdo viene massacrata da un commando di terroristi.
Il meccanismo narrativo di Yoga è quell’intreccio di storia personale, saggistica, autoanalisi e racconto aneddotico che Carrère ha perfezionato negli ultimi vent’anni della sua produzione. Ci sono le interazioni con gli altri sconosciuti del ritiro Vipassana; ci sono i ricordi di matrimoni infelici; ci sono i video di guru di arti marziali su YouTube; ci sono le divagazioni storico-letterarie; ci sono le speculazioni paranoiche sul prossimo, e su sé stesso, e sul proprio passato, e sul futuro. Ci sono anche, tipicamente, le scene di sesso, inclusa una lunghissima in cui una sconosciuta, senza una parola, lo porta in hotel alla fine di un seminario di yoga. È qui che viene usata, senza sarcasmo, la parola “nirvana”.
Nelle intenzioni originali di Carrère tutto questo materiale autobiografico, inquadrato narrativamente dai dieci giorni di Vipassana, doveva andare a comporre un libretto “agile e sorridente” che spiegasse la meditazione al suo pubblico. Nelle sue parole doveva essere “una specie di libro di auto-aiuto per lettori colti”. Aveva deciso di scriverlo rendendosi conto, per la prima volta, di essere felice: sposato serenamente, produttivo e di successo, senza episodi depressivi da più di un decennio. La quarta di copertina di questo libretto recita: “Ciò che chiamo yoga non è solo la ginnastica salutare che siamo così tanti a praticare, ma un insieme di discipline che mirano all’ampliamento e all’unificazione della coscienza. Lo yoga dice che siamo qualcosa di altro da quel piccolo ego confuso, frammentato, spaventato, e che esiste un modo di accedere a questo qualcosa. È un percorso, altri prima di noi lo hanno seguito e ce lo indicano. Se ciò che dicono è vero, vale la pena di andarci anche noi.”
Questa non è la quarta di copertina di Yoga.
Carrère è immerso nel silenzio trasognato del Vipassana da quattro giorni quando la redazione di Charlie Hebdo viene massacrata da un commando di terroristi. Una delle vittime, Bernard Maris, era il compagno di una sua cara amica, e lui viene bruscamente richiamato dal ritiro per scrivere l’orazione funebre. Al di là della circostanza tragica – Carrère avrebbe potuto ripetere i dieci giorni in un altro momento – questo episodio lo porta a riconsiderare il senso della meditazione, e quindi del libro che stava scrivendo. Improvvisamente ravvisa qualcosa di cupo, una sorta di rifiuto della vita, nelle cento persone che aveva lasciato a meditare in silenzio nel bosco, ignare del lutto nazionale. Il profilo vitale ed energico di Maris – a cui è dedicata la seconda parte del libro – pare in qualche modo offrire una risposta diversa alle domande che avevano attirato Carrère, e con lui il lettore, alla meditazione.
Eppure non è questo che fa deragliare il libretto “agile e sorridente” sullo yoga: ma un episodio di depressione che lo ha portato a passare quattro mesi in una clinica psichiatrica con una diagnosi di bipolarismo e un approccio terapeutico che includeva la ketamina e l’elettroshock. È questo che racconta nella terza parte, con un misto di vaghezza e brutalità che può essere sia una strategia letteraria che un effetto dei ricordi di quell’epoca. Il fattore scatenante sembra essere proprio l’amante con cui aveva raggiunto il nirvana in un momento non specificato del passato; Carrère lascia intuire che abbia svolto un ruolo in quello che è al contempo il cuore del libro e il suo buco nero, e cioè il suo divorzio.
Dico “divorzio” perché ho letto le interviste, ho visto le recensioni in Francia, ma in realtà in tutto il libro quella parola non viene pronunciata. In quello che è un apax legomenon vertiginoso per uno scrittore che ha costruito la propria identità letteraria intorno alla trasparenza autobiografica, su questo Carrère scrive solo che è successo qualcosa; che è stato questo qualcosa a determinare il suo episodio; e che non lo può raccontare perché riguarda anche altre persone.
Il libro deraglia a partire da un episodio di depressione che lo ha portato a passare quattro mesi in una clinica psichiatrica con una diagnosi di bipolarismo e un approccio terapeutico che includeva la ketamina e l’elettroshock.
La sezione sulla depressione è probabilmente la più potente, e straziante, del libro. Carrère racconta ciò che ricorda della vita in clinica, analizza il lessico degli psichiatri, ricostruisce con una precisione allucinatoria gli attacchi di panico e le vertigini della ketamina e l’elettrochoc. La scrittura di Carrère è spesso capace di una schiettezza tanto spiazzante da far sorgere il dubbio che sia compiaciuta, un modo di rovesciare la vergogna e l’imbarazzo del Carrère-raccontato nell’orgoglio del Carrère-raccontante per la sua sincerità senza remore. Questo dubbio non sorge mai leggendo della sua vita di uomo di mezza età in un piccolo appartamento vuoto, incapace di lavorare o di lavarsi. Il giornalista che verrà a profilarlo per il New York Times – a cui Carrère spiegherà quella casa come soluzione temporanea durante un trasloco – scriverà, nel suo articolo: “he was, in fact, suffering terribly”.
Rimessosi parzialmente, Carrère andrà a ritirarsi nuovamente su un’isola greca dove possiede una villa, trascinandosi svogliato attraverso l’estate fino a quando un incrocio di conoscenze lo porterà su un’altra isola per tenere un laboratorio di scrittura creativa in un enorme centro di accoglienza. A invitarlo e ospitarlo è un’accademica americana di nome Frederica, personaggio tormentato e accattivante con cui in più momenti il lettore potrebbe immaginare un flirt in corso. Alla storia di lei e a quelle dei ragazzini che Carrère conosce – tutti reduci da storie più che tragiche di emigrazione clandestina, tutti lacerati fra una superficie ottimista e un dolore sordo e profondo – è dedicata la quarta, lunga parte del libro, in quella che pare più o meno esplicitamente un’eco di Vite che non sono la mia.
Poi c’è un ritorno; una vita che va avanti; un libro, questo, che si termina; e in chiusura l’immagine, ottimista, di un nuovo amore. Yoga si chiude così, con una dissolvenza in rosa.
È impossibile considerare Yoga senza richiamare i libri precedenti di Carrère. Questo è vero per la ragione, tautologica, che è vero di chiunque scriva; ma in questo caso è vero di più. Dopo un successo giovanile come romanziere, Carrère ha risposto a una crisi di scrittura (raccontata ne Il regno) esplorando la forma specifica di non-fiction che è arrivata a definirlo: usando le sue vicende autobiografiche come via di accesso (per lo scrittore ma anche per il lettore) agli argomenti di cui voleva trattare. Nei momenti più riusciti, che sono tanti, ciò gli ha permesso di accedere a una sorta di oggettività soggettivata, una voce autorevole non perché impersonale ma proprio perché situata. La voce di Carrère è quella di una persona che racconta al lettore, con autoironia e lucidità, le parti del suo vissuto che l’hanno portata a interessarsi a un dato tema e gli aspetti di sé che ne hanno determinato la prospettiva. Questi temi sono stati, lungo l’arco della sua carriera, l’assassino Jean-Claude Romand e il letterato para-fascista Edouard Limonov; un certo tipo di russità in Francia e il Vangelo secondo Luca. Nel libretto agile e sorridente di cui qui si racconta il naufragio, quel tema doveva essere la meditazione. Ma non è quello il tema di Yoga. In Yoga, il tema a cui Carrère accede tramite la propria autobiografia è l’autobiografia di Carrère.
Da un certo punto di vista questo è in linea con la crescita o l’approfondimento dell’io narrante lungo vent’anni di produzione di non-fiction. Ne L’avversario, il primo, Carrère figurava principalmente come autore che cerca di comprendere l’assassino di cui scrive: la sua interiorità entrava in gioco poco. Qualcosa di simile vale di Limonov. Non così ne La mia vita come un romanzo russo, in cui viene schierata molta della sua storia familiare, come anche – nonostante il titolo – in Vite che non sono la mia. Il regno, il suo ultimo, si apre con una lunga sezione che racconta con estremo dettaglio un periodo doloroso della sua vita adulta. Da questo punto di vista, gli ultimi vent’anni di libri di Carrère rappresentano un atto di graduale sostanziazione che culmina con Yoga: il lento perfezionamento di una macchina stilistico-epistemologica che, macinando i temi più disparati, si è ritrovata a produrre qualcosa che col tempo si è fatto via via più simile alla figura di Carrère stesso.
La cancellazione di una donna dalla storia; la sopraffazione dei suoi desideri; la violazione della sua intimità sarebbero di per sé ragioni per ripensare profondamente la figura morale di Carrère.
Nel corso di Yoga, questa macchina manda segnali di anomalia. L’episodio taciuto che ha scatenato la depressione di Carrère è legato, nel suo racconto, all’amante senza nome con cui aveva raggiunto il nirvana. Verso la fine del libro, Carrère ammette che quella vicenda è frutto in certa misura di invenzione letteraria, come anche la figura di Frederica, al centro della quarta parte. È difficile esagerare la stranezza di questa circostanza: e non solo perché, in teoria, l’intero costrutto stilistico ed epistemologico della letteratura di Carrère si basa sulla verità di ciò che dice di sé e del suo punto di vista; ma anche perché, crucialmente, entrambe queste figure fungono da cardini fra le varie parti di cui si compone il romanzo. L’amante misteriosa è ciò che collega lo yoga alla depressione. Erica è ciò che collega la depressione alla crisi dei migranti. Se entrambe le figure sono rimaneggiamenti o fiction, le parti risultano scollegate, giustapposte.
Uno dei punti in cui ciò è maggiormente evidente è il passaggio fra la seconda e la terza parte – e cioè fra la crisi del libro sullo yoga dopo l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo e l’episodio depressivo vero e proprio. Quest’ultimo è raccontato senza alcun riferimento cronologico, e al di là di qualcosa di labile e arbitrario come l’ordine dei capitoli non vi è alcuna indicazione che sia avvenuto una settimana e non sei mesi o due anni più tardi. Il libro “agile e sorridente” era già naufragato. Se Yoga è un libro sullo yoga (o sul fallimento di un libro sullo yoga), la depressione e ciò che segue non vi hanno spazio. Se è un libro sulla depressione, non si capisce come mai aprirlo con duecento pagine di autopsia di un libro fallito. L’unica cosa che i due temi hanno in comune è che hanno fatto soffrire Emmanuel Carrère. La macchina stilistico-epistemologica, dopo aver macinato tutto, si trova a macinare se stessa.
Chi soffre è insicuro di tutto ciò che non sia l’immediatezza del dolore. Non sorprende rendersi conto che Yoga è costellato da segnali di insicurezza. Alcuni sono consapevoli, altri no.
“So che questi ricordi sono interessanti solo per me ed Anne e i ragazzi,” scrive Carrère dopo una pagina in cui ha rievocato certe estati di famiglia in Bretagna, in cui aveva da poco iniziato a meditare, “ma non importa, non importa, lettore, bisogna sopportare che chi scrive racconti cose del genere e non le tagli in rilettura, come sarebbe ragionevole fare.”
Superficialmente, questa è una smargiassata, la dimostrazione di forza di un autore narcisista e tanto sicuro di sé da riconoscere che un paragrafo è compiaciuto e superfluo e decidere di includerlo comunque. Ma sotto la superficie non c’è niente. Carrère non è nuovo al narcisismo delle dimostrazioni di forza autoriale – basti pensare che Il regno, un libro in cui parla del Vangelo, si apre con duecento pagine in cui parla di Carrère. Ma, appunto, ne parla con tanto brio e tanta lucidità e tanta profondità e tanta ironia che il lettore è ben contento di farsi trasportare nei suoi ricordi privati, e a nessuno – men che meno a Carrère stesso! – verrebbe in mente che potessero non essere interessanti. È l’autore a renderli tali. Qui non è più tanto certo di esserne in grado.
In Yoga la combinazione degli elementi eterogenei, tipica di Carrère, non si affianca ad alcuna fiducia nella possibilità di una loro sintesi produttiva.
Altri segni di insicurezza sono meno consapevoli di così, ma altrettanto palesi. Ad esempio, la prima parte del libro – più di 150 pagine di agili e sorridenti osservazioni sulla meditazione – è costellata di profezie e richiami della catastrofe che sta per abbattersi su Carrère. Oltre a una prima pagina che menziona il terrorismo jihadista e la crisi dei rifugiati – e una data, gennaio 2015, che abbaglia un lettore francese come un razzo di segnalazione – ogni quindici-venti pagine Carrère sente il bisogno di ricordare che tutta quella pace e distensione finirà, che il sugo della storia è in arrivo. Se fosse un espediente per creare atmosfera, la prima pagina (o se è per questo la quarta di copertina, identica) sarebbe bastata. È evidente che c’è qualcosa di più: Carrère ha paura che il lettore si annoi. L’idea del libro agile e sorridente, che gli pareva vincente quando si sentiva vincente lui stesso, gli sembra scialba e noiosa. Anche qui, invita il lettore a “sopportare che chi scrive racconti cose del genere”, promettendogli che arriveranno i fuochi d’artificio non ora, non ora, ma presto.
Alla disarticolazione strutturale si affianca, nel libro, anche una frammentazione del testo vero e proprio, suddiviso in capitoli brevissimi e titolati con sintagmi o frasi che riprendono – anticipandoli, commentandoli, ironizzandovi – i contenuti del breve testo a seguire. La tecnica, di per sé, è più o meno tradizionale, ma per Carrère è una novità e risulta difficile non considerarla alla luce dell’atmosfera generale del libro come una sorta di rassegnazione epistemica. La cifra letteraria degli ultimi vent’anni di produzione di Carrère era la composizione degli insolubili – unire autobiografia e indagine sul Vangelo, la vita di uno scrittore borghese e quella di un assassino impostore, e in quell’unione sintetizzare una consapevolezza illuminante o una verità profonda. In Yoga la combinazione di elementi eterogenei c’è, ma ad essa non si affianca alcuna fiducia nella possibilità di una loro sintesi produttiva. Ecco, sembra dire l’autore, qui c’è un riassunto del mio primo stage di tai-chi. Qui il mio discorso funebre per Bernard. Qui la quarta di copertina del libro che non ho scritto. Qui un resoconto dell’elettroshock. Qui una scena di sesso. Dev’esserci un filo conduttore di senso in tutto questo, lettore: ma devi trovarlo da te.
Ho detto “insicurezza”, ho detto “rassegnazione”. Carrère dice “depressione”, riferendosi unicamente al contenuto di una certa parte del libro. La sensazione alla lettura è che qui la depressione sia anzitutto nella forma: appunto, una forma esitante, insicura tanto del merito delle parti che mette insieme quanto della propria capacità di congiungerle in un tutto che risulti in qualche modo valido e compatto.
Questo rende ogni analisi del libro un’operazione moralmente ambigua, perché quelle che da un certo punto di vista sono sue mancanze oggettive, da un altro appaiono inscindibilmente, seppur involontariamente, legate alla sua ragione profonda, al suo tema. In un certo senso, un libro limpido ed efficace sulla depressione scritto in uno stile brillante e controllato risulterebbe insincero e in ultima analisi contraddittorio.
È fuor di dubbio che questo libro su un libro fallito sia a propria volta, in un certo senso, fallito. I materiali che assembla risultano eterogenei e disarticolati. La voce che li racconta pare a tratti quasi un’imitazione di quella di Carrère, altrettanto talentuosa nella superficie ma con qualcosa di carente in profondità, uno spartito eseguito col virtuosismo vacuo di un piano meccanico. Ma non solo. C’è qualcosa di osceno nel giustapporre il dolore di un uomo ricco e depresso alle sofferenze di un bambino rifugiato, o nell’incentrare sul proprio dolore il racconto della morte di un conoscente in un attentato terroristico. Di questa oscenità Carrère è consapevole, come in apparenza è consapevole di tutto, e la imputa a una disperazione tanto profonda da avergli reso impossibile l’accesso a qualcosa che non fosse il suo dolore. Questa scusa ha qualcosa di cavo, come anche l’ellissi che copre le ragioni della sua depressione, motivata col desiderio di rispettare l’intimità altrui: tale desiderio è chiaramente in conflitto con l’idea stessa di scrivere un libro come questo, tant’è vero che in quel vuoto, sulla stampa francese, si è creato un turbine di pettegolezzo (Carrère è una figura pubblica) probabilmente più doloroso, per le persone coinvolte, di qualunque spiegazione avrebbe potuto scrivere lui.
È fuor di dubbio che questo libro su un libro fallito sia a propria volta, in un certo senso, fallito.
Carrère ha spesso usato una sorta di schiettezza spregiudicata per disarmare i propri critici, ammettendo e sbandierando le proprie mancanze per rivendicarle prima che potessero venirgli rinfacciate. In Yoga rivendica, ma non abbastanza; e l’eccedenza, l’oscenità, la parte delle sue debolezze che è palese non per sua strategia ma nonostante i suoi sforzi, è forse l’elemento più potente e autentico del libro. È possibile che Yoga risulti carente come descrizione della depressione e della lotta per la pace interiore. Ma risulta abbacinante come sua illustrazione, o come esempio dei suoi effetti.
Carrère stesso scrive che Yoga sarà interessante soprattutto per chi ha letto i suoi altri libri, ed è indubbio che sia così. Non solo perché, centrato com’è su Carrère, presuppone un interessamento alla sua persona e una dimestichezza coi suoi scritti passati; ma soprattutto perché per molti versi Yoga sembra il punto d’arrivo del percorso di auto-non-fiction iniziato con L’avversario. È un esperimento radicale a cui è stata sottoposta la macchina letteraria che ha affinato per vent’anni. Come i suoi lettori hanno avuto modo di scoprire, era una macchina potentissima, in grado di generare conoscenza e meraviglia; ed era, o sembrava, estremamente duttile, capace di adattarsi con la medesima agilità ed eleganza ai contenuti – autobiografici o meno – più disparati.
Carrère vi ha inserito una vicenda a temperatura elevatissima. La macchina si è fusa.
È in questo, forse, il risultato più interessante che Yoga lascia al lettore. La scoperta delle zone d’ombra porta a rivalutare la luce. Nei suoi libri di non-fiction Carrère ha sviluppato con grande maestria una tecnica letteraria in qualche misura nuova: una voce di prima persona intima e saggistica al contempo, divertita e saggia, autoironica e fascinosa, autorevole non per eccesso di sicurezza ma per l’autenticità con cui esibiva le proprie insicurezze. Le sue dichiarazioni, i paratesti, ma soprattutto il suono di quella voce portavano i lettori a catalogarla come non-fiction, non tanto perché ciò che diceva era vero ma perché pareva vero e spontaneo il modo in cui veniva detto. In Yoga quella voce si è mostrata insufficiente, rivelando, a posteriori, quanto di costruito e di controllato vi fosse nella sua spontaneità e nella sua verità. Questo non significa che fosse falsa e mendace. Significa che in quella voce saggistica c’era una forte componente di invenzione, la stessa invenzione cui ha fatto ricorso in modo esplicito – con Frederica, con l’amante del nirvana – nei punti in cui quella voce, in Yoga, si è dimostrata maggiormente carente. La sua non-fiction era in larga misura una finzione.
In un’intervista del 2013 uscita sulla Paris Review, per la serie “The Art of Non-Fiction”, a Carrère viene chiesto se ha intenzione di scrivere ancora romanzi, e risponde senza esitazione di sì. Yoga dà la sensazione di essere un libro di transizione, e non mi sorprenderebbe se a posteriori Carrère vi vedesse una ragione di abbandonare un certo tipo di percorso letterario – non come una vena che si esaurisce, ma come un mondo lontano che si è finito di esplorare; e lo stimolo a esplorarne uno nuovo.
Mentre descrive il picco della sua depressione Carrère annuncia, di passaggio, di aver bisogno di un’immagine consolatoria e ottimista per chiudere il libro, e gli sembra impossibile trovarla. Eppure, nella dissolvenza in rosa finale, quell’immagine c’è.