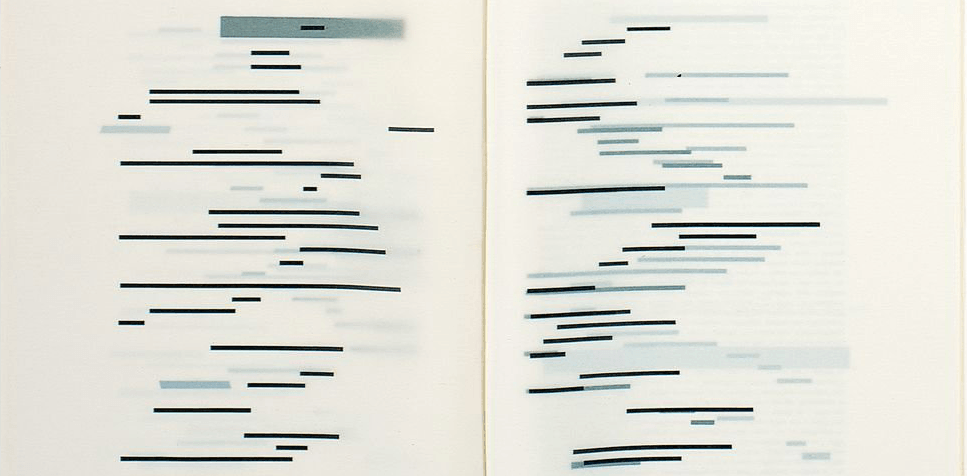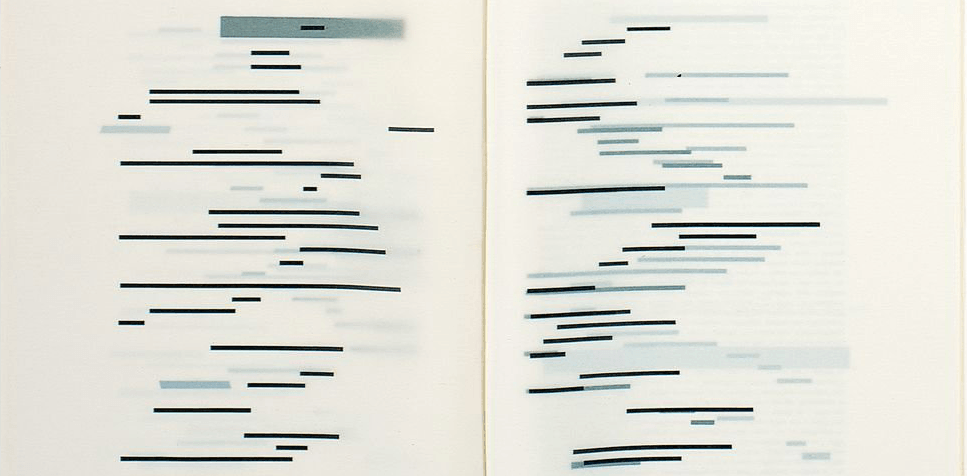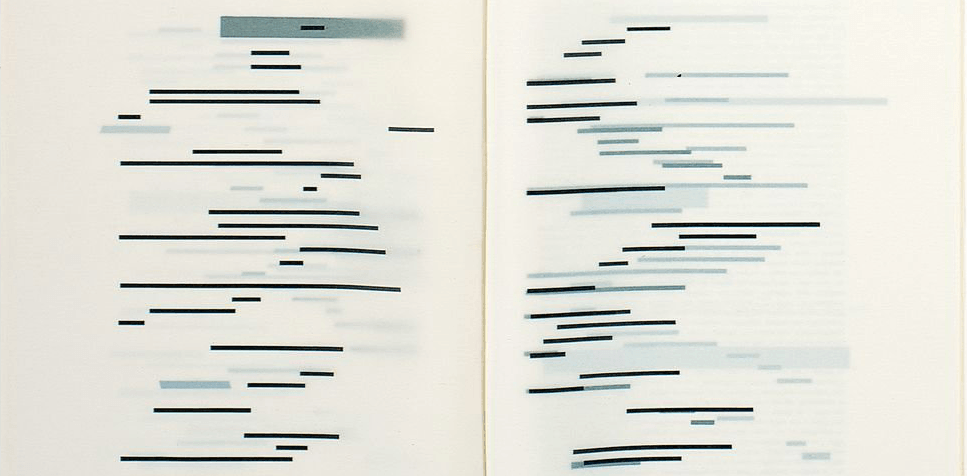L
eggere, leggere, leggere” e “poi scrivere, scrivere, scrivere”: queste dovrebbero essere le due occupazioni fondamentali di un aspirante scrittore o scrittrice. Vanni Santoni, nel suo La scrittura non si insegna (minimum fax 2020), costruisce attorno a questa idea un pamphlet sul mestiere dello scrivere, senza tracce dei classici consigli su “come si fa un incipit”, “come si tratteggia un personaggio”, o “come si struttura un arco narrativo”. Al loro posto, nutrite liste di lettura e un rigore ascetico quando si tratta di affrontare la pagina bianca.
Vorrei partire dalla dichiarazione fondante del libro, cioè che “la scrittura non si insegna, ma si può imparare a pensare come uno scrittore”. Che cosa significa pensare come uno scrittore? È uno stato che raggiungi e poi mantieni, oppure una qualità più volatile, che si rimette in gioco ogni volta?
Questa riflessione è emersa la prima volta che mi hanno chiesto di insegnare scrittura: non sapevo bene come approcciarmi alla faccenda perché ho sempre pensato che una visione “modulare” della letteratura sia in qualche modo mendace, dato che un testo letterario riuscito è un corpo vivo in cui le varie scelte dialogano tra loro, dipendono l’una dall’altra, e sono inscindibili. Non ero sicuro di poter accettare quell’incarico. Poi ci riflettei su e finii per pensare che forse qualcosa da trasmettere la possedevo: la mia esperienza diretta, visto che avevo dovuto fare molta gavetta. Abitando a Firenze, che non era esattamente una capitale dell’editoria (lo è un po’ di più oggi che Giunti ha acquisito Bompiani), quando ho iniziato a scrivere non conoscevo nessuno e non avevo alcun contatto. In più, per una serie di contingenze, mi trovai in una situazione spinosa che forse mi ha un po’ condizionato in questa visione così assoluta che ho oggi del “pensare come uno scrittore”.
Quando ero agli inizi, nel 2005, un anno dopo aver cominciato a scrivere dei racconti per una rivista autoprodotta che si chiamava Mostro, scrissi un piccolo romanzo, Vasilij e la morte, che partecipò a un concorso promosso da una rediviva, storica casa editrice, che metteva in palio la pubblicazione; fui tra i vincitori (credo più che altro per meriti altrui, perché secondo me il libro non era un granché) e da ingenuo, dissi a tutti che avrei pubblicato un libro. Non sapevo ancora che l’editoria è un campo instabile e non bisogna mai parlare di una pubblicazione finché il libro non è in stampa, se non già sugli scaffali. E infatti il concorso si rivelò truffaldino: non ci avrebbero pubblicati, ci dissero, perché la casa editrice era già prossima alla chiusura. Mi ritrovai quindi in una posizione incresciosissima: essendomi vantato di quella imminente pubblicazione avevo solo due possibilità: trovare un editore e pubblicare velocemente un libro altrove, oppure passare per lo scemo del villaggio.
Visto che conoscenze in campo editoriale non ne avevo, cercai di compensare il mio svantaggio strategico moltiplicando i tentativi. Questo si tradusse in un’attività totalizzante, mi buttai a corpo morto nella scrittura. Cominciai altri due romanzi più un terzo a quattro mani, aprii due blog in cui mettevo i miei testi, fondai un progetto di scrittura collettiva, intrapresi collaborazioni con tutte le riviste che trovavo a tiro… Due anni dopo partecipai a un altro concorso con un testo tratto dal mio blog Personaggi precari, vinsi e il libro che uscì ebbe, nel suo piccolo, diversi riscontri. Poco dopo, mi trovai per le mani un altro romanzo pronto, lo mandai a tutte le grandi case editrici, Feltrinelli rispose e così arrivò Gli interessi in comune. Quindi ecco, se dovessi dire cosa deve fare qualcuno per arrivare con buona approssimazione alla pubblicazione è: metterci tutto il sangue e il midollo che ha, gettarsi in un impegno totalizzante. Non si può solo limitarsi a seguire il proprio afflato del momento: è vero che ogni tanto c’è stato qualcuno che ha avuto un momento di ispirazione, ha scritto una sola cosa, l’ha pubblicata ed è andata benissimo, ma si tratta di eccezioni.
Proponendo le liste di lettura, scrivi: “pare che una volta […] qualcuno si mettesse in testa di scrivere un romanzo solo dopo aver letto tutto ciò che serviva per sentirsi legittimato a farlo”. La questione della legittimazione, che un po’ arriva dall’interno e un po’ dall’esterno, si collega al capitolo introduttivo con le reazioni degli scrittori italiani degli anni Ottanta quando fu lanciato il primo corso di scrittura nel nostro paese. Sono reazioni di pancia…
Sì, viscerali, quasi come se avessero percepito una lesa maestà. Sembrano dichiarazioni un po’ in malafede, di gente quasi offesa, che si sente sminuita nel momento in cui si dice che la loro magica arte può essere insegnata. Come se gli avessero tolto qualcosa.
Che è anche un po’ una contraddizione perché alla fine, in un modo o nell’altro, chi scrive ha voglia di ragionare sulla scrittura e di condividere questi ragionamenti. Ci sono Fruttero & Lucentini con I ferri del mestiere, che tra l’altro citi come voci fuori dal coro, ma penso anche a Natalia Ginzburg, che pure ha una reazione negativa all’idea dell’insegnamento della scrittura: dentro Le piccole virtù, c’è un saggio molto bello, “Il mio mestiere” in cui racconta cosa significa per lei scrivere, come è cambiato nel tempo, ed è una lezione di scrittura splendida. Come anche sono una lezione gli Esercizi di stile di Queneau. La scrittura deve restare un insegnamento indiretto, un po’ carbonaro?
Credo ci sia di mezzo una questione di aura. La scrittura è un’arte – personalmente rifuggo dall’idea della scrittura come artigianato, anche se ovviamente per diventare un’artista devi anche essere un buon artigiano – e spesso chi pratica un’arte sente il bisogno di mantenere una certa aura. Però la scrittura è un caso particolare, perché se ci pensi la pittura non ha meno aura della letteratura, ma nessuno si è mai sognato di mettere in discussione le accademie di belle arti o di sminuire un pittore che viene dall’accademia: sono piuttosto le eccezioni a non aver seguito un percorso del genere. E non c’è dubbio che La scrittura non si insegna sia anche un libro in cui, da un certo punto di vista, si “insegna la scrittura”: questo pamphlet è un po’ il risultato di una condizione in cui ci si ritrova quando si scrive da qualche anno (figurarsi poi se ti ritrovi a fare pure l’editor), perché dopo aver pubblicato qualche libro, qualcuno prima o poi verrà a chiederti come si fa. Del resto, per chi non ne sa niente, è anche un campo irto di fregature, pensa all’editoria a pagamento. Così a volte, a forza di ricevere mail, messaggi, finisci per sentirti quasi come se avessi una missione, salviamo tutti questi aspiranti scrittori dalla trappola dell’editoria a pagamento!
Spesso la gente dà per scontato di aver scritto un buon libro e vuole solo sapere come pubblicarlo. A volte – in realtà, nella maggior parte dei casi – occorre fare un passo indietro e anziché dare suggerimenti è opportuno instillare dei dubbi: ma questo tuo libro è davvero buono? Puoi fare di meglio? Forse questo testo ti ha aiutato a prendere le misure, ma quel che vuoi davvero scrivere deve ancora arrivare? Poi un giorno ti accorgi che sono quindici anni che dai consigli in giro, e quasi dieci che insegni scrittura, capisci che hai inventato una specie di metodo e arriva un editore come minimum fax a chiederti di sistematizzare queste idee.
A proposito della lista di lettura, tu citi una serie di “capolavori imperfetti”. Libri talmente grandi, ambiziosi, da avere per forza dei punti di cedimento. Quale potenziale ha l’imperfezione?
Penso sia bene chiarire cosa intendo per “imperfetto” nel mio pamphlet. Tra gli esempi di libro imperfetto cito Underworld di Don DeLillo – magari scrivere libri imperfetti come quello! Quello che voglio dire, è che il libro enorme, il romanzo-mondo, non può mai conseguire la perfezione cristallina che hanno i capolavori di piccoli dimensioni come, che so, Lo straniero di Camus. Ma per l’aspirante autore sono molto più utili perché gli fanno intravvedere le infinite possibilità dell’arte romanzesca. A volte, poi, i punti meno solidi possono fungere da “ingresso”: anche 2666 di Bolaño, che cito diverse volte, e non solo perché lo reputo uno dei più importanti libri del nuovo millennio, ha almeno un paio di passaggi deboli: La parte di Fate e La parte di Amalfitano sono un po’ “appese”, non hanno né la stessa pregnanza né la stessa coesione all’interno del testo delle altre tre parti. Ciò non toglie che il romanzo nel suo complesso sia un capolavoro. Ecco, quel tipo di libro imperfetto, oltre ai classici, è ciò che consiglio all’aspirante, per aprire i polmoni e allargare le spalle.
L’aspirante deve invece affrancarsi dall’idea di leggere subito i propri stretti contemporanei, i libri del momento: un giorno ci arriverà, ma se l’intento è diventare uno scrittore, deve prima sviluppare una certa preparazione, farsi le basi. Quando è formato, cambia tutto: allora diventa fondamentale leggere anche i contemporanei, magari pure quelli mediocri, per capire il campo letterario, per vedere chi sta scrivendo cosa. Devi starci, all’interno della società letteraria, sarebbe sciocco e presuntuoso non farlo. Ma quando l’obiettivo è quello di fare di un non-scrittore uno scrittore, bisogna che legga soltanto classici e capolavori che formano il “fronte d’onda del romanzo”. Se vedo un ragazzo che si presenta alla scuola di scrittura con un mio libro, o col vincitore dell’ultimo premio, lo bacchetto subito. Il fatto che abbia con sé quel libro è già il segno che insegue uno status, no? Devi ammirare James Joyce o Virginia Woolf, mica me: altrimenti sei già sulla strada verso l’inferno.
Parlami invece della rubrica che tenevi su minima&moralia, “Discorsi sul metodo”. Hai parlato con molti dei maggiori scrittori italiani, da Siti a Mari, e con diversi scrittori stranieri, Egan, Carrère, Eggers, Pauls, ecc., sul loro metodo di scrittura. Quanto ti è stato utile come scrittore?
Quella rubrica nasce proprio da un dibattito con alcuni colleghi. In Italia – nel mondo anglosassone sono un pochino più inquadrati – non ci sono molto discorsi rispetto a come si debba scrivere, a quanto si debba scrivere; la visione dello scrittore come mestiere romantico è ancora molto radicata. Discutevo con alcuni amici e colleghi di qual è la quantità ideale di battute da scrivere al giorno, e non ci trovavamo d’accordo. Siccome in quel periodo c’era il Premio Von Rezzori a Firenze, e in città c’erano diversi scrittori internazionali importanti, mi son detto, vado là e lo chiedo a loro. Venne fuori che 4/5mila battute al giorno è più o meno dove vanno a parare tutti. Volendo, quello è stato un primo embrione di La scrittura non si insegna, un’occasione in cui, attraverso le esperienze di altri, ho potuto capire meglio quello che facevo io e cosa avrei potuto consigliare ad altri. Mi preme molto, però, dire una cosa che potrebbe essere fraintesa quando si leggono frasi tipo “quante battute devo fare al giorno”, e cioè distruggere l’idea della scrittura come artigianato. Si sente dire molto e lo trovo fuorviante. La letteratura è arte, non artigianato. Certo, si può fare un’arte pessima. Ma i processi sono sempre e comunque al servizio di qualcosa di più profondo, di un afflato dell’anima si potrebbe dire. E tuttavia questo fatto è all’origine di un altro fraintendimento, opposto e polare: la percezione romantica dell’artista, di qualcuno che segue solo l’ispirazione. L’ispirazione non si segue: come diceva Jack London, “va rincorsa con un bastone”. Ti devi mettere tutti i giorni al tavolo, alcuni giorni va bene, altri va male. È una curiosa contraddizione: non è artigianato ma arte, e tuttavia proprio perché è arte per venirne a capo occorre piegarla a modalità organizzative molto serie.
Questa distinzione tra mentalità latina e anglosassone si collega anche al discorso che fai nel libro sulle scuole di scrittura americane e il rischio di omologare la produzione letteraria. Libri attenti, già con un occhio al mercato. Considerando che il fenomeno delle scuole di scrittura in Italia è di sicuro più limitato, tu hai visto qualche influenza su dove sta andando la letteratura italiana negli ultimi anni? Lasciano qualche stampo?
Negli Stati Uniti, per una serie di processi storici e di mercato, sempre più scrittori vengono dai writers’ workshop e dai master in creative writing. E lì, come è normale, si punta a farti lavorare in quel settore: più che una questione di contenuti – in questi workshop insegnano grandi scrittori americani, la didattica è sicuramente di livello – è una questione di approccio. Gli studenti cercano di produrre subito un testo spendibile con un’agenzia (prima ancora che con un editore, perché negli Stati Uniti tutto ormai passa dalla agenzie: lo scouting sulle riviste come avviene da noi, l’idea di mandare un manoscritto alle case editrici, non c’è più), così, per paura di non piazzarli, si tende a spingerli (se non lo fanno già da soli) a scrivere libri che assomiglino ad altri libri già usciti, con una lingua e una struttura non troppo sperimentali. Questo però porta a saltare un passaggio cruciale: nella formazione di uno scrittore non può mancare una fase di sperimentazione, in cui uno fa un po’ quello che vuole per ritrovare poi un ordine che sia veramente suo.
Mi sembra interessante il fatto che dopo un’egemonia indiscutibile della letteratura americana – solo tra il ‘96 e il ‘97 uscivano Pastorale americana, Underworld, Infinite Jest e Mason & Dixon! – oggi questo famoso “fronte d’onda del romanzo” si trovi nell’Europa dell’est, con autori come Krasznahorkai, Gospodinov, Tokarczuk, Drndić, Oravecz, Cărtărescu… Cos’hanno in comune questi autori arrivati dall’Ungheria, dalla Bulgaria, dalla Polonia, dall’ex-Jugoslavia, dalla Romania? Vengono da paesi dove il mercato del libro è relativamente piccolo e probabilmente non hanno avuto un agente se non da quando sono diventati autori internazionali: hanno fatto quello che gli pareva, prima di arrivare ai loro libri più importanti, e forse sono diventati grandi autori proprio perché hanno sperimentato liberamente e trovato così una voce unica.
In Italia, non so quanto sia valido il discorso appena fatto per gli USA. Lo scouting avviene ancora per lo più sulle riviste o tra gli autori che hanno ottenuto buoni risultati per marchi più piccoli, da noi la maggior parte dei corsi sono piuttosto brevi, non tutti fanno il biennio della Holden o il master della Scuola del Libro, quindi è chiaro che la scuola di scrittura sarà solo una delle tante influenze o suggestioni, un simile condizionamento c’è molto meno: lo dimostra il fatto che ancora oggi in Italia il panorama degli esordienti è molto variegato. Di solito gli editori cercano qualcosa che possa funzionare, si agisce ancora in modo un po’ divinatorio: questo scrive bene, questa ha una voce originale, quest’altro ha pubblicato dei racconti interessanti su questa rivista, proviamoli e vediamo come va. In Italia non c’è il filtro degli agenti, o non c’è ancora, dato che si sta andando un po’ in quella direzione. Lavorando in Tunué ho notato che sempre più spesso l’esordiente ha già un agente, il che una volta sarebbe stato addirittura ridicolo, perché l’agente nella tradizione italiana era quasi più un commercialista, si occupava del contratto e teneva i conti di anticipi e royalties. Poi bisogna vedere cosa succederà in futuro, l’esordio è solo il primo passo e molti grandi autori sono andati a realizzare i loro capolavori per vie molto diverse: se l’esordio è difficile, forse confermarsi, riuscire a stare sul mercato preservando la propria poetica e il proprio discorso, è anche più difficile. Prima ho citato Bolaño, trovo che sia sempre un buon esempio per l’esordiente: le sue poesie giovanili non sono un granché, e pure i suoi primi romanzi, La pista di ghiaccio o Monsieur Pain, sono dei piccoli noir; solo in tarda età è arrivato a scrivere dei capolavori come I detective selvaggi e 2666. Rispetto ad altre arti, nella nostra il genio conta un po’ meno: ciò che davvero fa la differenza è quanto si legge, quanto si scrive, e quanto si prende sul serio la letteratura.