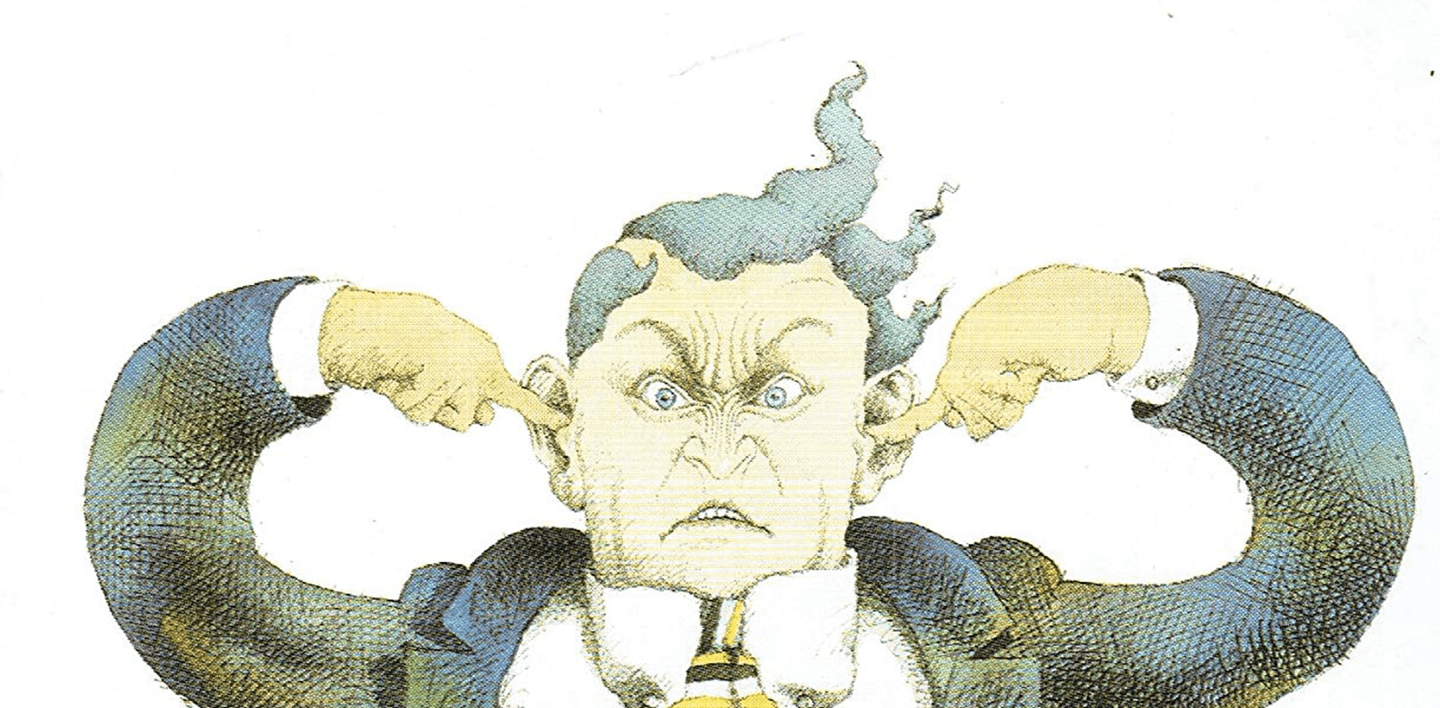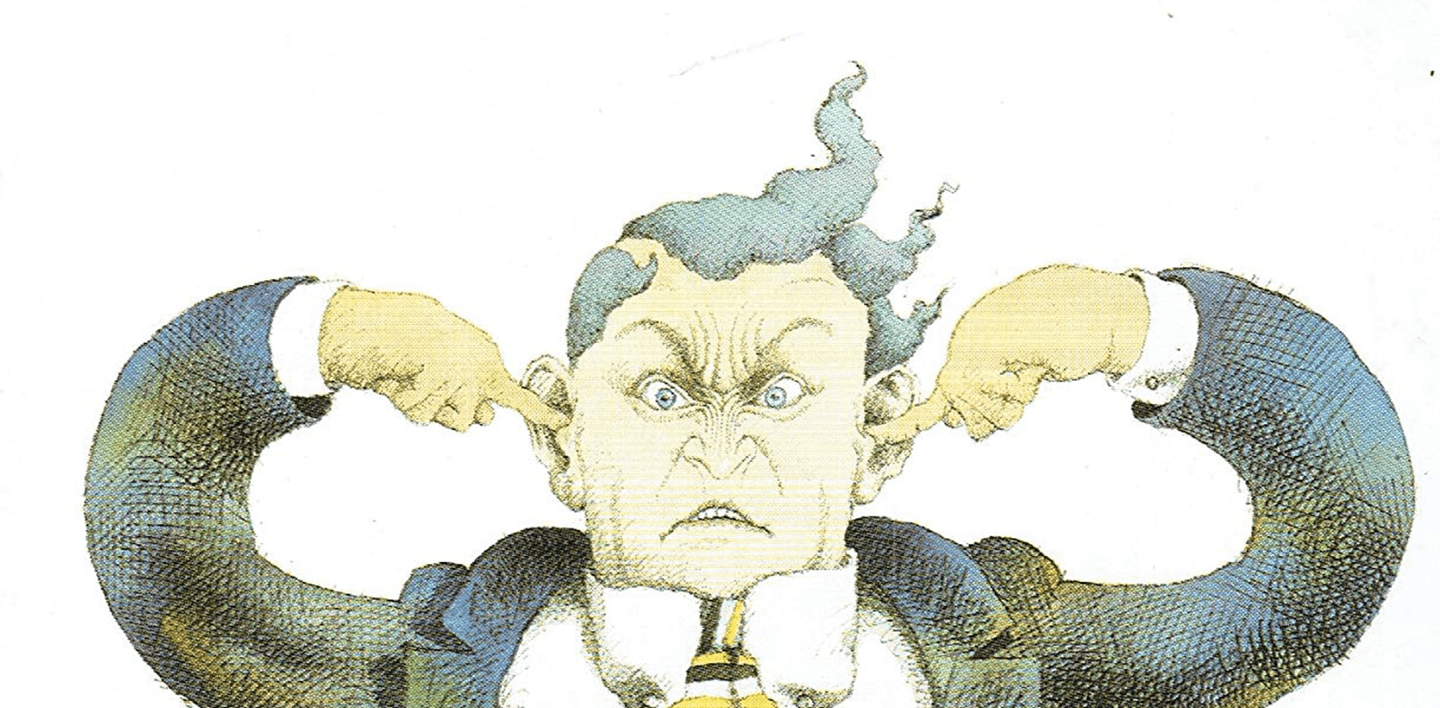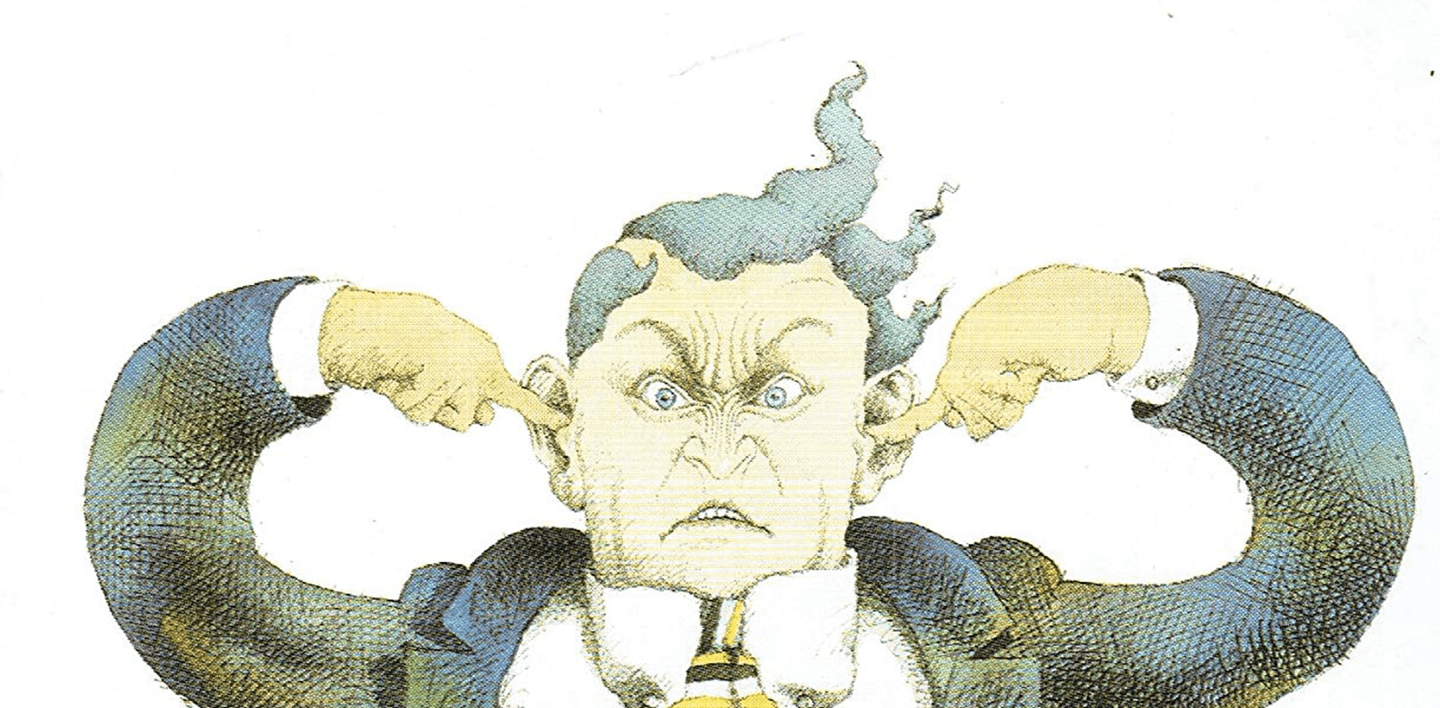T
ra gli addetti ai lavori in molti concordano che Tommaso Labranca sia stato uno degli interpreti più lucidi e originali del mondo culturale italiano (nel senso più ampio possibile) degli ultimi decenni. O meglio, lo pensano soprattutto quelli della sua generazione, dal momento che i suoi minuti di (relativa) celebrità coincidono più o meno con la seconda metà degli anni Novanta. Dopo un libro di successo come Andy Warhol era un coatto, uno per una casa editrice importante (Chaltron Hescon su Einaudi) e la collaborazione al fortunatissimo programma tv Anima Mia, il suo ruolo pubblico comincia a diventare sempre più marginale.
Labranca è morto il 29 agosto del 2016 e gli ultimi anni della sua vita sono caratterizzati da collaborazioni poco prestigiose e molto saltuarie, lavori smaccatamente alimentari come gli instant book sui cantanti e una serie infinita di progetti cominciati e abbandonati, di autoproduzioni, di pubblicazioni per piccoli editori. Alcune delle sue cose migliori (Neoproletariato, Il piccolo isolazionista) appartengono già a questa fase di progressivo declino.
Cattivo carattere, scarsa disponibilità al compromesso, gran rifiuti pagati cari, i motivi del suo isolamento dal dibattito pubblico sono tanti, ma è difficile non considerare un peccato che il suo lavoro sia noto soprattutto soltanto a un ristretto circolo di cultori. A raccontare la sua opera, un po’ della sua vita, e a cercare di leggere gli ultimi decenni italiani attraverso le sue parole ci ha pensato ora Claudio Giunta, scrittore e storico della letteratura, con un saggio pubblicato da Il Mulino dal titolo Le alternative non esistono. Ne abbiamo parlato con lui.
La prima cosa che vorrei chiederti è il perché del libro. Al di là della stima per gli scritti di Labranca, esplicitata nel testo, che può restare anche un fatto personale, come mai decidere di dedicargli una biografia? C’è l’idea anche di un riconoscimento tardivo (addirittura postumo) nei confronti di un autore meno noto di quanto dovrebbe essere?
Naturalmente sono stato un lettore di Labranca, un lettore fedele negli anni Novanta, più distratto dopo: e l’interesse che ho sempre nutrito per le cose che scriveva è stato il primo stimolo a scrivere a mia volta di lui. Ma la ragione principale è che m’interessava e m’interessa riflettere sugli ultimi trenta o quarant’anni di vita italiana, diciamo da Fininvest in poi, e mi è parso che parlare di lui fosse un ottimo modo per farlo. Per questo non la chiamerei biografia, non mi pare lo sia né nelle intenzioni né nei risultati: “Tommaso Labranca e il suo tempo” non sarebbe stato un sottotitolo possibile, fa subito atti di congresso dei Lincei, ma l’idea era quella, parlare di questi ultimi decenni attraverso di lui. No, per carità nessuna volontà di rivendicargli un posto nel ‘canone’, nessun risarcimento postumo, sarebbe ridicolo: ma certo mi piacerebbe se ora un buon editore ristampasse i suoi libri. Il proposito era, è anche questo.
C’è tanto materiale “perduto”: libri introvabili, articoli usciti secoli fa, cose scritte online e cancellate… Sarebbe bello se venisse recuperato e antologizzato.
Sì, probabilmente sarebbe la cosa migliore da fare, anche perché Labranca è stato soprattutto autore di libretti esili, che stampati singolarmente si perderebbero un po’, e di scritti sparsi sui giornali e sulla rete. Si potrebbe fare un’antologia con cinque o sei dei suoi libretti (senz’altro Andy Warhol era un coatto, Chaltron Hescon, Neoproletariato, Il piccolo isolazionista, Haiducii, Progetto Elvira), e poi una scelta dei Collateral che pubblicava su FilmTV, e una scelta di Labrancoteque, la rivista che pubblica online nel 2013, e altre pagine sparse. Nella selva delle cose che ha pubblicato in rete non so se metterei le mani… Comunque non è difficile, è un lavoro che potrebbe fare ottimamente per esempio Luca Rossi, che è stata la persona più vicina a Labranca negli ultimi anni, e sa scrivere, e io darei volentieri una mano. Occorre solo risolvere la questione dei diritti, credo risolubile, e trovare un editore. Io ne ho parlato in giro ma non ho trovato grande entusiasmo (ma gli editor più giovani sapevano a malapena chi fosse Labranca); ora speriamo che il mio libro smuova un po’ le acque.
Un altro motivo del libro è anche una sorta di fascinazione per il suo privato un po’ misterioso?
Mi dai un dolore, perché – almeno a livello conscio, inconsciamente non posso dire – non credo di provare nessuna fascinazione per il suo privato, per il privato di nessuno in realtà: e mi pare che tu lo riconosca quando osservi (ho sbirciato le domande successive) che non approfondisco la questione del sesso. No, è chiaro che se uno scrive un libro su uno scrittore deve dire com’era, come ha vissuto, salvo scrivere un saggio di pura critica letteraria. E forse lo avrei fatto, avrei scritto un saggio di pura critica letteraria (come ne ho scritti sui poeti del Duecento, su Dante), se avessi potuto contare sulla conoscenza di Labranca da parte del – diciamo – lettore medio. Ma dato che Labranca era ed è uno scrittore dimenticato ho dovuto armarmi di pazienza e ricostruirne un po’ la vita. Ed essendo un mio contemporaneo non ho potuto non riferirmi, anche, alla testimonianza di chi lo ha conosciuto, e dire qualcosa (non troppo mi pare) della sua vita privata. Poi certo, la vita di Labranca non è stata quella del medio scrittore italiano (liceo, laurea in Lettere, primo romanzo, collaborazione a un giornale minore, secondo romanzo o reportage, chiamata di Repubblica, comparsate televisive, libro-raccolta di articoli ecc.), o del medio intellettuale italiano (come prima, ma con l’aggiunta di una cattedra a scuola o all’università): di qui non la fascinazione, ma l’interesse sì, l’opportunità di approfondire un po’, di farsi delle domande non solo sull’opera ma sull’esistenza. Ma ripeto, mi sono occupato del suo privato solo perché quasi nessuno ne sapeva niente, sennò avrei fatto una cosa molto più centrata sui libri, più professorale se vuoi. E certo, anche più noiosa.
È vero, forse sto proiettando, perché per quanto mi riguarda invece sono sempre stato molto incuriosito da questa sua vita così reclusa, così particolare e rovesciata a piene mani in tanti suoi testi.
Sai, forse c’è anche il fatto che io di gente strana, per esempio con una vita sentimentale-sessuale problematica, ne ho incrociata parecchia, tra collegio universitario e università. Gli intellettuali hanno spesso un lato un po’ oscuro: voglio dire, la sua stranezza non era poi così strana, dopotutto. L’aspetto del suo privato che mi interessava era questa sua origine proletaria, la scuola per interpreti anziché il liceo, niente università, la cultura conquistata centimetro dopo centimetro con le sue sole forze (e senza internet!): mi pare che questo aspetto contribuisca a spiegare perché pensava e scriveva in un certo modo, e anche perché ha vissuto in un certo modo, e per questo cerco di approfondirlo. Ma non è che alla fine fosse un gran mistero, gli ingredienti della vita sono più o meno sempre quelli… Quanto alla vita rovesciata a piene mani nei suoi testi hai ragione, ma mi pare che la nostra sorpresa e la nostra curiosità siano legate al fatto che in genere le vite che vediamo riversate nei reportage o nella autofiction sono vite da scrittori in carriera o da professori, con le letture giuste, le reazioni giuste alle cose. Lui ha messo in scena un tale che, anziché glossare Kafka o contemplare con sussiego i croceristi ai Caraibi, guarda il Cantaitalia su una TV privata lombarda mentre fuori dalla finestra l’alba colora i capannoni. È un privato a cui non eravamo abituati.
Mi spiegheresti il titolo? Forse sono un lettore un po’ disattento, ma non mi sembra di averne trovato traccia nel testo, almeno non esplicitamente.
L’idea non è mia ma del mio collega-amico Giuseppe Sciortino, a cui il libro è dedicato (non per il titolo, per altre migliori ragioni). La frase è ovviamente della Thatcher, “There is no alternative”, e voleva dire più o meno che non c’è alternativa all’economia di mercato, cioè alla vita occidentale come la conosciamo. Ma il lettore dovrebbe vedere che in questa citazione non c’è, da parte mia, alcuna intenzione rivendicativa o moralistica. Semplicemente, mi pare che a un certo punto, a una certa età, la vita non dia alternative, che il sentiero sia segnato, e che Labranca fosse arrivato a quel punto, a quella età. Volevo anche suggerire l’idea – ma credo di dirlo chiaramente, da qualche parte – che la società in cui viviamo non dà alternative soprattutto alle persone con un profilo simile a quello di Labranca: intellettuali in senso amplissimo, gente che di mestiere scrive (per i giornali, la TV, il cinema) e non può contare su un reddito fisso, o su beni di famiglia e, specie negli ultimi anni, ha visto prosciugarsi quasi tutte le fonti di reddito. Io, come titolo, avevo pensato a Favoletta, come il raccontino di Kafka sul topo che si lamenta perché corre corre e il mondo intorno a lui diventa sempre più stretto, e sa che tra poco arriverà alla fine del sentiero e lì lo aspetta la trappola. E il gatto gli dice: “Non hai che da correre nell’altra direzione”, e se lo mangia. Bellissimo apologo, molto calzante: ma sarebbe stato incomprensibile. Le alternative non esistono mi piace molto, e mi pare vada molto bene.
Il libro è sicuramente un saggio, ma scritto in prima persona, a volte con passi personali del tipo “perdo di vista la sua opera per qualche anno”, che si mescolano a momenti anche di vera e propria “analisi del testo”. Come mai hai optato per questa formula? Anche per una sorta di omaggio al suo metodo?
No no, nessun omaggio al “metodo Labranca”. Mescolare l’analisi, la riflessione oggettiva a dati personali, all’autobiografia insomma, è una cosa che faccio spesso quando mi occupo di cultura contemporanea. Mi pare giusto farlo, mi viene naturale: l’oggettività, la neutralità che uso quando parlo di Dante Alighieri mi viene più difficile, mi pare quasi fuori luogo quando provo a riflettere su ciò che accade attorno a me (e Labranca è accaduto attorno a me); e mi pare anche che questa ibridazione funzioni dal punto di vista diciamo narrativo – dire dov’ero io quando leggevo Andy Warhol era un coatto mi pare possa tenere desta (non dico interessare, che sarebbe troppo) l’attenzione del lettore. Naturalmente non è una mia prerogativa, moltissimi lo fanno, infinitamente meglio di me. Quando aveva pochi anni più di me Martin Amis pubblicava Esperienza. Ognuno fa quello che può…
C’è una questione abbastanza spinosa ma che non ti fai problemi ad affrontare da subito molto direttamente, quella del suicidio. L’ipotesi viene menzionata già in quarta di copertina ed è presente sin dall’introduzione. Mi sembra che però, almeno pubblicamente, fosse sempre stata un po’ taciuta, anche tu racconti che il tuo primo articolo scritto dopo la sua morte era stato criticato per avere menzionato quell’ipotesi.
Intanto bisogna dire che è un filo narrativo comodo, che aggiunge mordente al racconto. In sé, una cosa anche un po’ scorretta. Ma in realtà quello che racconto nella premessa è tutto vero: a me dissero che si era suicidato, poi che era morto d’infarto, poi che la cosa era indifferente (e no, non mi pareva e non mi pare affatto indifferente). Così, una volta che ho deciso che avrei provato a scrivere dell’uomo e dell’opera, l’indagine sull’uomo è cominciata dalla fine, e alle persone che lo avevano conosciuto chiedevo che cosa pensavano fosse successo, e le risposte che ho ricevuto mi sono parse interessanti, mi è parso che rivelassero qualcosa di Labranca in vita (il che non è sorprendente: è ovvio). Non so, alla fine è soprattutto un buono spunto narrativo, credo.
Anche a questo proposito, come è stato il lavoro di raccolta delle testimonianze? All’inizio, anche per quanto detto sopra sulle critiche ricevute per l’articolo, poteva sembrare un’operazione difficile, mentre sembra che poi siano arrivate addirittura spontaneamente.
No, un lavoro facile e gratificante. Ho incontrato un mucchio di persone intelligenti e disponibili, gente che gli voleva bene, o gente che – magari essendone stata respinta (capitava spesso) – continuava a stimarlo. È stata la parte più piacevole del lavoro: prendere un caffè o pranzare con i suoi vecchi conoscenti: sono stati tutti, nessuno escluso, molto gentili, e felici che qualcuno, qualcuno che non l’aveva mai conosciuto poi, si occupasse del loro amico o ex-amico. Il libro non esisterebbe senza questa gentilezza. E decisivo, tra tutti, è stato Luca Rossi, che è stata la persona più vicina a Labranca negli ultimi anni: non credo che avrei fatto molta strada senza il suo consiglio. Ecco, è una bella cosa: grazie a questo libro ho conosciuto parecchie persone d’animo nobile (so che suona antiquato, ma è così), e lui, Luca, è stato il più nobile tra gli animi nobili.
Com’è scrivere di una persona morta, quindi non rintracciabile direttamente se non attraverso quanto lasciato, ma morta da poco, quindi con la possibilità di raggiungere pressoché tutti quelli che l’hanno conosciuta?
Per me è stato strano perché sono abituato a occuparmi di autori morti e stramorti (ho studiato soprattutto la letteratura del Medioevo); ma in realtà, dopotutto, neanche così strano perché in questi anni ho scritto anche di cose più vicine all’attualità: non è stato un esercizio del tutto nuovo. Mi sono preparato con la stessa serietà che cerco di avere quando mi occupo di Dante Alighieri, cioè leggendo o rileggendo tutto di Labranca e tutto quello che potevo trovare intorno a Labranca, prendendo intorno in un senso molto largo: intorno sono anche Eco, Debord, Lyotard, Girard eccetera – insomma il buon metodo dei saggi accademici, se vuoi (e questo nelle mie intenzioni lo è). E poi, come ho accennato, ho parlato con le persone che lo conoscevano, ho fatto telefonate, preso treni: e dato che quasi tutti i suoi amici sono vivi e gentili è stato abbastanza facile, uno ha portato all’altro o all’altra. “Ma hai parlato con Tizio? No? Dovresti”, e mi congedavo con un po’ di appunti sul mio bloc notes e un nuovo numero da chiamare. È stato divertente, soprattutto perché mi ha dato la possibilità di sbirciare in mondi (quello degli autori televisivi, delle riviste, della TV degli anni Novanta) che non mi erano familiari.
Che impressione fa il mondo degli autori televisivi a un intellettuale abituato al mondo accademico?
Devo dire che ho solo sbirciato, solo sbirciato. Quindi non posso darne un giudizio compiuto, solo impressioni, che naturalmente confermano ciò che uno poteva già intuire. È un mondo di compromessi, in cui persone anche molto raffinate e colte devono adeguarsi alle richieste (a quelle che si ritiene siano le richieste) di un pubblico non raffinato e non colto. Di qui – nei meno corazzati – un po’ di imbarazzo, un po’ di sensi di colpa, un po’ di vergogna. Ma è lavoro, il modo in cui sembra di dover fare questo lavoro nei nostri anni. Mi pare che mondi che conosco un po’ meglio come i giornali e l’editoria sollecitino gli stessi compromessi e le stesse frustrazioni, che conseguono, a dirla in breve, al necessario adeguamento al gusto di massa.
Pensi che Labranca avrebbe potuto trovarsi meglio in un contesto diverso, dalle dinamiche diverse, se mai si fosse avvicinato a un ambiente più simile al tuo? O sarebbe stato comunque destinato a essere ovunque un outsider?
Labranca era il perfetto ricercatore universitario – colto, fissato (anche se lui aveva tante fissazioni, in genere i ricercatori, quelli come me, ne hanno una o due), competitivo, e soprattutto livoroso. Era il posto per lui, ma veniva dall’ambiente sociale sbagliato, ha fatto le scuole sbagliate. Una volta dentro non è che sarebbe stato più felice, probabilmente, solo un po’ più libero; ma avrebbe avuto uno stipendio a fine mese, il che è importante.
Come convivono il rispetto, la privacy, e il racconto di una vita che è ancora materiale sensibile per molte persone? Problemi che non occorrono quando si scrive, non lo so, di Kafka.
Non saprei generalizzare. In questo caso la questione più delicata ha riguardato i familiari di Labranca. Che mi è sembrato opportuno lasciare fuori dall’indagine – appunto perché non stavo scrivendo una biografia ma un saggio, nelle intenzioni, “scientifico”. “Com’era Tommaso da piccolo?” è una domanda che non avrebbe avuto senso fare, non avrebbe aggiunto niente alla comprensione delle cose che ha scritto, forse avrebbe aggiunto solo qualche spunto aneddotico, ma appunto non ero in cerca di cose del genere.
Un’altra dimensione delicata è quella della sessualità di Labranca. Come giustamente dici nel libro, nonostante migliaia di pagine scritte su ogni argomento e spesso autobiografiche, quello era un tema che non toccava mai, neanche da lontano. Un’assenza notevole, in qualche modo. Tu da subito parli del suo compagno degli ultimi anni e sei anche in contatto diretto con lui nella redazione del libro, però poi il tema quasi scompare dal libro, se non per poche righe. Non parli con il suo compagno della loro relazione, del loro rapporto, né tantomeno vai a indagare sul suo passato (relazioni precedenti, o altro). È stata una scelta o la conseguenza di un rifiuto?
È una scelta. È una dimensione che non mi interessa granché. Quando leggo le biografie degli scrittori mi fanno sbadigliare le confidenze sulle relazioni sentimentali, i gusti o le perversioni sessuali, con la loro psicanalisi d’accatto appiccicata sopra… Mi interessano soprattutto le idee, i libri; mi interessano molto di meno (non dico niente, dico molto di meno) le chiacchiere sulla vita intima, perché non credo che la chiave delle idee e dei libri stia lì, e se anche sta lì a me interessa quello che affiora in superficie, non quello che smuove dal profondo. Cioè, lo so, intellettuali e scrittori che venero come Weber o Thomas Mann o Kafka avevano vite sessuali complicate: ma saperlo, approfondirlo, mi aiuta a capire la Sociologia delle religioni o I Buddenbrook o Il processo? Non mi pare. Certo, di amore e sesso ho parlato con i conoscenti di Labranca, ma alla fine le cose che sono venute fuori, oltre ad essere dubbie, incerte, mi è parso non mi aiutassero a capire meglio le cose che pensava e scriveva, quindi ho glissato. Forse se avessi scritto una biografia avrei agito diversamente, avrei tenuto il conto delle copule. Ma come dicevo non ho scritto una biografia nel senso tradizionale del termine.
Come sappiamo, Labranca era sicuramente un appassionato di tecnologia, pronto ad adottare presto e addirittura con entusiasmo qualsiasi innovazione: era però assolutamente allergico ai social network. La mia idea è che lui sentisse comunque il bisogno di parlare da un pulpito, con un’autorità riconosciuta, mentre l’ “uno vale uno” della rete non poteva che essergli indigesto.
Credo che quasi tutti sentano il bisogno di parlare da un pulpito, e che uno vale uno lo possa dire seriamente soltanto chi vale zero. La cosa interessante, nel caso di Labranca, è che voleva un pulpito, voleva essere autorevole e riconosciuto, voleva indicare la strada, ma negli anni gli hanno negato e soprattutto si è negato ogni possibilità di esercitare davvero questa autorità, di avere questo pulpito – niente cattedra universitaria, niente rubrica su un grande giornale, niente trasmissione in TV, niente blog in internet… La sua tragedia (ma non solo la sua) in fondo era quella di essere un intellettuale ancora novecentesco, uno che in fondo credeva ancora in idola come la cultura umanistica (in senso amplissimo, e ovviamente aperta agli audiovisivi, come deve essere) o la forma, la cura del linguaggio, in un contesto (e la rete va benissimo come metonimia, ma non è solo la rete) che di quelle vecchie distinzioni, di quei vecchi valori non sa che farsene.
In quest’ottica ho sempre trovato che Labranca fosse un po’ in perenne tensione tra due tendenze, quella per cui l’inferno sono gli altri e un profondo bisogno di piacere, di essere amato e apprezzato.
Sì, ma credo che sia una tensione nella quale molti viviamo: che proprio il continuo bisogno di riconoscimento da parte degli altri faccia sì che gli altri ci appaiano soprattutto come aguzzini anziché come alleati. Si chiama narcisismo.
Sono proverbiali in questo senso sia la sua disponibilità e gentilezza con qualsiasi sconosciuto che per esempio lo approcciasse via email, come la sua intraprendenza nell’organizzare feste a tema, ma anche la sua misantropia, il suo “isolazionismo”, il suo troncare improvvisamente amicizie di lunga data per un nonnulla. Nella tua ricerca questa ambiguità viene risolta osservando che non siamo mai una cosa soltanto, ma tante cose diverse a seconda del momento storico, dell’interlocutore, delle circostanze.
Sì, la risolvo così pensando soprattutto a me, dato che lui non l’ho mai conosciuto. Nel suo caso però mi pare ci fosse anche un elemento di disagio ulteriore, di schizofrenia, e anche di autodistruzione, insomma quel viluppo di nevrosi che lo portava a infatuarsi dell’ultimo arrivato – specie se giovane, specie se disponibile a un ménage pigmalionesco – per poi abbandonarlo al primo sgarbo, anzi alla prima nota falsa. Qui forse uno psicoanalista saprebbe dire cose più profonde e più vere. A me pare che gli mancasse quella, diciamo, divina indifferenza di fronte alle persone che rende tollerabile la vita sociale. Mentre nella vita delle persone normali, nella mia, ci sono alcuni amori, alcuni odi e, in mezzo, una sconfinata regione di indifferenza, mi pare che nella sua ci fossero solo i due stadi estremi, amore/odio, e che insomma avesse sempre un rapporto risentito con gli altri, per il bene (amore) o per il male (odio). Il che è soprattutto puerile, direi. Una mancanza di maturità. E che sotto molti aspetti fosse immaturo, almeno secondo i criteri correnti, direi che è indubbio.
Forse amava essere messo su un piedistallo e quindi era molto disponibile finché poteva approcciarsi in quel modo, per poi diventare subito scostante non appena ci fosse un accenno di dissenso? Anche questa è un’idea che mi sono fatto. Tu che ne pensi?
Anche peggio di così. Certamente, amava il piedistallo, più di quanto lo amino le persone normali, gli intellettuali normali (che già lo amano…). Ma poi diventava scostante non solo per un dissenso ma, come dicevo, anche solo per una nota falsa, per un mancato allineamento ai suoi gusti, alle sue idiosincrasie. Anche questo, mi pare, per puerilità, per insicurezza. Le persone sicure di sé sono liberali; anzi, se ne fottono proprio.
Oggi secondo te Labranca scriverebbe di Youtuber e Tiktoker? O li guarderebbe con disprezzo? Una cosa di cui non sono mai riuscito davvero a tirare le fila è secondo quali criteri una cosa di grande successo fosse per lui meritoria di uno sguardo senza pregiudizi o invece di disprezzo. A un certo punto per esempio tu citi Fedez e il suo matrimonio. Non saprei dire se Labranca lo avrebbe apprezzato per opporsi allo snobismo con cui lo guarda “la cultura di sinistra” e per la sua storia da self-made man, o se lo avrebbe disprezzato per essere un arricchito, volgare, autore di musica di pessimo gusto.
Buona domanda, non lo so. Forse, a quasi sessant’anni, non si occuperebbe di YouTube e TikTok. Ma certo, il Labranca trentenne lo avrebbe fatto. Non aveva i pregiudizi dell’intellettuale medio, del professore, il che me lo rende (ce lo rende, credo) molto simpatico; ma non avrebbe senso dire che non aveva pregiudizi, tutti li abbiamo. Ed è verissimo che aveva delle idiosincrasie, dei partiti presi, che però era ben propenso a mettere in discussione o a cestinare all’occorrenza (Luca Rossi, mi pare, mi ha raccontato che Labranca aveva scritto una pagina irridente su Jovanotti che doveva finire in Chaltron Hescon, poi aveva incontrato Jovanotti su un ascensore, a Mediaset forse, ed era stato gentilissimo, e allora lui aveva buttato via quella pagina). Non mi pare fosse un uomo di princìpi, come si dice, e anche questo me lo rende molto simpatico (c’è quella pagina di Proust in cui il narratore bambino scopre che suo padre, che anziché rimproverarlo per i capricci notturni ha appena permesso alla madre di dormire con lui, “non ha princìpi”: e lo scopre con sollievo, con ammirazione). Su Fedez non so dire. Forse avrebbe preso in giro la sua musichetta puerile, la sua atroce pronuncia dell’italiano, ma insieme avrebbe preso in giro le ubbìe della sinistra che lo critica per i soldi e il materialismo.
Forse l’unica cosa del tuo libro con cui non sono del tutto d’accordo è quando ne parli come di una persona molto aperta, in grado di confrontarsi con il buono o con gli spunti interessanti che ci sono più o meno in tutto, nell’alto come nel basso. Se è sicuramente vero che amava, con la sua intelligenza, far venire fuori spunti interessanti e “alti” anche dalle cose più triviali, mi sembra però che tante cose le disprezzasse per partito preso. Per esempio un po’ tutto quello che si può assimilare al concetto di midbrow.
Non credo affatto che mirasse a far emergere spunti ‘alti’ dalle cose triviali: credo che, come dico nel libro, mirasse a valutare e apprezzare gli oggetti dell’arte e del pensiero – Mozart e Moby, Il gattopardo e la réclame su Rete A – nel loro ordine, senza contaminazioni (ma so che questa è l’idea che si è diffusa, soprattutto per colpa di una lettura affrettata delle sue pagine sul trash). Mentre sono del tutto d’accordo sui partiti presi, come ho accennato. Bisogna anche tenere ben presente una cosa che nel libro spero di dire con sufficiente chiarezza: Labranca era un autodidatta, non aveva una cultura universitaria, non ha avuto maestri che lo indirizzassero e lo limitassero. Questa libertà può essere, ed è stata nel suo caso, una bellissima cosa. Ma ha anche dei lati negativi. Una persona del genere, una persona che scopre tutto da sola, senza mediazioni, è inevitabile che si fabbrichi delle idee un po’ irriflesse, annusando l’aria, innamorandosi e disamorandosi nel giro di qualche mese o di qualche settimana. I partiti presi, gli equivoci, le sopra- o sottovalutazioni sono stati inevitabili. Ma è perché non gli avevano mai dato una bibliografia, ha dovuto farsela da sé.
Quando parlo di spunti alti però non intendo che volesse nobilitare il basso, o che fosse solo un gioco intellettuale un po’ narcisista: lui stesso non me lo avrebbe perdonato, immagino. Intendo che era in grado, da cose comunemente intese come basse (le televendite), di far scaturire intuizioni e pensieri brillanti. Credo fosse un pregio, un merito, non è una critica. Grazie alla commistione tra la sua cultura e la perenne immersione nel popolare era in grado di riflessioni profonde a partire da cose che a noi comuni mortali non avrebbero detto quasi niente.
Sì, questa è la formulazione che sottoscriverei. Aggiungendo solo che non era il solo, o meglio che in Italia era uno dei pochi, e certamente il più articolato, ma che in altri paesi figure del genere si trovavano già negli anni Novanta, e oggi ovviamente si trovano in grande quantità. Qui c’entra un ritardo italiano nella valutazione equilibrata del pop che ha a che fare con la nostra tradizione umanistica, un po’ sospettosa del nuovo e del diverso, soprattutto del nuovo e del diverso che non passi per la carta stampata – ma si aprirebbe un lungo discorso, che nel libro ho solo accennato citando il libro di Cowen, In Praise of Commercial Culture.
Tornando ad alcune antipatie per partito preso, forse poteva trattarsi ancora una volta di una questione personale? Del resto uno scrittore di successo era sicuramente una figura più vicina e assimilabile a lui di quanto non fossero Haiducii od Orietta Berti. Insomma, parlare bene di uno scrittore di successo poteva quasi essere per lui controproducente dal punto di vista del successo personale, mentre questo meccanismo sicuramente non si poteva applicare trattando di pop rumeno. Mi viene in mente la battuta che citi di Gore Vidal sul non volere solo avere successo, ma volere che gli altri falliscano. In particolar modo i tuoi simili.
No, il fatto è che la letteratura non gli interessava granché, gli interessavano soprattutto i dischi, i film e la televisione. I giornali e i libri, e le gelosie nei confronti di chi scrive sui giornali e pubblica libri – questo viene dopo, ed è vero (era competitivo, invidioso, maldicente), ma riguarda il modo in cui era fatto, non la sua opera. Cioè, non è che sceglie di parlare di Haiducii o di Orietta Berti perché parlare di Aldo Nove o di Tiziano Scarpa gli toglierebbe la luce dei riflettori (tra l’altro in Chaltron Hescon e in RIO parla eccome di Nove e di Scarpa, ed è largo di elogi), è che il pop rumeno e Orietta Berti sono, per lui, oggettivamente, più interessanti. O se vuoi metterla diversamente: i suoi strumenti critici, diciamo, erano adatti a Haiducii e alla Berti, non a Nove e Scarpa (o a Piero Chiara, o Isherwood, o Siti, o altri scrittori che ammirava).
Ho approcciato il libro pensando di trovare, non tanto esplicitamente da parte tua quanto nella mia lettura, un atto di accusa contro il sistema culturale italiano e il suo mercato, che aveva fatto sì che una delle menti più brillanti degli ultimi decenni finisse quasi reietta. Sicuramente in parte è così, ma non è neanche così semplice: dal tuo libro emerge che spesso non ha voluto “abbassarsi” ad alcune cose (pur facendone di peggiori), non ha accettato compromessi, che le biografie “alimentari” non pagavano poi così male, che in molti dicono che ha attivamente perso tutte le occasioni che aveva avuto… Tu che idea ti sei fatto al riguardo?
Poche cose mi erano e mi sono lontane quanto il lanciare un ‘atto d’accusa’, di qualsiasi genere. Per carità. Parlare di colpa o di responsabilità, in questi casi, è ridicolo. Ma certo: Labranca ha avuto molte occasioni, e certamente le ha sfruttate male o non le ha sfruttate affatto, o per incapacità, o per capriccio, o per un comprensibile, encomiabile anche, desiderio di rigore che si è rivelato (non poteva non rivelarsi, in un mondo come quello dello show-business italiano) controproducente. Io ho solo cercato di dare qualche elemento di valutazione oggettiva. Poi certo, è chiaro che fa riflettere, fa riflettere amaramente, il fatto che una delle persone più intelligenti della sua generazione sia stato usato così male dal – chiamiamolo così – “sistema”. E certo, in quello che ho scritto c’è anche un giudizio sul “sistema” italiano, sul pubblico italiano, un sistema e un pubblico che non mi pare apprezzino molto l’intelligenza, l’originalità, il non-conformismo. Ma questo sarebbe un discorso molto più lungo.
Il libro, attraverso Labranca, è anche un affresco di questi decenni, e di molte sue tendenze culturali. Secondo te cosa resterà? Cosa ci ricorderemo? Davvero gli anni Dieci sono stati solo gli anni in cui i device sono diventati più piccoli e Internet più veloce (come disse lui in un’intervista a Che tempo che fa)?
Non lo so, si è sempre cattivi giudici degli anni che si sono vissuti e si vivono. E il giudizio è molto influenzato dalla vita che si è fatta e che si fa, dal lavoro, dai soldi, dal livello d’istruzione, insomma tutto dipende se si guarda il mondo dalle poltrone di prima fila o dalla piccionaia. A livello globale, mi pare evidente che il cambiamento quantitativo nella nostra comunicazione – essere sempre connessi, non solo una o due volte al giorno – ha generato un cambiamento qualitativo, nel modo in cui viviamo, che sarebbe assurdo ovviamente qualificare come ‘migliore’ o ‘peggiore’. Ma certamente, da un punto di vista materiale e ideale insieme, la democratizzazione del dibattito prodotta dai social, con tutte le sue conseguenze (stavolta, a mio giudizio, il giudizio di un professore, più negative che positive) è forse il fenomeno centrale degli anni Dieci. Labranca l’aveva capito, ma come molti altri. Quanto all’Italia, mi pare che l’evento del decennio sia il 32% del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 2018, un evento i cui effetti – politici, morali – dureranno molto più a lungo dell’eventuale estinzione del Movimento. Se invece parliamo di cultura e acculturazione, mi pare che il fenomeno più importante, reso possibile soprattutto da internet, è la conquista dell’inglese da parte di una vasta porzione del pubblico italiano, la competenza passiva se non ancora quella attiva. Non se ne parla molto (forse anche perché la vita pubblica è ancora gestita da cinquanta-sessantenni che a scuola hanno fatto francese: pensa a certi nostri ministri), ma è un fatto che, nel lungo periodo, mi pare molto importante.
Una curiosità quasi personale: ho letto tutti i suoi libri principali, quelli davvero parte del suo percorso, mentre non ho mai osato leggere quelli “alimentari”. Chiedo a te che avrai dovuto studiarti un po’ tutto: come sono? Ne varrebbe la pena? Riusciva in qualche modo a far emergere la sua acutezza di visione anche da una biografia dei Coldplay o di Skin? Nel libro dici per esempio che quella di Renato Zero è molto riuscita.
Sì, la biografia di Zero è molto riuscita perché è un ritratto del pop italiano, quindi della vita italiana, tra gli anni Settanta e i Novanta, e non ce ne sono molti, ed è pieno di osservazioni intelligenti che con Zero c’entrano poco. Consiglio caldamente la lettura. Anche gli instant-book su Jackson e Taricone sono interessanti, ma meno belli, anche perché Labranca li ha scritti in una settimana. I libri sui Coldplay, su Skin, su Fogli, su Calà, eccetera invece non aggiungono molto: sono migliori del prodotto medio congenere, e a volte c’è qualche pagina brillante, che sporge un po’ dalla nuda cronaca, ma restano libri servili.
Una domanda poetica, un bagliore di speranza, o forse una forzatura: giustamente sottolinei il suo odio per l’ideologia, e per via di questa sua posa anche molto insistita è davvero difficile considerarlo anche solo un po’ di sinistra. Ma, mi chiedevo, quella sua “personale Ginestra” che citi verso la fine, quel verso in cui dice che “si deve migliorare insieme” e non da soli non è poi il senso stesso della sinistra?
Non direi odio per l’ideologia ma insofferenza. E non credo che per essere di sinistra (ed evito la chiacchiera su cosa voglia dire questa formula) occorra intenerirsi per un’ideologia, credo anzi il contrario. Ma sì, “si deve migliorare insieme” è una frase “di sinistra” che lui effettivamente scrive. Ma penso che fosse una posa temporanea, non penso che ci credesse fino in fondo, era troppo individualista, troppo misantropo, e troppo sfiduciato nei confronti delle persone che si vedeva attorno (dato che nel libro tendo a volte a sovrapporre i nostri caratteri tengo a precisare che io non mi riconosco in nessuna di queste tre caratteristiche). Non gli piacevano i club, le conventicole, i partiti, quindi credo che l’avverbio insieme per lui avesse un brutto suono. No, credo che il tipo di vita che ha vissuto lo avesse convinto che si migliora da soli, che ci si salva da soli. Non so se sia vero, certo è triste.