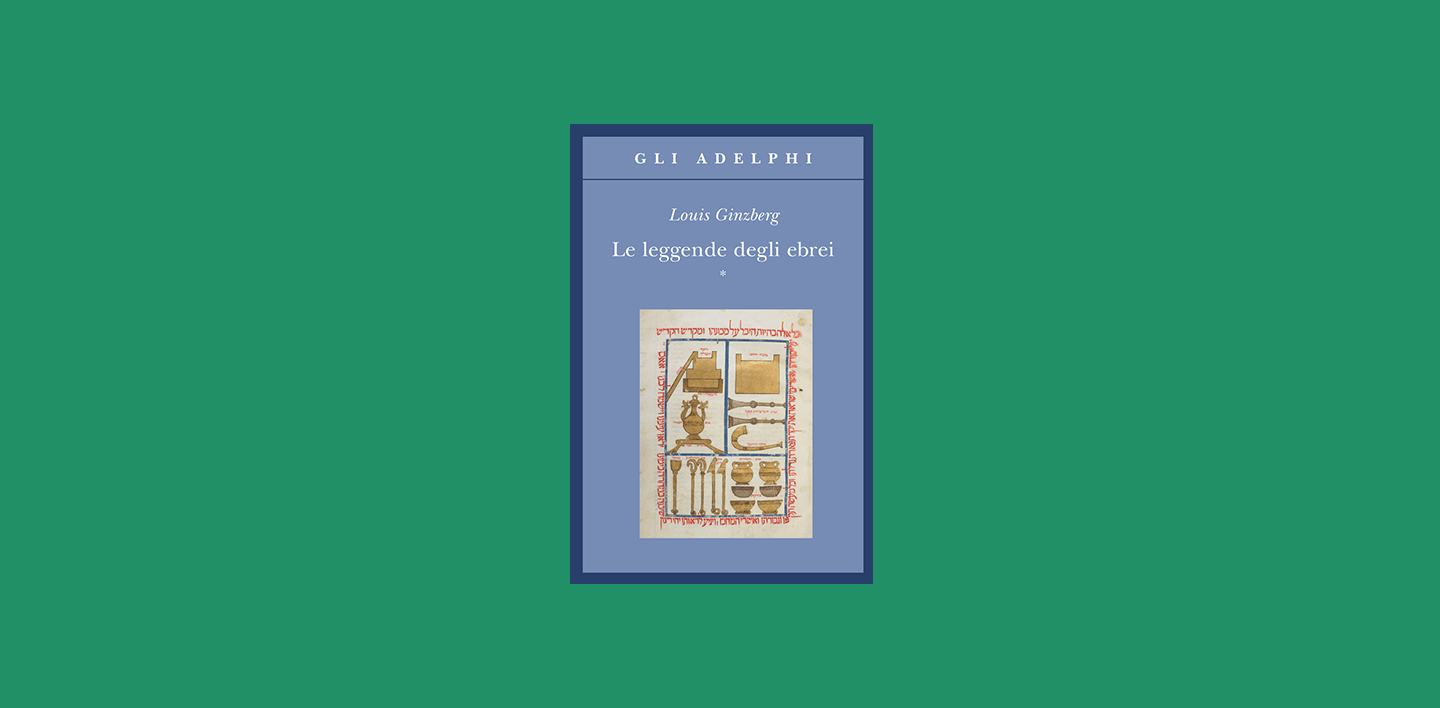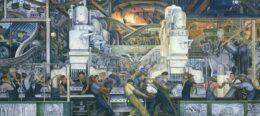M
artin Buber diceva che la natura ebraica si esprime anche nella forma di una comunità basata sul ricordo: “il comune ricordo ci ha tenuti uniti e ci ha permesso di sopravvivere”. Una delle parole che in ebraico indica il ricordo e il ricordare è “Zakhor”, che è anche il titolo di un prezioso libro di Yosef Hayim Yerushalmi dedicato proprio alla funzione del ricordo (pubblicato prima da Pratiche, ora da Giuntina), un verbo che viene usato nella Bibbia quando Israele viene ammonito, appunto, di ricordare. Non si tratta però semplicemente di modellare la propria esistenza su un passato da replicare, quanto invece di arricchire e stratificare ogni volta un patrimonio e farsene carico (la scrittrice e studiosa Yarona Pinhas, ha scritto che “Il ricordo è azione, è lavoro continuo: è il futuro che nasce dal presente, è l’interazione armoniosa di luogo – dove – e spazio – espansione e fruttificazione”): è chiaro quindi che questo materiale si fa sempre più grande e quindi sempre più complesso e faticoso potrebbe risultare serbarlo e rielaborarlo. Ha cercato di semplificare questo compito Louis Ginzberg, rabbino e filosofo di origine lituana e poi vissuto negli Stati Uniti, studioso della Torah, tra i più autorevoli rappresentanti dell’ebraismo ortodosso: la sua attenzione si è concentrata sulle leggende ebraiche e frutto di questo grande lavoro sono stati i sei volumi (sette se si considera anche l’ultimo con le note) che pubblicò negli Stati Uniti tra il 1909 e il 1938. I singoli libri sono stati pubblicati in Italia da Adelphi, con la cura sempre precisa e acuta di Elena Loewenthal, e Le leggende degli ebrei vengono adesso raccolte dall’editore milanese in due grossi volumi di quasi duemila pagine (il primo raccoglie i sei libri di leggende, il secondo le note e gli indici che costituiscono una preziosa novità), due volumi che consentono felicemente di superare la frammentarietà aprendo a una più semplice consultazione.
La mole di questo libro è impressionante, così come lo è stato il lavoro di Ginzberg. Le Leggende degli ebrei sono infatti una narrazione delle vicende della Bibbia dal primo capitolo dedicato alla creazione del mondo a quello incentrato sulle avventure della regina Ester, l’ultimo libro del canone sacro. Queste storie sono arricchite da dettagli, divagazioni e suggestioni che provengono non solo della letteratura ebraica e rabbinica, ma anche da molte altre fonti, come quelle ellenistiche e cristiane. Per portare a termine questo lavoro Ginzberg ha vagliato e collazionato un numero straordinario di fonti, non tralasciando neanche i momenti apparentemente minori, riuscendo a dare a questo corpus sterminato una forma organica:
Questa mia opera – scrive Ginzberg nella
Prefazione – rappresenta un primo tentativo di raccogliere dalle fonti originarie tutte le leggende ebraiche, limitatamente a quelle che si riferiscono a personaggi ed eventi biblici, e di riportarle con la maggior completezza e precisione possibili.
Non è certo possibile, in questo ristretto spazio, dare conto delle storie che Ginzberg assembla e ricostruisce, né forse è interessante farlo perché, e qui sta una delle ricchezze di questa opera, le Leggende degli ebrei rappresentano un profluvio di storie e di parole nel quale è possibile entrare da qualsiasi porta di ingresso si ritenga più adatta, quella più vicina alla propria indole o quella che meglio si confà a un preciso momento della propria esistenza. Il risultato non cambierà e arriverà se si è in grado di mettersi in ascolto della parola e dei propri itinerari di ricerca. All’interno di questa materia sterminata, è comunque possibile evidenziare un’interessante linea di lettura, la straordinaria capacità narrativa di Ginzberg, luminosa testimonianza della grandezza del suo lavoro. Scorrendo infatti tra le diverse storie che vengono raccontate, ci si accorgerà immediatamente dello stile affabulatorio che impregna il suo dettato: una delle impressioni principali durante la lettura è infatti quella di trovarsi in una stanza con lo stesso Ginzberg nelle vesti di un anziano che tutto conosce delle storie degli ebrei e si impegna nel tentativo di mantenere viva la memoria attraverso il racconto. Si pensi per esempio al momento in cui viene riportata la morte di Mosè (personaggio al quale è dedicato il numero maggiore di capitoli e pagine), dove Dio si rivolge direttamente alla sua anima: “Figlia mia, 120 anni ti avevo assegnato da vivere dentro il corpo di questo sant’uomo. Non indugiare più, figlia mia. È giunta l’ora”. Così continua il racconto di Ginzberg:
L’anima rispose: Tu mi hai creato e posto nel corpo di questo sant’uomo: esiste forse al mondo un corpo più puro e immacolato e santo di questo? Sto bene qui, non voglio andare via! Ma l’Eterno ripeté: Non indugiare, figlia mia, la tua fine è ormai arrivata… Quando si avvide che l’anima rifiutava di uscire da lui, Mosè congedò l’anima sua con queste parole: Torna, anima mia, alla tua pace, perché il Signore è stato buono con te! E fu così che il Santo, sia Egli benedetto, prese l’anima di Mosè baciandolo sulla bocca… Dio stesso pianse per la morte di Mosè. Non piango per Mosè – spiegò il Signore – ma per ciò che i figli d’Israele hanno perduto con la sua dipartita.
Già Gianfranco Ravasi ha notato come da queste pagine emerga il racconto commovente di una scena esemplare, quella in cui Mosè sente venire via il suo soffio vitale, che si cristallizza nella bellissima, e definitiva, conversazione con Dio. Ciò che colpisce di questa vicenda, che in questo frangente si è riassunta, è la bellezza del dialogo a tre tra Dio, Mosè e la sua anima, tre personaggi uniti da un dolore dalle sfumature diverse che si tramuta però in un pianto comune.
La stessa sensazione si avverte anche leggendo le altre parti di questa incredibile opera: ci si sentirà sospesi tra il Cielo e la Terra nelle pagine dedicate alla creazione (dove immediatamente si forma il connubio tra mondo e parola “Quando Dio si accinse a creare il mondo per mezzo della Sua parola, le ventidue lettere dell’alfabeto discesero dalla sublime e maestosa corona divina dove erano state incise con una penna di fuoco fiammante”), inermi di fronte agli avvenimenti della vita leggendo dell’esistenza di Giobbe (“l’uomo non può comprendere la sapienza divina, sia ch’essa si manifesti nelle cose inanimate e nella natura, sia per ciò che riguarda la vita dell’uomo”) o ancora strabiliati dalle incredibili vicende della regina Ester nelle pagine che chiudono questa formidabile storia con il salvataggio del popolo ebraico dallo sterminio (“Ester si recò dal re accompagnata da tre attendenti, uno alla sua destra, uno alla sua sinistra e il terzo che le sorreggeva lo strascico appesantito dalle pietre preziose di cui era tempestato. Ma il suo ornamento principale era lo spirito di santità sceso su di lei”). Un simile sentimento di sorpresa e trasporto si ritroverà anche nelle numerose immagini di angeli che vengono presentate tra queste pagine, come quelli che, alla morte di Adamo, pregheranno Dio affinché abbia pietà della sua anima (“Giunti lassù, bruciarono incenso finché le nuvole di fumo avvolsero i cieli e poi pregarono Dio di aver pietà della Sua immagine e dell’opera delle Sue sante mani”).
Gli angeli sono anche figure fondamentali per quanto riguarda la storia del linguaggio, tanto che saranno protagonisti della distribuzione della parola: “quando l’Eterno discese con settanta angeli capeggiati da Michele, ordin[ò] loro di distribuire i settanta idiomi fra le settanta famiglie di Noè”. Le leggende degli ebrei è infatti anche, e forse soprattutto, un inno alla parola, al racconto come collante di una comunità, alla storia come creazione per l’unità: per poter incarnare con successo questa idea, le ricerche di Ginzberg vanno a rintracciare i loro fondamenti nell’antichità, cercando di ritrovare il potere della lettera in queste storie antichissime: “Come il nome aderisce all’uomo, così gli uomini aderiscono ai nomi” scrive Ginzberg nella sua Prefazione, insistendo sul fatto che se per l’uomo antico il nome è già parte dell’essenza della persona o della cosa che si nomina, anche negli stadi più avanzati di civiltà “i giudizi non vengono sempre formulati in accordo con la realtà dei fatti ma piuttosto in base ai nomi con cui sono chiamati”. Esemplare è, da questo punto di vista, la vita di Davide, il re d’Israele che secondo la tradizione compose i Salmi (ed epica è anche la sua morte, che “non significò certo la fine della sua gloria e grandezza, ma soltanto un cambio di scenario”). Quest’atto creativo (che porterà Davide anche a cadere nella trappola della superbia) nasce all’interno di una devozione nella preghiera tale “da far scendere in terra cose dal cielo”, a segnare appunto questa unione tra la parola, le cose del mondo e ciò che ne è fuori, in un impegnativo sforzo nomotetico, il forgiatore di nomi è “tra gli uomini […] il più raro degli artifici” ha scritto Platone: uno sforzo che è, alla fine, essenza stessa non solo della preghiera ma anche della letteratura.