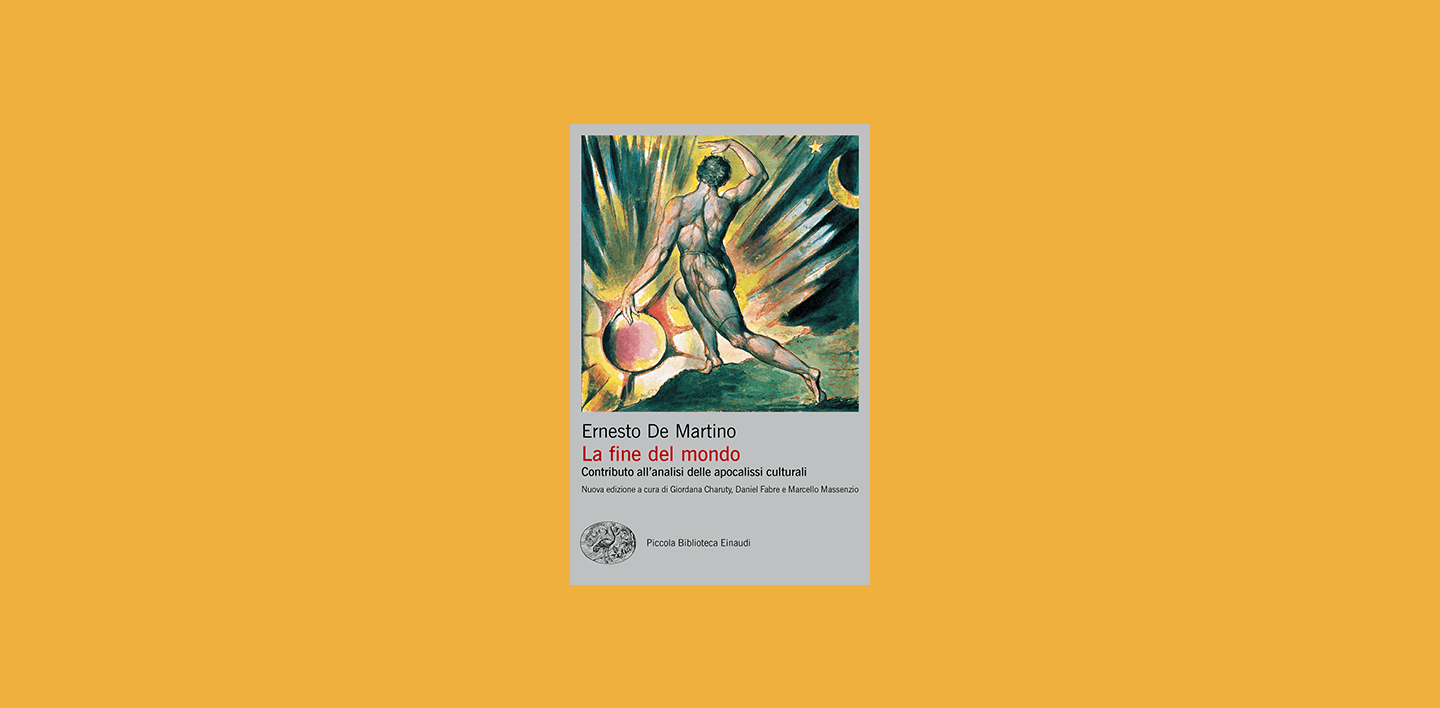L
a fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, ambizioso e affascinante libro postumo di Ernesto De Martino, fin dalla sua prima edizione del 1977 ha dato occasione di ripensare all’intera opera dello studioso napoletano. Per un verso, infatti, non si trattava di un’opera, ma di un progetto incompiuto, di cui quell’edizione riportava un’ampia scelta di documenti – saggi preliminari, bozze, appunti, estratti commentati di una sterminata bibliografia – trasferendo il lettore nel laboratorio di De Martino. Per l’altro verso – come diventa più evidente nella nuova edizione ricavata da quella francese, che oggi è riproposta in italiano – quel progetto tracciava un percorso dai forti tratti filosofici che gettava nuova luce sull’intero pensiero demartiniano. Riprendere in mano quel progetto, oggi, è un modo per tornare a parlare di un autore apparentemente inattuale, i cui interrogativi si rivelano lungimiranti.
Per introdurre la questione, bisogna prima di tutto chiarire a quale “fine del mondo” si riferisse De Martino. Non si trattava, in senso naturalistico, di una “catastrofe cosmica che può distruggere o rendere inabitabile il pianeta terra”, ma di una perdita “del senso dei valori intersoggettivi della vita umana”, per cui si può “annientare la possibilità della cultura”. Una fine del mondo in questo senso era una possibilità già realizzata storicamente per determinate civiltà. In una conversazione con Cesare Cases, De Martino osservava:
La fine del mondo c’è sempre stata. Che altro vuoi che abbiano pensato gli Incas o gli Aztechi di fronte ai conquistadores spagnoli, questi marziani piovuti da chissà dove, se non che quella era la fine del mondo? Noi possiamo dire che era la fine del loro mondo, ma che cos’è la fine del mondo se non sempre la fine del proprio mondo?
Queste parole fanno venire in mente le foto degli aborigeni australiani – riportate ne Il mondo fino a ieri di Jared Diamond (2012) – che, al primo incontro con gli europei, scoppiano in lacrime disperate. Ma l’esempio più vicino a De Martino era stato il crollo della tradizione mitica e terapeutica del tarantismo pugliese, osservato durante la memorabile spedizione in Salento documentata ne La terra del rimorso (1961). Di fronte a questi fenomeni, De Martino s’interrogava sulla ricerca di nuove risorse simboliche, religiose e laiche, che interessavano il mondo contemporaneo dall’Italia alla Russia sovietica ai paesi in via di decolonizzazione. Ma la domanda, per De Martino, si rifletteva sulla civiltà europea in genere, che poteva senz’altro durare materialmente, ma poteva “impiegare le stesse potenze del dominio tecnico della natura secondo una modalità priva di senso”.
Ecco la questione del nuovo progetto: interrogare la “crisi” nel mondo contemporaneo e i modi in cui a questa si può reagire sul piano simbolico e culturale, confrontandoli con quelli praticati fin dall’antichità. Così La fine del mondo si apre con un’analisi di un rituale di apertura di un varco sull’aldilà e di rigenerazione del mondo nella Roma antica, poi analizza la crisi individuale del “delirio schizofrenico di fine del mondo” di un contadino di Berna e si concentra in genere sulle “apocalissi psicopatologiche” in cui si manifesta la fragilità dell’uomo contemporaneo; il libro doveva trattare poi dei diversi modi in cui il tema di una fine dei tempi era stato affrontato dal cristianesimo e dal marxismo, e di come si esprimeva nella letteratura europea (Mann, Sartre, e così via) e nei movimenti apocalittici del terzo mondo. Il tratto unificante di questa ampia fenomenologia era una crisi di simboli e valori che per De Martino andava interrogata con un “doppio sguardo”, quello interno su sé stessi in quanto europei e quello su altre civiltà, all’insegna di un “umanesimo etnografico” che mirava a cercare nuovi orizzonti di senso in una prospettiva globale, ma senza rinunciare alla propria specificità storica in nome di un astratto relativismo.
I concetti di “crisi” e di “mondo” rimandavano alle origini del percorso demartiniano, in paticolare a Il mondo magico (1948), il capolavoro che nell’immediato Dopoguerra – analogamente alla Dialettica dell’illuminismo di Adorno e Horkheimer – affrontava il problema di come si potesse conciliare la fine delle tradizioni arcaiche con la ripresa di una civiltà borghese che prometteva progresso ma che aveva portato anche alla catastrofe del nazismo. In questo libro si poneva il tema filosofico centrale della sua opera, la “crisi della presenza”, cioè il problema di una costitutiva fragilità dell’io che non dipendeva da fattori fisiologici e medicalizzabili ma da un intrinseco bisogno di orizzonti simbolici per l’agire. De Martino individuava nella magia l’esempio di un procedimento arcaico di protezione simbolica dell’individuo che non trovava più sicuri correlati nel mondo moderno, e si era ripresentato in forma distruttiva nella cultura fascista e nazista:
Un’altra epoca, un mondo storico diverso dal nostro, il mondo magico, furono impegnati nello sforzo di fondare la individualità, l’esserci nel mondo, la presenza, onde ciò che per noi è un dato o un fatto, in quell’epoca, in quell’età storica stava come compito e maturava come risultato.
Con un salto metodologico che non ha smesso di far discutere, De Martino costruiva una sua originale apparecchiatura teorica per analizzare la crisi dell’individuo attingendo a Heidegger, all’esistenzialismo, alla fenomenologia religiosa di autori come Mircea Eliade e Rudolf Otto, per applicarla a un problema posto da Gramsci (altra influenza decisiva, di cui nello stesso 1948 uscivano i Quaderni del carcere), cioè quello delle culture subalterne del Sud Italia. Nella sua “trilogia” meridionalistica – Morte e pianto rituale (1958), Sud e Magia (1959), La terra del rimorso (1961) – De Martino esplorava il tema della crisi della presenza in culture dotate di antiche risorse pagane che si erano fuse al cristianesimo e sostenevano l’individuo, nel momento storico in cui la compattezza di quell’orizzonte mitico-religioso iniziava a essere rotta dall’accesso alla modernità. D’altra parte – in Furore simbolo valore (1962) – De Martino avanzava l’ipotesi che un nuovo “simbolismo laico”, quello socialista, potesse sostituire quello religioso e assolverne la funzione nell’orientare le masse di contadini e proletari che irrompevano nella storia del Novecento. Si trattava di una concezione molto legata al contesto storico-politico di quell’epoca, che ne La fine del mondo, con i suoi documenti frammentari e le sue ipotesi aperte, non resta che un’ipotesi tra le tante.
Tutte queste idee diedero un’immediata propulsione alla cultura dell’epoca – si pensi solo al debito verso De Martino di storici come Carlo Ginzburg e Paolo Rossi, o psichiatri come Giovanni Jervis – ma furono subito criticate da più parti, senza soddisfare quasi nessuno. L’impostazione filosofica di De Martino, resa più evidente nella nuova edizione, fu all’origine di un dissidio con Croce, di cui De Martino si riteneva allievo, perché presentava l’ipotesi di un venire meno della storia e di una ricaduta dell’uomo a natura, in fasi storiche particolarmente critiche, che il filosofo non accettava. D’altra parte, molti hanno lamentato l’idealismo della sua prospettiva, che pone una condizione della cultura in uno slancio etico non analizzabile né in termini scientifici, né in termini sociali – l’”ethos del trascendimento” – che può di volta in volta permettere all’uomo privato di un sicuro orizzonte culturale di superare la crisi e accedere a un altro orizzonte di senso.
Quest’ultima critica è ingenerosa, e occulta gli aspetti che dal punto vista attuale appaiono più interessanti dell’opera demartianiana. De Martino difendeva con tenacia la sua idea che la crisi individuale non è riducibile a una causa naturale, ma consegue a una lacerazione di un tessuto sociale e culturale, ponendosi tra i due estremi dell’idealismo allora ancora dominante in Italia e di un riduzionismo psiconeurologico emergente. L’inattualità dell’ultimo De Martino continua a parlarci proprio per le opzioni – teoriche e politiche – che rifiutava. Piuttosto che rievocare una solidarietà tradizionale come i tanti pensatori della destra religiosa da lui frequentati, De Martino poneva il problema di affrontare la ricerca di nuovi orizzonti di senso, di un accesso a valori mondani che non poteva più essere iscritto con sicurezza nell’orizzonte teleologico del cristianesimo o del comunismo. La ricerca sulla fine del mondo, quindi, non era un lamento decadente e nostalgico, ma apriva all’esigenza di esaminare il problema e le sue possibili soluzioni in un’ottica globale, di elaborarlo con un metodo interdisciplinare, capace di abbracciare anche la consapevolezza di altre civiltà emergenti. In questo l’umanesimo etnografico di De Martino non guarda soltanto a mondi finiti, ma riguarda l’incertezza del presente.