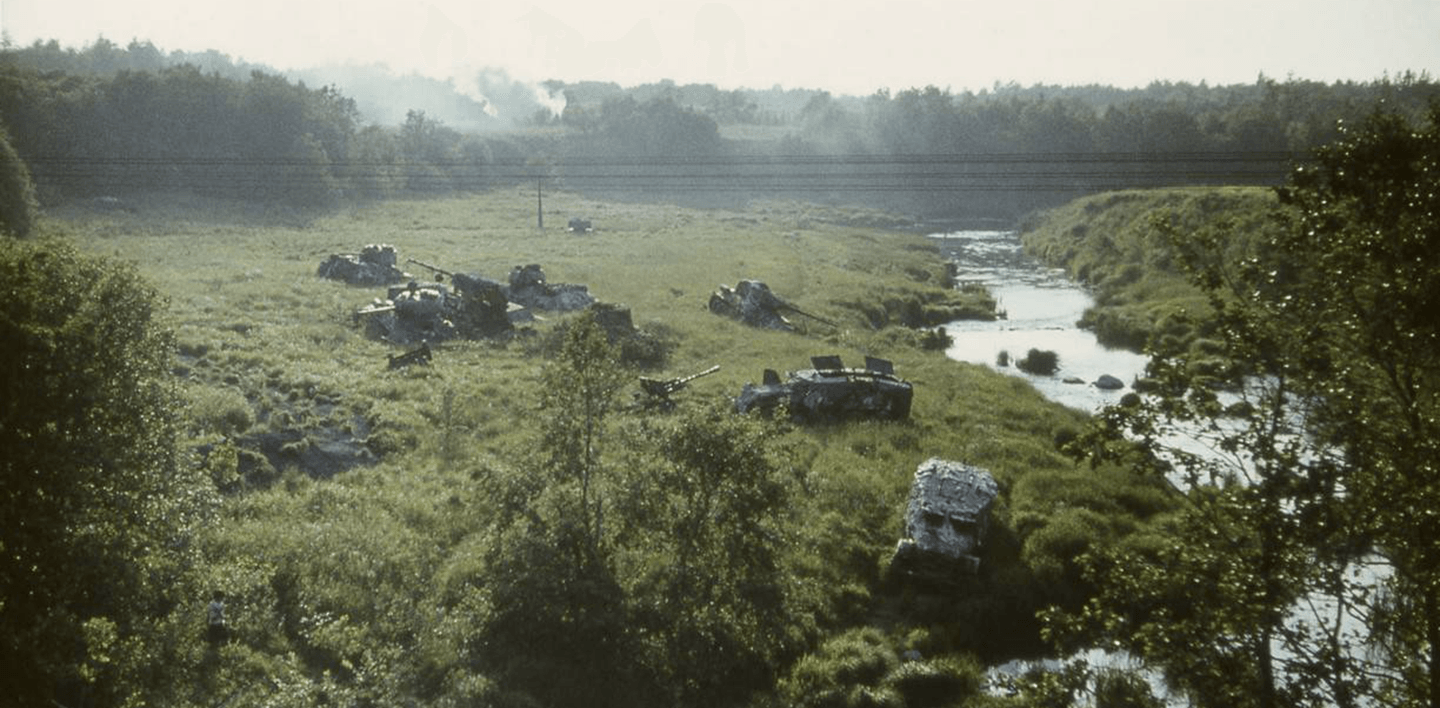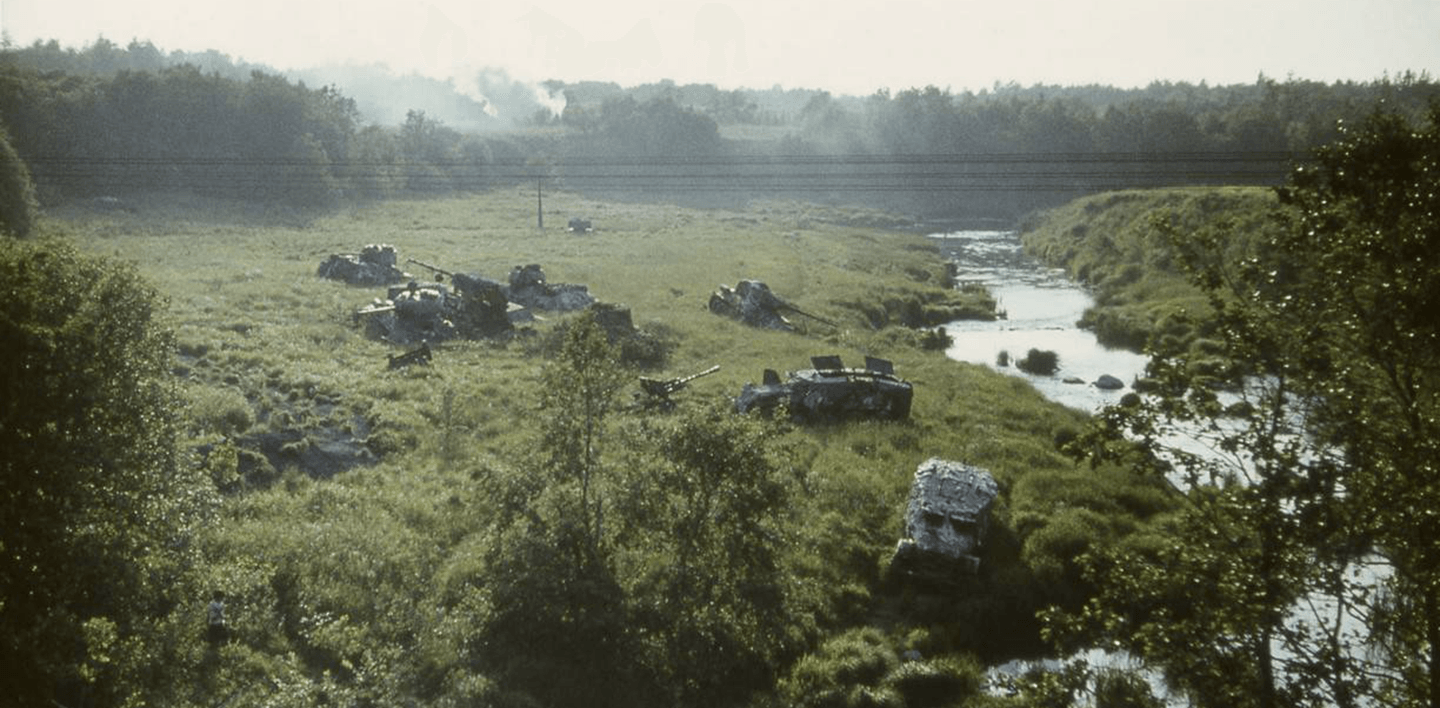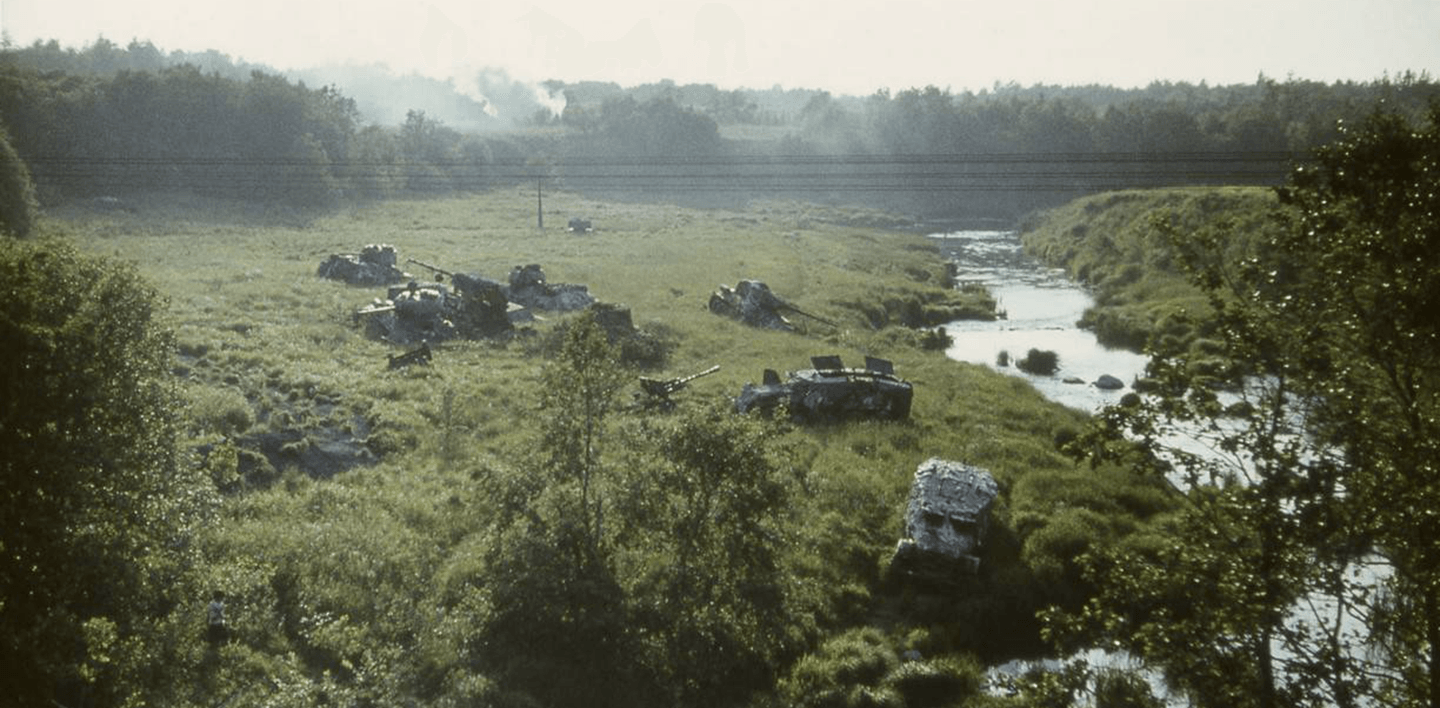I
n un testo in cui il ritratto viene definito “tra tutte le arti umane, ancora più della musica, la più filosofica, ovvero la più ostinata nella ricerca della verità”, Emanuele Trevi cerca il vero con lo strumento che meglio può aiutare a trovarlo, allora, offrendoci il ritratto di Arturo Patten, fotografo statunitense del Novecento, di Amelia Rosselli, poetessa e del critico letterario Cesare Garboli.
In Sogni e Favole Trevi ricorda Ivan Il’ič del racconto di Tolstoj: “Ivan Il’ič ragiona sull’abissale differenza tra imparare a scuola che tutti gli uomini sono mortali e capire che, in quel dato momento, a tirare le cuoia è proprio lui e non c’è più niente come ‘tutti gli uomini’”. Così l’autore dà al lettore la sensazione che non ci sia “più niente come tutti gli uomini”, e per questo ciò che sta scrivendo ha il gusto della confidenza, di un ideale dialogo tra lui e te, che lo stai leggendo. Forse ciò avviene perché, come ci dice all’inizio dell’intervista, quella attraverso la scrittura, diversamente dalla filosofia o dalla scienza, è una ricerca della verità pigra, che non tende all’universale, ma si concentra sul particolare, sulla singolarità.
Nel tuo libro scrivi: “nella sua essenza più profonda, la poesia è la forma suprema della biografia. Al contrario, le epoche di mediocrità letteraria sono caratterizzate da una generale estraneità delle opere all’esistenza che le produce”. Perché definisci la poesia come la forma suprema della biografia?
Quando l’ho scritto pensavo alla formula di Ungaretti che decise di raccogliere tutte le sue poesie in un’opera intitolata Vita di un uomo, formula davvero convincente per me. Quel modello artistico prevedeva scrittori la cui opera era ciò che avevano capito durante la vita, vivendo la quale avevano risposto alla domanda: “cosa mi ha tolto o cosa mi ha dato l’esistenza?”. Oggi esistono libri bellissimi, ma chiunque avrebbe potuto scriverli, tanto debole è il legame tra l’opera e la vita di chi li ha composti.
Al contempo, però, la nostra è un’epoca letteraria in cui l’autobiografia trova ampio spazio.
Sì e la contraddizione è solo apparente, perché protagonista dell’auto-fiction è un io sperimentale. L’auto-fiction è usare il proprio io per proiettarlo in un esperimento di scrittura, si tratta di un genere narrativo, quindi di un prodotto: la quantità di invenzione necessaria per creare la storia di un personaggio fittizio è la stessa che serve per dare vita al personaggio dell’autore. In questi testi che possono essere anche eccezionali manca, però, quella che Philip Roth definisce “la macchia umana”: il percorso esistenziale di un autore che si lascia dietro una specie di bava di lumaca, che è l’opera. L’artista del Novecento cercava il significato della propria esistenza attraverso il mezzo artistico, per questo è stato il produttore di se stesso, basti pensare a Samuel Beckett, Jackson Pollock, Picasso, Frank Zappa.
Si potrebbe pensare che si tratti di una conseguenza della trasformazione del ruolo dell’artista, la cui vita ora, come scrivi, è “un pettegolezzo, una delle tante variabili mercantili della celebrità, un’attraente carriera mondana”. Credi che questo cambiamento intervenuto nel modo di essere un artista si sia verificato a causa dell’avvento del neoliberismo, o perché gli artisti del Novecento erano più grandi, il loro spirito più potente?
Mi ricordo quando è avvenuto questo cambiamento perché c’ero: a un certo punto è sorto un enorme fastidio per quel tipo di artista. La cultura postmoderna che si è sviluppata dagli anni Ottanta, attraverso per esempio il minimalismo, è una cultura in cui la biografia dell’artista e l’arte come apice, espressione suprema della vita dello scrittore, hanno iniziato a essere svalutate.
Intendi dire che la fine della concezione dell’opera come compimento supremo della vita dell’artista fu conseguenza dell’uccisione simbolica dell’autore, anche da parte di critici e filosofi come Roland Barthes e Michel Foucault?
Certo: la vita dell’autore è stata sostituita da un criterio di efficacia. Nel momento in cui si crede che la letteratura si genera dalla letteratura stessa, allora quella breve stagione che principiò con Edgar Allan Poe, Nerval, Beaudelaire e durò fino agli artisti del Novecento, si è esaurita. Però è durata due secoli.
E la tua in Sogni e favole è una autobiografia allo specchio, creata attraverso una carrellata di ritratti altrui?
C’è un elemento di identificazione, sì, ma l’aspetto più importante è proprio il contrario dell’identificazione: la distanza narrativa. Io sono una persona diversa dai miei protagonisti, io manco della loro vitalità: questa specifica opposizione torna sempre nei miei libri. Arturo, per esempio, mi svegliava la mattina e mi diceva di andare a vedere una cosa bella, era felice.
La mia mancanza di vitalità è diventata l’elemento centrale della mia narrativa, in particolare perché so amare ciò che mi è complementare. Questo aspetto lo si trova nel personaggio della bambina in Il libro della gioia perpetua, ispirato a Chiara Gamberale che era mia moglie a quel tempo, oppure in I cani del nulla. È rappresentato, appunto, da Arturo Patten in questo romanzo.
L’amore per la vita io l’ho vissuto di riflesso, ma non si tratta solo di un problema esistenziale, è una questione tecnica, perché a partire da questa distanza imposto la mia voce narrativa. Altre voci narrative, invece, sono fondate sulla affinità, come la biografia di Sof’ja (Sonečka) Gollidej scritta da Marina Cvetaeva.
Studio costantemente libri che raccontano di persone reali, chiedendomi quale punto di vista è stato scelto: lo stile di scrittura che permette di riconoscere l’unicità del personaggio è quello in cui l’autore riesce a trovare la distanza giusta e ciò può avvenire a partire da diversi punti di vista, adeguatamente vicini o lontani.
“Sogni, e favole io fingo”: il sonetto di Metastasio fa da contrappunto al tuo romanzo, guidandoti nella stesura del testo. Da una parte esprime come la finzione dell’Arte sia sullo stesso livello della menzogna della realtà, dall’altra i versi del poeta raccontano una visione specifica dell’esistenza terrena. Trattasi di ateismo radicato o dichiarato misticismo?
Qual è la differenza? Io non riesco a darmi la fede se non ce l’ho, ma ciò non mi impedisce di comprendere un’idea religiosa. Metastasio se l’è fatto incidere sulla tomba: “fa’ che io trovi riposo in sen del vero”. Chissà in che cosa credeva? I sentimenti religiosi sono segreti perché molto spesso coincidono esattamente con ciò che sente chi non è religioso.
Più si invecchia e più si oscilla. Nella vita si perde tanto: funziona come una clessidra, una parte si vuota e l’altra si riempie. Di cosa? Di desideri, di rimpianti, di ciò che non c’è più, ecco perché invecchiando si diventa più propensi a credere a un aldilà, a una dimensione ulteriore delle cose: semplicemente perché sarebbe bello che ci fosse. La vita ci spoglia di tutto. Se dopo la morte potessi riabbracciare le persone care e vivere tranquillo, certo non direi: “eh, no, non ci sto, perché io sono ateo!”.
Da giovane ero più sicuro che tutto fosse materia e sarebbe tornato alla materia, ora so che l’unica cosa certa è che non sappiamo niente; però mi risulta difficile capire perché, se esiste una divinità onnipotente, essa ci debba provare così tanto, col dolore, con la sofferenza, con le catastrofi. Perché non ci rende le cose semplici? Mi è estraneo da sempre, infatti, il concetto di Provvidenza.
Scrivi che “questa è la vita umana, un nome e un lavoro incorniciati da due date, è questo che si prende la morte”; ma anche “noi scivoliamo continuamente, senza accorgercene, nella nostra unicità”. In che modo la pochezza della vita umana e la gloriosa unicità di ognuno non sono in contraddizione?
Sulla lapide di Arturo c’è scritto Arturo Patten Fotografo e poi due date, la nascita e la morte. Fotografo è il nome comune e le date di nascita e di morte ci sono per tutti, allora cosa resta di irriducibile all’universale? Il nome: Arturo Patten. Gli omonimi sono solo l’eccezione che conferma la regola.
Di Metastasio scrivi che ricordava come “cosa più importante della vita” la lontananza dalle origini, dalla povertà di via dei Cappellari, a Roma. Si tratta esattamente del contrario dell’ossessione del ritorno che caratterizza Odisseo e su cui si fonda il mito della nostalgia della patria.
Sì, non esiste l’antonimo di nostalgia, bisogna usare una perifrasi, eppure si tratta di un sentimento ugualmente forte. In Metastasio per trovare una frase che racconti un sentimento personale è necessario percorrere migliaia di pagine di epistolario, di lettere formali, però quando dice una cosa autentica essa ha una forza clamorosa. In questo caso, lui sta raccontando al fratello di vari acciacchi fisici e poi aggiunge, appunto per esprimere davvero ciò che conta: “sono ancora lontano dal punto onde partii”. Io per esempio non ho mai avuto un’esperienza del genere, anzi, sono nato vicino a dove abito e non mi sono mai spostato nemmeno di quartiere. Vivo ancora nei luoghi della mia infanzia, la strada dove abito è la stessa che percorrevo per andare a scuola, anche se ho viaggiato in tutto il mondo, sono sempre tornato qui. Si tratta di narrare di un altro opposto, allora, che mi permette quella distanza narrativa per me necessaria.
“Il luogo più importante della Zona, nel film di Tarkovskij, è la stanza dei desideri. Anche il migliore degli stalker, il più esperto e coraggioso, teme questo portento […] Noi viviamo all’ombra di desideri che non si realizzano, la frustrazione protegge la specie e l’individuo […] Un luogo dove si realizzassero le nostre paure più profonde non sarebbe così pericoloso”. Perché la stanza dei desideri sarebbe tanto pericolosa da esserle preferibile quella delle nostre paure?
Per strani casi della vita mi è capitato proprio nel momento in cui stavo concludendo Sogni e favole di leggere il libro di Geoff Dyer Zona. Un libro su un film su un viaggio verso una stanza (Il Saggiatore, 2019) basato proprio su questa immaginazione di Tarkovskij della stanza dei desideri. Noi sappiamo dire benissimo ciò che non desideriamo, ma chi avrebbe il coraggio di varcare la soglia del luogo in cui il più grande dei nostri desideri diventa realtà? Non sappiamo qual è il nostro più grande desiderio: non ci vuole Freud per capire che quella stanza sarebbe il posto più pericoloso, lo percepiamo d’istinto, perché tutti sanno che il cuore umano è molto più vasto di qualsiasi percorso di analisi che possiamo fare, non si raggiunge mai la conoscenza piena dei suoi desideri.
Dove sono le stanze dei desideri di una città come Roma, “imbrattata di tempo”?
Roma è tempo calcificato. Roma è questa cosa che scorre, il tempo che diventa visibile, evidente. Se il tempo prende un aspetto di spazio prende un aspetto di Roma. Roma è la mia ossessione. È piena di stanze dei desideri, perché camminare per il centro, se si ha una certa età e si è vissuto in un certo modo, significa vedere dei portoni, delle scale che sono legate a un desiderio che chissà dove è andato a finire.
Poi, visto che Roma è la calcificazione del tempo, non può che essere piena di stanze dei desideri anche alla maniera di Tarkovskij, luoghi terribili dove non bisogna finire perché là si realizzerebbe ciò che si vuole nel profondo.