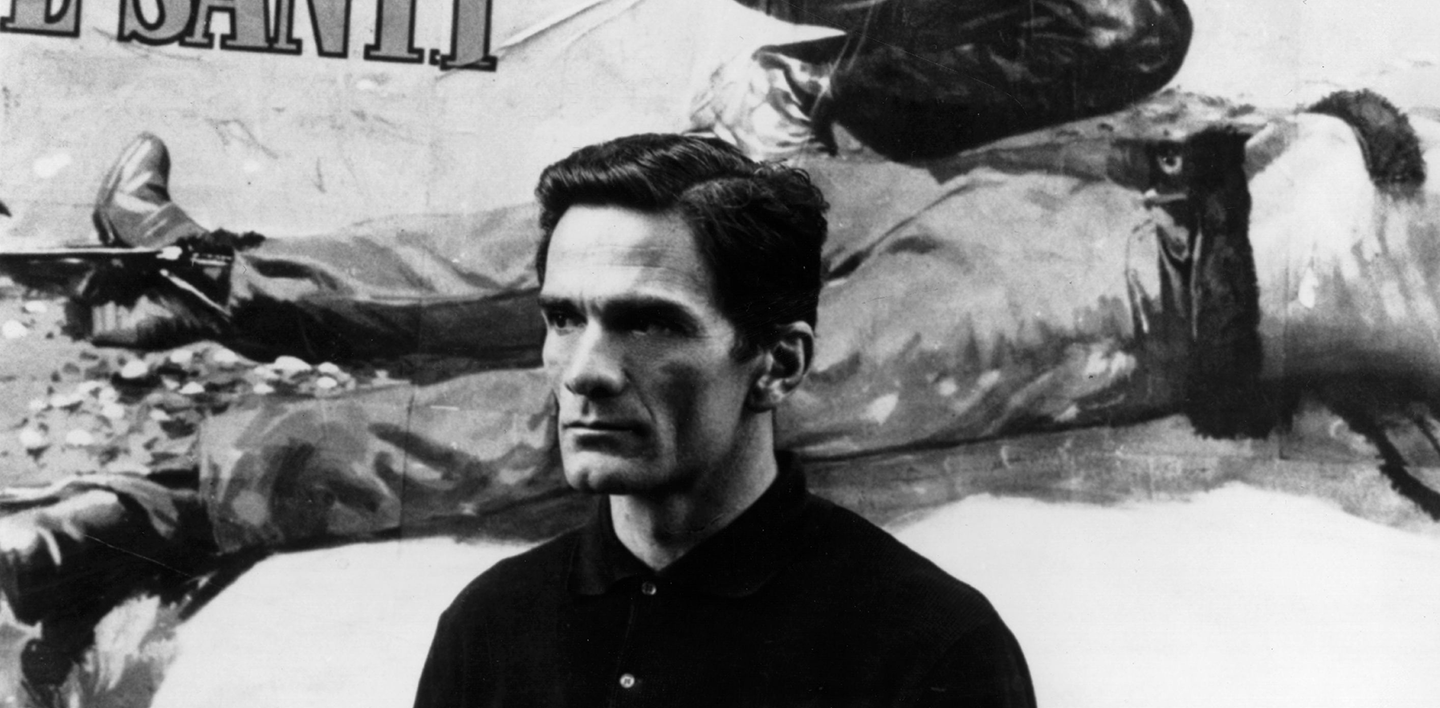
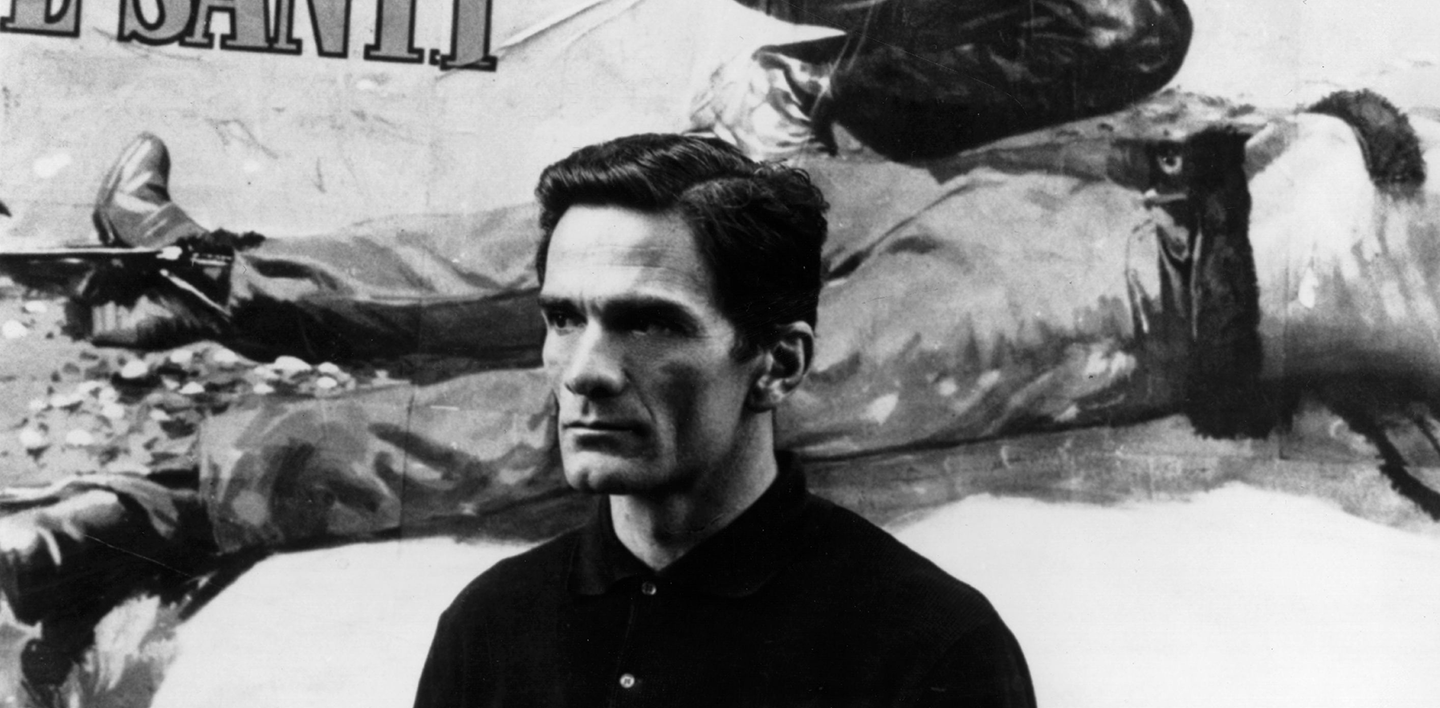
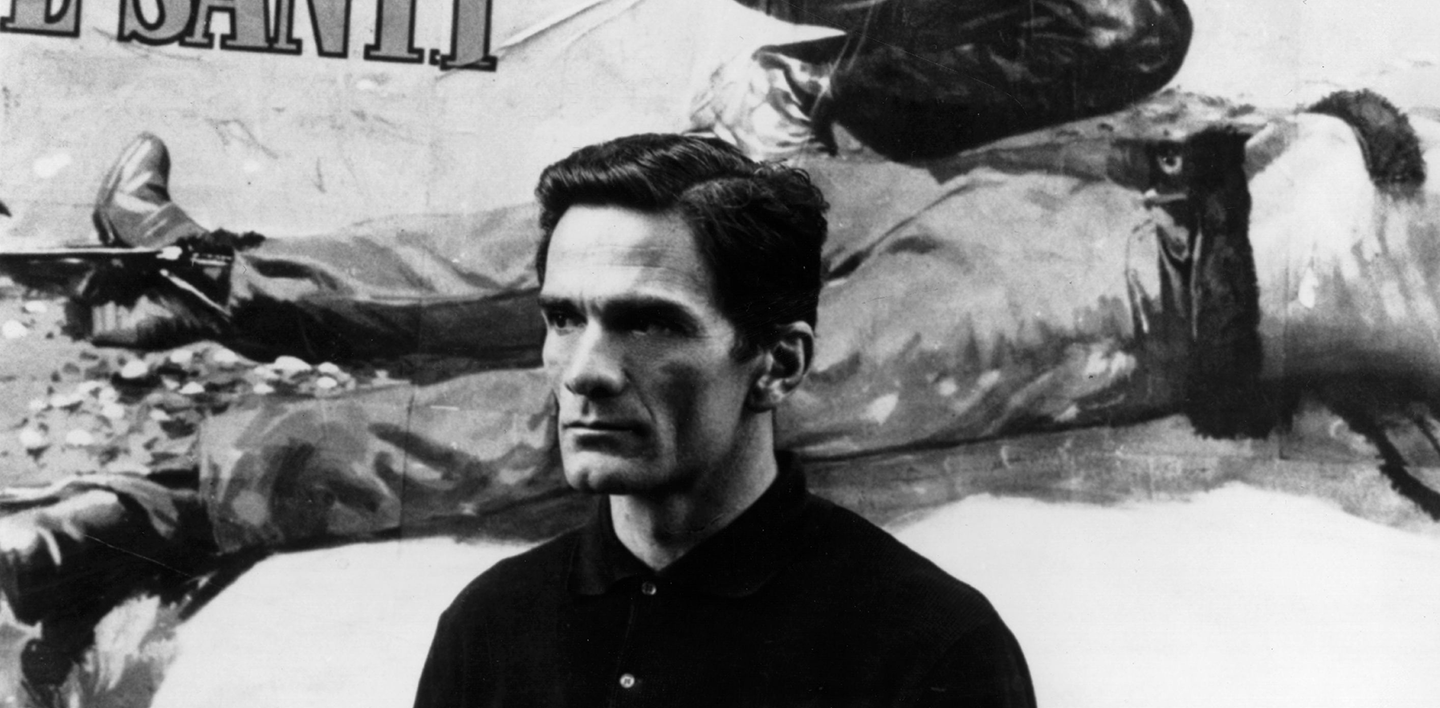
U na vita violenta ha un protagonista nascosto: il movimento. Lo incontriamo fin dall’inizio della storia, con le sue folate: “arrivarono davanti alla scuola almeno una mezzoretta prima. / Lí intorno c’erano già però pure altri pipelletti della borgata, che giocavano sulla fanga col coltellino. Tommaso, Lello e gli altri si misero a guardarli, accucciandosi intorno, con le cartelle che strusciavano sulla fanga: poi vennero due o tre con una palla, e gli altri buttarono le cartelle sopra un montarozzetto, e corsero dietro la scuola, nella spianata ch’era la piazza centrale della borgata”.
In questo romanzo è tutto un arrivare e ripartire, assembrarsi e disperdersi, correre e fermarsi. Dai giochi dei pipelletti ai colpi in giro per Roma, dalle retate della polizia in borgate e ospedali alle serate in centro, ci si muove fino all’ultimo respiro in una Roma mai troppo grande perché non la si possa attraversare furiosamente, a piedi, coi mezzi o sulle macchine rubate. C’è Tommasino che torna a casa a piedi dal quartiere della fidanzata per risparmiare i soldi del tram; ci sono i ragazzi che “si fecero a fette tutto il pezzo dal Ponte Rotto fino al Largo Argentina. Qui incontrarono altre cricche, che se ne venivano con aria indifferente come loro, dalle sezioni lí attorno, Borgo Pio o Ponte o Panigo; e pure quelle piú lontane, Monteverde o l’Alberone, perché per lí passavano parecchi autobus…”.
La possibilità di rubare imprime un movimento elettrizzante: “andarono verso Ponte Milvio, e si diressero alla Cassia… Tagliando per il Gianicolo e per Monte Mario, fecero subito a arrivare in mezzo alla campagna, tutta collinosa…” e poi “riattraversarono mezza Roma, e rifurono sulla Via Portuense”, e “Girarono girarono, rifecero due tre volte la scesa, passarono pei giardinetti davanti al Brancaccio, tornarono indietro”.
È come se Pasolini avesse sostituito il movimento al racconto dei sentimenti, che sono una cosa borghese. Come un Kerouac che tiene i suoi personaggi in un sola città, la Città eterna peraltro, invece che sulle strade d’America.
Gli psicanalisti dicono che i bambini quando corrono hanno come degli orgasmi, esprimono il piacere di vivere con il movimento. Nei due romanzi di Pasolini usciti negli anni Cinquanta, questo e il precedente Ragazzi di vita, non c’è la sofisticata nevrosi dei borghesi novecenteschi che dalla Scandinavia all’Italia dell’amico Moravia, all’America degli scrittori ebrei, contagia le voci interiori dei protagonisti. Herzog, il romanzo di Saul Bellow, comincia quasi negli stessi anni – 1964 – con l’incipit: “Se sono pazzo, per me va benissimo”.
Una vita violenta scarta le nevrosi e vive a razzo, sembra un musical di Broadway, un film di Visconti, una sinfonia, un pezzo di teatrodanza di Pina Bausch o Anne Teresa de Kersmaeker: “La razzietta dei polli a Anguillara andò al dritto, e ne fecero un’altra il giorno appresso, a Tivoli, e poi un’altra a Villalba, e poi un’altra a Settecamini… Il Sabato Santo… andarono a fare lo sgobbo a Ponte Mammolo, ch’era lí a due passi, dietro l’Aniene”.
Il titolo Vita violenta nasconde in sé quel movimento – la vita e la violenza, l’opposto dell’indifferenza e della noia dei personaggi moraviani.
Ora: se parlando di Pasolini non fossimo obbligati a pensare con grande serietà alle implicazioni del romanzo, a quel che dice sulla società capitalista, sul consumismo, sull’assimilazione dei borgatari alla cultura piccoloborghese dopo la guerra, al processo per oscenità (concluso con l’archiviazione), potremmo pensare che lo scopo principale di questo libro, nascosto nel titolo, sia stato creare in prosa un movimento così vitale da essere violento per gli standard della letteratura italiana del Novecento.
Bene. Detto ciò, questo romanzo ha anche un protagonista vero e proprio: Tommasino, un ragazzo di borgata, e i suoi amici e conoscenti grandi e piccoli: Pasolini li chiama “polletti che correvano in mucchio dietro la palla”, “visi gialli di volpi affamate” “cagnoletti ancora poppanti”, “ragagnottoli”, “curiosi come scimmie”; in un caso paragona Tommaso, in un momento di tensione, a una “lumaca quando esce dalla sua casetta, e punta in alto le corna”. Così vitali da non poterli non paragonare ad animali. Pasolini lo fa spesso, come a spingerci a prendere posizione, a dire indignati: “ma sono animali!”. Sembra che Pasolini voglia esplicitamente portarci a questa conclusione, come quando trascina per pagine la seduzione fra Tommasino e Irene, al cinema, fino a farci vedere in che maniera brutale lui si fa dare ciò che vuole nel buio della sala, con l’effetto di siglare un patto vergognoso, tanto che dopo escono dal cinema camminando “zitti, come vecchi fidanzati, che non hanno niente da spartire col resto della gente”.
Tommaso gioca, commette crimini, sempre in gruppo, si trova una fidanzata, si fa arrestare. Succedono altre cose, ci sono delle redenzioni vere o finte, oppure trionfa il caso, probabilmente trionfa il caso, o la merce, o la morte. Ci sono borgate e palazzi popolari da occupare o farsi assegnare. Basta cominciare ad accennare alla trama e ci si trova costretti a scrivere una tesi di dottorato, o un manifesto politico. Quando si parla di Pasolini si ha voglia di fare i compiti perché se si dice la cosa sbagliata su Pasolini poi non si campa più.
Invece leggendo questo libro – meglio ancora, ascoltandolo – a me viene voglia di giocare.
Come gioca Pasolini, che per raccontare la schifosa vicenda di un gruppo di fascisti che vanno a tirare merda contro un albergo perché ospita una delegazione di cecoslovacchi, usa una messainscena esilarante che fa sembrare simpatici i fascisti (ma a essere simpatico è anche stavolta il movimento): “Allineati qua e là, sui marciapiedini, agli angoletti delle strade, sugli scalini della fontana, cominciavano a fischiare, a organizzare la gazzara”. “I camerieri già s’erano dati, dopo aver chiuso alla scappavia tutte le finestre, e solo la porta era mezza aperta, col proprietario che ogni tanto ci faceva capoccella, cagandosi sotto per la paura. «Via li cecoslovacchi!» gridavano intanto beffardi i missini, e giú fischi di nuovo”. Questi missini vengano avanti “a passo di marcetta, coi mastelli in mano: mastelli, bagnarole, secchi”. I secchi sono pieni di merda.
Presero e incominciarono a buttarla contro la porta e la parete dell’alberghetto. Ci voleva una tattica speciale, perché la merda, buttata, non rischizzasse addosso a chi la buttava e agli altri ch’erano intorno. Prendevano il secchio agili per il manico e per il fondo, e via, con un colpo secco, la scaricavano, uno qua uno là”. C’era una tanfa che toglieva il fiato, e tutti ridevano, ridevano, sgriciolandosi.
Ci vuole del genio e del coraggio per condensare così il fascismo in una storia che avrà a che fare con la consapevolezza politica e con il comunismo. Pasolini gioca spudoratamente con idee, ideologie e immagini. Come qui il fascismo è divertimento, nel resto del libro i fascisti borgatari – anche se gli è stato ucciso il padre dai partigiani – sono quelli che pensano: “io c’ho avuto fede in quell’omo: pensala come te pare, però quello ch’ha fatto ha fatto tutto per benessere de noiantri!… Guarda er Foro Mussolini, guarda tutti i progetti che se so’ fatti e che oggi se sa che realmente ce staveno! Perché voi l’avete tradito! Io lo farebbe resuscità… Pe’ favve sputà in faccia!».
Poi, andando a rubare, gridano “vincere – e vinceremo!”.
Il fatto che Pasolini venga letto solo seriamente, cioè mai come artista, come scrittore, penalizza la ricezione della sua opera. Bisogna essere alla sua altezza, pare, per leggerlo: ma chi lo è? Questa cosa non poteva non capirla il curatore dell’edizione delle sue opere complete: Walter Siti. Anni fa, Siti ha polemizzato con quella parte della critica che “avanguardizza” Pasolini, quella che, cito, “lo vuole trascinare su un terreno che gli è sempre stato estraneo, quello di un’assoluta novità «epocale» e, appunto, astratta”.
Quella parte non vede che Pasolini, cito ancora Siti, “era uno che anche le teorie le capiva a suo modo e le applicava sùbito, magari barando, alla scrittura – uno che non smetteva di soffrire (o di ridere) come un ragazzo, con un piede in quel che ancora non c’era e un altro nel vecchiume più kitsch”.
Ecco, aggiungo io, tutto pur di giocare con le idee e le immagini e avvincere. Vincere la battaglia ideologica e insieme avvincere. Quanto poi al piede che Pasolini terrebbe nel vecchiume kitsch: prendiamo il kitsch di Roma: i panorami con cui incornicia le scene dei ragazzi sono del gran kitsch letterario:
Era un cielo che proprio non aveva fine: bianchiccio e un po’ rosso. Dato ch’era mattina, s’era levata una giannetta fresca, che gelava tutto, e per questo non pioveva, e tutto era chiaro e pulito. Ma quel rosso che copriva i mucchi delle nuvole, non risultava s’era il riflesso dell’illuminazione notturna della città, che si stendeva per chilometri e chilometri da una parte e dall’altra, oppure s’era, ormai, un po’ di luce del giorno.
Ce ne sono di piccole sequenze in apertura e in chiusura delle scene, acquarelli del cielo romano come li troveremmo tra i pittori di Piazza Navona. Ci stanno perfettamente. E sono indistinguibili da quel che c’è di non kitsch: “i mucchi di palazzoni tutti uguali che volavano indietro, nel buio, poi le casette bigonze del Forte, poi la Parrocchietta in pizzo a una montagnola, poi tutte le campagne gonfie d’acqua come spugne, zozze, e finalmente il Trullo, coi lotti gialli in fila e quattro lampade accese che illuminavano il paesaggio della fame e della morte”.
Ora torniamo al movimento: che sia l’altro protagonista insieme a Tommasino è rivelato dal fatto che nel romanzo esistono potenti forze impegnate a fermarlo. Le guardie compaiono continuamente per metterli un freno: succede per esempio quando cercano di arrestare il Cagone, o quando vanno a risolvere uno sciopero in ospedale.
Nella borgata, l’avvicinamento delle guardie e la reazione compatta dei residenti produce un balletto di pagine e pagine: ecco la gente del bar che percepisce l’arrivo degli agenti in borghese: “Tutti i senza speranza seduti ai tavolini si fecero segno, con gli occhi malinconici, passandosi la lingua pigramente sui denti o mezzo sbadigliando. Ciancicavano: «Che c’è? Che c’è? La carica?»”.
Poi le guardie si avvicinano ai tavolini della cricca, “e già la voce si stava spargendo intorno: quelli che stazionavano alla fermata dell’auto, le donne che passavano per lí a far la spesa, le masnade di ragazzini, gli altri clienti del bare, tutti già avevano svagato il movimento da naso”. “La gente si stringeva sempre piú intorno, specialmente donne: quelle che già stavano in giro, e quelle che abitavano nelle casette lí accanto, ch’erano sortite a guardare. Tutte povere donne di borgata, scapigliate, con addosso le vesti nere di casa, unte e sporche, con le ciabatte ai piedi”.
È la storia più grave e triste che c’è ma è raccontata come la premessa di un enorme numero di canti e danze in un musical. Che poi esplode non in una canzone ma in morsi, pugni e arresti: “tutte le donne si gettarono in massa, a calci, a morsichi. Li spingevano per dietro, ai fianchi. Due tre volte quelli cascarono a terra, in ginocchio o lunghi, con le donne intorno che li pestavano, gli sputavano addosso. Allora loro si misero a correre, svincolandosi, e pedalando sempre più in fretta. Da dietro le donne gli tiravano serci, mattoni, pezzi di legno”.
In ospedale succede una cosa ancora più caricaturale. Il personale sciopera e i granatieri li sostituiscono come crumiri, facendo innervosire i lungodegenti:
Ormai quasi tutti i malati che potevano camminare erano venuti sotto la direzione, nel piazzale dell’ingresso principale: erano tutti millecinquecento duemila.
Cinque seicento agenti si pararono davanti al cancello, coi mazzarelli alla mano e gli idranti puntati.
Qui c’è un gusto per le scene di massa che viene da Zola, da Tolstoj.
I ricoverati fecero caporetto, intrufolandosi dove potevano, chi verso il Reparto Invalidi, chi dentro la direzione, scantonando per tutti i pizzi, pei corridoi, per le scalinate. Ma erano tanti, e chi era piú esposto, verso l’ingresso, nel giardino, non ce la fece a ripararsi dalla carica.
Ognuno aveva da dire la sua, e tutti si sbracciavano, cioccavano, urlavano, che non ce la sfangavano piú: erano i nervi che li sostenevano, con quei panni smagozzati sulle spalle, quei pigiami bianchi a bragolone, che parevano una folla di pulcinella.
Qui come nella scena degli arresti in borgata, ci sono le guardie mandate a vigilare sul popolo scalmanato. Chi manda queste guardie? Le manda l’altro personaggio nascosto del libro: il borghese, quella figura tetra che siamo io e probabilmente te che ascolti.
Il borghese è quello che davanti alle manifestazioni di disagio o di vita reagisce dicendo: “Decoro!”, che non vede la sfortuna né la posizione di inferiorità in un rapporto di potere, vede solo la sporcizia o l’atto criminale.
Tutto questo libro è una provocazione a riscoprire la nostra natura eternamente indignata di borghesi. Che ciò sia realizzato esplicitamente nel libro lo si capisce in maniera inconfutabile in una scena di inseguimento dove uno dei ragazzi, Salvatore, sta scappando per non farsi arrestare e a un certo punto si vede comparire un borghese, che lo vede e lo giudica.
Salvatore corse fin che gliela fece, con gli altri appresso che strillavano, e pure uno che passava di lí, un borghese, gli corse appresso, con la macchina. Ma non lo poteva fermare, e gli correva allo stesso livello; quando s’avvicinava, Salvatore montava sul marciapiede, e quello perdeva terreno.
Il fatto è che borghese si è agitato a vedere quel movimento indecoroso: dev’esserci qualcosa che non va in quella mancanza di decoro, lo spettro dell’illegalità. Ma il borghese non insegue rabbioso e assetato di sangue, insegue al contrario con la curiosità quasi filosofica del confessore. Sentite cosa gli domanda:
Al punto di un collegio di certe monache … Salvatore, spompato che non respirava piú, fece per zompare il muro, ma non ce la faceva e il borghese gli diceva: «Statte fermo, statte fermo, a morè, ma che hai commesso?»
Questo – potrebbe essere il punto centrale del romanzo. Il borghese è spaventato dal movimento. Vuole ordine. Ora però allarghiamo il campo e pensiamo a questo romanzo che è tutto corse e furia e sberleffi. Il lettore borghese dentro di noi vuole fermarne il movimento, e allora si mette a parlare di questo romanzo con tono grave. Sembra che Pasolini voglia prenderci in giro spingendoci a parlarne in questo modo.
Secondo me, il lettore che parla di Pasolini con tono grave è come il borghese che dice al libro: “Statte fermo! Statte fermo! Ma che hai commesso?”. Se leggiamo questo romanzo senza abbandonarci alla sua vertigine, se lo leggiamo solo per pensare la cosa giusta, stiamo cercando di fermarlo e di non farci colpire dalla sua vita, stiamo cercando di non eccitarci, di mantenere un contegno. I romanzi borgatari di Pasolini sono delle sornione macchine di piacere travestite da ragionamenti. La sfida è scoprirlo. Sono macchine di piacere senza essere prodotti da consumare. Da qualche parte Pasolini scrive che le opere commerciali sono quelle di cui non resta nulla una volta consumate. Questo libro invece è un cartoccio di bruscolini salatissimi che non si svuota mai.
Se il critico borghese che è in noi vuole farci pensare altrimenti, è solo per la sua tendenza a soffocare ogni forma di vitalità artistica. È per questo motivo che concludo con tre immagini di ragazzi che godono o che spiegano la loro idea di piacere. Nella prima c’è Tommasino:
Si sentiva soddisfatto della vita, anzi quasi sazio, e aspettando, non gli restava che sbadigliare un po’.
Questo è un piacere che conosciamo bene. La seconda è collettiva e più scatenata:
a causa di tutto quell’alcole che avevano succhiato, erano venuti giú di corsa per Via dei Santi Quattro, tutti col pisello in mano, pisciando di corsa a zig zag, per la terza o quarta volta, gridando: «Guarda che bella caligrafia!».
Qui sembra quasi dirci che questo libro non sia stato scritto esattamente con l’inchiostro, no? Infine, ecco la terza scena, che è una dichiarazione di poetica, e un manifesto filosofico:
«Quanto me piace stà ‘n machina quanno piove!» fece gongolante Salvatore. «Due so’ ‘e cose che me piaciono a me!» aggiunse, mentre la macchina sguazzava tra le pozzanghere, «annà ‘n machina quanno piove, e cagà sur prato, guardando la gente che passa pe’ ‘a strada!».
Dall’introduzione dell’audiolibro Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini, letto da Francesco Montanari (Emons).