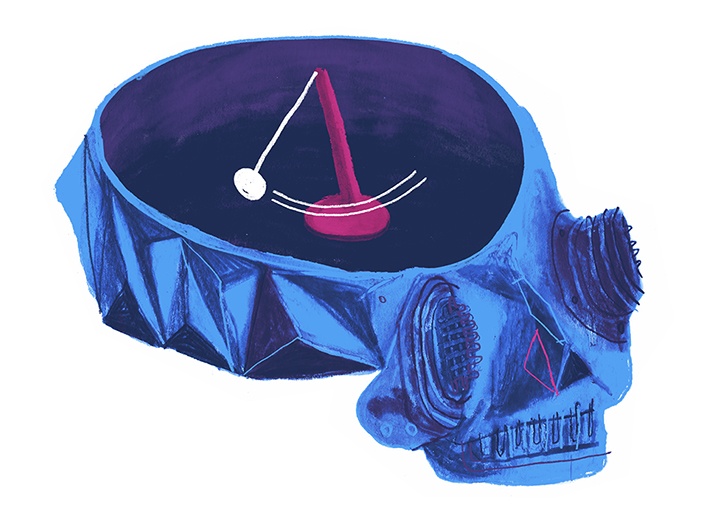U na delle cose che più fanno saltare la mosca al naso ai fisici è aver a che fare con chi sostiene che la meccanica quantistica, la migliore teoria che abbiamo a disposizione per descrivere le proprietà delle particelle, degli atomi e delle molecole, possa spiegare anche la nostra mente. Quest’idea ha la sua origine nelle riflessioni e nelle indimostrate ipotesi di alcuni tra i più grandi scienziati del secolo passato (Wigner, Von Neumann, Bohm e così via) ma è stata amplificata ogni giorno di più dal numero immane di sciocchezze veicolate da strampalati guru dei nostri tempi, da gente come Deepak Chopra per esempio, il celeberrimo neuroendocrinologo indiano, esperto di medicina ayurvedica e terapie alternative, e in genere da tutti quelli che provano a giustificare le loro credenze irrazionali facendo largo e ingiustificato uso della parola “quantistico”.
La meccanica quantistica, del resto, è una teoria strana e per molti aspetti paradossale, e fornisce una descrizione delle cose assai diversa dalla realtà a cui siamo abituati. Per esempio nel mondo degli “oggetti quantistici” non si può misurare nulla senza influenzare l’esito della misura: chi osserva – lo sperimentatore – dà sempre noia all’osservato e diventa così parte integrante dell’esperimento. Per alcuni, Eugene Wigner in particolare, ciò rappresenterebbe la prova che è la stessa mente di chi osserva che influenza, in qualche indecifrabile maniera, l’esito dell’osservazione.
A invertire il collegamento tra mente e meccanica quantistica ci ha pensato più di recente Roger Penrose, matematico e fisico britannico, che è arrivato ad affermare che la mente è quantistica e che è proprio questa la ragione per cui gli esseri umani possono fare cose che nessun computer classico sarà mai in grado di fare. Gli argomenti che ha portato a sostegno della sua tesi non hanno persuaso la stragrande maggioranza dei ricercatori. Ciò nonostante, negli ultimi anni si è assistito a un rinnovato e crescente interesse di parte della comunità scientifica verso il tema più generale della biologia quantistica, essenzialmente per due ragioni: lo sviluppo prepotente, concettuale e tecnologico, dell’informazione quantistica, la disciplina che utilizza la fisica quantistica per trattare l’informazione e che prevede e promette la possibilità di realizzare dispositivi dalle prestazioni enormemente più elevate rispetto a quelle fornite dai sistemi classici; il perfezionamento di tecniche e strumenti per l’osservazione delle dinamiche nei sistemi biologici su scale di tempi e lunghezze sempre più piccole, quelle in cui effetti quantistici inattesi potrebbero far valere la loro presenza, prevista solo dalle speculazioni più ardite. All’alba del nuovo secolo, per esempio, e per mezzo delle nuove tecniche sperimentali, è stato possibile riesaminare nel dettaglio i processi di trasporto e di conversione dell’energia negli organismi che “fanno” la fotosintesi e osservare l’eventuale influenza degli effetti quantistici persino a temperatura ambiente.
E quindi – è la speranza di alcuni scienziati – se davvero la natura si serve della meccanica quantistica per consentire o rendere più efficiente una funzione biologica, allora forse prima o poi saremo in grado di fare quello che il povero Newton si lamentò di non saper fare il giorno in cui perse gran parte dei suoi denari in una speculazione finanziaria sbagliata: “calcolare la follia degli uomini”.
I from qubit
Nel cervello umano cento miliardi di neuroni rilasciano e trasmettono segnali verso migliaia di destinazioni: non c’è alcun dispositivo fisico “classico” in grado di riprodurre un situazione del genere. Il computer neuromorfo più avanzato riesce infatti a simulare al più l’attività di ottantamila neuroni della corteccia cerebrale, una quantità neanche pari al numero dei neuroni contenuti nel cervello di un moscerino della frutta. Anche solo per scandagliare la formazione dei pensieri di un topo servirebbero ben altre performance che forse solo l’intervento della meccanica quantistica è in grado di garantire.
Malgrado la meccanica quantistica sia, come abbiamo già ricordato, la migliore teoria che abbiamo a disposizione per descrivere il mondo microscopico, la sua efficacia, come la democrazia per Winston Churchill, va di pari passo con parecchie stranezze che l’hanno resa indigeribile persino a certi grandi scienziati. Richard Feynman, ne Il carattere della legge fisica, del 1965, sottolineava come egli fosse quasi certo che nessuno la comprendesse. “Sono nato non capendo la meccanica quantistica e non la capisco ancora”, avrebbe poi ribadito nel 1983. Questa difficoltà non era però tale da impedirgli di apprezzarne l’uso. In Simulando la fisica coi computer, titolo di un celebre seminario tenuto al MIT di Boston nel 1981, aveva infatti concluso: “la natura non è classica, dannazione, e se se ne vuole fare una simulazione sarebbe meglio usare la meccanica quantistica e si tratta di un problema fantastico, perdiana, perché non sembra così semplice da risolvere”. In quel colloquio c’è dunque la prima teorizzazione di un “simulatore quantistico”, il progenitore del computer quantistico, una della sfide tecnologiche attuali più difficili e avvincenti.
Un computer quantistico è un computer che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per elaborare i dati e utilizza come unità fondamentale il qubit (da quantum bit). A differenza di un bit classico, che può occupare alternativamente solo uno di due possibili stati classici (un gatto può essere vivo o morto, una capra può stare sopra o sotto una panca), un qubit è una particolare sovrapposizione di due stati quantici. È come avere a che fare con un fisico quantistico che alterna due personalità – quella che potremmo chiamare mainstream e quella da crackpot (si dice delle speculazioni fragili come una porcellana) – attraversando una condizione in cui è una miscela di entrambe [nota assolutamente necessaria: il fisico è quantistico nel senso che studia quelle robe lì, la personalità non è uno stato quantico ovviamente, quindi l’analogia è inappropriata al pari di tutte quelle che si possono immaginare col mondo visibile ai nostri sensi]. Affinché questo umore oscillante si mantenga è necessario che la nostra cavia se ne stia chiusa da sola nella sua stanzetta: un’intrusione, anche solo uno sguardo, potrebbe perturbare il suo stato ondivago e influenzarla a tal punto da farla precipitare in breve tempo in una delle due condizioni “estreme” (o si adegua al mainstream o si frantuma in mille pezzi). Questo fenomeno è detto decoerenza.
Coerenza, nel linguaggio comune, è generalmente intesa come coesione, lo stare assieme (co-) uniti (haerere), una connessione tra le parti di un sistema o di un ragionamento, fra l’operare e il pensare. In fisica, in Ottica in particolare, esprime la proprietà di un’onda di mantenere inalterate, nello spazio e nel tempo, certe sue caratteristiche. La situazione descritta sopra, l’andar ciclicamente da uno stato all’altro a ritmo costante, esprime una situazione di coerenza perfetta, una situazione ideale che nel mondo reale può durare solo per un tempo finito in uno spazio finito.
Riuscire a mantenere il più a lungo possibile la coerenza è importante perché la coerenza, oltre a permettere la produzione di fenomeni di interferenza sufficientemente stabili e che possono essere rivelati dagli strumenti di misura, è condizione necessaria per un altro fenomeno: l’entanglement, che è la coerenza tra le parti di un sistema, l’intreccio inestricabile che si può instaurare tra i qubit e che si mantiene tale anche a distanze incredibilmente grandi. È proprio grazie alla sovrapposizione e all’entanglement che un computer quantistico è potenzialmente in grado di elaborare un gran numero di calcoli simultaneamente.
Per alcuni, a cominciare da Roger Penrose, il computer quantistico è il dispositivo che meglio potrebbe simulare i processi cerebrali che “realizzano” quella cosa che chiamiamo mente umana. Il suo fantasioso sodale, l’anestesiologo Stuart Hameroff, una trentina di anni fa, aveva così immaginato di poter ingaggiare nel ruolo di qubit neurale i microtubuli, una struttura proteica a forma cilindrica, dei “bucatini” di lunghezza pari alla spessore medio di un capello umano (decine di milionesimi di metro). L’ipotesi fu rigettata da Max Tegmark, fisico e cosmologo del MIT, in uno studio pubblicato nel 2000 in cui aveva quantificato le chance di sopravvivenza dell’eventuale sovrapposizione quantistica tra stati neurali: praticamente nulle. Critiche erano arrivate anche dai filosofi, in particolare da Patricia Churchland, che nel 1998, ospite di una conferenza sulla “Scienza della Coscienza” organizzata a Tucson in Arizona proprio da Hameroff, non era stata capace di rinunciare al dileggio: “La polvere fatata nelle sinapsi è tanto esplicativa quanto la coerenza quantistica nei microtubuli”.
Fosforo
Quella della coerenza è una questione delicata, e i fisici si impegnano al massimo per proteggerla in laboratorio. Raffreddano i sistemi quasi fino allo zero assoluto e usano il vuoto cercando di isolarli da qualsiasi disturbo esterno. Un ambiente molto diverso, per esempio, da quello caldo, umido e caotico del cervello. Matthew Fisher, fisico all’Università della California, a Santa Barbara, di recente ha proposto un nuovo candidato al ruolo di qubit neurale. A svolgere questa funzione, sostiene Fisher, potrebbe essere la più elementare e celebre proprietà intrinseca delle particelle (elementari o meno): lo spin.
Lo spin è la grandezza quantistica per eccellenza: non ha un analogo classico, non si può cioè visualizzare come qualcosa che appartiene al mondo tridimensionale che abitiamo (no, neanche alla rotazione su se stessa di una trottola). Esprime il fatto che particelle e nuclei, quando attraversano una zona in cui è presente un campo magnetico costante, si comportano come l’ago di una bussola: tendono ad allinearsi alla direzione del campo. In questa situazione, le orientazioni permesse sono solo un numero finito, due soltanto nel caso degli elettroni, dei protoni e di certi nuclei, ovvero in un verso e nell’altro rispetto a una certa direzione fissata. Ma quando nessuno li disturba gli spin possono puntare un po’ di qua e un po’ di là allo stesso tempo, stanno insomma nella solita situazione imbarazzante – la sovrapposizione di due stati – che ci è impedito di osservare.
Per alcuni, il computer quantistico è il dispositivo che meglio potrebbe simulare i processi cerebrali che “realizzano” quella cosa che chiamiamo mente umana.
Eccolo il qubit neurale ma bisogna ancora cercare chi è che lo sostiene. Per Fisher potrebbe essere il nucleo dell’atomo di fosforo. “Senza fosforo non c’è pensiero” sentenziava il medico e fisiologo Jakob Mileschott nel suo Trattato di alimentazione per il popolo (1850), tanto apprezzato da Feuerbach che, ispirato, coniò immediatamente la celebre affermazione “l’uomo è ciò che mangia” (e da qui al mito “mangia pesce che diventi più intelligente” è un attimo, purtroppo).
Nel cervello il fosforo è presente in quantità assai limitate e, nei sistemi biologici, è quasi sempre legato a quattro atomi di ossigeno che lo circondano formando una struttura tetraedrica. Questa specie chimica si chiama fosfato. Fisher ha stimato che la durata temporale della coerenza dello spin nucleare del fosforo, quando il fosfato è libero di muoversi in acqua, è pari a un secondo, un tempo troppo breve perché possa svolgere la funzione desiderata. Se vogliamo sperare di servircene come componente di base per la computazione quantica nei processi cognitivi, il nucleo dell’atomo di fosforo va dunque protetto meglio. Quella che a Fisher è parsa servire a questo scopo è la molecola di Posner, un aggregato di fosfati di calcio presente soprattutto all’interno del tessuto osseo. La stima del suo “tempo di coerenza” in soluzione acquosa è pari a un giorno intero, una cosa da non credere ma che torna (fin troppo) buona per gli scopi del nostro. Fisher sta cercando le prove che la molecola di Posner agisca come e dove lui spera e per questo ha ottenuto, nel 2017, un finanziamento di circa un milione e trecentomila dollari per il suo Quantum Brain Project (QuBrain).
Topi a Cornell
Ma ci sono prove che lo spin nucleare abbia una qualche influenza sulla mente? Secondo Fisher sì e lo dimostrano i risultati di un articolo pubblicato nel 1986 sulla rivista ufficiale della Society of biological psychiatry e dal titolo: “Genitorialità aberrante e ritardo di sviluppo nella prole di ratti esposti al Litio”. In un esperimento condotto all’Università di Cornell, alcuni sventurati topi femmina sono stati trattati con sali di Litio prima e durante la gestazione e l’allattamento. Il Litio è composto da due isotopi stabili, il Litio-6 (per circa il 7%) e il Litio-7 (per il restante 93%) e la scoperta dei ricercatori statunitensi pare sensazionale: i topi trattati con il Litio-6 nidificano in modo tradizionale e curano i loro cuccioli in maniera impeccabile (quasi morbosa, a dire il vero) al contrario di quelli trattati col Litio-7 che si mostrano negligenti e meno capaci. C’è di che rimanere basiti: gli isotopi di uno stesso elemento hanno sì proprietà fisiche diverse (a causa della massa differente) ma la stessa struttura chimica (hanno lo stesso numero di elettroni) e dunque non c’è ragione per attendersi un effetto biologico diverso a seguito della loro assunzione. A meno che, sostiene Fisher, la variabile di cui tener conto non sia un’altra, ad esempio l’ormai famigerato spin nucleare che, nei due casi, è effettivamente diverso.

Queste speculazioni sullo spin si basano comunque sui risultati di un lavoro pubblicato 32 anni fa, citato pochissimo e non su riviste di primo piano, che mai nessuno fino ad ora ha provato a replicare. Anzi no, uno ci ha provato: lo stesso Fisher, con l’aiuto di alcuni ricercatori della Stanford University (dove peraltro lavora il fratello Daniel, fisico specializzato in dinamiche evolutive). I tentativi pare però siano stati infruttuosi o, comunque, che non abbiano portato a nulla di pubblicabile. Ma insomma, non è che siamo ancora una volta dalle parti della Cargo Cult Science di Feynman in cui si cita come esempio di “scarsa scientificità” proprio un esperimento coi topi condotto nel 1947 dagli psicologi di Cornell? Le coincidenze a volte sono davvero strane.
Cervelli e patate
“I segreti quantistici della fotosintesi sono stati rivelati”. Comunicato stampa del Berkeley Lab, 12 aprile 2007.
Sbirciare tra i commenti di un post, a volte, può essere utile. In quello che John Preskill, professore di fisica teorica e direttore dell’Institute for Quantum Information and Matter al California Institute of Technology, ha dedicato a Fisher nel blog del suo Istituto è intervenuto, per esempio, Stuart Hameroff, per difendere il suo lavoro con Penrose e sottolineare la superiorità della sua proposta rispetto a quella di Fisher. L’attuale direttore del centro per gli studi sulla coscienza dell’Università dell’Arizona ci ha tenuto in particolare a far presente che “senza effetti quantistici nel cervello (…) la fotosintesi sarebbe impossibile e noi probabilmente neanche esisteremmo. Se una patata può utilizzare la coerenza quantistica è probabile che il nostro cervello (e la vita in generale) abbia sviluppato meccanismi per farlo.” Ma ci sono davvero le prove che la coerenza quantistica regoli i processi biologici?
Questa storia inizia nel 2007, l’anno in cui viene lanciato nello spazio telescopio spaziale Kepler alla ricerca di pianeti simili alla Terra e in cui Nature pubblica un articolo che sembra rivoluzionare quello che abbiamo sempre creduto di sapere su alcuni aspetti del meccanismo che probabilmente aprì la strada, 2,4 miliardi di anni fa, allo sviluppo di forme di vita complesse sul nostro pianeta: la fotosintesi, appunto. Secondo i suoi autori è stato trovato il segno inequivocabile di una coerenza quantistica di lunga durata tra i cromofori, le entità deputate al trasferimento di energia all’interno di un foto-sistema.
L’idea è che il fotone, il quanto di luce, quando è catturato da una molecola di clorofilla, la ecciti promuovendo un elettrone in uno stato a energia più alta. Questa energia di eccitazione viene trasportata fino al cosiddetto centro di reazione dove viene trasformata in energia chimica. Nel tragitto non si comporta come si è sempre creduto e cioè non salta da una molecola all’altra come un ubriaco in cerca della strada di casa, ma segue più strade allo stesso tempo, arrivando al centro di reazione più rapidamente. Nei punti in cui due strade si incrociano si possono generare effetti di interferenza, che a loro volta producono le oscillazioni rivelate dall’esperimento del 2007.
Ci sono davvero le prove che la coerenza quantistica regoli i processi biologici?
La sorpresa è grande perché questa interpretazione è in netto contrasto con quello che per tutti è un fatto acquisito: la coerenza (dunque la sovrapposizione e l’interferenza), nei complessi fotosintetici, è rapidamente distrutta dall’interazione con l’ambiente in un tempo inferiore a quello che serve per trasferire l’energia da un pigmento all’altro. Così, siccome “affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie”, gli esperimenti vengono ripetuti con gli stessi e altri complessi fotosintetici e a varie temperature ma il risultato è sempre quello: le oscillazioni si rivelano reali e persistenti.
Presto le cose cambiano e si capisce che se il risultato degli esperimenti non può essere messo in dubbio non si può dire lo stesso per la sua interpretazione. Ci si rende conto del fatto che, a essere osservate, sono le oscillazioni dovute alle vibrazioni delle molecole e se correlazione tra le eccitazioni c’è non è dovuta a coerenza quantistica, che è tutto fuorché longeva, ma è quella mediata da queste vibrazioni. Può questo debolissimo accoppiamento vibronico (la crasi di “vibrazionale” ed “elettronico”) migliorare il trasferimento dell’energia? La risposta definitiva ancora non c’è e la “pistola fumante”, la prova che gli effetti quantistici si facciano sentire dalle parti della biologia, non è stata ancora trovata senza ombra di dubbio.
Tra gli scienziati c’è però chi non interpreta questi risultati come un fallimento, tutt’altro, vi vede invece l’evidenza del fatto che la natura non si è evoluta per superare la decoerenza ma per sfruttarla. Nei complessi fotosintetici, per esempio, la decoerenza potrebbe aiutare l’energia a trovare la sua strada lungo il percorso più efficiente dal punto di vista energetico, a fare un po’ come Pollicino, che lascia briciole di pane lungo il percorso per poter ritrovare il sentiero senza perdersi ogni volta nell’esplorazione dell’intero paesaggio.
Come capita molto spesso, la spiegazione più semplice potrebbe essere quella giusta. Non è detto cioè che per trovare la ragione di certi processi sia sempre necessario evocare effetti speciali dal mondo dei quanti. O forse no, forse davvero di certe cose non ne cogliamo la natura proprio perché sono regolate dalle leggi di quel mondo lì, che ancora non abbiamo ben compreso. Per alcuni è così, per altri è tempo perso, è la foga riduzionista dei fisici che mal si concilia con la complessità e la varietà strutturale dei sistemi biologici. Al di là dei soliti luoghi comuni, più le tecniche sperimentali diverranno raffinate, più i risultati degli esperimenti porteranno a nuove sfide teoriche e allo sviluppo di nuovi approcci.
Grazie a Matteo Paris (Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”, Università degli Studi di Milano) per i preziosi commenti e suggerimenti.