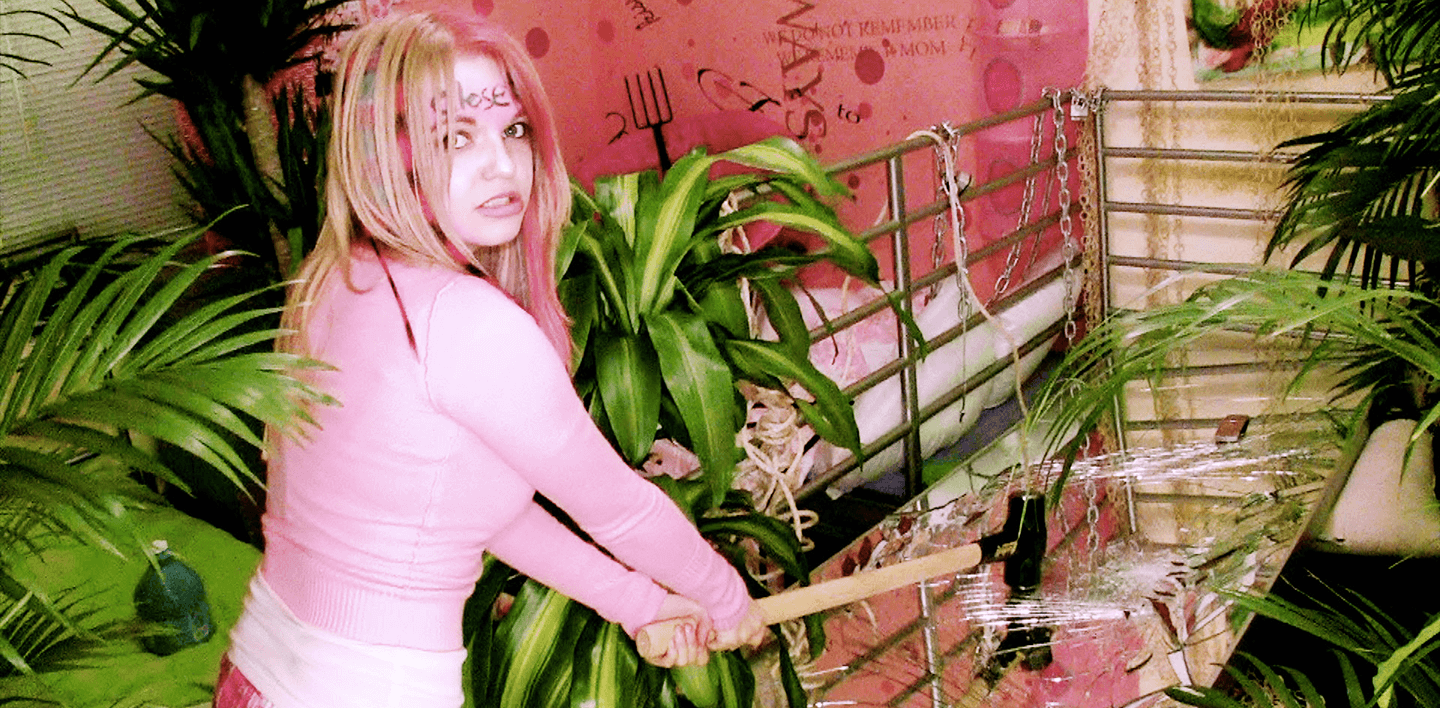
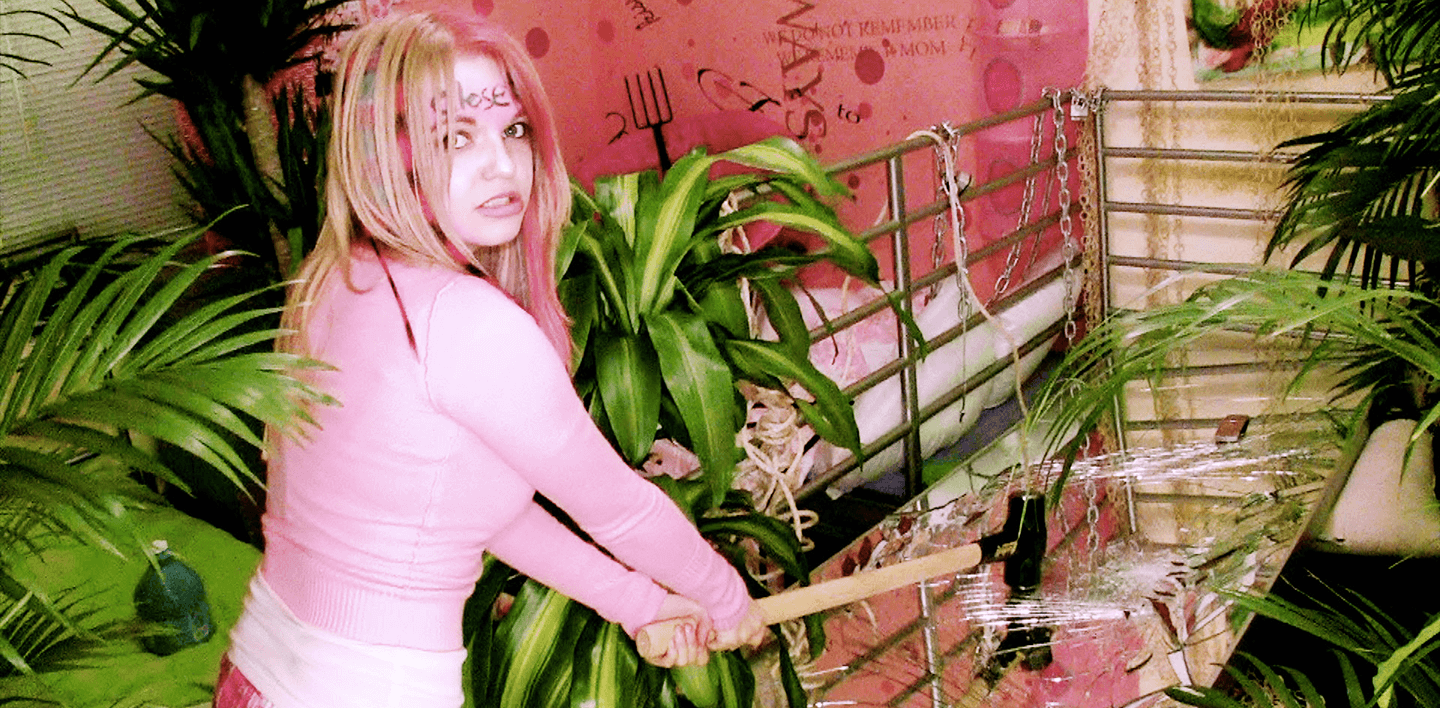
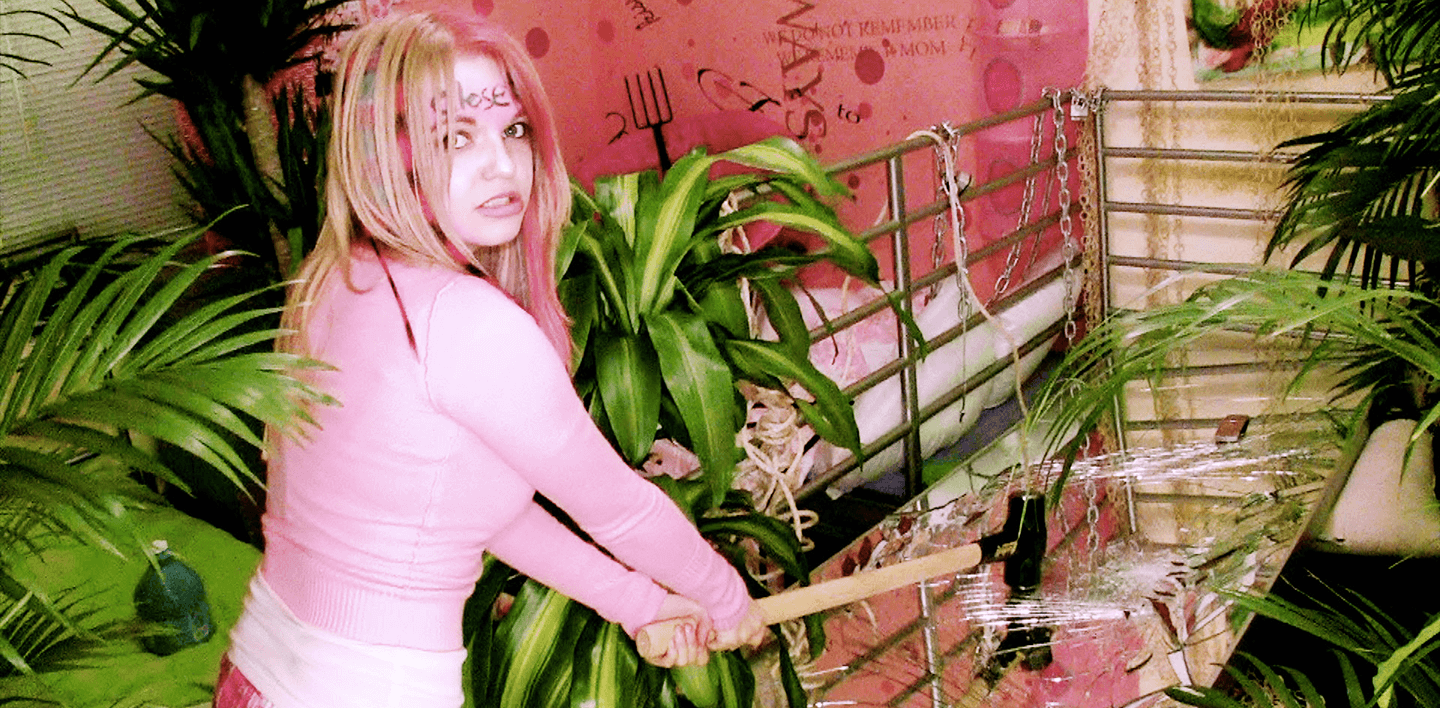
N el penultimo romanzo di Teresa Ciabatti, La più amata, finalista allo Strega, verso la fine è rivelata una richiesta ricevuta dall’editor dopo la prima stesura: “Riscrivi. Cerca la voce. La voce adulta”. Secondo l’editor, non funziona: il problema è la voce, “troppo infantile, non è la voce di una donna”. Alternatamente adolescente e bambina, questa voce è “continuamente fuori fuoco, instabile, troppo sofferente per essere adulta, ossessionata da piccoli eventi del passato…”. Vero o inventato che sia, l’appunto dell’editor mi fa pensare a quel che Teresa Ciabatti cerca in ciascuno dei suoi ultimi libri: una forma che possa ospitare, limitare, ingabbiare il racconto di una crescita interrotta, una maturità impossibile da conseguire, una forma di pazzia (borghese) creativa e distruttiva.
Se ci concentriamo sugli ultimi tre libri – il citato La più amata; il romanzo che lo precede, Il mio paradiso è deserto, e quello che lo segue; il nuovo Matrigna – possiamo seguire lo sviluppo di questa ricerca attraverso le forme ospiti cercate con impazienza da TC. Tutti e tre i libri raccontano confronti di una figlia con un genitore, e ciò è importante perché sembra che in ogni libro Ciabatti cerchi una forma – un genere – che ospiti la pazzia raccontata allo stesso modo conflittuale e spesso imbarazzante in cui un genitore ospita in casa un figlio.
Questa casa, in Il mio paradiso è deserto, è il romanzo epico del generone romano – alla maniera di Piperno o dei film di Sorrentino. Soldi, individualità forti, clan, roba. Il libro racconta di un padre costruttore e di una figlia rabbiosa e sovrappeso. Dopo i libri chiamiamoli giovanili, Ciabatti tenta quel tipo di romanzo che deve molto agli ebrei americani del Novecento e all’Ottocento francese, insomma due età dell’oro della borghesia internazionale: sociologia, frenesia, ganci pop e distensione narrativa da Zola.
Per inquadrare il padre costruttore: “C’era qualcuno che lo chiamava l’Ottavo Re di Roma. Sbagliava. Attilio Bonifazi non era re. Lui era Roma”. Attilio è un maniaco del controllo, “Tutto doveva essere come diceva lui”, e così nel paragrafo successivo godiamo la panoramica dall’alto della situazione finanziaria e immobiliare, un topos del romanzo borghese: mi ricorda per esempio l’invisibile carrello usato da Piperno per introdurre la gated community dell’Olgiata di Roma all’inizio di Persecuzione. Attilio controllava tutto “dalla famiglia agli affari, non tralasciando le case: Villa Quintili, che aveva deciso di comprare” (ecco i tipici dettagli che vogliono mostrare una vita fatti di scambi e accomodamenti…) “sebbene il principe proprietario continuasse a ripetergli che non era in vendita, non aveva prezzo (poi invece il prezzo era saltato fuori)”.
Non è un caso che per questi slanci nel solco del modo di raccontare della pseudo-borghesia italiana del ventunesimo secolo Ciabatti si serva del personaggio maschile: questi dolly invisibili sembrano fatti per inseguire fantasie maschili, per uno struggimento che può prescindere dall’interiorità. Dopo aver elencato varie proprietà, finiamo la scena nella piscina appena finita ma vuota, “Attilio era sceso. E poi era successo che, soddisfatto ed estasiato, mormorasse qualcosa (…) ‘Signore’, si era messo a pregare, ‘proteggi Luisa’”. Altrove, in un passaggio importante per la figlia, Ciabatti si cimenta in una scena di natura:
Nevicava sul prato, sui campi e oltre, sul bosco, dove c’erano solo tenebre, e in alto, sulle colline, nevicava sul paese addormentato, debolmente rischiarato dalla luce del campanile.
Dovendo collocare la storia fastidiosa, impopolare di una ragazza ricca e sovrappeso (l’ideale personaggio antipatico di TC: “‘Petto di pollo?’ le venne incontro Lourdes… ‘Ficcatelo nel culo’ rispose lei (…), ‘e ringrazia che non ti prendo a schiaffi’) decide di accasarla in solidi paesaggi “da romanzo”. La scena della neve prosegue con la foschia che “avvolgeva quei luoghi sotto gli occhi di Marta che alla finestra si congedava dai suoi sogni”. È nella contemplazione melò di questo paesaggio tipico che Ciabatti permette alla sua eroina uno dei suoi slanci ridicoli e solenni: “Si tolse il pigiama e infilò i vestiti abbandonati sulla sedia. Non avrebbe aspettato mattina, il tempo di prendersi Roxy e se ne sarebbe andata, accidenti a quando aveva accettato di partecipare a quella sceneggiata, altro che tranquillo weekend in famiglia come aveva detto la mamma, due giorni di ipocrisia!”
Ma la sceneggiata, a ben vedere, è questo genere di romanzo davanti alle esigenze di Ciabatti. La quale appunto si pente di aver costretto il suo personaggio femminile nella casa di bambola di un romanzo manierista e come prova successiva scrive un memoir diretto e personale. La più amata segna il momento in cui il suo alter ego, che qui è Teresa Ciabatti stessa, può circondarsi di un mondo più affine, quantomeno nella pazzia.
La più amata racconta il rapimento del padre, il dottor Ciabatti, notabile di Orbetello, fascista, tessera P2, e le conseguenti derive della figlia amata. Antonio D’Orrico, il critico del Corriere che ha il merito di cercare sempre una scintilla nei romanzi e di trattarli come oggetti di contemplazione ed eccitazione, l’ha definito “capolavoro (…) di autolesionismo, sinistro come una messa nera, blasfemo come un comandamento alla rovescia: disonora il padre per onorarlo”. Al critico era “piaciuto tutto in quel romanzo sospeso tra incubi alla Hitchcock e sogni alla Scott Fitzgerald”: la cattiveria, l’infingardaggine, la disperazione. Le situazioni borghesi qui possono sfaldarsi e rivelare una frequenza più contemporanea: se Ciabatti nel libro prima chiedeva che la pazzia di certe bambine venisse tutelata nelle grandi case di grandi uomini, qui c’è una parentela tra la follia della bambina e la follia dei grandi. Per la follia della bambina-ragazza scelgo la scena in cui l’impopolare Teresa invita nella sua villa con piscina le ragazze e i ragazzi più popolari della sua scuola:
E i bagni, ci sono undici bagni.Undici persone possono pisciare nello stesso momento? chiede Gino.
E io, senza nemmeno girarmi (…) rispondo sì. Sì, ragazzi, possono pisciare tutti insieme.
Immagino quello che provano ora nei miei confronti: ammirazione, amore. Odio. E io che non voglio essere odiata, ma solo amata – amatemi, poveri! – li lascio entrare nel buco della piscina, fate quel che volete, correte.
E tra sé li chiama “i miei meravigliosi criceti”. Alla disperazione del paesaggio mentale, affettivo e morale di questa bambina si accompagna una vita degli adulti insensata, illogica e infelice. Il dottor Ciabatti è un mitomane manipolatore. Ha mentito alla fidanzata dicendosi orfano, salvo poi presentarle la madre. E anni dopo ha mentito alla stessa donna, ora sua moglie, sull’identità di chi l’ha rapito per vicende legate alla P2.
“Chi era quello, che voleva?” chiede la moglie investigando sul rapitore. “Ti ha fatto del male. dimmelo, Renzo”. Il padre sostiene che sia stato “Un drogato di Albinia”. Ma la moglie ha dei dubbi: “un drogato con la pistola?” Il padre sminuisce, “la pistola ce l’hanno tutti”. Poi la madre lo minaccia di andare alla polizia per vederci chiaro e lui alza le spalle per intendere che le riderebbero dietro, “anche loro conoscono quel drogato”. Ma la madre sospetta che “quell’omone che è piombato a casa puntando la pistola” non sia un semplice drogato di zona e ci sia qualcosa di molto più brutto dietro la brutta esperienza fatta dal marito. “Dopo tutto questo, Francesca Fabiani dice basta”. Francesca Fabiani, la madre, lascia il padre. Sono pagine di nauseante incertezza. Noto per inciso che Teresa Ciabatti non è apprezzata dalle sottoculture antiborghesi ed è un peccato perché è tra gli scrittori italiani più capaci di descrivere senza pathos e illusioni la vita borghese: nel suo caso, si confonde il significante con il significato e si condanna l’assenza di un apparato, attorno al testo dei suoi libri, che segnali che si tratta di romanzi che fanno una critica profonda e piena di disprezzo al generone. Oltretutto, nei fatti narrati, qui c’è una moglie e madre che “dopo gli anni in cui si è fatta sempre più incolore, sforzandosi di essere la donna che voleva il marito, chiudendo gli occhi, (…) ignorando le chiacchiere di paese, ripetendosi nella testa: mio marito è un uomo buono, una persona perbene”, lo lascia, prende i figli e si trasferisce da Orbetello a Roma.
In questo libro, Ciabatti non conquista la controcultura o gli amanti della letteratura di ricerca ma certamente invece il lettore forte borghese. Il miracolo commerciale e di stima avviene grazie a uno sforzo coscienzioso di composizione dei suoi lati infantili (gli undici bagni della casa sbandierati) con le necessità di un romanzo-memoir articolato e ragionevole, un memoir tra Valeria Parrella e il personal essay all’americana, dove la si sente dire: “Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quarantaquattro anni e non trovo pace. Voglio scoprire perché sono questo tipo di adulto… Dev’esserci (…) un motivo che mi ha resa tanto diversa…” Lo sforzo sta nel voler allestire la scena in modo articolato anche davanti al vuoto spirituale dei fatti narrati: suo padre infatti più che un antieroe risulta anti-personaggio, privo di anima cioè di interessi in cui il lettore si possa ritrovare. È un complottaro perbene, un dottore rispettato con simpatie e relazioni orribili.
Nella scena in cui il padre, ancora giovane fidanzato, presenta alla fidanzata la futura suocera, che fin lì la fidanzata credeva morta a causa di un insensato scherzo prolungato, Ciabatti fa un ritratto violento di quelle famiglie che si raccolgono intorno al maschio impunito e geniale, l’oggetto dell’investimento familiare. Alla scoperta della bugia, Francesca – la fidanzata – “non reagisce, si ostina a credere che quella sia una zia, una vecchia zia”. La spiegazione: “le ho detto che ero orfano di babbo e di mamma, mamma morta in un incendio”. Tutti ridono, “la vecchina alza gli occhi dal piatto: ti piacerebbe, lo fulmina”. Lui replica “suvvia” e “ancora ridono, tutti tranne Francesca”. “Renzo ha questo lato goliardico” dice un parente, “se era per lui eravamo tutti morti”. “Ti piacerebbe, maledetto” dice la madre. La scena, prova della pazzia del figlio amato, si dissolve perché tutti sorridono.
Lei però è una donna buona. Lei non s’indigna come farebbe qualsiasi altra donna, lei, Francesca Fabiani, è diversa. Abbraccia forte la donnina piccola, l’abbraccia con gli occhi pieni di lacrime, la chiama mamma: proprio così: mamma, dice. Nel trasporto di quella riparazione di dolore. Mentre la vecchina le sussurra nell’orecchio: avete fatto all’amore?
C’è un accumularsi di smorfie, sorrisi, sussurri e risate da Bruegel il vecchio. Una vignetta disgustosa che culmina nella soffocante domanda confidenziale ma anche pragmatica della futura suocera non-morta: avete fatto all’amore? Il fondo di disgusto della letteratura di Teresa Ciabatti ha trovato in La più amata un compromesso elegante per non soffocare questa visione di terrore in maglie troppo strette e perbene, senza però che il peso di una certa visione del mondo faccia ancora degenerare la proposta narrativa oltre la condizione di sano prodotto commerciabile.
Il passo però era inevitabile, e in Matrigna, intitolato finalmente come un asciutto nome da favola perché è qui che l’eterna bambina di Ciabatti può davvero crescere, in un mondo fatto a sua misura, la letteratura di Teresa Ciabatti perde ogni residuo comico per trovare nell’oscurità pura una casa per il suo alter ego, che stavolta si chiama Noemi e non è una ragazza benestante. In questo libro, pubblicato velocemente, a nemmeno due anni dal memoir, si racconta di un altro rapimento e di un’altra donna che rimane bloccata nell’infanzia: in Matrigna a essere rapito è il fratellino della protagonista, e a crescere con questo fardello è poi la bambina che diventa donna tentando di non sentire il peso di aver perso il fratello che le era stato affidato. Se La più amata era un confronto serrato con il padre, questo lo è con una madre che rimasta vedova si innamora di un uomo molto più giovane e mette così in crisi la figlia.
In La più amata c’era ancora tutta la disponibilità a credere alle esigenze di intrattenimento. Magari il riferimento si era spostato dall’asse Piperno-Sorrentino alla cassetta degli attrezzi della commedia all’italiana, cioè a un periodo, la metà del Novecento, in cui il mondo del benessere era trattato come più fluido e raccontato con più cinismo: il borghese non era un personaggio acquisito, eravamo tutti Mostri e lo status era più evidentemente il prodotto di una performance sociale che di ormai atavici conti in banca e investimenti in mattone. Ma c’era ancora lo storytelling. In Matrigna, Ciabatti sembra voler deludere l’editor del libro precedente, non fare la cosa adulta di scrivere da donna onorando snodi narrativi e grandi fatti: innalza l’infanzia a tema principale della maturità fin dal titolo, un termine che è uno degli incubi più tipici dell’infanzia, almeno in letteratura (e che qui è usato liberamente, direi per definire meglio cos’è una madre).
Matrigna mi sembra perciò il libro della maturità di Teresa Ciabatti, il romanzo con cui accetta le proprie priorità e si costruisce una casa su misura: si sente libera di raccontare la sua orribile prospettiva sulla vita senza l’impalcatura di un genere letterario alto (romanzo manierista o memoir elegante); si smarca dalla borghesia facoltosa e fa trovare casa alla sua ennesima bambina poco cresciuta fra i registri del Chi l’ha visto? e della cronaca nera, senza esagerare (senza arrivare a un Aldo Nove d’antan). Fa bene D’Orrico, criticandolo sul Corriere, ad aprire la sua descrizione di questo romanzo citando frasi insolitamente opache per la Ciabatti recente: “Era inverno quando mio fratello sparì”. “La mamma mi aveva chiesto di tenerlo per mano”. “Dunque è da questa mano che si è staccato”.
C’è una fretta nella scrittura di questo libro che non è precisamente la fantomatica “urgenza”. Con questa storia veloce tutta a precipizio verso l’invecchiamento dei suoi personaggi, Ciabatti sembra parlare seriamente per la prima volta, seguendo il principio formalizzato a un certo punto con la frase “La coscienza è solo una parte della mente, una medusa che galleggia nel vasto mare”. Con questo programma, le scene ricevono una minore mantecatura e vengono ordinate senza una ricerca dell’effetto. Fa venire in mente le canzoni dei Joy Division, la tetra reiterazione di un tema melodico senza cercare picchi:
Seguì un periodo convulso. Persone che entravano e uscivano da casa nostra. Lo squillo del telefono a interrompere sospiri e occhi bassi. Uno squillo, ed era speranza. E fiducia – ho fiducia nelle forze dell’ordine, le parole di papà.
C’era la preghiera e la speranza davanti alla segnalazione di qualcuno “che aveva visto il bambino in farmacia per mano a un uomo che comprava lo Zirtec”, l’antistaminico del fratellino. “Quell’uomo che, al suggerimento della dottoressa di un generico, aveva insistito per lo Zirtec, con il piccolo accanto che annuiva inebetito, forse drogato, doveva essere lui”.
È cupo l’amore dell’Italia che dalla tv e poi dalla rete seguirà le vicende della famiglia: “Tanti sconosciuti che avrebbero desiderato abbracciarci. Mi pareva amore. L’Italia ci voleva bene, e non aveva intenzione di dimenticarci”. Il tono iperbolico naturale per la penna di Ciabatti qui viene usato per sviluppare un calore catodico, spettrale. Non le esuberanze di ragazze che vogliono sopravvivere ma la ronzante finta vitalità di un sentimento di comunità creato guardando sugli schermi video di persone scomparse. “Un bambino fermato su un treno insieme a una donna rom che si ostinava a sostenere fosse figlio suo”, qui lo strisciante razzismo italiano, “biondo, occhi azzurri, non poteva esserlo. Gli zingari rubano bambini, diceva la mamma, è lui”. E le ricerche che portano alla favola dell’orrore degli avvistamenti: “Non eri tu la creatura nascosta nella stiva della nave”. E sempre la favola, senza mai ridere: “A chi vuole più bene la mamma? chiedevano sconosciuti nella stanza del commissariato il giorno che mio fratello sparì”.
Comicità e gioco di registri, da sempre due armi di TC, qui sono usati per mantenere un livello piatto che deve forse qualcosa all’attuale era dello Xanax, la droga più cantata nella musica pop. Il narratore pare sotto ansiolitico mentre mastica parole di tutti, l’italiano che evolve sui social, dove i privati parlano come i conduttori tv: “Ai microfoni delle televisioni, davanti alle telecamere, la mamma dichiara riportatelo a casa. Era certa che fosse stato rapito. Un bambino così bello fa gola a molti (testuale)”. E le banali e mortali conversazioni dei grandi: “Quanti minori sparivano ogni anno? Venduti a famiglie che non potevano avere figli. O peggio, molto peggio… Origliavo discorsi che si affievolivano, diventavano sussurri”.
La protagonista, crescendo in mezzo a questa miseria morale, crescendo ha le visioni: se una “violenta grandinata (…) devastava strade e abitazioni tranne la nostra” e si sentiva un suono di passi, “io rannicchiata sotto le coperte: sei tu? (…) Segnali che lui c’era, e ci osservava. Mi aspettavo che da un momento all’altro sarebbe ricomparso per dirci: avete pianto poco, troppo”. Se guardava la televisione con la madre e “d’un tratto l’immagine si interrompeva e lo schermo diventava blu pulsante come un richiamo, pulsante come una creatura viva” si domandava: “c’era qualcuno di vivo là dietro?”.
La vicenda diventa ancora più cupa con l’arrivo di un giovane che fa innamorare la madre vedova della protagonista. “La zia faceva intendere che fossero amanti (non voglio fare nomi, ma ci sono persone che lo hanno visto uscire di mattina presto da casa di lei; e ancora: facci caso, guarda come si prendono la mano)”. Il racconto di questo nuovo amore (“chi avrebbe detto che la mamma frequentasse locali? Chi avrebbe immaginato che avesse ripreso a guidare?”) è spettrale in una maniera che ricorda Il poema dei lunatici di Cavazzoni:
Le lenti degli occhiali nascondevano occhi piccoli e ravvicinati. Ma a colpire di lui era soprattutto il pallore. Da quanto non vedeva la luce? Veniva da chiedersi, in alternativa: di che malattia soffriva? Anemia, leucemia. Eppure sorrideva.
Questo giovane amante ha, inevitabilmente soprattutto agli occhi della figlia, “qualcosa di sgradevole in lui”. C’è “qualcosa di scandaloso nella loro confidenza. Lui che si sedeva sul bordo del letto, lei che sospirava: quanto ci hai messo. Lui: dovevo sistemare cose di lavoro. Lei, allarmata: problemi? Lui rassicurante: tutto benissimo, ora pensiamo a te”. È insolito veder raccontare l’intimità di altri personaggi così da vicino, con così tanta incredulità. L’esperienza di sentire l’intimità altrui come infernale è un fatto frequente della vita, Ciabatti lo scrive benissimo ma è come se questo merito non si potesse mettere agli atti perché sgradevole in una maniera impossibile da riscattare.
Un capitolo ha come solo testo una citazione da Piccole donne, letto dalla protagonista a tredici anni: “Allora non approva il suicidio?”. “No, è un modo vile di porre fine ai propri guai. Meglio superarli o sopportarli con coraggio”. Questo concetto, uno dei ritornelli dell’educazione borghese, è calato come l’ennesimo crudele enigma – che senso hanno queste massime alla luce dell’insensatezza del mondo? D’altronde, sono vent’anni che Ciabatti cerca di raccontare questa sensazione e ora, con questo libro freddissimo e triste, mi sembra aver toccato il punto cruciale.
Criticando Matrigna, D’Orrico si è immedesimato nei panni della scrittrice fresca di successo: “Come si fa a continuare a scrivere (e a vivere) dopo un romanzo come La più amata?” E preferendo quello al successivo ha dichiarato: “Il romanzo del padre”, La più amata, “ha prevalso sul romanzo della madre”, Matrigna. Nel secondo l’autrice “non si è messa in gioco, non ha scritto, contemporaneamente, a favore e contro sé stessa, che è la sua forza”. E ha concluso: “Il format di Teresa Ciabatti è Teresa Ciabatti stessa. (…) La prossima volta torni a concederci il piacere (e il dispiacere) della sua presenza”. Vale a dire torni a fare il pagliaccio, a darci quindi lo zuccherino necessario in cambio dello squallore paterno che ci ha voluto raccontare. D’Orrico ha scritto che il padre è stato disonorato per essere onorato, ma secondo me non è vero. La tanta commedia fatta da TC su di sé l’ha fatto credere, ma era un compromesso, e il padre è stato disonorato davvero.
L’editor di La più amata le aveva detto che era “troppo fredda sul presente, non racconta la morte del padre e della madre. E la nascita della figlia?” Non si prende la briga di descrivere grandi eventi, cadaveri, funerali. “Pagine e pagine invece sulla bambola che dice mamma. Come può una donna essere tanto indietro, ferma all’infanzia. Riscrivi. Cerca la voce. La voce adulta”. Il critico uomo e la editor donna, come un padre che letteralmente la critica e una madre che letteralmente la corregge, chiedono entrambi qualcosa all’autrice: l’uomo le chiede di fare da sola tutto il gioco delle parti con il padre, per salvarlo; la donna le chiede di non fare la bambina, di fare ciò che è sempre chiesto alla donna, comportarsi bene, secondo le circostanze, non fare brutta figura, descrivere le scene importanti – i traumi indescrivibili – invece che le bambole – la scia degli choc lasciati dai traumi.
Ciabatti, al terzo di tre libri tutti dedicati ad affrontare figure genitoriali, ha rifiutato sia il padre che la critica che la madre che la corregge. L’ha fatto abbandonandosi all’oblio di una vicenda che ottunde e ipnotizza, e ha cercato in fondo a quella malinconia una verità inadatta alla mossa, compiuta col libro precedente, di fare un libro importante, un libro da scrittore quarantenne. C’è una dinamica forte nelle trasformazioni formali di Teresa Ciabatti nel corso di tre libri. La sua opera non si limita allo sforzo per il singolo libro da mettere in libreria e vendere: l’interesse fornito dalla sua letteratura sta in una non comune voglia di distruggere e crescere.