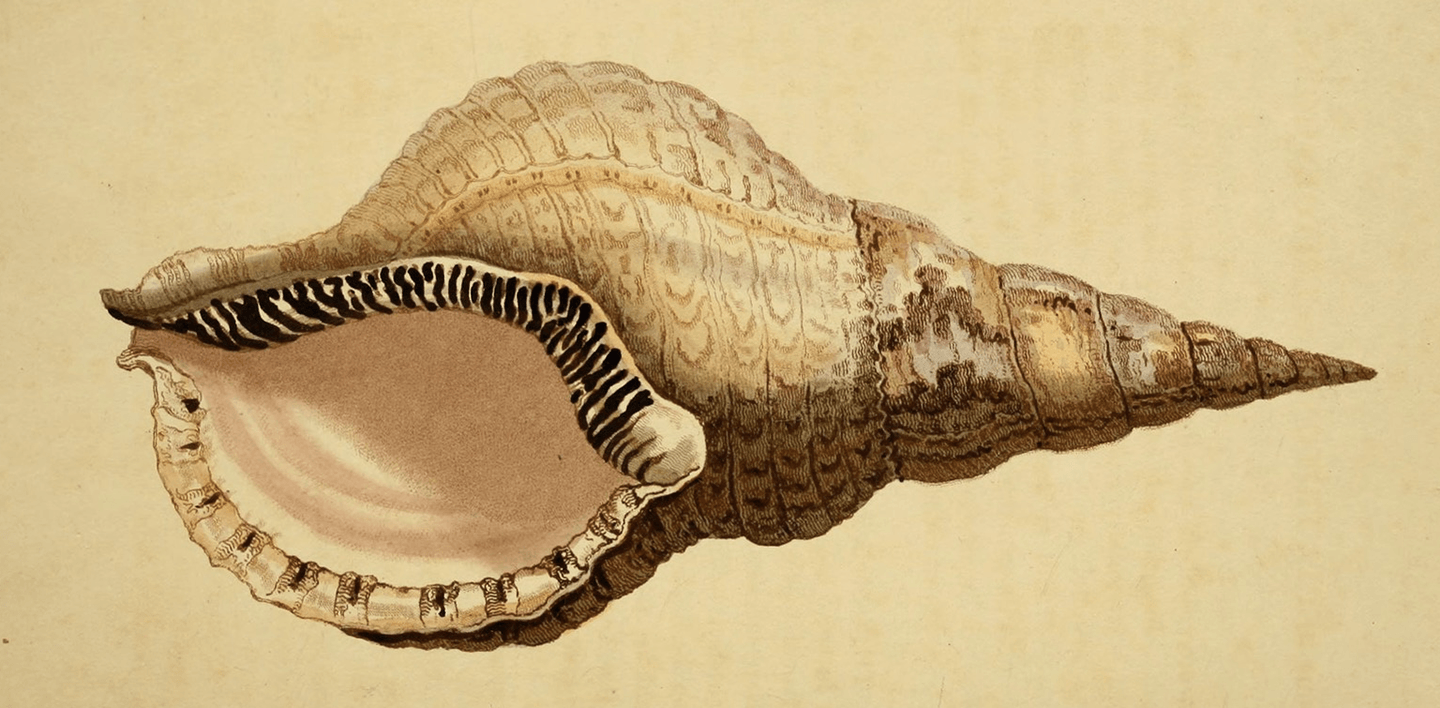
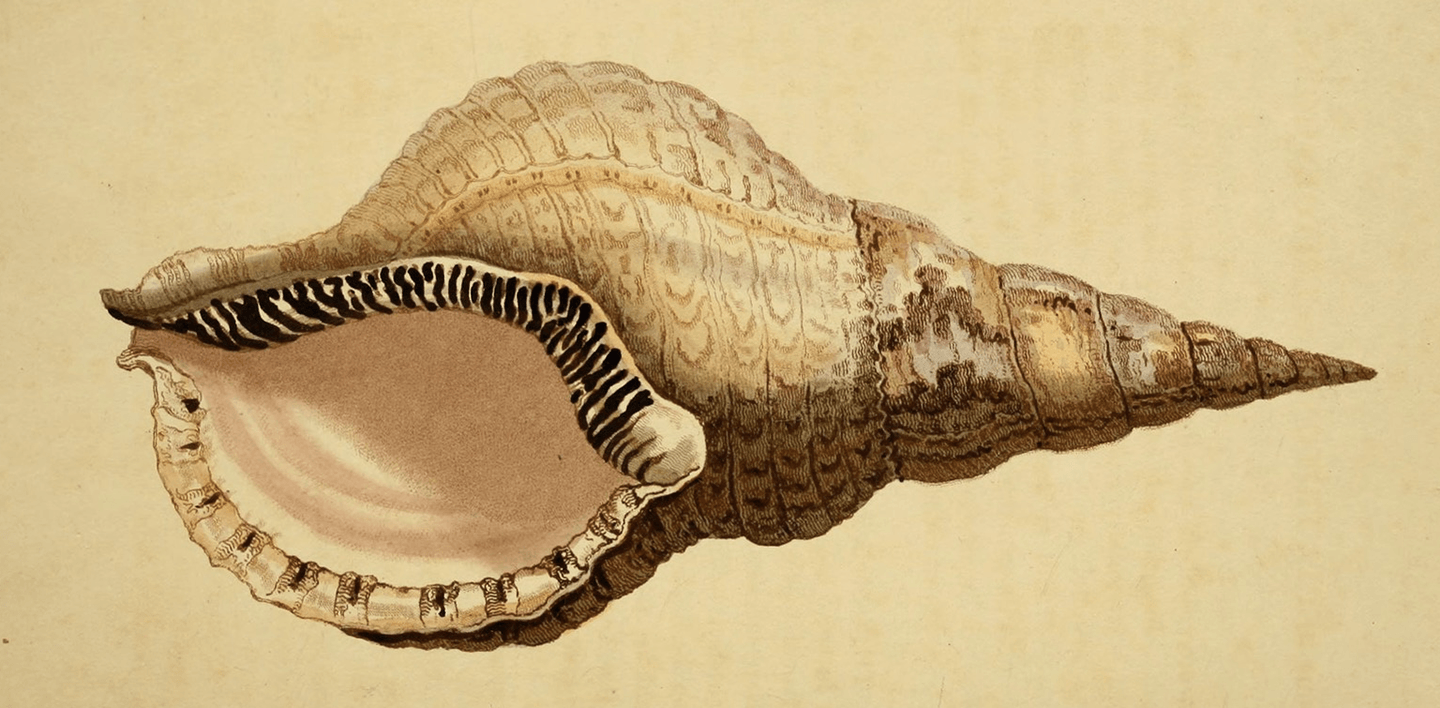
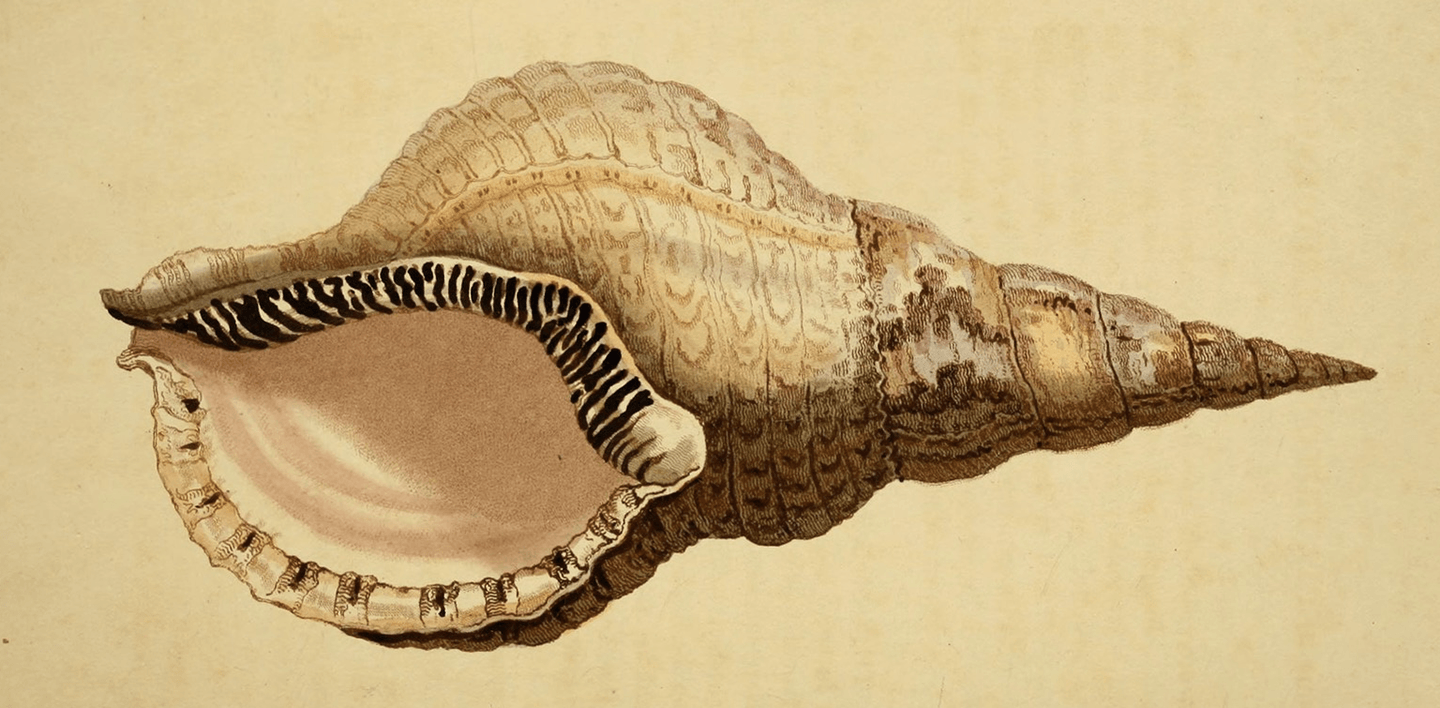
“L a storia è fatta per metà di monumenti, ma per il resto è interpretazione. C’erano cose peggiori dell’oblio, ed erano il travisamento, l’omissione, la descrizione selettiva degli eventi. La verità andava raccontata: non semplicemente lasciata a raccontarsi, come aveva fatto lei con la polizia dopo l’incidente, ponendosi in un certo senso fuori campo.”
In un articolo del 2015, apparso sul New York Times, Heidi Julavits scriveva che leggere Resoconto “era come stare sott’acqua, separati dalle altre persone da qualcosa di più denso della sola aria”, ma, continuava, “non c’è niente di confuso o ovattato nello sguardo di Cusk o nella sua prosa”. Dove in Tra le pieghe dell’orologio Heidi Julavits comprimeva due anni della sua vita in un diario privo di una cronologia riconoscibile, tornando indietro, andando avanti, perdendosi nel tempo per raccontare come tutto ci trasformi o, forse, come niente sia eterno, in Resoconto Rachel Cusk parla di divorzi, scrittura e passato con una linearità che la rendono, in egual misura, odiosa e degna di ammirazione per chiunque si metta davanti a un foglio bianco e dica di voler raccontare una storia.
Finalmente in Italia per Einaudi Stile Libero con la traduzione di Anna Nadotti, Resoconto è un romanzo in dieci conversazioni tra Faye, la protagonista del libro, e le persone che incontra durante un viaggio in Grecia, dove tiene un corso di scrittura creativa. Eppure la parola “conversazione” non sembra descrivere del tutto la natura di questi incontri: Faye non interviene praticamente mai in maniera diretta e quasi ci dimentichiamo della sua esistenza. La sua posizione è quella di chi ascolta e incoraggia la confessione, non tanto come una terapeuta, ma piuttosto come uno sconosciuto che non incontreremo mai più. Non sono monologhi, ma ci si avvicinano.
Il romanzo si apre a bordo di un aereo con destinazione Atene: seduto accanto a Faye c’è un uomo distinto; i due si scambiano le solite cordialità – quelle cose sul clima e il viaggio che si dicono per ovviare al senso di imbarazzo per essere costretti a condividere lo stesso spazio. L’uomo, però, continua a parlare e le racconta di essere greco, di aver vissuto in Inghilterra fin dall’infanzia, erede di una famiglia di armatori; i due parlano di matrimoni, di entratura e di cosa possono comprare i soldi.
Lui si è messo a farmi domande, come se gli avessero insegnato a ricordarsi di farlo, e io mi sono chiesta chi o cosa gli avesse impartito tale lezione, che alcune persone non imparano mai.
Quando Cusk inserisce questa frase all’inizio del libro, sembra volerci fornire una chiave di lettura. È vero, del resto, che la maggior parte dei suoi interlocutori si dimostra incapace di ascoltare, di fermare anche solo un attimo l’inutile e ripetitiva autoanalisi che porta avanti per fare una domanda qualsiasi (il suo amico Ryan, scrittore irlandese che dopo la prima raccolta di racconti non è più riuscito a scrivere niente, dopo una lunghissima riflessione sulle cause e gli effetti di questo blocco, le chiede “e cosa mi racconti di te, stai lavorando a qualcosa?”: il capitolo finisce qui, un punto interrogativo e una pagina bianca).
È per questo che Faye non parla? È di questo che parla Resoconto, di egocentrismo e mancanza di empatia? Non esattamente. Faye ammette di essere “sempre più convinta dei pregi della passività, e del vivere una vita contrassegnata il meno possibile dall’ostinazione”: non sono solo le persone a non far domande a Faye, ma piuttosto è lei a volersi sottrarre allo scrutinio altrui, a restare opaca e impenetrabile allo sguardo degli altri e del lettore. Resoconto è un libro sull’osservare senza essere mai visti: attraverso questo esercizio di passività, Faye lascia che i suoi interlocutori si confessino, raccontino il loro passato, e così riproducano le dinamiche delle loro relazioni, trasfigurandole e riscrivendole perché ci siano vincitori e vinti, come se il passato fosse un romanzo in capitoli, un percorso fatto di bivi inequivocabili.
“Si può definire la realtà come l’eterno equilibrio di positivo e negativo”, commenta Faye, “ma in quella storia i due poli erano stati dissociati e ascritti a identità separate e in conflitto. La narrazione presentava inevitabilmente alcune persone – il narratore e i suoi figli – in una buona luce, mentre la moglie entrava in scena solo quando la si voleva stigmatizzare ancora di più”. A volte sembra quasi giudicare la bontà dei racconti che le vengono fatti in termini di trama e intreccio.
Cosa sappiamo di Faye? Condivide con Rachel Cusk alcuni dei tratti anagrafici: entrambe sono scrittrici, hanno divorziato, hanno più di un figlio, vivono a Londra (Cusk, che è canadese, si è trasferita in Gran Bretagna da bambina); Faye, però, non è Rachel Cusk, nello stesso modo in cui i protagonisti dei romanzi di Karl Ove Knausgaard, Sheila Heti o Ben Lerner (gli autori di autofiction a cui spesso viene avvicinata) non sono mai davvero loro. In più, rispetto ai loro personaggi, la presenza di Faye è ancora più astratta ed evanescente.
In un’intervista per The Cut, sempre con Heidi Julavits, Cusk dichiara: “[Sheila Heti] usa il suo io, la sua Sheil-ità, molto, molto, molto più di quanto lo faccia io” (ripete “molto” tre volte); tra Rachel Cusk e Sheila Heti corrono dieci anni e tra il suo Puoi dire addio al sogno, il suo libro su maternità e lavoro di scrittrice, e l’ultimo di Heti, che appunto si chiama Motherhood, più di venti: a distanziarle, però, non è una semplice questione di cronologia, ma, piuttosto, di atteggiamento. A differenza della protagonista del romanzo di Sheila Heti (ma anche dei personaggi di Lerner, Knausgaard, eccetera), Faye è, nell’accezione più classica del termine, un’adulta: qualcuno che non si aspetta più di cambiare, che non ha intenzione di trasformarsi in una versione più definitiva di se stessa. Una definizione limitante, certo, perché l’età adulta non è un luogo in cui niente accade, ma che spiega qualcosa di Resoconto e di quello che Julavits intendeva con “mai confusa, mai ovattata”: se non sentiamo la sua voce, è perché a Rachel Cusk non interessa più esprimersi, per così dire. Si spiega in questo senso anche il suo rapporto col tempo, così pacificato da essere radicalmente diverso rispetto a quello di molti autori di autofiction: Heti, Lerner e Knausgaard o la stessa Julavits raramente rispettano l’andamento cronologico delle loro storie; al contrario Cusk non ha bisogno di trattenere più il presente, che è libero di trasformarsi in passato e, poi, di svanire nell’oblio.
Resoconto, insomma, sembra un carnet di viaggio di una donna troppo abituata alla imprevedibilità delle vite per esserne toccata: qualcuno che ha visto abbastanza per potersi permettere di ascoltare gli altri per ore, senza annoiarsi. Un libro freddo forse, ma, ancora una volta, non è neppure solo questo: più di tutto, il libro di Rachel Cusk sembra dire che possiamo smettere di affannarci, interrompere le fantasie di trasformazione e vivere la vita che già abitiamo. Come dice Paniotis, uno degli uomini con cui parla Faye: “io non voglio più saperne di questa concezione della vita come un continuo progredire”.
“Ho imparato che migliorare le cose è impossibile”, dice, “e che sono altrettanto responsabili le brave e le cattive persone, e che forse l’idea stessa di miglioramento è una fantasia personale, solitaria”. Allo stesso modo, quando, sull’aereo per Atene, il suo vicino di seduta, scoperto che lei è una scrittrice, nasconde la sua copia di Wilbur Smith, affrettandosi a dire che quel libro “non era rappresentativo dei suoi gusti in fatto di libri”, Faye dice tra sé e sé:
io in realtà non avevo più alcun interesse per la letteratura come forma di snobismo o addirittura di autodefinizione; non avevo alcun desiderio di dimostrare che un libro era migliore di un altro, anzi, ero sempre più restia a parlare dei libri che mi capitava di apprezzare.
Per molti versi, leggere il libro di Rachel Cusk è un’esperienza inaspettatamente riposante. Nel libro non succede granché: Faye arriva ad Atene, si sistema nell’appartamento che le è stato messo a disposizione, incontra degli amici, fa lezione a una classe di uomini e donne che vogliono scrivere o, forse, solo sopravvivere all’estate. Come riconosce Faye, “c’era una grande differenza fra ciò che volevo e ciò che in apparenza potevo avere, e finché non mi fossi infine pacificata con tale stato di cose, avevo deciso di non volere nulla di nulla”: senza desiderio non c’è azione, solo reazione ai desideri degli altri. Atene, da questo punto di vista, è la città giusta per questo tipo di comportamento: l’incomprensibilità dell’alfabeto greco le permette di esistere nella più perfetta passività, a maggior ragione considerato che è una scrittrice, una persona abituata, cioè, a leggere il mondo.
“Senza linguaggio non sono una persona che viaggia, ma una che osserva”, stavolta a parlare è Joanna Walsh in Break.up, il suo ultimo romanzo, storia di un esorcismo sentimentale che porta la scrittrice in peregrinaggio per l’Europa per dimenticare un amore. Walsh condivide questa riflessione appena arrivata ad Atene: anche a lei il neogreco provoca una piacevole sensazione di spaesamento, una scusa per non dover interagire con nessuno. Non capire significa non parlare, non parlare significa non dover mettere in ordine i propri pensieri: a volte non si desidera che questo. Qualche giorno prima, seduta in mezzo a degli scavi archeologici, aveva sentenziato che “le rovine non sono altro che frasi a metà”: qui ad Atene, una città famosa solo per i resti di uno splendore passato, non le resta che abbandonarsi a frammenti di pensiero.
Perché questa ossessione con la passività e l’inazione? Sia Faye che la protagonista di Break.up sono inglesi: è curioso quanto vulnerabile ed esposta possa essere una persona che parla inglese, con i suoi pensieri, le sue conversazioni accessibili a tutti. Ne scrive Olga Tokarczuk in Flights (Fitzcarraldo Editions, 2017):
quanto persi devono sentirsi nel mondo, dove tutte le istruzioni, tutte le parole di tutte le più stupide canzoni, dove tutti i menù, i peggiori libretti e tutte le brochure – persino i bottoni dell’ascensore! – sono scritti nella loro lingua privata. Compresi da chiunque in qualsiasi momento, ogni volta che aprono la bocca.
“È difficile ricordarsi che l’inglese è una lingua privata”, conclude, una volta che bloccata in aeroporto, si imbatte in connazionali polacchi e si trova a comprendere conversazioni che non sono intese per lei.
Diventare invisibili per Faye e Joanna implica, quindi, uno sforzo attivo: tutto quello che dicono è in un codice che altrimenti non sarebbe mai segreto, mai privato, su cui chiunque potrebbe imporre il proprio desiderio. Flights, il libro con cui Olga Tokarczuk ha vinto il Man Booker International Prize di quest’anno, è una strana e imprevedibile raccolta di testi brevi, che mescola riflessioni su corpo e anatomia a teorie sul viaggio, a parti di memoir e racconti, in uno splendido spreco di grande prosa della scrittrice polacca. C’è, anche qui, un racconto ambientato in Grecia: una coppia di anziani accademici si imbarca su una crociera di lusso, dove, ogni giorno, lui tiene una lezione sulla storia e la mitologia greca. Un giorno, guardandolo sul ponte della nave, la moglie sente che questo è il loro ultimo viaggio insieme e che il suo compito sarà quello di trascrivere e mettere insieme il suo ultimo libro e, poi, andare avanti: qualche giorno dopo il marito avrà un malore. La donna getterà le sue ceneri nel mar Egeo.
“Pensò a come nessuno ci abbia insegnato a invecchiare e a come non sapevamo come sarebbe stato”, commenta Tokarczuk: proprio su questo torna spesso Rachel Cusk, nelle sue riflessioni su quale sia la distanza tra i nostri desideri e la loro realizzazione; a legare questo brano di Flights a Resoconto, infatti, non è tanto l’ambientazione, quanto il racconto di un matrimonio, che altro non è che una promessa nella buona e cattiva sorte da parte di due persone che ancora non hanno idea di cosa vogliano dire né l’una né l’altra. In Resoconto, Cusk lascia che i suoi interlocutori parlino di speranze, di ambizione e di tutto quello che non è stato più, trasformando queste conversazioni in una meditazione sul tempo e il disincanto:
ora lo capiva, si era sempre ispirato al principio del progresso: nell’acquisto di case, terreni, automobili, nell’aspirazione a uno status sociale più elevato […] era inevitabile, ora lo capiva, che quando non c’erano stati più oggetti a raggiungere o migliorare, né obiettivi da conseguire o fasi da attraversare, il viaggio sembrasse concluso, e che lui e la moglie si sentissero oppressi da un tremendo senso di futilità e da una sensazione di malessere, che in realtà era solo una sensazione di immobilità dopo una vita di eccessivo movimento, la stessa che sperimentano i marinai sulla terraferma dopo essere stati troppo a lungo in mare, invece entrambi l’avevano interpretata come la fine del loro amore.