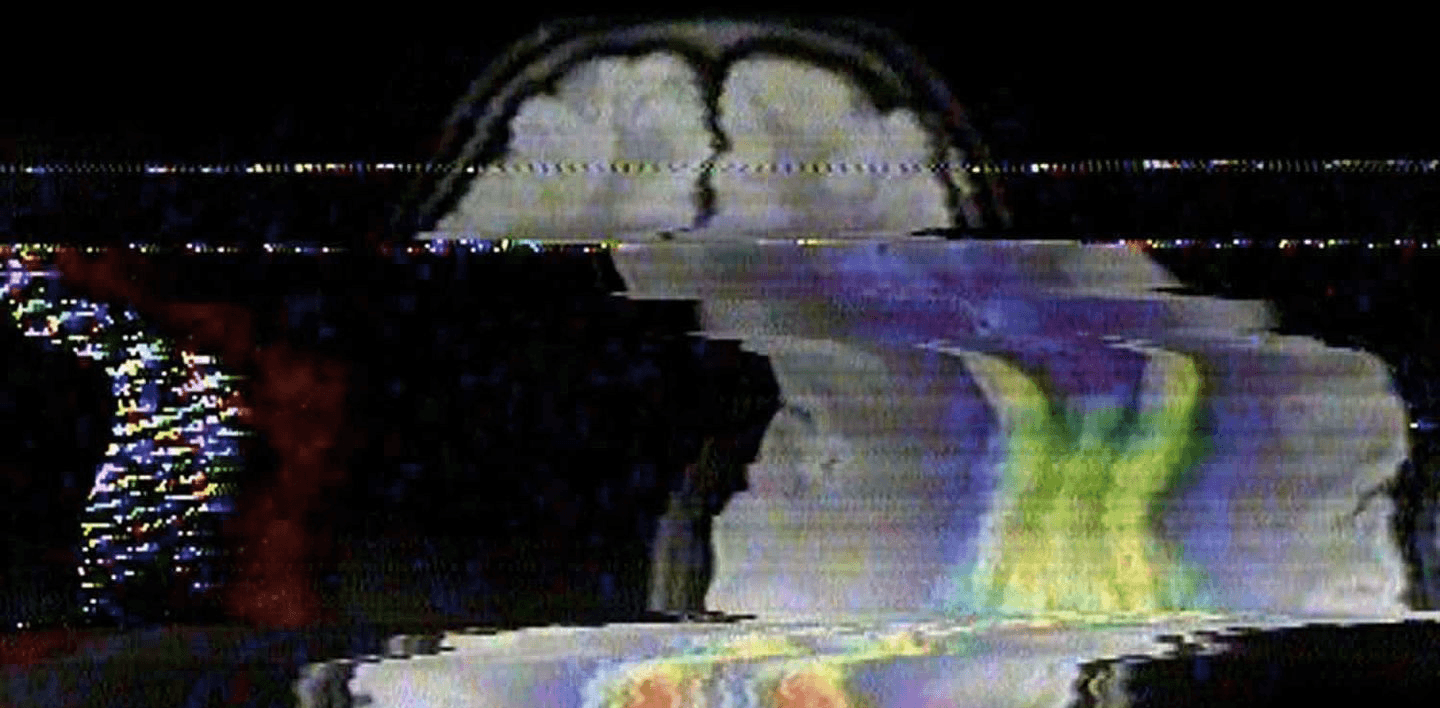
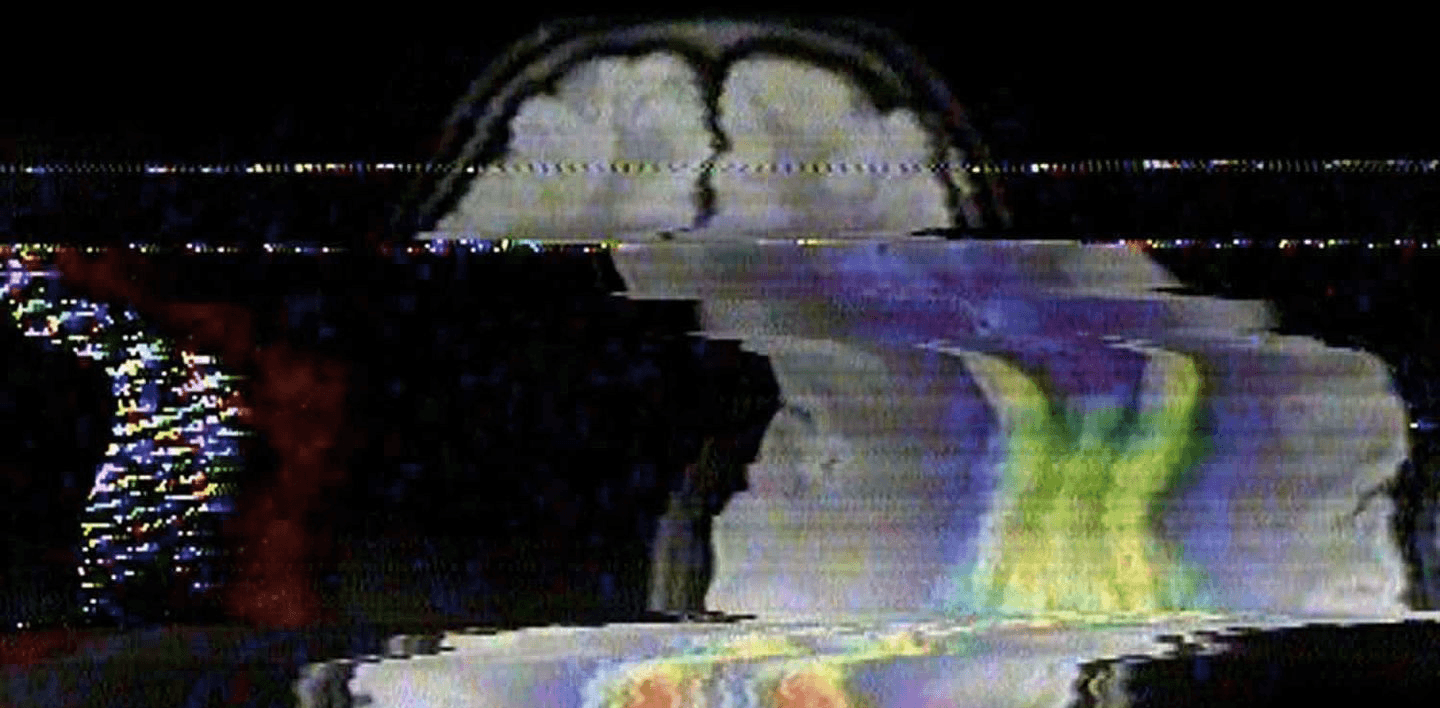
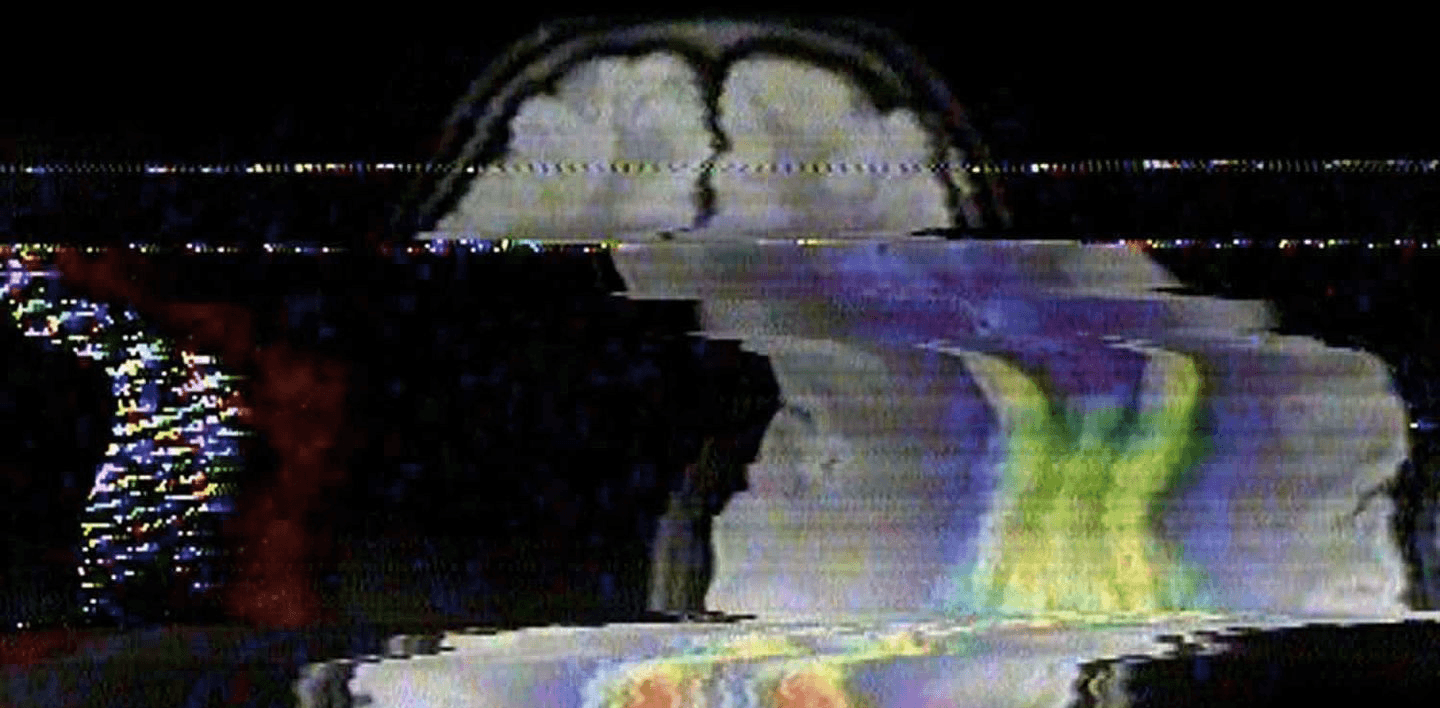
Benedetti coloro che zittiscono i propri pensieri,
Che non li condividono nemmeno con se stessi.
Non diffondono crimini nell’aria; vanno per la propria strada.
Si chiama “Technologies of the heartbreak” il seminario di scrittura creativa che Ben Marcus insegna da anni alla Columbia University e che studia il modo in cui le emozioni possono essere riprodotte e trasmesse dalle parole. La bibliografia cambia ogni anno: nel 2014 includeva, tra gli altri, romanzi e racconti di Richard Yates, Sherwood Anderson e Marilynne Robinson; lo si legge nella presentazione del corso, riportata sul sito di The Believer, dove si dice che durante le lezioni ci si interrogherà su “come può una frase o un passo far in modo che proviamo qualcosa? Percepire questa temperatura emotiva è la stessa cosa che dire che un libro “ci piace”? Che cosa significa “tenere” a un personaggio o allo svolgimento della storia? E come viene installata in noi questo tipo di premura?”. Al centro ci sono le emozioni – simpatia, desiderio, repulsione ed empatia – considerate, però, come tecniche di linguaggio, come effetti speciali delle parole: se per anni sono stata sicura che il titolo originale del seminario fosse “Anatomy of the heartbreak”, è solo un piccolo lapsus che dice molto del modo in cui Ben Marcus scrive e considera la scrittura.
Ben Marcus è in Italia per la pubblicazione de L’alfabeto di fuoco (Black Coffee, traduzione di Gioia Guerzoni) quando lo incontro a Torino. Il suo romanzo, il primo a essere tradotto a più di dieci anni da Il costume di mio padre (Alet Edizioni, 2004) e quello strano catalogo chiamato L’età del fil di ferro e dello spago (Alet Edizioni, 2006), racconta di un mondo in cui le parole dei figli diventano improvvisamente velenose per i genitori, intossicandoli, uccidendoli gradualmente, una conversazione alla volta.
Nei mesi che avevano preceduto la nostra partenza, gran parte di ciò che ci aveva fatto ammalare era scaturito dalla bocca della nostra adorata figlia. Erano parole pronunciate, bisbigliate, a volte gridate. Le scarabocchiava, le scriveva e poi le leggeva a voce alta (…) ogni lettera dell’alfabeto sembrava una grassa molecola satura d’aria sul punto di scoppiare. Che cara ragazza.
“Quando divenne visibile, quando iniziammo a sentirne parlare, a ripensarci, la malattia ci aveva già travolto”: il libro si apre con i genitori che fuggono in auto esausti, intorpiditi dal dolore, hanno provato fino all’ultimo a resistere accanto a lei, nascondendole la malattia, “meglio vivere quei momenti felici, se lo erano, e dare a Esther un padre che non fosse un guastafeste, che non impallidisse di fronte alle parole più semplici”. I genitori dovrebbero essere programmati per prendersi cura dei figli, per proteggerli nonostante tutto: il detto non dice forse che “non smetterò mai di amarvi, figli miei, se anche sarò nella merda fino al collo”?
“Un padre magnete, una madre magnete”, li chiama Marcus: l’illustrazione di Josephine Demme per il seminario di Columbia rappresenta un uomo con il titolo del libro di Sebald, Gli emigrati, piantato in mezzo petto e Meridiano di sangue inciso sopra la rotula: se c’è una cosa su cui Ben Marcus si interroga è questa – come possono ferirci le parole, se non sono nient’altro che vibrazioni trasparenti e senza peso, disperse nell’aria? Come possono avere un effetto su di noi?
“La malattia prosperava sul mio nome”, constata il narratore de L’alfabeto di fuoco, quando scopre le macchie che gli costellano il corpo: “all’inizio pensavamo fossero morsi. Qualcosa ci era atterrato sulla schiena e succhiava. Saremmo morti. […] Osservando bene, ci accorgemmo di avere la schiena ricoperta di chiazze rosse. Frammenti di mappe, come un tatuaggio incompiuto”.
“Scriviamo perché chi ci legge provi qualcosa”, risponde Ben Marcus, quando gli chiedo di spiegarmi il funzionamento del seminario, questo gigantesco teatro anatomico di romanzi, che mi ero immaginata per anni, “quello che voglio è che i miei studenti scrivano col fine ultimo di produrre una reazione nel lettore. A volte, nella scrittura, questo accade per caso, senza che sappiamo come sia successo. Quello che facciamo durante il corso, quindi”, mi spiega, “è leggere un sacco di ottimi libri, perché il punto non è arrivare a scoprire chissà cosa, il punto sta proprio in questo processo, è diventare un po’ più consapevoli di come vogliamo che il lettore si senta e che tipo di reazione vogliamo produrre. Non credo che la scrittura possa essere ridotta a una serie di regole, perché ha qualcosa di magico e misterioso, che, se comprendessimo del tutto, andrebbe perso. È un bel corso da insegnare”, continua, “perché spesso gli studenti non hanno ancora maturato quel tipo di urgenza nel trasmettere le emozioni; credono che il lettore sarà comunque obbligato a leggere e leggere le loro cose, fino alla fine, anche se sono noiose”.
Il corso, insomma, serve a evitare sentimentalismi, ironie facili ed emozioni fraudolente; “tanto varrebbe guardare Netflix, sennò”, gli dico, citando la risposta di un amico quando, una volta, gli avevo confessato che la lettura del suo ultimo romanzo mi aveva costretta a giorni di angoscia. Da quel giorno consideravo quell’affermazione l’undicesimo comandamento per uno scrittore. Glielo racconto e lui mi risponde che “l’idea del corso mi è venuta perché vorrei davvero dare ai miei studenti gli strumenti per scrivere meglio, più accuratamente”.
Cambio la bibliografia ogni anno, cercando di pensare a libri che abbiano avuto un impatto emotivo su di me o che, al contrario, abbiano provato a farlo senza riuscirci; i libri sentimentali, insomma, quelli che vogliono che tu li prenda a cuore, in cui, che so, c’è una famiglia e muoiono i figli e tu sai che dovresti starci male, ma ancora non hai avuto il tempo di affezionarti ai personaggi; o anche i melodrammi, dove tutto sembra più importante di quello che è in realtà.
Era l’effetto che aveva avuto su di me Una vita come tante di Hanya Yanagihara: quel libro contiene così tanto dolore che è impossibile uscirne indenni, gli dico, ma questo non vuol dire che sia scritto bene, anzi, la scrittura e lo stile sono ingiudicabili, annegati dalle lunghe descrizioni di abusi, che finiscono per occupare tutta l’ aria della pagina. “È anche vero che non tutti i lettori sono uguali: c’è chi desidera il melodramma, c’è chi finirà per considerare l’operazione manipolatoria. Non c’è uno standard da rispettare”.
Ben Marcus è autore di romanzi e racconti, uno scrittore di speculative fiction e distopie, che riempie i suoi libri di personaggi terribili e spiacevoli, padri che odiano i figli, figli che uccidono i padri e così via: “negli Stati Uniti si discute ancora se sia giusto o meno scrivere personaggi negativi – personalmente la trovo una domanda assurda, perché, dall’altra parte, non capisco perché dovremmo pretendere che tutto vada bene, a chi serve? Certo, capisco che le persone possano provare disagio a leggere certe cose, ma quello che è affascinante in certi scrittori, come Mary Gaitskill, per esempio, è che non gli interessa essere irritanti, come non gli interessa essere manipolatori. È solo il modo in cui vedono il mondo”.
Di Mary Gaitskill, Jennifer Egan una volta ha detto che “non c’è posto in cui abbia paura di spingersi”: lo fa in una conversazione con Deborah Treisman su The other place, per il podcast del New Yorker. Al centro di quel racconto c’è un uomo che scopre che la violenza contro le donne lo eccita e fantastica di ucciderne una: è un racconto potente e straordinariamente accurato nella resa psicologica del protagonista, soprattutto se si pensa che a scriverlo è una donna; Marcus lo ricorda molto bene: “è un racconto molto disturbante questo che hai citato – anche perché, di fatto, non accade nulla. Ecco, ha esattamente quel tipo di scrittura che ti fa desiderare di far esperienza del mondo per quello che è e non per quello vorremmo che fosse”.
Tra i più attenti e seri lettori di short stories in circolazione, Ben Marcus, oltre ad essere scrittore e professore, ha anche curato due antologie di racconti, The Anchor Book of New American Short Stories (2004) e New American Stories (2015). In quelle raccolte, oltre, ovviamente, a Mary Gaitskill (sempre per il podcast del New Yorker, legge e commenta un’altra delle sue storie, A dream of men – si ascolta qui), ha incluso George Saunders, Lydia Davis, Joy Williams e molti altri: “le mie sono scelte molto personali, non voglio dire, cioè, che questi siano i migliori racconti mai scritti in America, anche perché penso che nessuno sia in grado di dirlo. Il fatto è che amo questa forma narrativa: per me fare un’antologia è come fare un mixtape, è come dire leggi tutte queste cose insieme e ti diranno cose incredibili”.
“Per arrivare alla selezione finale, chiedo a chiunque di consigliarmi autori nuovi, autori che dovrei recuperare, finché non mi trovo ad avere una lista lunghissima di titoli e inizio a leggerli tutti. Se un racconto mi piace, me lo segno e lo metto da parte, poi, dopo un po’, lo leggo di nuovo – se continua a farmi lo stesso effetto, lo tengo”. Tra gli autori che lo hanno colpito di recente, cita Jen George con The babysitter at rest (“mai letto niente di questo tipo”), Ottessa Moshfegh, il cui Eileen è uscito nel 2017 per Mondadori, e Alexandra Kleeman (il cui libro, come quello di Joy Williams, è edito sempre da Black Coffee). Gli chiedo che effetto abbia avuto questo lavoro di curatela sulla sua scrittura: se da una parte mi sembra il sogno di ogni scrittore, dall’altra capisco che possa essere un compito non poco problematico:
ho iniziato a lavorare alla seconda raccolta subito dopo aver finito il mio libro: pensavo che fosse un’occasione imperdibile, poter leggere centinaia e centinaia di racconti. Credevo anche, egoisticamente, che mi avrebbe fatto bene, ma in realtà non è successo affatto – leggi un sacco di letteratura fantastica e ti dici che adesso puoi farlo anche tu, e invece non funziona proprio in questo modo.
A guardare bene questa selezione di autori, li si scopre accomunati dallo stesso uso creativo del linguaggio rintracciabile nei libri di Marcus, dal desiderio di una lingua vibrante e viva, al di là della varietà dei contenuti. E perfino in un romanzo come L’alfabeto di fuoco, dove al centro c’è la più tragica delle storie (genitori che amano i figli e che vengono, letteralmente, uccisi da questa relazione), l’effetto emotivo non è tanto legato alla trama, quanto al linguaggio o, per meglio dire, alla riflessione sul linguaggio. “Sarebbe troppo facile usare la rabbia o l’odio per mandare avanti un romanzo”, mi dice. Il romanzo infatti non mette tanto in scena il più innaturale degli abbandoni, quanto si chiede: cosa accadrebbe se a un certo punto, l’espressione “mi stai spezzando il cuore” passasse da essere un rimprovero a una diagnosi medica?
“Di solito quando mi trovo a scrivere un passaggio molto intenso, provo a capovolgerlo, così che torni ad essere di nuovo maneggiabile, provo, cioè, ad abbassarne la temperatura per vedere cosa c’è dall’altra parte. L’importante è tenere al centro la storia, scrivere qualcosa a cui teniamo”. “Linguaggio è sinonimo di bara” – dice uno dei personaggi ne L’alfabeto di fuoco – “Il linguaggio uccide se stesso, muore in chi lo ospita, agisce come un acido sul proprio messaggio. Se non ti interessa più un’idea o una sensazione, trasformala in linguaggio”.
In un altro dei suoi romanzi, Notable American Women, forse il suo migliore, Ben Marcus racconta il disgregamento di una famiglia (che condivide con lui il cognome Marcus), mentre la fattoria in cui vivono viene occupata da un gruppo di donne che praticano l’astinenza dalla parola, le silentists, capitanate da Jane Dark. Nell’introduzione, Michael Marcus, il padre, dà alcuni avvertimenti – in particolare, che la sua prole, Ben, potrebbe benissimo essere mentalmente handicappata: scrive “come ci si può fidare anche solo di una parola pronunciata del cuore marcio e corrotto di Ben Marcus?”.
Provo a non parlare sempre di linguaggio, anche se è la cosa che mi interessa più indagare: è uno strumento potente e misterioso e noi lo usiamo senza rifletterci, per gli scambi quotidiani, per chiacchierare e poi per compiere operazioni specifiche, nelle emergenze. C’è un compito che do ai miei studenti all’inizio di ogni semestre: gli dico che devono scrivere una pagina e che lo devono fare facendo finta che sia l’ultima della loro vita, che deve essere la cosa più urgente e intensa che scriveranno in assoluto – gli chiedo, se questa fosse l’ultima volta che puoi usare il linguaggio, che uso ne faresti? Ovviamente è un compito impossibile e finisce per farli sentire inadeguati, ma l’obiettivo è un altro, è diventare più consapevoli, più attenti nell’uso delle parole.
Forse è L’età del fil di ferro e dello spago il libro che più di tutti porta all’estremo le considerazioni di Marcus sul linguaggio: il più oscuro e assurdo dei suoi libri, è un catalogo diviso in otto sezioni (titolati “Dio”, “Sonno”, “Tempo” e così via) in cui il contenuto quasi mai corrisponde all’intestazione, prose brevissime e impossibili, corredate a un vocabolario pieno di definizioni assurde, del tipo:
Paradiso – area di contenimento finale, costruita sul modello della prima casa. Può essere attaccato a un gancio, fatto scivolare e spostato. Il fondo può essere segato. I membri all’interno guardano verso fuori e ogni tanto si sporgono.
Leggere L’età del fil di ferro e dello spago è un’esperienza straniante, che mette di fronte al fatto che tutte le parole che usiamo non hanno un significato valido in assoluto o in eterno, su cui poter contare ciecamente – e che però, d’altra parte, non possiamo farne a meno. “Pochissimo di quel che facciamo non prevede l’uso del linguaggio: tutte le nostre relazioni si basano su quello. L’età del fil di ferro e dello spago nasce dall’uso, personalissimo e privato che faccio del linguaggio, dall’abitudine che ho di trasformare mentalmente quello che le persone mi dicono nel suo contrario, dalla constatazione di come un buon editing possa rivoluzionare il senso e il ritmo di quello che scriviamo: una cosa minuscola, insomma, può cambiare tutto. Questo processo mi affascina, assomiglia a un’operazione chirurgica”.
Da quest’attenzione all’uso del linguaggio si produce una continua tensione dialettica, un’elettricità che probabilmente è la qualità migliore della sua scrittura. Questa tensione però deriva anche dalla totale assenza di spiegazioni, cronistorie e contestualizzazioni della trama: Marcus crea mondi terribili e impossibili, ma non spiega mai come ci sia arrivati. “Quando in un romanzo si ferma la storia per raccontarne i perché mi pare che tanta energia venga dissipata – la buona scrittura ti induce a fare domande, a cercare chiarimenti, ma poi raramente ti dà le risposte; crediamo di volerle, ma una volta che le abbiamo ottenute, smettiamo di preoccuparci. Un certo grado di mistero ti tiene incollato alla storia”.
C’è un lungo scambio sulla forma del racconto tra George Saunders e Marcus (tradotto anche sul sito di Sur) che mi è tornato di recente in mente. Entrambi scrittori che condividono l’interesse per il linguaggio e l’energia che una buona scrittura può produrre, i cui racconti sono spesso ambientati in mondi assurdi, pieni di dolore, con Lincoln nel Bardo e L’alfabeto di fuoco sono passati da prose brevi e elettriche a scritture più distese. Gli chiedo allora cosa sia cambiato nell’approccio alla scrittura: “quando lavori a un progetto più lungo devi impegnarti a mantenere costante desiderio, attesa e suspense nel lettore e poi sperare che rimanga con te”. C’è qualcos’altro che, però, mi pare accomunare le loro parabole: una maggiore luminosità delle storie, cupe sì – in entrambi i casi i padri si confrontano con la perdita di un figlio – ma aperte all’empatia e alla compassione:
Ho avuto anche l’impressione che i miei primi libri fossero fin troppo caratterizzati da una certa stranezza e tensione e in questo volevo far spazio alle emozioni. È importante per me, non volevo che quello che stavo scrivendo fosse visto come freddo. Volevo che si sentisse l’umanità, la verità di quello che scrivo, anche quando non è reale; ecco volevo che il libro fosse percepito realistico, a livello emotivo. In America spesso con realismo si indicano storie in cui il mondo rappresentato è quello convenzionale, dove tutto è normale, per così dire, ma per me la parola realismo sta a indicare la qualità delle emozioni, poi non importa se un romanzo è ambientato sulla luna. E poi, ho scritto cose meno strane anche per provare a fare qualcosa di diverso, per non rischiare di ripetermi.
Prima di andare via gli chiedo quale sia il suo rapporto con la religione: quale miglior libro per un autore come lui, di uno in cui “il verbo si fece carne”? “Mi interessa molto la scrittura sacra – all’università ho studiato filosofia e teologia – ma la leggo come fosse fiction. Nell’accezione migliore del termine, si intende: del resto i testi sacri non sono stati scritti da persone? In un certo senso, è come se le religioni facessero a gara per stabilire di chi sia il romanzo migliore, quale risponda meglio alla domanda come è stato creato il mondo? È tutta un’altra storia, certo, quando si prendono per veri, è un po’ come se qualcuno prendesse per vero un romanzo”, dice mettendosi a ridere, “d’altra parte, però, per me scrivere equivale in un certo senso a fondare ogni volta una religione: per L’alfabeto di fuoco mi sono inventato una religione, ma l’obiettivo finale sarebbe scrivere un intero testo sacro”.