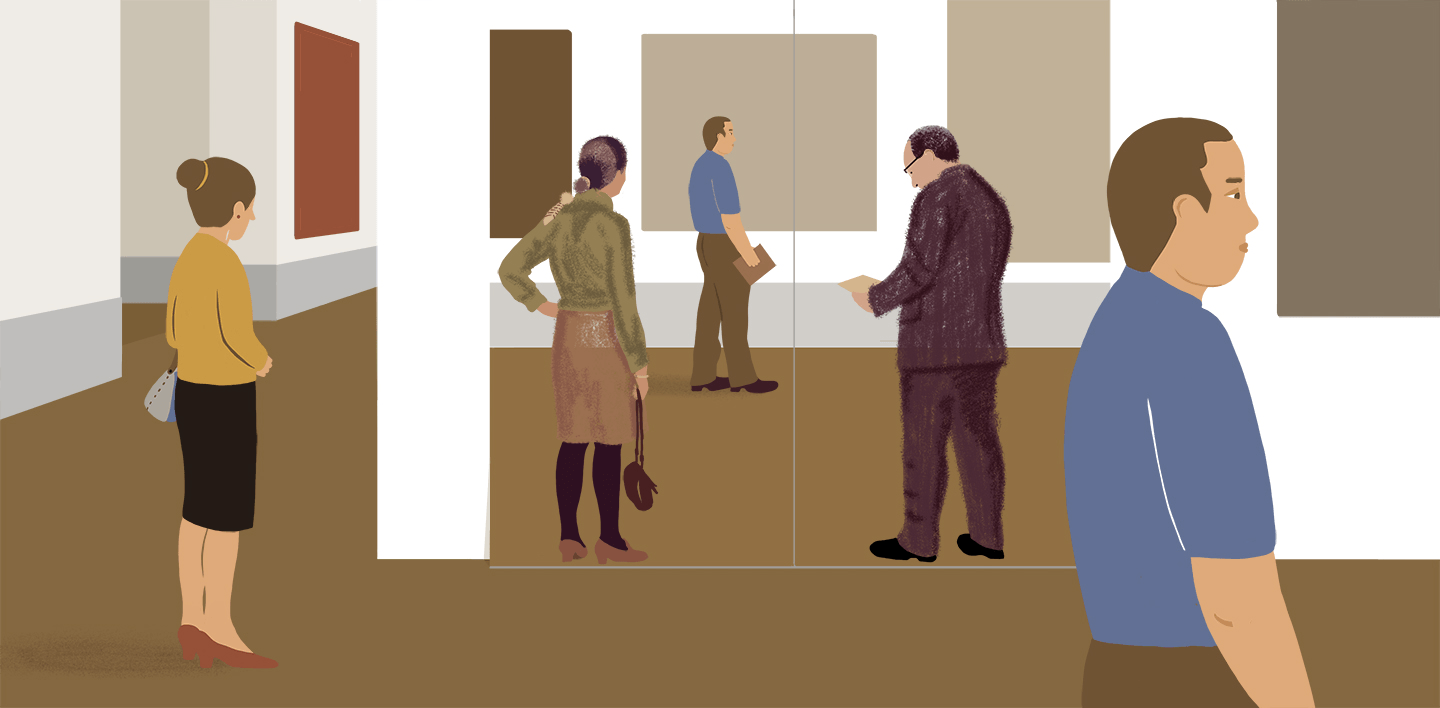
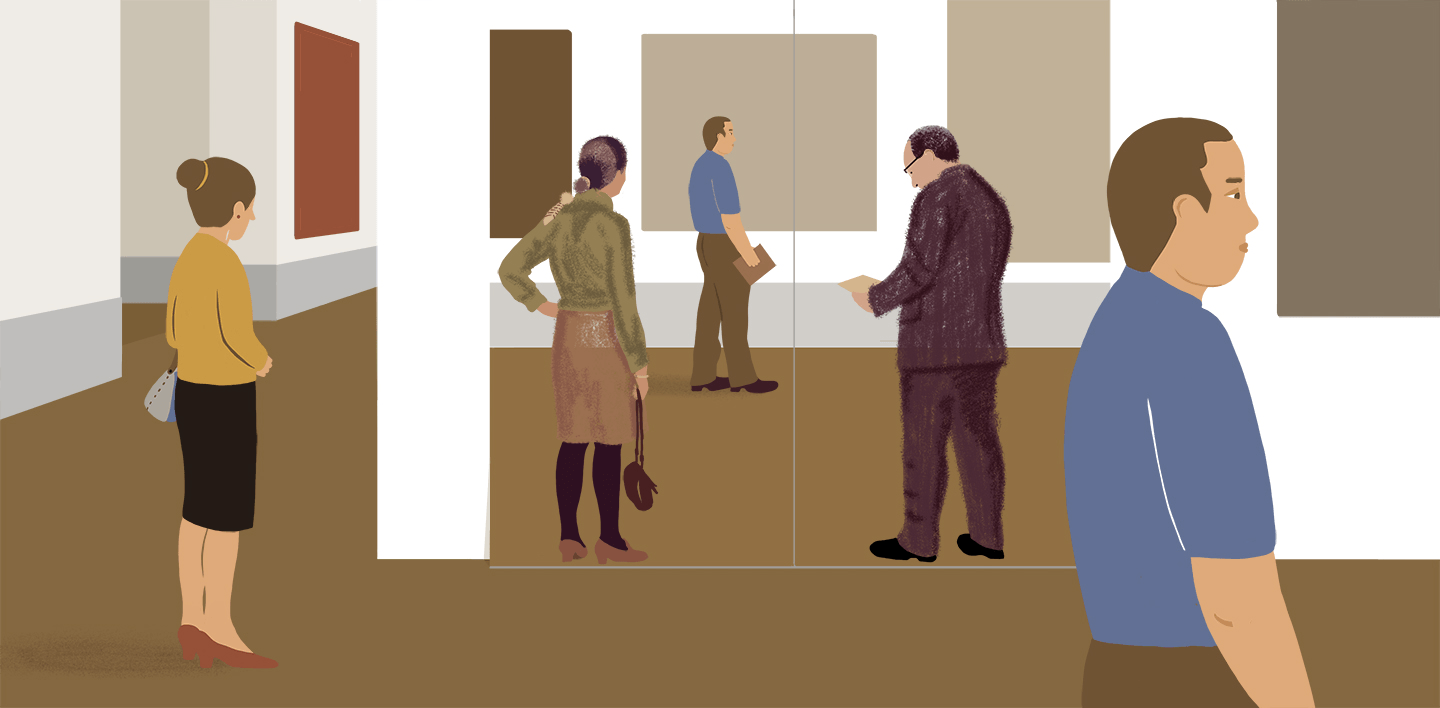
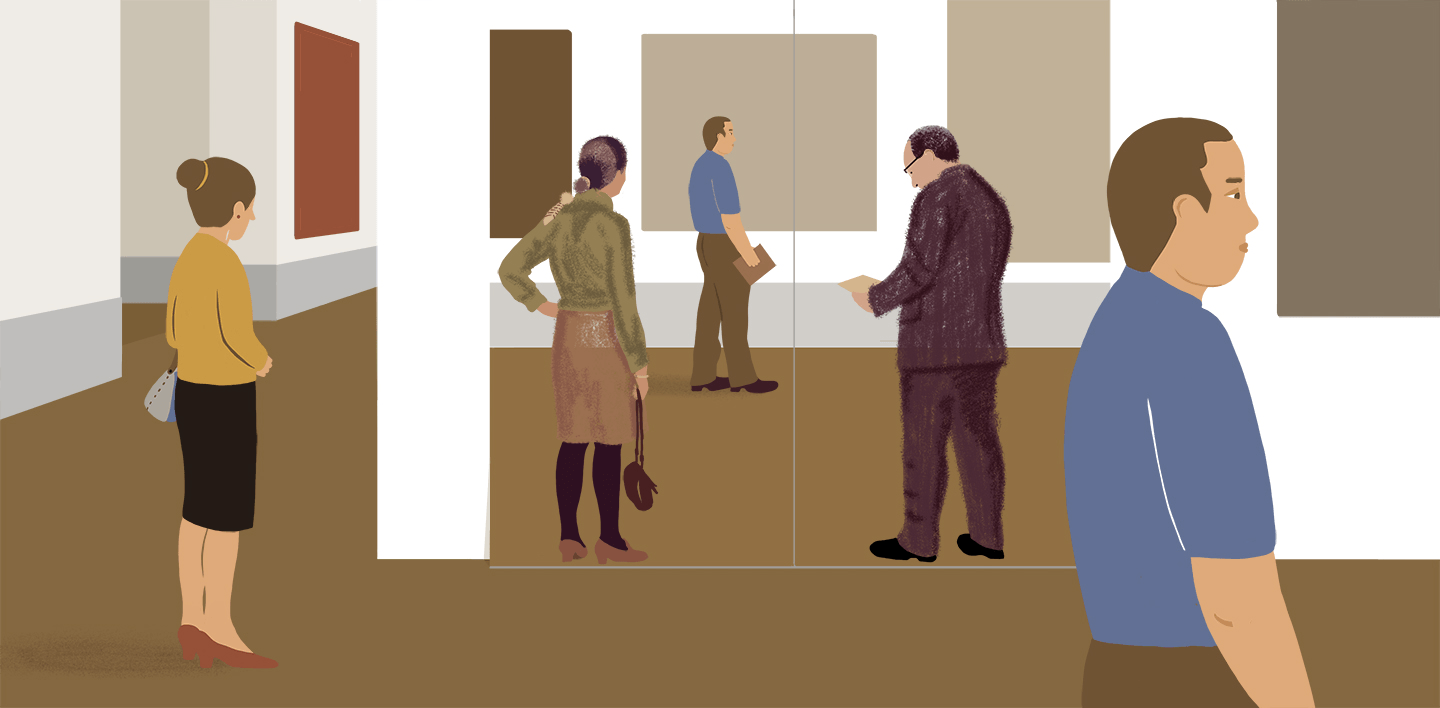
Un giorno, tutto questo, è il tema della trentunesima edizione del Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Il Tascabile partecipa al progetto 5domande ideato quest’anno dal Salone, un questionario nato per “riflettere sul mondo in cui viviamo e sul mondo che ci aspetta, e la cui forma dipenderà evidentemente anche da noi”. Abbiamo risposto alle 5domande girandole a donne e uomini arrivati sul Tascabile dai percorsi più diversi: dallo sport all’astrofisica, passando per l’arte contemporanea. Il futuro non è ancora scritto: c’è chi però, raccontandolo, può aiutarci a cambiarlo.
Oggi ci siamo chiesti: chi voglio essere? La nostra identità è in continua costruzione. Nell’epoca del culto di sé, chi aspiriamo a essere? Che rapporto c’è oggi tra l’essere se stessi, il conoscere se stessi e il diventare se stessi?
Veronica Raimo – scrittrice, autrice di Miden
Per rispondere a questa domanda mi vengono in mente due cose, due diverse forme di disagio: la prima è quando qualche amico è contrariato dagli esiti dell’ultima stagione di una serie televisiva, la seconda è quando per lavoro mi trovo a recensire dei dischi e leggo le cartelle stampa dei promotori. La serialità televisiva ci ha instillato l’idea che un personaggio per essere tale debba per forza evolversi. L’iperproduzione dell’industria musicale costringe i promotori a descrivere la parabola di un musicista in termini di continue prese di coscienza, svolte fondamentali che danno vita al “lavoro più autentico di sempre” e dischi che segnano una chiara maturità artistica; il punto è che poi costretti a comunicare lo stesso identico concetto al disco successivo. Non facciamo che evolverci, prendere coscienza, diventare autentici e maturare. Anche all’apice del nostro processo di maturazione, possiamo continuare a evolverci, prendere coscienza, autenticarci e maturare.
Ci viene richiesto di parlare delle nostre vite secondo parametri aziendalisti di scalata verticale, per quanto ci troviamo in un’azienda in cui le scale funzionano un po’ come in un quadro di Escher. A che serve allora mantenere questa idea evoluzionista? Perché dovremmo augurare a qualcuno una maturità artistica, o una maturità di qualunque tipo, se non per augurargli la morte? Ma poi teniamo troppo alla sua sopravvivenza, e giustamente profaniamo i nostri stessi convincimenti. Ce ne freghiamo se il lavoro più autentico di qualcuno si rivelerà un’impostura perché – a quanto pare – è in arrivo un altro lavoro ancora più autentico. Non mi piace immaginare l’identità come una linea su un diagramma e non sono affatto convinta sia in continua costruzione, piuttosto la vedo marcire e trasformarsi, scartare, e vivere negli infiniti momenti in cui non tende a nient’altro. È nell’esilio di quei momenti, e negli incontri che si faranno in quell’esilio, che riconosco un’identità. Per me un personaggio è qualcuno che entra in scena, fa quello che deve fare, e poi scompare. Era la cosa più autentica che potesse fare? Non lo so, mi piace pensare che non volesse fare altro. Ciò che aspiro a essere è quella presenza in una scena.
Raffaele Alberto Ventura – giornalista, autore di La classe disagiata
Essere se stessi, fateci caso, è piuttosto costoso. Pochi di noi possono dire di riconoscersi pienamente in quello che la vita ha fatto di loro: non è che sognassimo chissà cosa, ma di certo credevamo che le cose sarebbero state meno faticose. Avremmo studiato per qualche anno una certa cosa, poi quella cosa avremmo finito per farla tutta la vita. Volevamo fare gli artisti, i cantanti, gli scrittori, i giornalisti, o gli sportivi, o ancora gli imprenditori di successo, oppure semplicemente volevamo lavorare nel mondo culturale, o nella cooperazione internazionale, o insegnare a scuola, insomma volevamo renderci utili, in mezzo a persone interessanti, vivere esperienze arricchenti, tutto pur di non finire in un ufficio come il ragionier Fantozzi. E invece eccoci qua, sospesi nel mezzo. Perché oggi, come cantavano i Baustelle in un pezzo di quando avevo vent’anni e studiavo filosofia, «la personalità se la può concedere solo una piccola élite». Se soltanto anche noi potessimo permetterci di continuare a investire sulle nostre aspirazioni!
Negli anni Quaranta uno psicologo comportamentale chiamato Abraham Maslow aveva proposto uno schema in forma di piramide per spiegare in che ordine vengono soddisfatti i bisogni umani. Alla base ci sono i bisogni fisiologici (l’alimentazione, il sonno…), poi c’è la sicurezza, poi quello che lui chiama “appartenenza” ovvero l’amicizia e la famiglia, poi la stima e infine l’autorealizzazione. Ovvero, appunto, il bisogno di riconoscere se stessi attraverso il riconoscimento degli altri. È un bisogno molto astratto, certo, ma le sue conseguenze sono concrete: in un certo senso è quello che guida le nostre scelte più importanti — e spesso irragionevoli, pazze, disperate. Studiamo per anni per entrare in settori professionali in cui non c’è posto per tutti, perché sono quelli in cui sentiamo che potremmo realizzarci, e troppo tardi ci accorgiamo di essere diventati inutili. “Buoni a nulla”, come scriveva Mark Fisher.
Se il vecchio Maslow insegnava che una piramide si costruisce mattone dopo mattone, dalla base alla cima, la verità è che questa gerarchia tanto ordinata è puramente ideologica. Dobbiamo, insomma, rovesciare la piramide. Di fatto proviamo un particolare tipo di mancanza, un profondo disagio, quando il bisogno in cima alla piramide non viene soddisfatto. Nella nostra società non c’è soltanto un’ineguaglianza nell’accesso ai beni primari, in basso alla piramide, ma al cuore stesso della classe media, relativamente agiata, un’ineguaglianza nella distribuzione del riconoscimento. Perché naturalmente non possiamo essere tutti artisti, cantanti, scrittori… Ma anche perché non ci basta essere uno scrittore tra tanti, magari autopubblicato in rete: dobbiamo essere tra i più amati e tra i più venduti se vogliamo sperare di guadagnarci qualche soldo, finanziare la nostra scrittura, essere presi sul serio dagli altri scrittori.
Ecco dunque il paradosso: il riconoscimento è una merce strutturalmente scarsa, ovvero non possiamo essere tutti egualmente riconosciuti. Si tratta di un bene posizionale, che ha valore in funzione della sua posizione rispetto a tutti gli altri beni. Perché la nostra società è così costruita — piuttosto male in effetti: via via che i nostri bisogni materiali vengono soddisfatti cresce la competizione per quei bisogni sociali la cui soddisfazione dipende… dalla insoddisfazione degli altri. Nessuno di noi è il solo ad aspirare alla propria identità. Per questo «essere se stessi» è così costoso. Per questo siamo così reticenti alla cooperazione su questo mercato del lavoro inselvatichito dalla corsa per il riconoscimento. E per questo ci siamo trasformati, da classe agiata, in una classe disagiata.
In questa competizione posizionale ci saranno più perdenti che vincitori. Non solo, ma i perdenti avranno speso un’enorme quantità di risorse per partecipare alla competizione. D’altronde ve l’ho detto: la nostra società è una piramide a testa in giù; ma provate a farla stare in equilibrio, una piramide rovesciata, in bilico su quella sottilissima punta. Funziona forse per qualche secondo, poi ciondola girando su stessa e infine cade giù in mille pezzi, trascinando con sé tutte le nostre illusioni.
Cesare Alemanni – senior editor del Tascabile
Penso che l’idea che si debba innanzitutto “essere se stessi” sia molto sopravvalutata. Dirò di più: mi pare addirittura pericolosa. Come la mettiamo se “me stesso” è un cretino? Invece di spingermi a esserlo di meno, la propaganda dell’“essere se stessi” mi fornisce un alibi per restare tale. Mi bisbiglia nell’orecchio che: “Del resto che cosa posso farci io? Io sono solo me stesso”… e quindi “lasciatemi cantare”. Mi pare una retorica di un’auto-indulgenza paradossale. Per questa ragione, a un concetto di rigida identità credo siano preferibili la flessibilità del divenire e l’orizzontalità del conoscere. È l’esistenza stessa che richiede di essere vissuta facendo tesoro di entrambe, è la sua imprevedibilità a imporlo. Più che “sii te stesso” direi quindi “diventa te stesso” ogni giorno, usa ogni giorno per conoscere meglio gli altri, il mondo e anche te stesso, come già suggerivano a Delphi. Conosci te stesso ed entra in relazione con l’altro, essendo cosciente dei tuoi valori di riferimento e dei loro confini, ma rimanendo aperto alla possibilità di doverli rinegoziare dopo l’incontro.
La nostra epoca sta evidentemente rimescolando molti aspetti del tema dell’identità. Se da un lato i social media – e internet in generale – ci offrono strumenti inediti per plasmare i modi in cui ci presentiamo e quindi potenzialmente di diventare ogni giorno qualcosa di diverso a seconda delle nostre velleità del momento; dall’altro, quando invece di utilizzare le loro logiche ne veniamo utilizzati, questa schizofrenia può generare mostri. Individui che vivono dentro realtà separate, fisicamente ancora tutti sullo stesso pianeta ma di fatto isolati nel proprio spicchio di realtà. E così la nostra volatilità, la nostra mancanza di punti fermi in questa epoca di grandi rinegoziazioni identitarie, diventano facili prede per la propaganda di ideologie scadenti, che le sfruttano per ingabbiarci nella loro rigidità, dentro visioni del mondo manichee, politicamente e moralmente puerili. È quello che è accaduto negli Stati Uniti con l’elezione di Trump – uno che sul mito di ’”essere se stesso”, di dire “pane al pane” ha costruito una fortuna pubblica – e che sta accadendo un po’ ovunque in Occidente.
Tutto questo si perpetua anche perché, come detto, le infinite pluralità dell’esprimersi contemporaneo ci hanno portato a smarrire quasi del tutto un “principio di realtà” condiviso. In questi casi andrebbe ricordata una frase di Daniel Patrick Moynihan, un politico americano scomparso nel 2003: “abbiamo tutti diritto alle nostre opinioni ma non abbiamo diritto ai nostri fatti”. E quindi si ritorna al tema della conoscenza. Che non è per me sinonimo di “prerogative culturali” ovvero, come direbbe Ventura, “beni posizionali” in un gioco di specchi per allodole sociali, ma è semmai sinonimo di (e un prodotto della) curiosità. Per questo mi sento di dire che qualunque sia il campo in cui ci si muove non è tanto all’accumulazione di “cultura” che si dovrebbe puntare ma alla stimolazione della propria e altrui curiosità. Una curiosità da spingere il più possibile in direzioni nuove e diverse da quelle che la “cultura” – intesa appunto come merce di scambio in un mercato basato sul prestigio – riconosce come “cultura”. Solo con una genuina, ma allo stesso tempo rigorosa (e quindi rispettosa dei fatti), curiosità è possibile non cadere nelle trappole della contemporaneità. Si può evitare di restare prigionieri dell’asfittico banchetto della “cultura” fine a se stessa, di visioni della realtà artificiose, semplicistiche e confezionate da altri. La stessa curiosità andrebbe anche, se non soprattutto, diretta verso se stessi.
Nell’odierno caos credo sia salutare ogni tanto porsi domande come “perché la penso in questo modo piuttosto che in un altro?”, “le mie idee sono davvero migliori di quelle che reputo mie avversarie?”, “le ho formato attivamente o le ho desunte passivamente e conformisticamente dal contesto da cui provengo?”, “ho appreso dei nuovi fatti alla luce dei quali è necessaria una revisione delle mie opinioni?”. Curiosare insomma tra i nostri “contenuti” per accertarci della loro fattura e data di scadenza. Lo ritengo un esercizio propedeutico per poter davvero entrare in relazione con l’esterno, con chi la pensa come noi e soprattutto con chi la pensa diversamente da noi, per capire ed eventualmente criticare, ma in modo davvero lucido ed empatico, ciò che “contengono” gli altri.