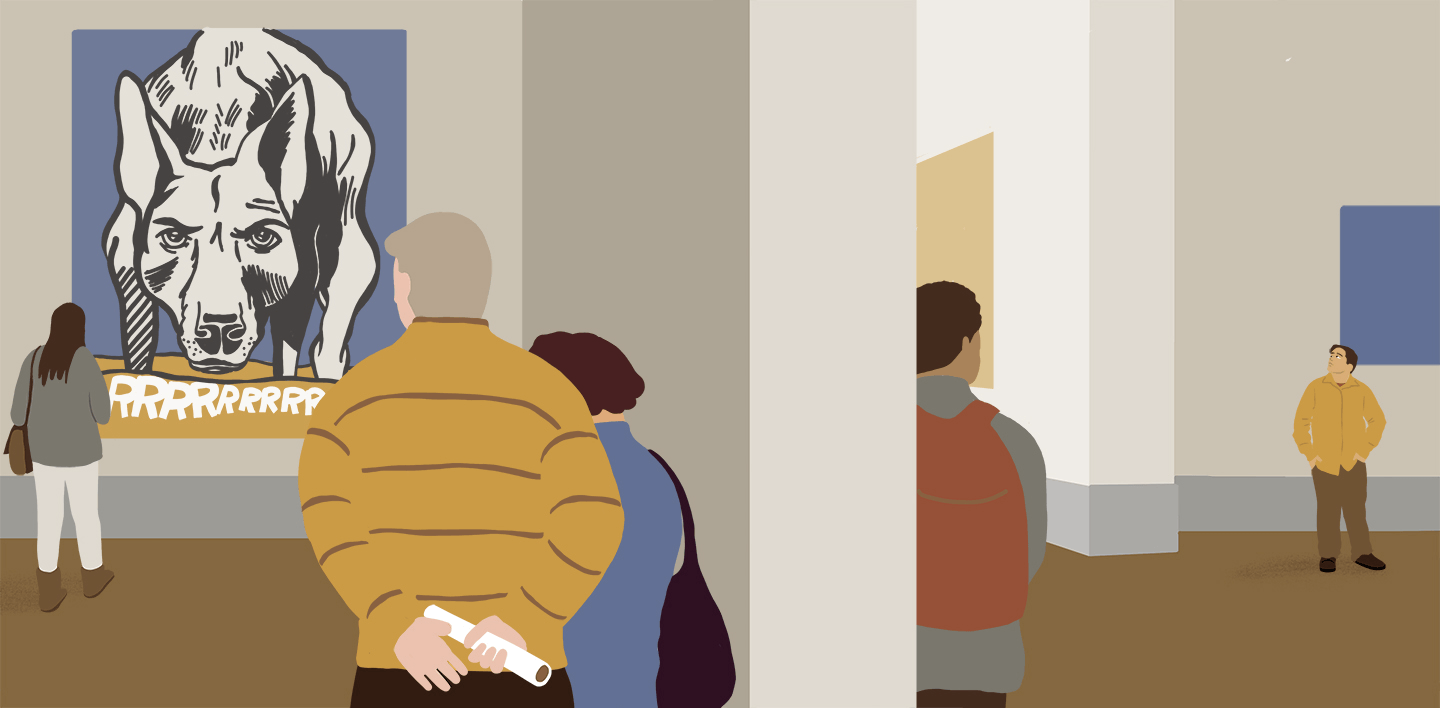
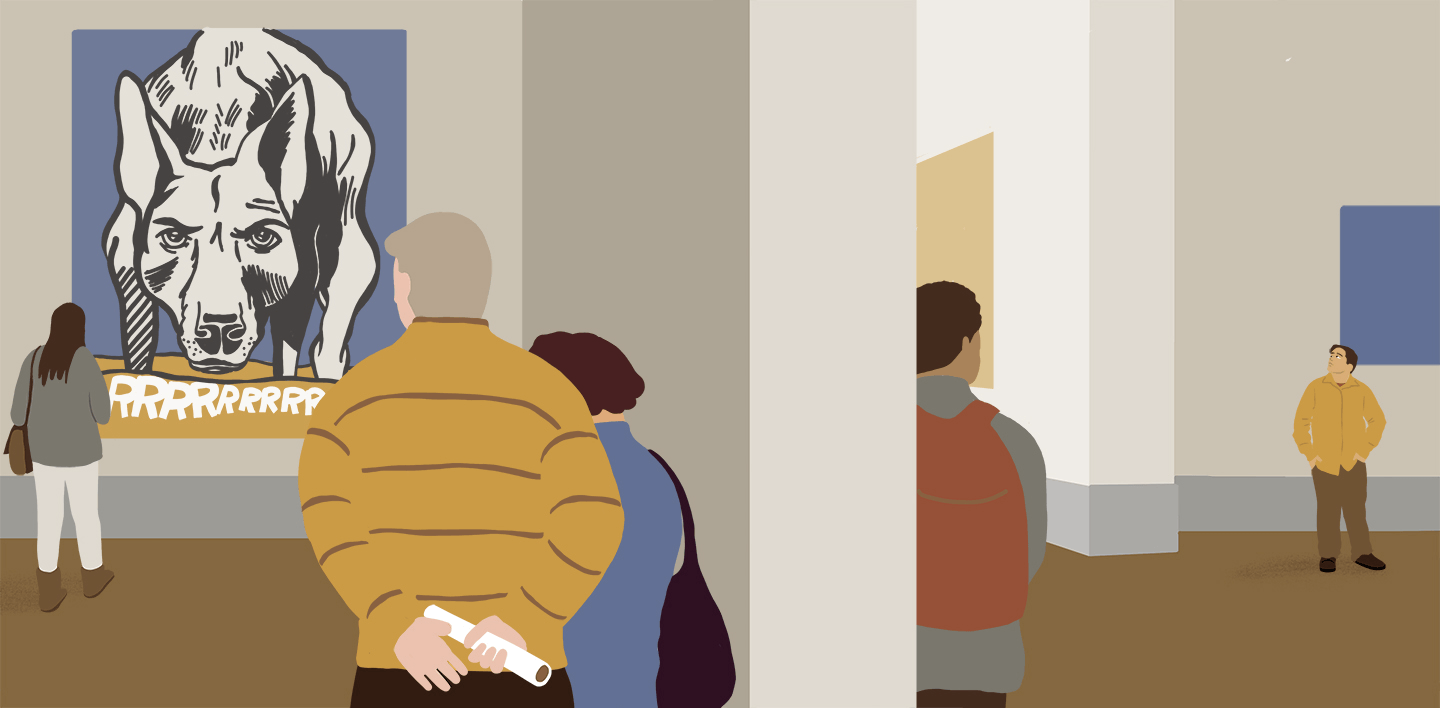
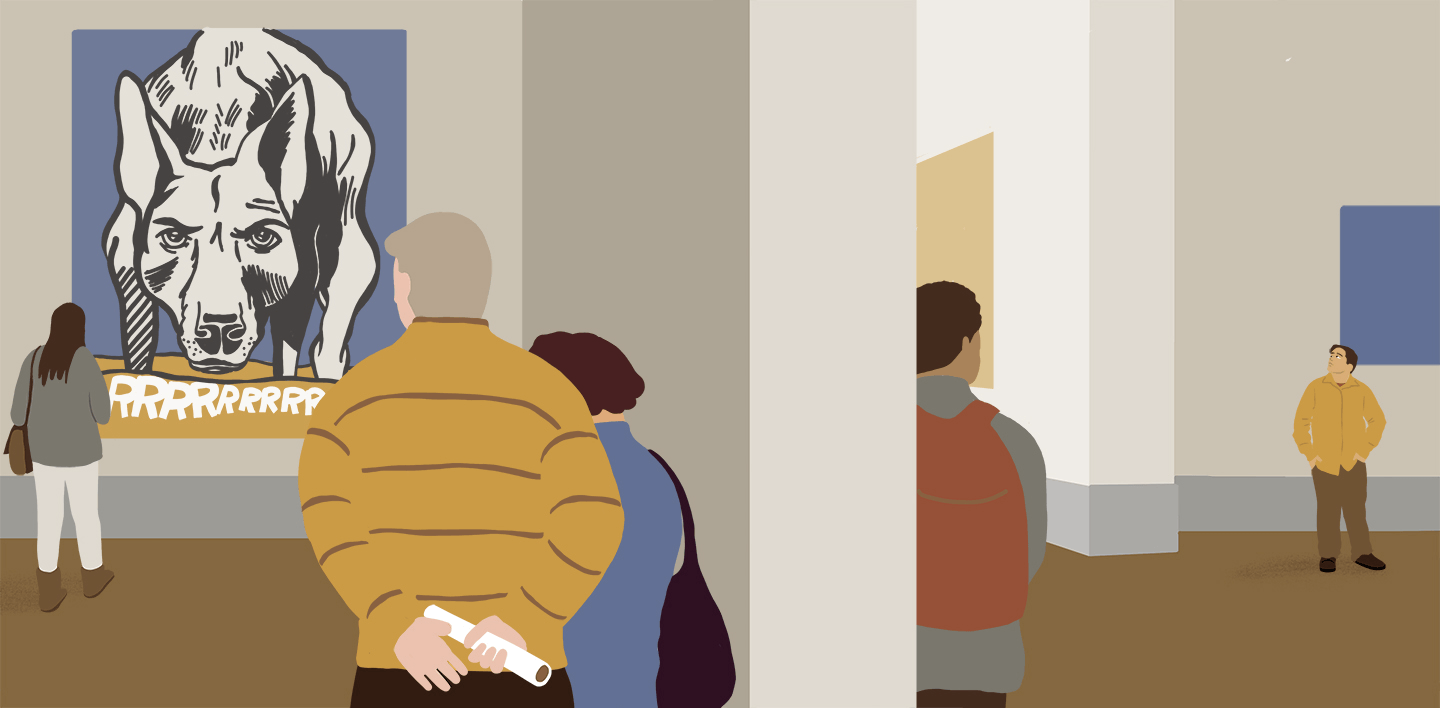
Un giorno, tutto questo, è il tema della trentunesima edizione del Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Il Tascabile partecipa al progetto 5domande ideato quest’anno dal Salone, un questionario nato per “riflettere sul mondo in cui viviamo e sul mondo che ci aspetta, e la cui forma dipenderà evidentemente anche da noi”. Abbiamo risposto alle 5domande girandole a donne e uomini arrivati sul Tascabile dai percorsi più diversi: dallo sport all’astrofisica, passando per l’arte contemporanea. Il futuro non è ancora scritto: c’è chi però, raccontandolo, può aiutarci a cambiarlo.
Oggi ci siamo chiesti: Perché mi serve un nemico? I confini ci proteggono oppure ci impediscono di incontrarci e cooperare? Come e perché li tracciamo? Abbiamo bisogno di costruirci un nemico per poter sperare di non averne?
Daniele Manusia – direttore de L’Ultimo Uomo
Un ragazzo, o magari è una ragazza, nel pieno della propria forma fisica entra in un’arena attraverso un corridoio stretto, circondato da persone festanti che lo incitano. Arrivato a bordo gabbia si volta a salutare i membri della sua squadra, lo abbracciano uno a uno e ne raccolgono i vestiti quando se li toglie, prima di presentarsi agli ufficiali di gara. Se ne resta in calzoncini, o in calzoncini e reggiseno sportivo, davanti a un ufficiale di gara, che gli sparge le sopracciglia di vasellina per far scivolare i colpi che riceverà, per fare in modo che il guantino che lo colpirà in viso non gli strappi via la pelle. Poi entra nel ring circondato da una rete metallica e quando la porta si chiude alle sue spalle resta da solo con un arbitro e un avversario. L’arbitro rappresenta il confine. È lui che decide quando l’incontro è da interrompere, in caso uno dei due combattenti non sia più in grado di difendersi. Le MMA sono uno sport limite, mescolano le diverse arti marziali per ottenere la miscela più “autentica”, “vera”. Sono nate per vedere quale delle diverse discipline alla sua fosse la più competitiva.
Sono ammesse ginocchiate e gomitate e una volta a terra bisogna continuare a difendersi altrimenti l’avversario è tenuto a continuare a colpire. Sono ammesse prese che rompono gli arti, soffocamenti e prese che chiudono le arterie carotidee in modo da impedire che il sangue ossigenato arrivi al cervello. Se uno dei due si arrende è l’arbitro a dover mettere il suo corpo tra quello del vincitore e quello dello sconfitto. Non succede praticamente mai che qualcuno muoia per la violenza dello scontro ma una concreta possibilità è quella di uscire dall’incontro modificati, cambiati. Con una cicatrice in più, magari, o un orecchio “scoppiato”. Con qualcosa al proprio interno che potrebbe rendere uno dei due rivali, o entrambi, diversi da come che erano prima, nel bene e nel male. I due ragazzi, che magari sono due ragazze, si guardano negli occhi da vicino un’ultima volta prima che l’incontro cominci, separati solo dalle mani dell’arbitro che chiede se vogliono toccarsi i guanti in segno di rispetto oppure no. La maggior parte lo fa, ma non tutti.
Scrivo di sport da pochi anni e da ancora meno mi interesso di MMA. Quando mi è stata rivolta la domanda che leggete qui sopra ho pensato subito a questo sport e ai due diversi approcci con cui si può entrare in quella gabbia per “fare la guerra”, come dicono quasi tutti i fighter. Dalle discipline tradizionali, le MMA hanno recuperato anche quel sostrato filosofico che ha come pietra angolare il rispetto per l’avversario. Fanno parte di un incontro di MMA anche gli abbracci e le parole di reciproco rispetto tra i due contendenti, uomini o donne che siano, esausti e feriti, spesso vicini (se non di molto oltre) a quello che dovrebbe essere il loro punto di rottura naturale, e che fino a un attimo prima se le stavano dando di santa ragione. Eppure qualche fighter ha bisogno di vedere un nemico nel suo avversario. Qualche fighter comincia prima ancora dell’incontro, a mostrare la sua mancanza di rispetto per l’avversario, il proprio disprezzo. E non lo fa solo per strategia, per innervosirlo e magari e portarlo a compiere qualche errore: il miglior trash-talking è quello sincero. Quando vedo fighter di questo tipo, che rompono il codice marziale e il patto con il pubblico tradizionale, mi chiedo sempre: ma perché lo fa?
Allo stesso modo, ogni volta che gioco un torneo di calcetto e con la squadra avversaria si instaura un rapporto conflittuale gratuito, incivile di default, mi chiedo perché debba essere per forza così. Nello strutturalismo l’identità è sempre differenziale. Io sono io, perché non sono te, né chiunque altro. Ho bisogno di un nemico per definire la mia identità. Umberto Eco ha scritto: “Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell’affrontarlo, il valore nostro. Pertanto, quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo”. E quella di avere un ostacolo da superare che ci aiuti a misurare il nostro valore, o quello degli atleti che osserviamo, è più o meno l’idea sulla quale si è appiattita la narrazione sportiva di questi anni. Persino Cristiano Ronaldo comunica su Instagram che “Il vostro amore mi rende forte, il vostro odio inarrestabile” e l’ostacolo può essere sociale – un’origine svantaggiata, un contesto sfavorevole – pratico – lo scetticismo di un allenatore, dei risultati non soddisfacenti a inizio carriera – oppure un avversario – Messi, o un atleta preparato per farti male finché non sei costretto a ritirarti dalla competizione – e il nemico sei sempre anche te stesso: i limiti del tuo talento, i limiti del tuo corpo.
Immagino che sul piano psicologico il bisogno di crearsi un nemico anche solo per competere al proprio meglio copra un vuoto interiore di proporzioni notevoli. Se tutto quello che sai di te è quello che non sei, forse in realtà dovresti provare a conoscerti meglio. Se non riesci a goderti il tuo talento perché immerso nello spirito competitivo dei nostri tempi, allora a che serve avere un talento? Ma vedere un nemico nel diverso, confondere gli stessi concetti di avversario e nemico, significa anche perdere qualsiasi sensibilità nei suoi confronti. Ridurre il rapporto alla supremazia dell’uno o dell’altro. Lo sport però è prima di tutto la pratica sportiva, è un fine, non il mezzo con cui arrivare a un obiettivo, al successo, o un metro con cui misurare la nostra effimera grandezza. Quest’ultima è un’idea di sport che fa comodo allo spettacolo, alle tv, ai social media, ai raccontatori sportivi. Lo sport, anche quello dove il confronto è brutale, è anzitutto un’esperienza conoscitiva, di rapporto con il proprio corpo e con il mondo, di espressione di un talento unico (come tutti i talenti). Lo sport dovrebbe ricordarci, al contrario di come viene raccontato, che anche se il tuo scopo è far svenire il tuo avversario incrociando le gambe intorno al suo collo non hai bisogno di un nemico.
Marina Pierri – giornalista televisiva
Nelle storie il conflitto è la forza motrice degli eventi. La sola forza possibile. Non è dato romanzo, film o show nel quale due o più istanze non finiscano per scontrarsi generando una tensione esteriore o interiore, operando direttamente sul caos e tramutandolo, nel migliore dei casi e con molto dolore, in armonia; in sintesi. Parlando per universali, per esempio, dopo la lotta tra bene e male probabilmente viene quella tra maschio e femmina, tanto che avere due personaggi di sesso diverso è di solito considerata una buona premessa di per sé per una vicenda; accade in decine di racconti romantici intelligenti o stupidi dove la differenza tra le caratteristiche distintive delle donne e degli uomini genera una collisione, allontana, divide e, quando c’è un lieto fine, unisce.
L’esempio dell’uomo e della donna, quando si parla di conflitto, non è casuale. Il conflitto nasce dal confine, dallo spazio che delimitiamo per noi stessi e definisce l’identità al polo opposto rispetto all’alterità; l’appartenenza da un lato e l’esclusione dall’altro. Il problema del concetto di confine – anche quando esiste una ragione biologica o comunque tangibile, materiale per tracciarlo – è che nelle sue sfumature pressoché infinite rimane spesso un costrutto culturale, contingente rispetto ai mezzi e ai costumi contemporanei. I muri si alzano con il tempo, mattone su mattone, e quando la società cambia; quando le ragioni della sanzione cominciano ad apparire futili; quando valori ritenuti fondamentali per decenni vengono messi in discussione; quando le domande opportune sono poste i mattoni iniziano a sgretolarsi. Ma le barriere non cadono del tutto. È, anzi, possibile che si erigano molto più velocemente di quanto si abbattono.
Tornando alle commedie romantiche, con i cliché perpetrati fino alla nausea che si riverberano fino alla vita quotidiana – fino ai giornali dove le mogli dei politici si fanno fotografare mentre stirano le camicie dei mariti di cui desiderano restare nell’ombra – le demarcazioni sono dure da spezzare. Affinché uno steccato sia oltrepassato, e le staccionate spazzate via, occorrono numeri molto grandi. E ancora quei numeri potrebbero non essere sufficienti, perché un’altra complessa peculiarità del confine è che persiste e, quando pare sia finalmente scomparso, l’ombra rimane. Fugarla diventa tanto più difficile. Nei buchi in cui erano conficcati i paletti ora dormono le talpe.
Disegnare confini è probabilmente funzione dell’istinto; un meccanismo innato di protezione che può degenerare, e degenera spesso, in isolamento. D’altro canto è straordinario come nella nozione esista una polarità perfetta: sacralità positiva, bene accetta, accolta, indispensabile; ostruzione negativa, rifiuto di una condivisione che può, e spesso si rivela, fertile e altrettanto sacra. Perduti sul continuum, sulla retta che separa ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, forse non resta che fare ritorno a una nozione più individuale del confine, nel tentativo di ricordare che quella che è diventata una spinta collettiva una volta era una spinta individuale. Può darsi che sia necessario ritornare a un’autodeterminazione saggia, oculata delle proprie vicinanze, e delle proprie separazioni; porre attenzione alle persone o alle cose che definiamo intruse nel nostro cerchio, nemiche. Smontando e trasformando il vecchio conflitto in una nuova cooperazione, scrivendo le storie che ascolteremo, leggeremo, guarderemo domani.
Philip Di Salvo – ricercatore, giornalista
Sono nato e vivo in un posto che fa da confine al Paese che mi dà una cittadinanza. Il confine, per la mia città, è un dato di fatto con cui si impara a convivere molto presto: sin da quando ero bambino so che il limite stesso di Como coincide con la fine stessa dell’Italia e che oltre – “di là”, come si dice qui – c’è qualcosa di altro. Per storia familiare – metà della mia famiglia è svizzera e germanofona – quell’altro non ha mai però significato molto per la mia geografia personale: sono sempre stato inevitabilmente un frontaliere emotivo, con una lingua madre scissa, due passaporti e due cognomi in due lingue diverse. Certamente anche per questa ragione, il confine della mia città non è mai stato presente per me, non è mai stato visibile o non ha mai avuto un ruolo significativo. Il confine tra Italia e Svizzera è un dato di fatto per Como, ma è placido, non spaventa, non è politicamente carico. Simboleggia e certifica, al massimo, una serie di privilegi che a lungo hanno agito sottotraccia, senza mai rendersi visibili né senza mai davvero esplicitarsi in un qualche modo politico. Il confine, qui, non ha mai fornito una chiave di lettura tangibile di sé né del presente, non ci ha mai insegnato nulla, non ci ha mai detto nulla che non sapessimo già.
Nell’estate del 2016, invece, il confine ha fatto della stazione San Giovanni di Como un campo profughi. Fino a 500 migranti si sono trovati costretti a essere comaschi per qualche settimana, bloccati dal confine e impossibilitati a continuare il loro viaggio attraverso la Svizzera e verso il Nord Europa. Da quel momento, e ancora ora, il confine è diventato politico, è diventato davvero un tema e ha spinto la città a fare una riflessione su di sé, sul suo ruolo e sul significato di quello che in precedenza era solo una dogana e, ora, è uno snodo delle migrazioni contemporanee e lembo di terra in cui l’Europa finisce. A un anno di distanza dai fatti del 2016, e in un clima politico ostile e costantemente in cerca di un nemico, è nato il progetto Confine, un libro ibrido in cui abbiamo raccontato collettivamente la storia dei migranti alla stazione e fatto una riflessione più ampia sul tema del confine stesso.
Mentre il libro prendeva forma, ci siamo resi conto di come il confine di cui volevamo parlare fosse anche simbolico e dividesse il visibile dall’invisibile. I migranti, arrivando in stazione e a Como, ci hanno messo davanti agli occhi la realtà che per decenni Como aveva voluto non vedere, i privilegi che la geografia ci ha dato come città e come questi possano essere invece limitazioni oscene imposte ad altri. In pochi giorni, in stazione, la realtà è diventata visibile, ha passato il confine e ha preteso che venisse vista. In un’intervista concessami qualche tempo fa, l’artista americano Trevor Paglen, mi ha detto che scopo del suo lavoro è fornire gli strumenti per vedere l’epoca storica in cui si vive, sottrarla all’invisibile e portarla dal lato visibile del confine. I migranti, popolando la stazione della mia città, hanno fatto qualcosa di simile, dando un significato al confine, rendendolo visibile fino a renderlo accecante.
Passo il confine tutti i giorni, prendendo gli stessi treni su cui i migranti cercano di salire per lasciare la mia città. Dopo 3 minuti di galleria, al buio, si è di là. Succede ancora che qualche migrante sia seduto di fronte a me mentre passo il confine, o che qualche migrante sia seduto sotto il mio sedile. Nessuno di loro arriva mai di là, vengono tutti fermati sul confine, dal confine stesso. A me, al mio doppio passaporto e ai miei privilegi è concessa diversa fortuna e nessuno mi ha mai chiesto ragioni del mio viaggio, né mi è mai stato impedito di portarlo a compimento. Youssouf Diakite, invece, maliano, aveva dieci anni meno di me quando è morto folgorato sul tetto di un treno in cui potevo essere seduto io, pochi chilometri dopo aver passato il confine. Lui, più di tutti gli altri, chiede di restare dalla parte visibile del confine.