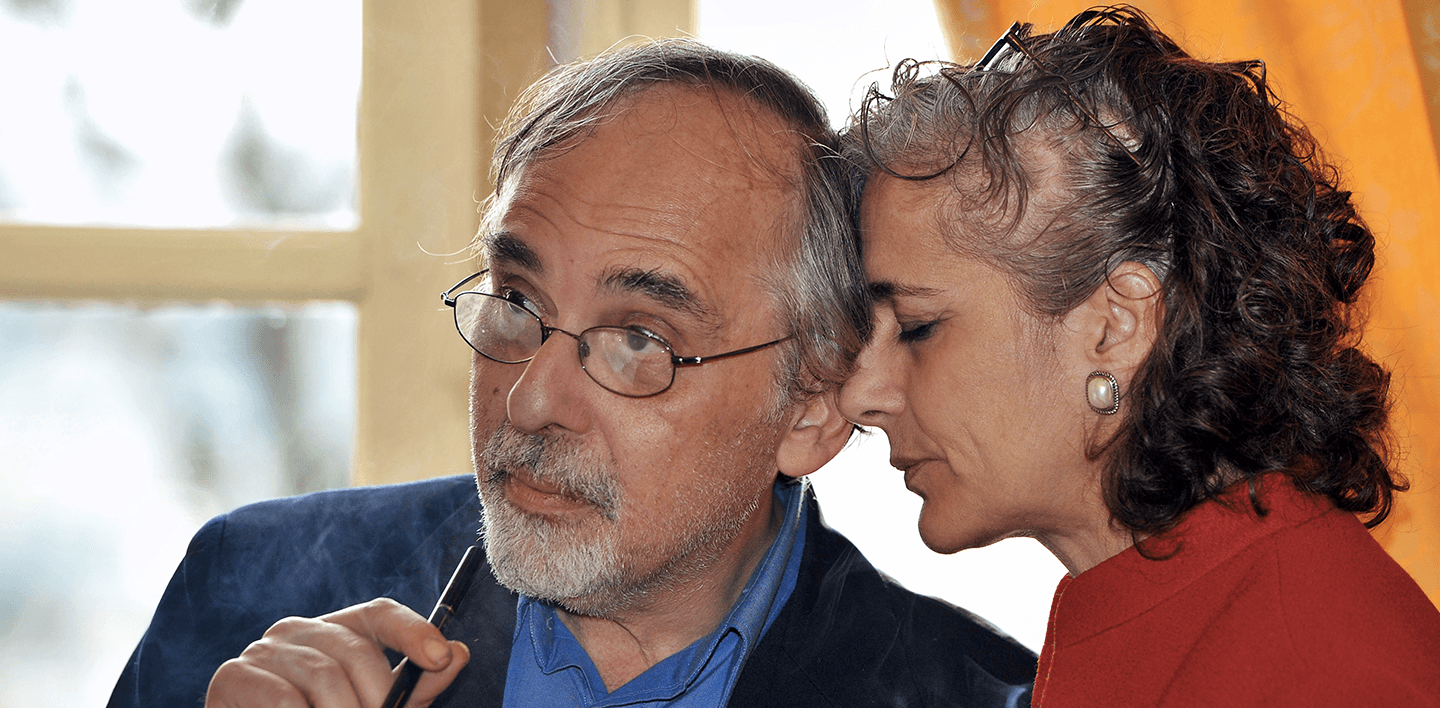
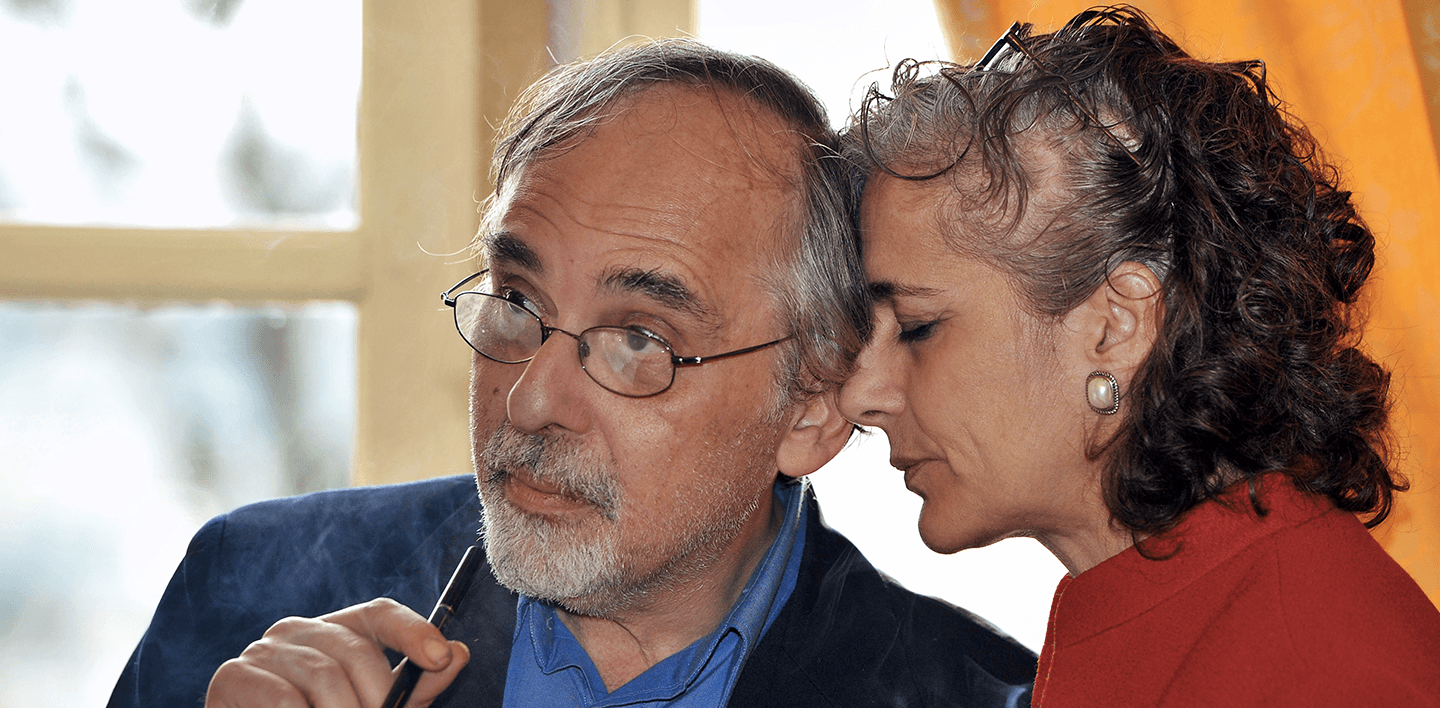
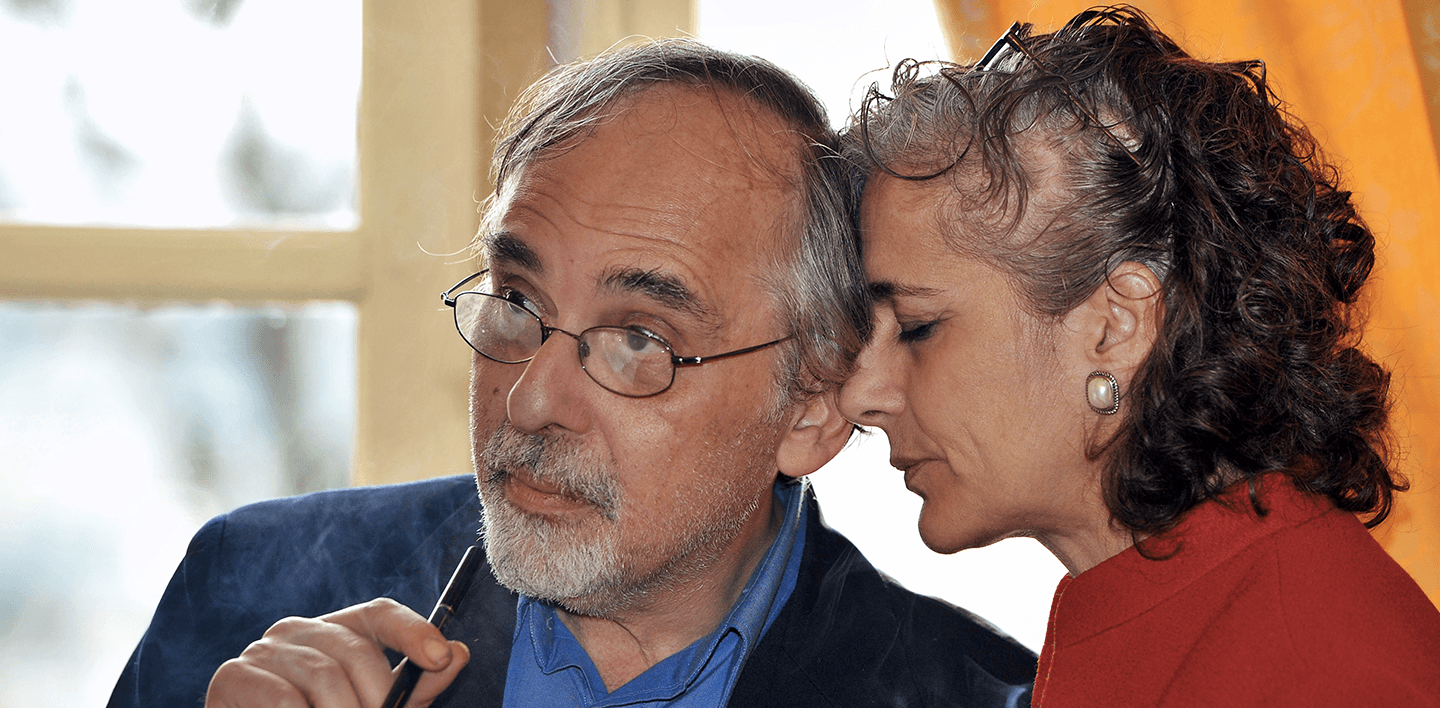
“M ia madre non era perfetta. Mia madre era intensa”: si chiama Dovrei proteggerti da tutto questo (Edizioni Clichy) il primo libro di Nadja Spiegelman e racconta la storia di tutte donne eccezionali che hanno attraversato la sua famiglia; c’è la madre, Françoise Mouly, art director del New Yorker, bella e imprendibile, una scia di profumo che aleggia nelle stanze degli appartamenti in cui vive; c’è Josée, la nonna, diminutivo per Josette o, meglio, per j’ose être; c’è la bisnonna Mina, che ha cresciuto le figlie durante la guerra e che sa cosa significa la parola compromesso. Questa è la linea matriarcale dell’eccellenza, sembra suggerirci Nadja, anzi, la linea matriarcale della sua eccellenza: una, due, tre e, adesso, quattro donne che non si sono piegate a diventare la moglie di qualcuno. Persone che hanno provato a vivere, nonostante tutto.
Una educazione femminile: sì, perché di Art Spiegelman, padre e, più notoriamente, autore di Maus, non c’è quasi traccia. Dell’artista che era riuscito a trasformare una storia personale – la deportazione del padre Vladek e della madre Anja – in un racconto universale, capace a parlare di Olocausto e padri, alla figlia non sembra interessare. Foss’anche solo per questo, perché sempre di eredità familiari parliamo, ci si aspetterebbe di vedere il padre comparire da qualche parte e, invece, in un memoir di più di quattrocento pagine non accade che un paio di volte. Di lui parlano a un certo punto Nadja e la madre Françoise:
‘Lo sai che quello stiamo facendo somiglia parecchio a Maus? A quello che ha fatto tuo padre quando ha intervistato suo padre?’‘Certo che lo so’ rispondevo io, sorpresa dal fatto che pensasse che non me ne ero accorta. ‘Fa parte del lavoro, voglio scrivere, e non posso farlo se prima non affronto quello che ha fatto lui. Sto facendo una cosa parallela che però è diversissima. E poi penso di fare l’unica cosa che papà non potrà mai fare.’
La madre di Art si era suicidata a vent’anni e i suoi diari erano stati bruciati, ma quello che stupisce qui è il clima competitivo che instaura Nadja: è una figlia che vuole eccellere nella stessa disciplina dei genitori, qualunque essa sia, e non manca occasione di rivendicare la propria straordinarietà, che è ora radicale diversità rispetto a loro (“l’unica cosa che papà non potrà mai fare”), ora perfezionamento dinastico (sennò perché infliggerci il racconto di chi l’ha preceduta?).
La sua sembra la resa dei conti finale: d’altra parte, però, Spiegelman è perfettamente consapevole che è proprio perché è la figlia di che leggiamo la sua storia. Così esplode il paradosso, che si incarna in una lunghissima lista di rimostranze: la storia delle madri diventa la storia di un conflitto matrilineare, di donne che dovevano proteggerla da tutto questo e che invece non lo hanno fatto. Spiegelman seziona e ricuce il passato a sua misura, tanto che finisce per ottenere un effetto dissonante: ogni volta che il confronto tra lei e le donne della sua vita le pare impietoso, calca la mano sui loro difetti, sulle loro mancanze; alla fine di queste donne si ricordano solo gli insuccessi, mai i traguardi.
Suo padre, invece, è poco più di uomo che scuote la testa, sconsolato di fronte alla moglie che ferma la macchina in mezzo a una pioggia tropicale per ballare con i figli, un silenzioso e pacifico – viene da dire, assente – spettatore della crescita della figlia. Solo questo? Così pare. Che parli dell’occupazione nazista di Parigi o della New York degli anni ’80, in primo piano resta sempre Nadja e il suo terrore di essere inadeguata: il suo è una specie di romanzo di formazione o, meglio, di rivendicazione, che procede per balzi, per flashback, ondeggiante come la memoria di una persona anziana, per cui passato e presente finiscono per coincidere.
Scrive nella premessa: “le scelte editoriali necessarie a trasformare le loro vite in un’opera di narrativa sono mie. Questo libro riflette la mia cognizione personale di un passato complesso, condiviso e soggettivo”. Le mie scelte, la mia cognizione: quanti aggettivi possessivi. In un libro uscito per minimum fax, Una vita non mia, di Olivia Sudjic, si legge: “le storie delle origini ci fanno sentire al sicuro; sbrogliarle può farci crollare”. A scriverlo è Mizuko, la scrittrice giapponese verso cui Alice Hare, la protagonista, inizia a nutrire una vera e propria ossessione:
Certo, pensai. Già. Cominciai a immaginare che quelle parole fossero state addirittura scritte da me. Leggere della sua vita era come premere l’uno contro l’altro i palmi delle mani. Sembrava combaciare perfettamente con la mia. La trasformai nella storia delle mie origini – un modo per spiegarmi a me stessa, come se solo lei potesse giustificare la mia presenza nell’universo.
La protagonista di Una vita non mia ha perso il padre adottivo ed è sfuggita dall’Inghilterra e da Susy, sua madre, per trasferirsi a New York (“New York è il luogo dove sono nata; ecco perché ci sono tornata”). Lì c’è Silvia, la nonna paterna, che prima la invita e poi, quando arriva a casa, le dice pensavo saresti arrivata domani e non si alza ad abbracciarla. Per certi versi Alice assomiglia a Nadja: entrambe hanno bisogno di riappropiarsi della storia delle proprie origini, ma questo processo appare in continua evoluzione, un testo pieno di lacune e imprecisioni; cercano il loro posto nel mondo e provano a farlo attraverso la memoria e le storie, ma, come insegna la neuroscienza, quando smuoviamo un ricordo lontano, quest’ultimo fluttua nel nostro inconscio, “instabile, per una finestra temporale di tre ore, durante quel tempo, il ricordo è malleabile. Il presente penetra nel passato. Aggiungiamo dettagli per riempire i vuoti. Poi il cervello ricodifica il ricordo come fosse nuovo, sovrascrivendo il vecchio.”
“La memoria è la nostra prima arma. Impariamo a riconoscere il volto di chiunque ci nutra, e altre cose – meno corporee. Ricordiamo i sentimenti, o i dubbi più ostinati”, conclude ad un certo punto Alice di fronte alla frustrazione provata nel capire qualcosa di più della sua vita: “se mettevo in dubbio qualcosa – date, nomi, luoghi – mia madre ribatteva non con una risposta ma con una domanda, tipo perché non andavo a cercare i miei veri genitori e non la lasciavo in pace?”
Diceva Leonard Cohen che le cicatrici sono quello che accade quando la parola si fa carne, come se ci scambiassimo storie perché non ci possiamo scambiare i corpi: quell’atto di compromissione, quel gesto per cui ci si consegna all’altro è talmente prezioso da sembrare un rituale governato da regole segrete. “Le storie che usiamo per creare le nostre identità,” scrive Nadja Spiegelman, “le storie che raccontiamo ai nuovi amanti alle cinque del mattino per fargli capire chi siamo, sono anche quelle su cui abbiamo ricamato maggiormente. Sono state modificate dagli umori e dalle circostanze in cui le abbiamo raccontate. Sono state modificate dal significato che ogni volta avevamo bisogno di attribuire loro”. Sua madre una volta le aveva detto che non riusciva a trovare un ricordo in cui non fossero presenti i suoi figli: si tratta di un’esagerazione, ma spiega bene come funziona la memoria, quanto fallibile e quanto intrecciati al presente siano i ricordi, in ogni momento. “Fili luminosi di me stessa, ricamati sul suo passato” li chiama Nadja, con una certa soddisfazione: perlomeno, pensa, sono riuscita a colonizzare i pensieri di mia madre.
In Una vita non mia, è Silvia, madre di Mark, l’evanescente padre, a scrivere lettere alla nipote, per darle una versione, la sua versione, degli eventi che hanno portato alla sua nascita: “inizierò col dirti quando sei nata. A Manhattan, nel 1991. Io ti chiamavo Coniglietto. Era lo stesso nome con cui chiamavo Mark quando era bambino”; per Alice, tornare a New York è il modo più rapido per scoprire qualcosa di più dell’uomo che chiamerebbe mio padre e, di conseguenza, su di sé. Ma la memoria delle persone resta un terreno troppo scivoloso per trovare appigli sicuri; neanche scoprire di come suo padre fosse volato a Dallas per studiare il bosone di Higgs, di come, tornato a New York, avesse vissuto con loro in una casa arredata come un transatlantico, del Giappone e di come aveva conosciuto sua madre, neppure tutti questi dettagli insieme riescono a illuminarne la figura. È il principio di indeterminazione dei ricordi:
Il punto principale è sempre il marito assente, il mio secondo padre assente, Mark. A volte è un disertore e il suo ricordo viene disprezzato e insultato; altre volte diventa una specie di destino, adorato e compianto. Il mio ruolo nella vicenda è sempre diverso. Sono stata una salvezza per il matrimonio e una rovina per il matrimonio.
Senza possibilità di determinare il passato, cosa le resta? Senza il passato, paiono suggerirci questi libri, non c’è futuro o, meglio, non c’è identità; è la stessa ragione che spinge Amy Fusselman, in Il medico della nave (Edizioni Black Coffee), a recuperare i diari di bordo del padre dopo la sua morte, perché lui se n’è andato e lei ha bisogno di ricucire il passato, ora che si appresta a diventare madre. Il libro inizia così: “Non fare sesso su una nave a meno che tu non voglia rimanere incinta”.
C’è un rischio che corrono tutti questi libri: è quello di scriversi addosso, di mettere insieme date, nomi, azioni, biografie sommarie o interi alberi genealogici, senza altro scopo che dire qualcosa su se stessi che può parlare solo alla propria memoria, sordi a qualsiasi altro richiamo. Sezionano ricordi, aprono archivi, alludono a versioni alternative e passati non ufficiali, ma assomigliano a rese dei conti, a rivendicazioni di esistenza. Il problema non è scrivere qualcosa di personale, non è la parzialità dell’esperienza, quando la fertilità della scrittura, far di queste parole uno strumento che parli del mondo al mondo e non solo di sé.
Trattare il passato come una terra da conquistare non è un desiderio meno egoista e cieco di quello d’oblio: l’intuizione migliore di Una vita non mia, non a caso, ha a che fare con l’ossessione verso gli altri, con il desiderio, come lo chiama Alice, di far combaciare la storia degli altri con la propria. Per questo le città, per questo l’anonimato, per questo il racconto di come il coniglietto Alice finisce down the rabbit hole (capito il gioco di parole?) della rete. Al di là delle ambizioni di essere il primo romanzo su Instagram, al di là delle trappole della commodificazione della nostra intimità, qui risuona il desiderio di svanire dietro uno schermo, in mezzo alle immagini e le parole degli altri: dimenticarsi un po’, far dissolvere il romanzo familiare nell’aria sottile. Un giorno Silvia la porta nella stanza in cui ha conservato tutti gli oggetti appartenuti al padre: Alice si ripromette di aprire quelle scatole, ma poi non lo fa mai. Ricorda: “le storie delle origini ci fanno sentire al sicuro; sbrogliarle può farci crollare”.
‘Dimenticherò tutto. Devo scriverlo’ ho scritto in un quaderno che ho tenuto in quei mesi, ma poi invece ho scritto poco altro. Lasciavo che i giorni cedessero il posto alle notti e tornassero a essere giorni, con l’alba che mi colpiva come una pulsazione veloce. Se provavo a ricordare cosa avessi fatto il giorno prima, vedevo solo strisce di colore, come un acquarello rimasto sotto la pioggia.