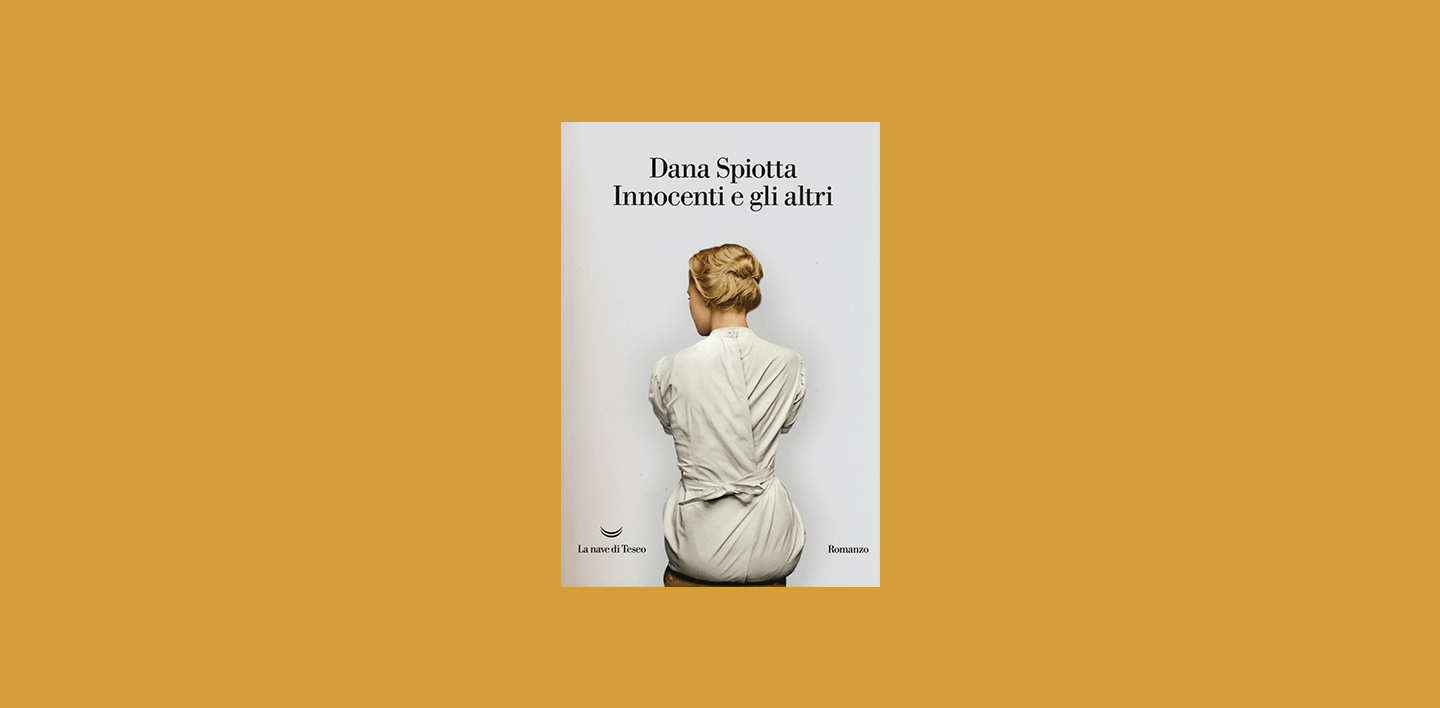
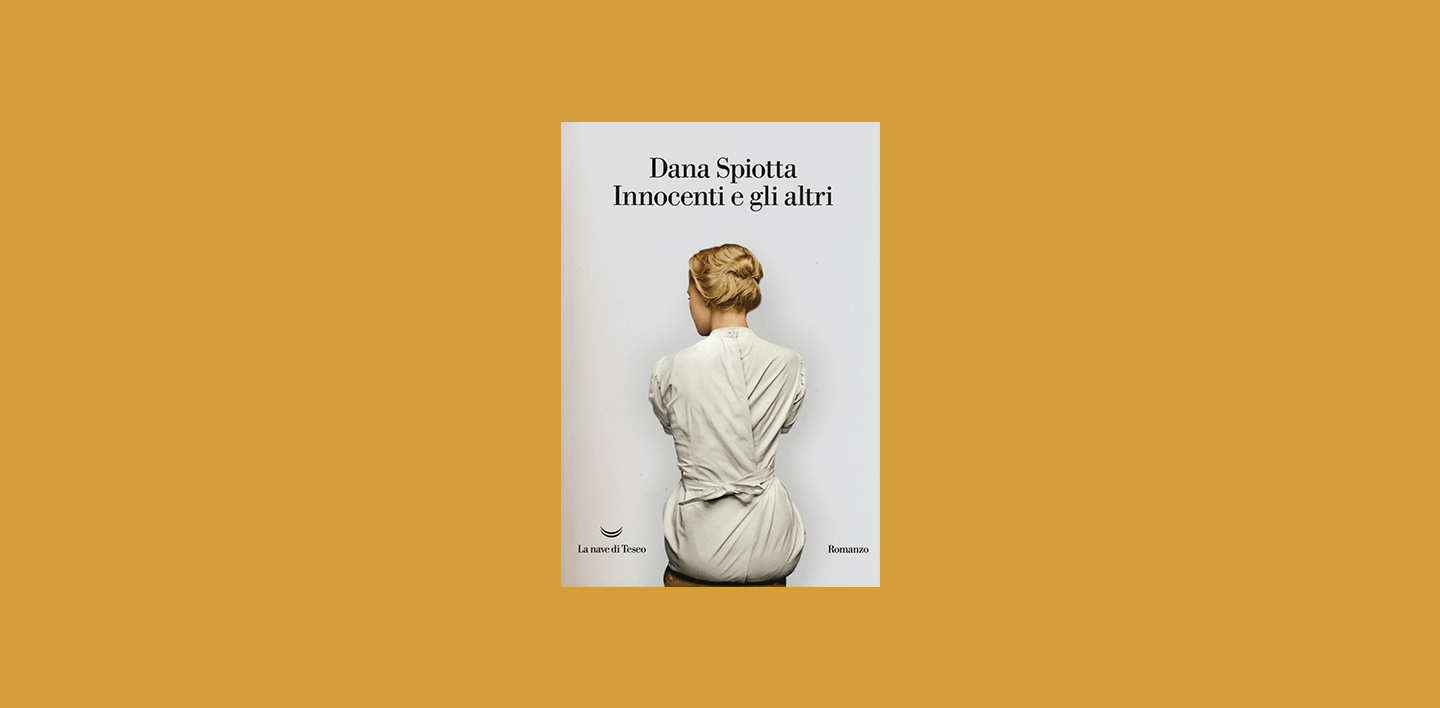
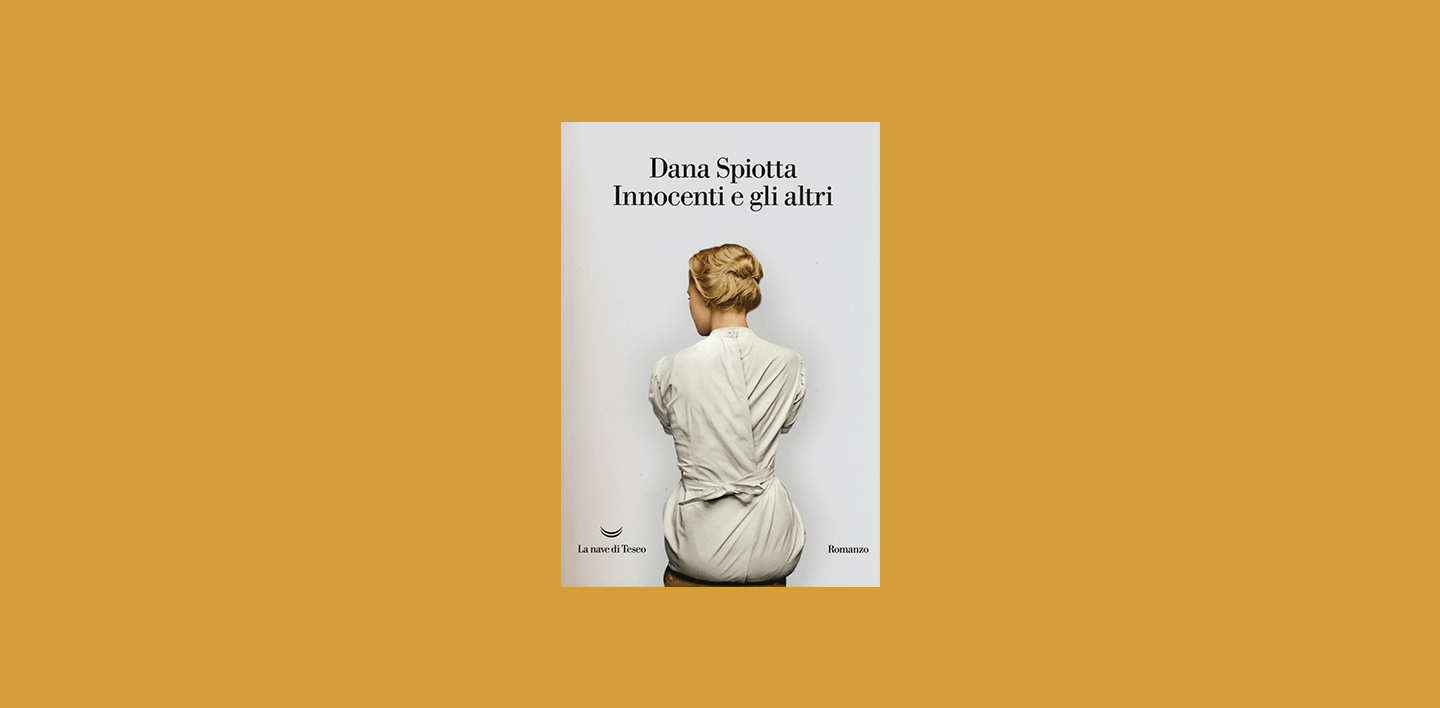
D i quella notte, Sarah Mills ricorda solo l’odore di bruciato, Jason svenuto sul divano e la loro bambina abbandonata nella culla: per quanto provi a ripercorrere gli eventi, la donna non riesce a ricordare più di così. Eppure ha confessato di essere stata lei ad appiccare l’incendio in cui sono morti. Al tempo aveva diciotto anni, problemi di soldi e di droga e aveva litigato furiosamente col fidanzato: se si sforza, ricorda di essere uscita in mutande nella neve, poi nient’altro.
Questa è solo una delle storie che si incrociano in Innocenti e gli altri, il nuovo romanzo di Dana Spiotta (La Nave di Teseo, traduzione di Carlo Prosperi), un’indagine sui confini tra menzogna, artificio e verità, in forma di romanzo. Qui Spiotta racconta la vita di una regista, Meadow Mori, nella Los Angeles degli anni ’80, e lo fa utilizzando, con incredibile grazia, proprio gli strumenti del cinema-verité. Innocenti e gli altri è, insomma, una storia che mette in scena se stessa, come in quei mockumentary in cui la distinzione tra la realtà e la finzione diventa sempre più labile, o forse è solo del tutto insignificante.
Quando, filmando la sua intervista a Sarah Mills per il documentario a cui sta lavorando, Meadow si premura di restare visibile entro i margini dell’inquadratura, non lo fa solo perché, da diligente studentessa di cinema, sa che “lo spettatore subisce quello che si chiama pregiudizio da posizionamento della camera quando nei filmati degli interrogatori si vedono solo gli indagati. Vengono percepiti come colpevoli, se invece si vede anche colui che interroga, mentre pone le domande, il pregiudizio scompare.”, ma proprio per il motivo opposto. Se la responsabilità di Sarah Mills non è del tutto chiara, il suo compito, da regista, è far saltare ogni certezza: instillare il dubbio che Sarah sia solo una ragazza disturbata, che si è assunta la colpa per la morte della figlia, perché la narrativa del delitto glielo aveva prescritto. Prenditi la colpa, sconta i tuoi peccati, qualsiasi essi siano:
La gente ti dice di tutto. Voglio confessare, disse Meadow a voce alta e rimase scioccata da come suonava la sua voce nell’abitacolo. Rise. Forse per tutte le confessioni che aveva visto alla tv e al cinema.
Nei giorni in cui finivo di leggere Innocenti e gli altri, usciva, sul New Yorker, una lunga ricostruzione di un singolare caso di cronaca giudiziaria: in una cittadina del Nebraska, sei persone si erano dichiarate colpevoli dell’assassinio di una donna, avvenuto nel 1989. Una dopo l’altra, come in un’epidemia della confessione, avevano sfilato di fronte alla polizia, per consegnarsi alla giustizia: ognuno aveva fornito dettagli di quella notte, certo di essere stato complice. Ad anni di distanza, la prova del DNA li aveva scaglionati: nonostante l’ostinazione di certe confessioni, il colpevole non era tra di loro. Cos’è che ricordavano, allora?
“Nessuno di noi era innocente, eravamo tutte persone distrutte, eravamo tutti a pezzi per qualche motivo”, ha commentato uno dei sei imputati, dopo l’assoluzione. La memoria tradisce le nostre intenzioni, ci mente continuamente: di tutte le metafore che vengono usate per descriverla, la più accurata è quella di una pellicola piena di salti e di tagli. Le storie che ci raccontiamo sono, appunto, storie: somme di dettagli che forse non sono mai esistiti.
Mentre leggevo la storia dei sei del Nebraska, è apparso un pop up a interrompere la mia lettura: mi chiedeva di sostenere il New Yorker, impegnato a combattere le storie false con quelle vere. Questa è la differenza tra questa storia e il romanzo di Spiotta: a Meadow non importa affatto di arrivare al nucleo luminoso della verità; quando Sarah Mills conferma la versione dei fatti che l’ha portata in prigione, la regista torna a casa e distrugge la pellicola – la storia di una ragazza fragile, spinta dalle autorità a confessare un crimine che non aveva mai commesso, si era trasformata nella patetica tragedia di un incidente domestico. Al cinema e alla letteratura non interessa che le storie siano veritiere, quanto che siano verosimili: immagini dentro le quali possiamo riscrivere la nostre vite, il commento di una regista che dice “non mi interessano le vittime, ma i carnefici”.
Meadow diventa una regista proprio nell’estate in cui non gira nessun film, ma in cui racconta di essersi chiusa, invece, nella villa di un regista in declino, a Brentwood: qui, tra il divano e il letto di quell’uomo che assomiglia terribilmente a Orson Welles, passa il tempo a vedere film e leggere sceneggiature di altri. Un anno dopo dice:
sono una giovane donna affamata, come migliaia di altre giovani donne. Ma ho delle idee. Un linea di condotta, per così dire. Lavorare, lavorare. Dicevo che questa è una storia d’amore, e in effetti comincia come una storia d’amore: il mio amore per il cinema, puro come nessun altro amore che abbia mai conosciuto. Fare, guardare, pensare cinema.
Dice: voglio diventare “una macchina da cinema, un creatore monoculare”, ma lo è già. Che la sua relazione con Orson Welles sia vera o sia solo una genealogia mitologica delle sue influenze artistiche non cambia molto; è una storia abbastanza bella per poterci credere. Che Meadow abbia passato quei mesi a Brentwood o in un motel dell’Arizona, sopravvivendo grazie ai soldi di papà, non importa a nessuno: quello che conta è ciò che ne ha fatto di quell’estate, la sceneggiatura che ha scritto della sua vita, la capacità di impersonarla, di dirigere il suo personaggio con sufficiente padronanza. Quando anni dopo una studentessa di cinema la avvicina per complimentarsi per quella fan-fiction (l’aveva chiamata così, fan-fiction) su Welles, Meadow si mette a ridere: anche quella ragazza era stata in grado di riconoscere un buon soggetto, una volta che se lo era trovato davanti.
Nabokov affermava che “la letteratura non è nata il giorno in cui un ragazzo, gridando al lupo al lupo, uscì di corsa dalla valle di Neanderthal con un gran lupo grigio alle calcagna: è nata il giorno in cui un ragazzo arrivò gridando al lupo al lupo, e non c’erano lupi dietro di lui” e ci sono pochi autori che hanno appreso questa lezione bene come Spiotta. Innocenti e gli altri riprende il discorso iniziato in Versioni di me, continuandolo: in quel romanzo, Denise commentava le Cronache di suo fratello Nik, la biografia immaginaria composta in decenni di isolamento, dicendo che
alla fine la sua vita nelle Cronache non è stata troppo diversa dalla vita vera. Per certi versi è stata peggiore, per altri esattamente uguale. Non una vita di fantasia perfetta, per niente, solo una vita diversa, magari fatta più ad arte.
Così Innocenti e gli altri si muove sugli stessi fili e racconta il desiderio di riscrivere la propria esistenza: i racconti di Welles, di Sarah Mills o di Jelly e Jack, che si intrecciano a quella di Meadow, sono storie sulla seduzione della parola, di come il sesso, il piacere e la bellezza siano legati alla possibilità di essere descritti. E Spiotta fa un passo in più, chiedendosi quali siano i limiti della narrazione, dell’inganno – quanto bella deve essere la verità, perché io mi decida a credervi?