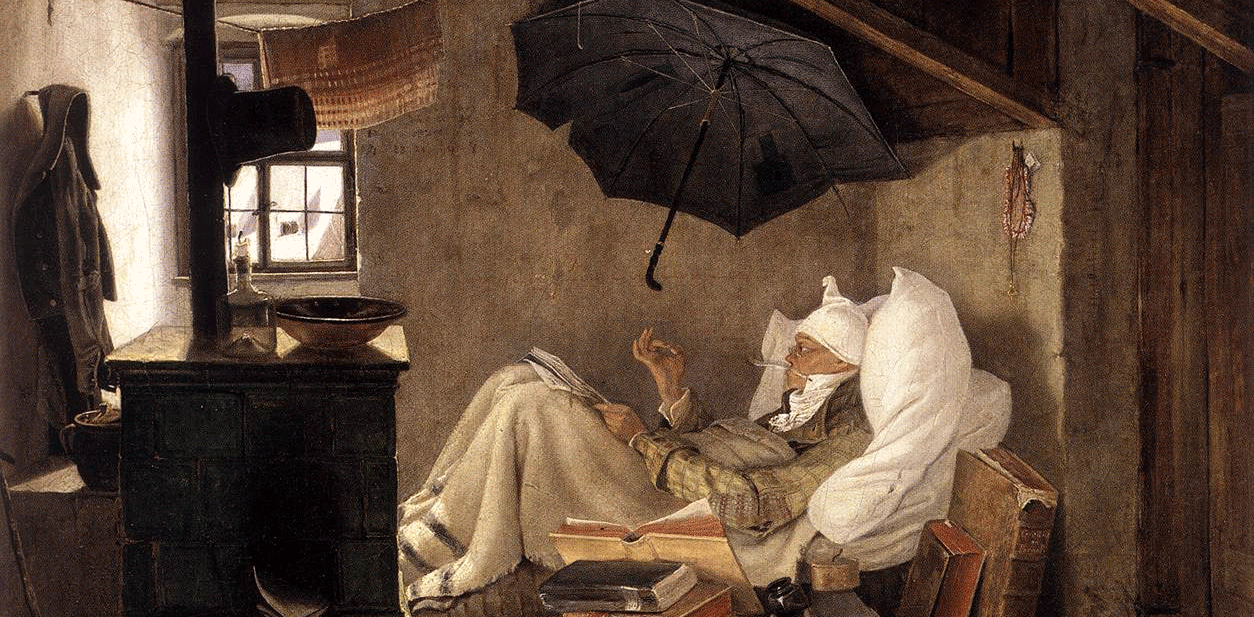T
eoria della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura è uscito di recente nella sua seconda edizione per Minimum Fax. Nel saggio, l’autore utilizza lo strumentario della filosofia, delle scienze politiche, delle dottrine economiche e della cultura pop per analizzare lo statuto economico, sociale ed esistenziale di quell’ “esercito di venti-trenta-quarantenni, decisi a rimandare l’età adulta collezionando titoli di studio e lavori temporanei in attesa che le promesse vengano finalmente mantenute, vittime di una strana «disforia di classe» che li porta a vivere al di sopra dei loro mezzi, a dilapidare i patrimoni familiari per ostentare uno stile di vita che testimoni, almeno in apparenza, la loro appartenenza alla borghesia”.
Auto-pubblicato in rete nel 2015 e ora approdato all’edizione cartacea, Teoria della classe disagiata presenta alcuni punti in comune con Class di Francesco Pacifico (Mondadori 2014, uscito in America nel 2017 con Melville House, anch’esso in una nuova versione), un romanzo che racconta gli stessi contesti e le stesse ansie attraverso le storie di emigrati italiani a New York alla ricerca di lavori creativi. Da questi punti di contatto nasce il confronto tra Raffaele Alberto Ventura e Francesco Pacifico, redattore de Il Tascabile.
Raffaele Alberto Ventura: La classe disagiata è il nome che ho dato alla classe agiata — cioè la borghesia piccola, media o grande, una popolazione che sembrava destinata a trovare posto nel terziario più o meno avanzato — nel momento in cui si accorge di non avere più le risorse sufficienti a garantire il suo stile di vita. Qualcuno potrà trovare curioso che io definisca addirittura “agiato” il ceto medio, ma per me è fondamentale partire da questo dato: per quanto esistenzialmente disagiati noi ci troviamo alla fine di una certa catena internazionale del valore, ne siamo beneficiari. Peggio, ne dipendiamo. Insomma consumiamo un’enorme quantità di ricchezza ma nemmeno ce ne accorgiamo, e infatti non riusciamo nemmeno a godercela. Mi pare che sia un tema che perseguita anche te. Il tuo romanzo Class inizia con una frase che ho messo in esergo al primo capitolo del mio libro. Eccolo qua: “La realizzazione personale di un borghese non vale il denaro che costa”. E qui dici due cose fondamentali. La prima è che la realizzazione costa, anche se spesso questi costi non li vediamo: è quello di cui parlava Marx con l’idea dell’occultamento dei rapporti di produzione, con il suo concetto d’ideologia. E non vale solo per la borghesia relativamente agiata di cui parli nel libro, ma per tutta la classe media che non si accorge di quanto disperatamente dipende da quella dimensione economica che spesso disprezza. La seconda cosa importante sta in quel “non vale”, che lascia intendere un fallimento, ed è questo fallimento esistenziale che racconti nel tuo romanzo. Ma in che senso secondo te questa realizzazione non vale il denaro che costa? E toglimi una curiosità: a te quanto è costata?
Francesco Pacifico: Negli ultimi anni non ho fatto altro che parlare di soldi nelle interviste e nei miei pezzi di giornalismo culturale. E Class l’ho scritto per parlare di soldi. È la narratrice marxista a dire che la realizzazione personale non vale il denaro che costa. In altre versioni era “il petrolio”, in altre ancora “la carbon footprint”. È la narratrice marxista a denunciare l’inutilità, la velleità, la frana. Io devo raccontare delle immagini che ho nel fondo della mente e una narratrice marxista morta mi è sembrata la cosa da fare per parlare sub specie aeterni del problema del denaro nostro e dei nostri genitori. Parlare dello status e dei simboli di status dal punto di vista della morte.
Ora ho letto il tuo libro e l’ho trovato perfetto per questo momento storico e mi sono sentito rappresentato. Ho studiato scienze politiche e perciò ho sempre cercato di descrivere rapporti di potere, di classe nei miei libri. Sono abituato così, e mi disturba che in letteratura si cerchi solo l’empatia, oggi, e si consideri il personaggio più un Mensch che un membro di una classe sociale, con vizi tic e interessi. Il tuo libro mi rappresenta. Al tempo stesso, non vorrei che tu pensassi che un romanzo e un saggio siano sullo stesso piano solo perché parlano della/alla stessa generazione.
RAV: Nel tuo romanzo inquadri il problema in maniera simile a come ho fatto io, con una specie di ossessione economica che ti porta a osservare ogni dettaglio in maniera spietata, ma mi è parso subito evidente che la classe che racconti tu è una borghesia davvero più agiata di quanto possa esserlo io, che non faccio il filmmaker a New York coi soldi di famiglia. Ma grazie ai soldi di famiglia ho comunque potuto studiare, come almeno un terzo dei miei coetanei italiani, e poi scegliere di partire a cercare un lavoro all’estero. A quel punto ho dovuto scegliere tra le mie aspirazioni e la ragione economica, ho dovuto tagliare il nodo di Gordio e forse è stato questo che mi ha salvato — contrariamente ai tuoi personaggi, che forse in effetti assomigliano a te più di quanto assomigliano a me. Perché tu hai scelto le tue aspirazioni e sei diventato scrittore. Pure portandoti dietro una consapevolezza piuttosto rara della tua condizione economica.
FP: Ho una casa di proprietà che ovviamente non ho comprato io. Nessuno mi aprirebbe un mutuo. Eppure ho quei beni di cui parli tu, ho lo status, ho la distinzione. La nostra conversazione è affacciata su un baratro e su un baretto: al baretto confrontiamo gli status symbol che abbiamo addosso; sul baratro invece ci chiediamo come mai tutto, compresa questa chiacchierata, è chic, è parte della ricerca della distinzione personale, della realizzazione personale, mentre ancora viviamo nel sogno dickiano, gnostico che è il paradigma della vita al tempo dei nostri genitori: impégnati, fatti dare un mutuo, porta avanti questo mondo stupendo. Noi non possiamo farlo, e ci sembra colpa nostra. Al narratore del mio libro sembra colpa nostra: ma come fa a essere colpa nostra?
Il tuo saggio spiega che non è colpa nostra. Tu hai messo in fila tutte quelle riflessioni di storia ed economia per cui non può essere colpa nostra. Eppure, in entrambi i libri si respira un che di accusatorio, come se non potessimo fare a meno di fingere di criticare la nostra generazione.
Le recensioni di Class in Italia dicevano tutte: visto questi bambocci quanto fanno schifo?
Siamo tutti vittime della storia e ci accusiamo a vicenda come se il fatto che ci piaccia l’ultimo disco di Calcutta fosse il motivo per cui non possiamo aprire un mutuo.
Come mai hai pensato di scrivere e autopubblicare un saggio del genere? Volevi regalare uno status symbol o uno strumento?
RAV: Sicuramente uno status symbol: non c’è niente di più elegante per un borghese declassato che sventolare questa consapevolezza come fosse un orologio d’oro. Nel 2018 Teoria della classe disagiata andrà tantissimo, altro che Calcutta.
Scherzo. In realtà nella mia riflessione le due letture sono possibili: spesso vengo accusato di colpevolizzare la classe disagiata (fingendo di difenderla) e altre volte di difenderla (fingendo di colpevolizzarla). Ma non direi che fingo di colpevolizzarla, semmai nell’arco di scrittura nel libro — cioè vari anni — sono passato da un’autocritica feroce, che doveva spingermi ad accettare la realtà, a un’indulgenza che mi aiutasse ad accettare le mie aspirazioni. Il risultato è un faticoso tentativo di sintesi tra queste due posture. Il che è molto rappresentativo, lo ammetterai, della nostra condizione. Conosciamo le nostre debolezze e le combattiamo. E nello stesso tempo sappiamo da dove vengono, sono la tremenda eredità che ci è stata lasciata — siamo proprio come i personaggi dei romanzi di Zola che subiscono il destino iscritto nei loro geni. A un certo punto però mi sono accorto che questa sintesi tra giustificazione e colpevolizzazione era semplicemente impossibile. In fondo si tratta di uno dei problemi filosofici più antichi del mondo, ovvero la contraddizione tra determinismo e libertà. Può sembrare astratto ma alla fine è qui che si va a parare. In che misura possiamo dirci colpevoli di qualcosa che non potevamo non fare? E nel nostro caso specifico: di qualcuno che non potevamo non essere? Eppure i tribunali continuano a processare e condannare le persone anche se i loro crimini sono soltanto conseguenze di conseguenze di altre conseguenze.
E infatti, per rispondere alla tua domanda, questo libro è come un processo alla classe disagiata. L’ho iniziato con un atto di accusa, ho invitato a comparire tutte le nostre aspirazioni e i nostri privilegi, la sentenza era già scritta. E poi invece cos’è successo? Colpo di scena: la difesa si è mostrata molto più agguerrita del previsto, e risalendo la catena delle cause è riuscita a portare a casa perlomeno un pareggio. Un’assoluzione per eccesso di prove. Ma un risultato spero di comunque di averlo portato a casa, ovvero quello di spiegare che in fin dei conti il problema non è di sapere di chi sia la colpa di questo pasticcio ma capire quali alternative ci restano. Ne restano poche.
Il che in fondo mi pare un problema molto letterario, perché un buon personaggio deve essere in qualche modo prodotto dal suo ambiente ma non può ridursi a una semplice figurina meccanica su cui vanno a incidersi le determinazioni socio-economiche. In questo senso mi chiedo, e lo chiedo a te che inventi personaggi, se in fondo noi della classe disagiata siamo dei buoni personaggi. Non ti pare tutto così prevedibile? I nostri consumi, le nostre aspirazioni, le nostre tragedie, le nostre sfuriate e i nostri pianti? Possibile che non riusciamo ad allontanarci da questo canovaccio?
FP: La mia esperienza con Class è stata sorprendente da questo punto di vista. In Italia ha sortito due reazioni: nelle persone cui si ispirava, millennial e generazione X affini ai miei personaggi in cerca di semi-lavori aspirazionali, ha suscitato paura e identificazione. La seconda reazione è quella dei recensori che si sentivano al riparo dal problema generazionale: ecco raccontati i bambocci! L’idea era un po’ quella. Nessuna pietà da chi non si identificava, paura per chi si identificava. Negli Stati Uniti invece il tema delle velleità e della fine del lavoro è stato inserito, da chi l’ha recensito, nel contesto più generale dei temi del libro: il purgatorio, il marxismo, il consumismo, più semplicemente la moda, e anche New York come personaggio. Insomma l’hanno preso seriamente. Un mio amico filosofo mi ha detto che secondo lui gli americani prendono sul serio le cose perché sono il centro dell’impero e vagliano le questioni. Noi forse ci sentiamo così periferici che tutto ci sembra futile. E alla fine riduciamo ogni cosa al problema di costume e società: perciò forse a te sembra prevedibile, il solito canovaccio.
RAV: Qui tocchi qualcosa di profondamente vero, che ho sempre pensato quando vedo i film americani. Anche nelle baracconate di supereroi, loro riescono ad affrontare temi importanti. Mentre noi riusciamo a essere futili anche nei film d’essai.
FP: Io credo nel romanzo, è la legge della mia vita, quindi ho sofferto quando Class è stato preso come semplice sberleffo alla classe disagiata. Noi siamo un ex impero e non riusciamo più a prendere sul serio niente. Il che è completamente interno alla logica della nostra generazione. Mi esalto se conosco un amico stilista che ha cenato con Kanye West, ma non penso che la mia generazione produca storie interessanti. E qui aggiungerei una cosa: noi abbiamo creduto troppo alla stupidaggine insegnataci dai nostri genitori, al fatto che le sole vere storie sono quelle di chi si è fatto da solo. Chi si è fatto da solo in Italia in quella generazione si è fatto da solo perché ci sono stati il piano Marshall e il welfare state. A noi è arrivata questa idea di farci da soli ma con quella ricchezza di famiglia che fa sentire molto più in colpa del denaro pubblico. Ora, io sono quindici anni che mi ammazzo di lavoro sottopagato, e anche se ho una “carriera” so benissimo che è il sistema a permettermi di “fare carriera”. A noi ci hanno solo detto: naviga pure nelle acque tiepide e protette, e se ti impegni comprerai anche la casa al mare. Come mai noi crediamo a quella legge morale di un’altra epoca? Se è una contingenza storica, ormai superata, dovremmo smettere di sentirci in colpa.
Che è un po’ il posto in cui mi hai riportato con il tuo saggio: tu a volte usi la cultura in un modo molto politico, per regalare ai tuoi simili uno strumento per non farsi massacrare dal ditino alzato di qualcun altro. Alla fine del libro tu mi avrai dato Veblen e Balzac e Jane Austen e io mi sarò collocato meglio nella storia, forse mi sentirò meno afflitto.
La mia scrittura muove tutta dalle tue fonti letterarie: il romanzo dell’Ottocento, fino alla coda modernista di Proust. L’uomo come prodotto della sua classe, il romanzo come comico resoconto, foglio Excel degli alti e bassi di chi scende o sale nella società. Forse la seconda guerra mondiale ha distrutto il romanzo europeo, facendo scordare completamente che eravamo un prodotto della storia e non semplici vettori a sé. Non credo molto nell’idea debenedettiana del “personaggio uomo”. Il personaggio uomo, cioè colui che è protagonista per la sua anima e non per il suo contesto, secondo me è una invenzione critica molto problematica. Bisogna essere meno spirituali quando si giudica la società.
RAV: Se capisco bene tu manifesti l’esigenza, che io condivido, di liquidare il modernismo (perlomeno in letteratura) per via della sua incapacità di parlarci della realtà che ci circonda, dei nostri problemi veri. Ora che la storia ha fatto il suo giro largo possiamo finalmente alzarci ed esclamare, un po’ come Fantozzi con la sua famosa corazzata, che certi esperimenti artistici avevano senso soltanto per una certa élite intellettuale molto protetta. E quindi ora torniamo a Dickens: abbiamo Franzen, Eugenides, Chabon, eccetera, autori che sono riusciti a parlare, in vario modo, della “classe disagiata” perché chiaramente si pongono molte più domande sul mondo di quante se ne pongano sull’arte.
FP: Vorrei chiederti una cosa: cosa significa per te René Girard: il desiderio mimetico, il triangolo del desiderio dove desideri solo ciò che desidera il tuo modello, e quindi il frastuono di feedback prodotto da tutti i desideri che si accavallano… È stata una teoria importantissima nel mio sviluppo di scrittore antiromantico. Ho in parte superato quella dimensione, forse grazie alla psicanalisi freudiana, ma come congegno narrativo mi è sempre parso impareggiabile, e Menzogna romantica e verità romanzesca è per me un grande manuale di scrittura attraverso Stendhal e Don Quixote. Ora: che ruolo ha Girard nel tuo pensiero?
RAV: Girard è riuscito, direi con la sola forza della sua scrittura, a convincere se stesso e il mondo di avere fatto una scoperta rivoluzionaria: ma a furia di letture, che sono poi quelle che convergono nella Teoria della Classe Disagiata, mi sono convinto che è stato soprattutto in grado di mettere ordine tra idee e concetti che si respiravano nell’aria tra gli anni Cinquanta e Settanta, in pieno boom. Penso in particolare alla teoria dei giochi, alle riflessioni sulla Mutual Assured Destruction e alla popolarizzazione di Veblen ad opera di Vance Packard. Girard inizia un lavoro genealogico che lo porta a scoprire queste dinamiche prima nella storia della letteratura, col suo primo libro del 1961, poi nei miti antichi e nel cristianesimo, finendo per produrre una convincente teoria generale. Nel momento in cui giunge a questa sintesi, con La violenza e il sacro nel 1972, si trova di fronte un’opera che io considero il suo opposto speculare ovvero L’anti-Edipo di Deleuze e Guattari. Da una parte hai una decostruzione radicale del desiderio, delle sue cause mimetiche e delle sue conseguenze sociali, e dall’altra un inno alla liberazione del desiderio. Non parlo necessariamente di sesso, per intenderci, anzi. Da una parte quindi (Girard) si rivendica il ruolo delle strutture culturali che regolano il potenziale distruttivo del desiderio, dall’altra (Deleuze) la volontà di abbattere queste strutture per sognare un uomo nuovo. Nel mio libro riprendo indirettamente questo dibattito. Ma poiché è passato quasi mezzo secolo è cambiato il contesto e sono cambiate le premesse, e per noi tutto è molto meno astratto: il mio punto di vista incarna quello di una generazione che soffre proprio a causa dei desideri con cui è stata programmata. Insomma, credo che tu abbia capito da che parte sto tra Deleuze e Girard… E tu? Come convivi con il desiderio? Lo so che ora magari suono come un teologo alessandrino del terzo secolo, che poi a me piace un sacco, ma facci caso: forse questo tipo di speculazioni riemergono nei tempi di crisi (all’epoca la dissoluzione dell’impero romano, oggi la dissoluzione dell’impero americano) come dispositivo culturale più adatto per fronteggiare una crisi… Come una posa più aerodinamica per svernare nella lunga notte che ci attende.
FP: La mia risposta è questa: ho convissuto col desiderio come ho convissuto con il bisogno di scrivere: vagliando i classici. Ho una sensibilità da laboratorio, da bottega, che è forse un modo per sfuggire al caos della storia. La mia vita è stata un laboratorio in cui ho provato sul mio corpo e la mia mente diverse grandi vene dell’occidente: il cattolicesimo, la psicanalisi, il rock, lo yoga all’occidentale, la filosofia politica… Non credo di averle consumate. Le ho provate sulla mia pelle e sono tutte rimaste con me. Sia come seguace che come lettore sono sempre stato appassionato di classici, e la loro rilettura o riscoperta continua occupa quasi per intero il mio rapporto con quel che desidero e con quel che faccio. Rimandare sempre ai classici se vuoi è un modo di non liberare troppo il desiderio, di non rifondare l’uomo. Non avrei mai pensato di chiederti del tuo desiderio, però dopo aver risposto alla tua domanda trovandola naturale la rivolgo io a te. Non vorrei che sembrasse un nuovo inizio del riflusso, ma mi viene da chiederti come vivi le giornate avendo scritto un libro così esplicito sull’illusione di appartenere a un sistema che funziona, che ci premia, ci mette i voti come a scuola. L’altra sera uno scrittore che stimo, su un palco in una piazza, con il microfono in mano rispondeva a un mio stimolo su questi temi dicendo che gli sembra assurdo dire che noi intellettuali siamo élite. Io gli ho detto che per rispetto del pubblico quando parlo da una pedana con un microfono o da un giornale devo considerarla una cosa da élite; lui aveva delle obiezioni economiche e di numeri effettivi, di attenzione… allora io gli ho chiesto: “Scusa, stiamo parlando del fatto che non avremo la pensione?” Eravamo disorientati, l’argomento ci svaniva tra le mani. Esisti, hai un pulpito, e insieme non esisti, non avrai la pensione. Il terzo interlocutore sul palco, un ex giornalista in pensione, ha cambiato argomento senza fare una piega. Una scena che pare uscita dal tuo libro.
RAV: Guarda, io non darei troppa importanza alle pedane perché credo che abbiamo fin troppe pedane, una sovrapproduzione di pedane, anzi se dovessi investire in qualcosa investirei in questo: pedane. Voglio dire che queste cose oggi contano meno di quanto contassero un tempo, per via di quella faccenda dei quindici minuti di celebrità. Abbiamo moltiplicato i segni del successo — i diplomi, i premi, il numero di editori e di libri, le riviste — ma non abbiamo ridistribuito il successo in quanto tale, né peraltro le risorse economiche associate, perché questa è una cosa che non si può fare per via di quelli che l’economista americano Fred Hirsch chiamava i “limiti sociali dello sviluppo”. Ne parlo nel libro. La cosa un po’ patetica è che io dicevo già queste cose quando davvero non mi ascoltava nessuno, e allora poteva sembrare invidia; mentre ora le dico avendo pubblicato un libro e scrivendo sulle riviste, con gente che si felicita con me perché sono arrivato un po’ più lontano di quanto siano arrivati loro, ed è molto peggio perché suono blasé, disilluso, eternamente insoddisfatto e dunque irriconoscente, forse pure abbastanza poser. Eppure io ho fortemente desiderato che questo libro venisse pubblicato, e ora mi ritrovo a non sapere più cosa desiderare perché faccio i conti con il vuoto che stava dietro a questo desiderio: quello che mi sembrava un lauto bottino di capitale simbolico ora mi appare come un insignificante mucchio di spiccioli.