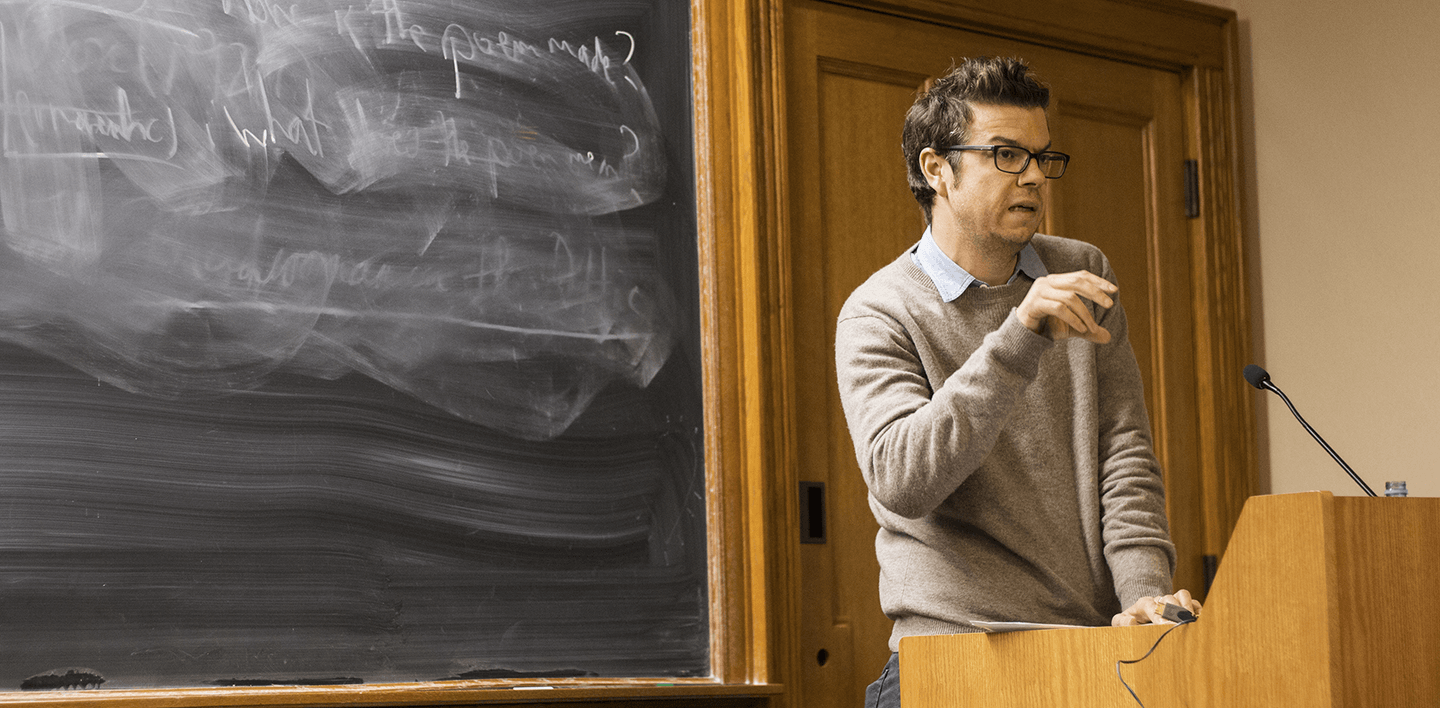
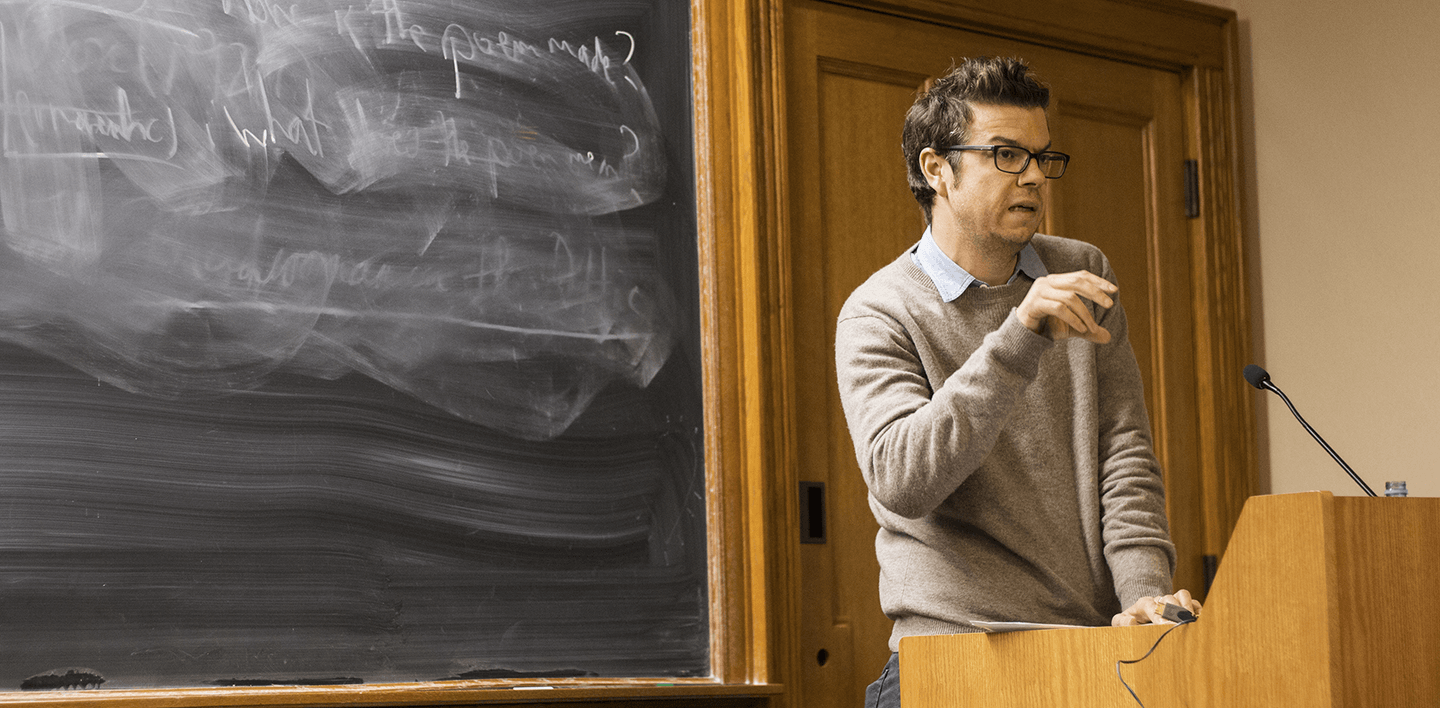
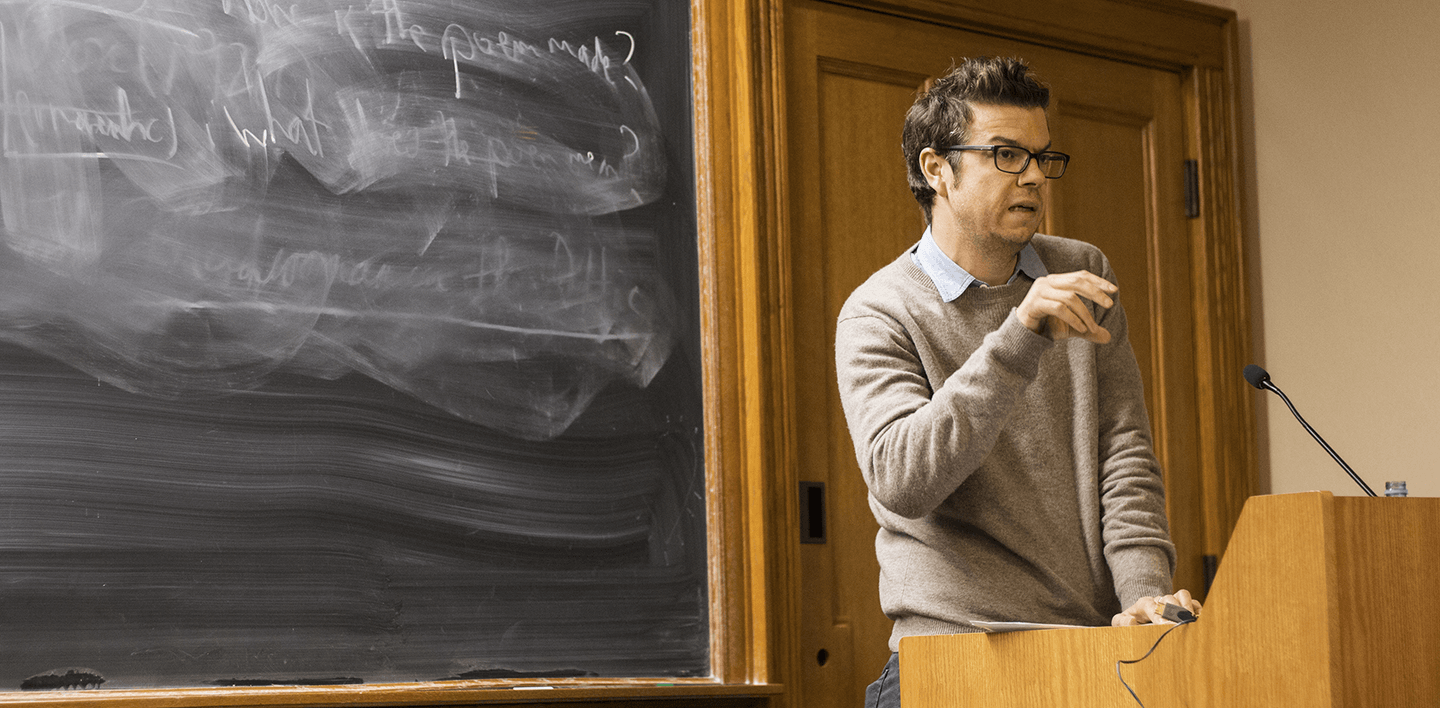
B en Lerner è un autore della mia generazione. Siamo cresciuti invidiando i romanzi riusciti e famosi di una scuola di scrittori – “quelli di McSweeney’s”, “i burned children” – che è riuscita, attraverso opere come Tempesta di ghiaccio (Moody), Infinite Jest (Wallace), Le correzioni (Franzen), La fortezza della solitudine (Lethem) a salvare l’idea di grande romanzo americano smontandolo e poi rimontandolo. Eppure, man mano che passava la sbornia per quelle opere esaltanti, divertenti, forti, cominciavamo a dirci che in fin dei conti gli statunitensi non avevano la classe di Bolaño o il senso della poesia, del ragionamento e della biografia di autori italiani come Siti, Albinati, Trevi.
Quella generazione di americani si era concessa piaceri letterari solamente con progetti deliberatamente non grandiosi come le raccolte di Lydia Davis, autrice di racconti filosofici minuscoli e sofisticati, veri ma anche cerebrali; Davis è donna, e traduttrice di Flaubert e Proust: poteva disinteressarsi al sogno troppo virile del grande romanzo per dedicarsi a una letteratura più ondivaga, toccante, “poetica”. Ben Lerner si è imposto in Italia due anni fa con il suo secondo libro narrativo: Nel mondo a venire, opera di autofiction alla europea. Cristiano De Majo ne parlava così su Repubblica: “Della sbornia iperrealista, grottesca e satirica, del romanzo americano anni Novanta non c’è traccia. I numi tutelari non sono più i padri del postmoderno, ma scrittori europei come Sebald e Benjamin, poeti come Ashbery, o lyric essayist molto poco conosciuti in Italia come Anne Carson”.
Quando ci si cominciava a interessare a lui (ricevetti una copia di Leaving Atocha Station, il primo libro in prosa, dalla nostra comune agente, che compare nella prima scena di Nel mondo a venire, quella con i polipi decadenti serviti nel ristorante costoso e pagati con i soldi dell’anticipo), la cosa che si premetteva sempre è che Lerner era un poeta che aveva scritto un libro in prosa per un piccolo editore: un successo inatteso, insperato. Il successo venne rilanciato, come dicevo, da Nel mondo a venire, che divenne il simbolo di un cambiamento; Lerner era il Gavrilo Princip il cui gesto metteva fine all’era del grande romanzo americano. Il suo successo serviva alla letteratura americana per voltare pagina dopo essersi accorta, grazie ad alcuni exploit in traduzione come Knausgård, Ferrante, Houellebecq e appunto Bolaño, che esistevano altre strade, più “poetiche” rispetto a quella della programmatica ricerca del successo.
Nel mondo a venire era un libro che non aveva l’aria di voler essere epocale, né particolarmente grande o se è per questo americano, e non si poteva dire che fosse un romanzo né che non lo fosse. Incarnava il desiderio dei lettori sofisticati americani di vivere la letteratura in un altro modo. Queste poesie, che escono oggi con la garanzia della traduzione di Moira Egan e Damiano Abeni, amati traghettatori di poesia americana nella lingua italiana, hanno un ruolo importante: comparse in italiano alla fine del percorso con cui Lerner si è affermato in Italia, servono a chiarire il senso della sua scrittura. Il poeta prestato alla prosa. È il momento di vedere cos’erano queste sue poesie degli anni zero.
Le figure di Lichtenberg (Edizioni Tlon) esce a poca distanza dal saggio Odiare la poesia, scritto invece negli ultimi tempi. È interessante leggere i due libri insieme, sono uno il compagno dell’altro e ci aiutano a capire come mai per la letteratura americana è stata tanto importante la figura del poeta venuto a salvare la prosa.
Fin da piccoli ci hanno insegnato che siamo tutti poeti in virtù del semplice fatto di essere umani. La nostra capacità di scrivere poesie è quindi, in un certo senso, la misura della nostra umanità.
Estratta dal suo contesto questa frase perde l’umorismo sornione del ragionamento di Lerner sul ruolo del poeta, ma serve per dire che Odiare la poesia riflette sul rapporto complicato e felice dell’autore con la fonte della sua creatività. Il punto di partenza è che il poeta è come la persona ideale, il Mensch. Anche se non è vero caso per caso, tutti guardiamo ancora alla poesia come alla fonte dell’umanità. Per questo forse ci risulta importante il mito di un poeta che salva la prosa dagli eccessi virili da grande romanzo. La prosa di Lerner nasce da un’irrequieta poesia:
Tutti i lettori di poesia mi danno il voltastomaco. Voi, con il vostro dottorato sovietico / e il fermacravatte afghano. Voi con il pene incastrato in una bottiglia. E certo, io mi do il voltastomaco / con i miei esempi ovvi e interminabili / sulla profonda mediocrità culturale della borghesia americana.
L’ho ricopiata con le barre invece di lasciare una riga per verso per omaggiare un’idea molto bella che Lerner esprime in Odiare la poesia: la poesia migliore è quella vista da dentro la prosa.
Tendevo ad apprezzare la bellezza dei versi solo quando li trovavo citati in brani di prosa, nei saggi che i professori mi assegnavano in lettura al college, in cui le barre sostituivano gli a capo, così che ad arrivarmi non era tanto quella particolare poesia quanto l’eco di una possibilità poetica.
Quest’eco rimane nella sua prosa e le dà forza. La forza che Lerner ricava dalla poesia nasce soprattutto da una riottosità verso la singola poesia. La vera poesia non fa che alludere alla poesia. La singola poesia è un veicolo imperfetto di aneliti.
La prima volta che ho scoperto il congiuntivo, non aveva un quattrino ed era nudo come un bruco. / Adesso pretende la metà. Vuole il suo mazzo di chiavi / e pallottole progettate in modo da espandersi all’impatto.
Non cerca la bella poesia. Certamente Lerner cerca l’effetto, perché qui è un giovane poeta, ma cerca soprattutto di non far sentire a suo agio il lettore. Lo riempie di ragionamenti e di sfoghi sulla poesia:
Il pensabile passa singhiozzando di porta in porta / in cerca di predicati accessibili a piedi. / Ma il senso è molto più basso visto di persona / e si ritira da camera ad anticamera a testo.
Oppure:
“Avrei voluto scusarmi in anticipo. / Avrei voluto gettare a mare tutto il dogmatismo della teoria e tutta la sclerosi dell’organizzazione”.
E un impaziente,
La poesia deve ancora emergere. / L’immagine non la può supplire. L’immagine è un aneddoto / sulla bocca di un nato morto. E non la riflessione, / con la sua cattiva infinitudine, né la religione, con i suoi tre grammi di psilocybe, / possono portare l’orgasmo all’orgasmo come la poesia. Di norma / siamo generalmente dispiaciuti. Ma essere dispiaciuti non basta. / Dobbiamo chiedervi di levarvi le scarpe, le lenti, i denti. / Dobbiamo chiedervi di singhiozzare senza remore. / Se vi può in qualche modo consolare, noi ammiriamo i primi libri di John Ashbery. / Se vi può in qualche modo consolare, non sentirete niente.
In Odiare la poesia si analizza l’impossibilità di fare poesia con la poesia. La poesia si può magari difendere («sono arrivato a convincermi che l’attrattiva dell’apologia, come genere, consiste in gran parte nel fatto che è essa stessa una sorta di poesia virtuale: consente di descrivere le virtù della poesia senza dover scrivere poesie destinate a soccombere alla crudeltà del reale»), ma non si può scrivere. Perfino Keats non può che limitarsi ad alludere al canto della poesia.
perfino nelle sue odi più melodiose Keats descrive una musica ideale che le poesie in sé non possono rendere udibile. Dall’Ode su un’urna greca: “Sì, le melodie ascoltate son dolci; ma più dolci / Ancora son quelle inascoltate. Su, flauti lievi, / Continuate, ma non per l’udito; preziosamente / Suonate per lo spirito arie senza suono”. […] Al cuore della poesia di Keats ci sono quelle che Clune chiama “immagini di una musica virtuale”: una musica che Keats è in grado di descrivere ma non di suonare (e che nessuno è in grado di suonare nella dimensione del tempo: non è difficile, è impossibile). La forma letteraria non può produrre la musica superiore che Keats immagina, può solo raffigurarla […] L’incredibile maestria di Keats, il modo in cui intesse le vocali, ci fanno venire la tentazione di credere che la musica impossibile sia quasi a portata di mano…
È stato questo senso di impossibilità a portare Lerner a scrivere poesia attraverso la prosa? Solo nella prosa si poteva davvero alludere alla poesia. I versi raccolti in questo volume sono quindi i complici di un gioco tra prosa, poesia e saggio che fa intravedere la vera poesia solo nell’orizzonte comune di queste tre attività, e non nelle poesie stesse. Nel suo Il borghese. Tra storia e letteratura, Franco Moretti fa con Lukács un gioco che io vorrei fare con Lerner. Moretti parte citando il seguente brano da Teoria del romanzo in cui si raccontano le possibilità della compatta, aritmica prosa rispetto alla poesia:
Solo alla prosa è dato abbracciare, con pari vigore, il lauro e il dolore, la lotta e l’incoronazione, il cammino e la consacrazione; solo la sciolta flessibilità e la compattezza aritmica della prosa riesce a stringere insieme, con pari forza, le catene e la libertà, la pesantezza ereditata e la conquistata levità di un mondo, il cui senso ritrovato s’irraggia adesso nell’immanenza.
A questo punto, Moretti prova a spiegare dove va a parare Lukács. Siccome il mondo del romanzo è “infinitamente grande […] e ricco di doni e di pericoli”, “il romanzo”, scrive Moretti, “ha bisogno di un mezzo che sia allo stesso tempo ‘aritmico’ (per adeguarsi all’eterogeneità del mondo), eppure avere una ‘compattezza’ sufficiente a conferire a quella eterogeneità qualche forma. E quel mezzo, per Lukács, è la prosa”. Ma per raccontare a cosa serve la prosa, nota Moretti, Lukács ha usato una prosa niente affatto prosaica. La Teoria del romanzo ha, come sottotitolo, “Un saggio”: e per il giovane Lukács il saggio era la forma che non aveva ancora perso la sua “indifferenziata unità di scienza, morale e arte”. E arte. E dunque voglio citare il brano una seconda volta:
Solo alla prosa è dato abbracciare,
con pari vigore,
il lauro e il dolore,
la lotta e l’incoronazione,
il cammino e la consacrazione;
solo la sciolta flessibilità e la compattezza aritmica della prosa
riesce a stringere insieme,
con pari forza,
le catene e la libertà,
la pesantezza ereditata e la conquistata levità di un mondo,
il cui senso ritrovato s’irraggia adesso nell’immanenza.
“Le parole sono le stesse”, scrive Moretti. “Ma la loro simmetria è ora evidente: un’antitesi equilibrata dopo l’altra […] sigillate da due verbi sinonimi […] completati da espressioni verbali identiche. […] Semantica e grammatica si trovano qui in completo disaccordo: una pone la disarmonia della prosa come fatto storicamente ineluttabile, l’altra la racchiude in una simmetria neoclassica. La prosa è resa immortale in uno stile antiprosaico”.
La prosa è resa immortale in uno stile antiprosaico. In maniera simile, dopo essersi lasciato innervosire dalla tensione tra poesia concreta e poesia ideale, Ben Lerner è passato alla prosa e lì ha fatto lo stesso gioco di Lukács: ha provato a renderla immortale in uno stile antiprosaico. Lo scopo di Lerner, con il suo discorso che oscilla tra poesia, prosa e saggio, sembra essere l’indifferenziata unità di scienza, morale e arte. Le poesie sono il suo punto di partenza.
Si ringrazia Tlon Edizioni per la pubblicazione dell’estratto da Le figure di Lichtenberg, uscito in questi giorni nelle librerie.