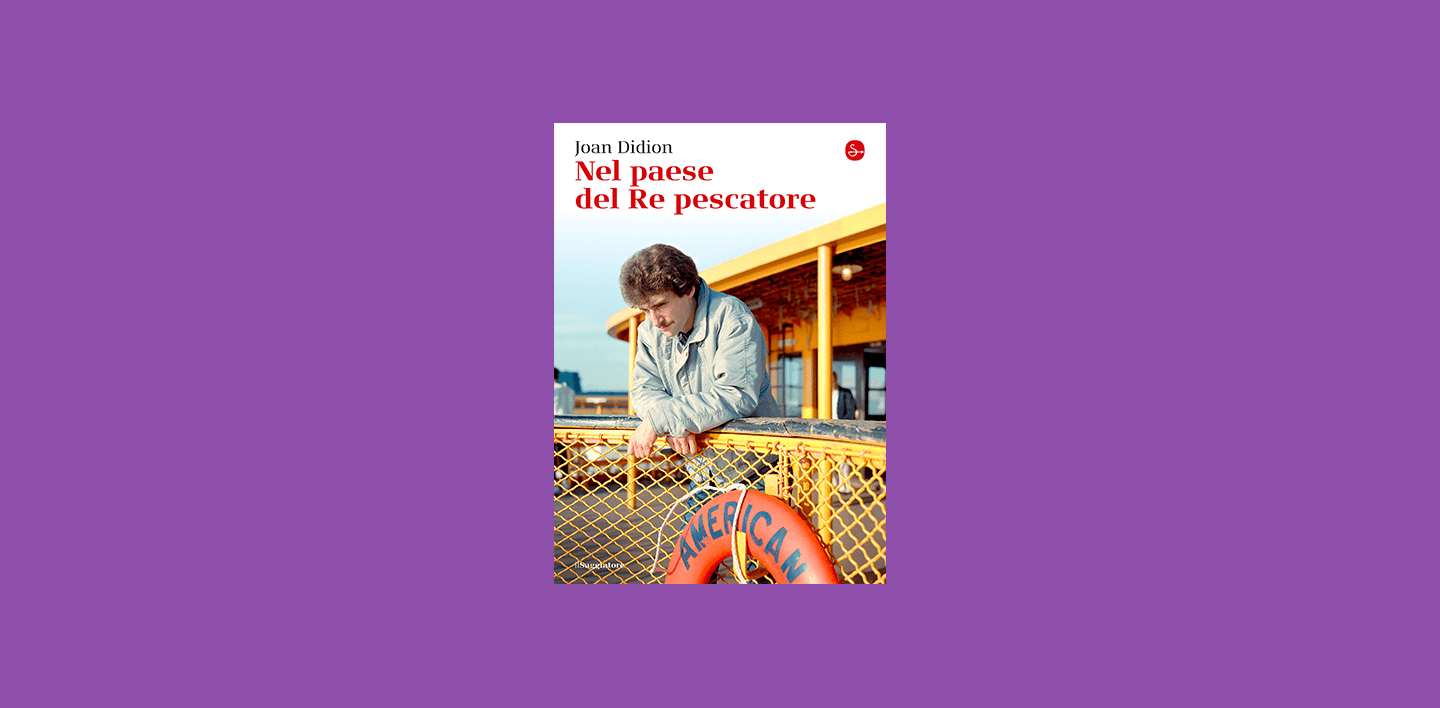
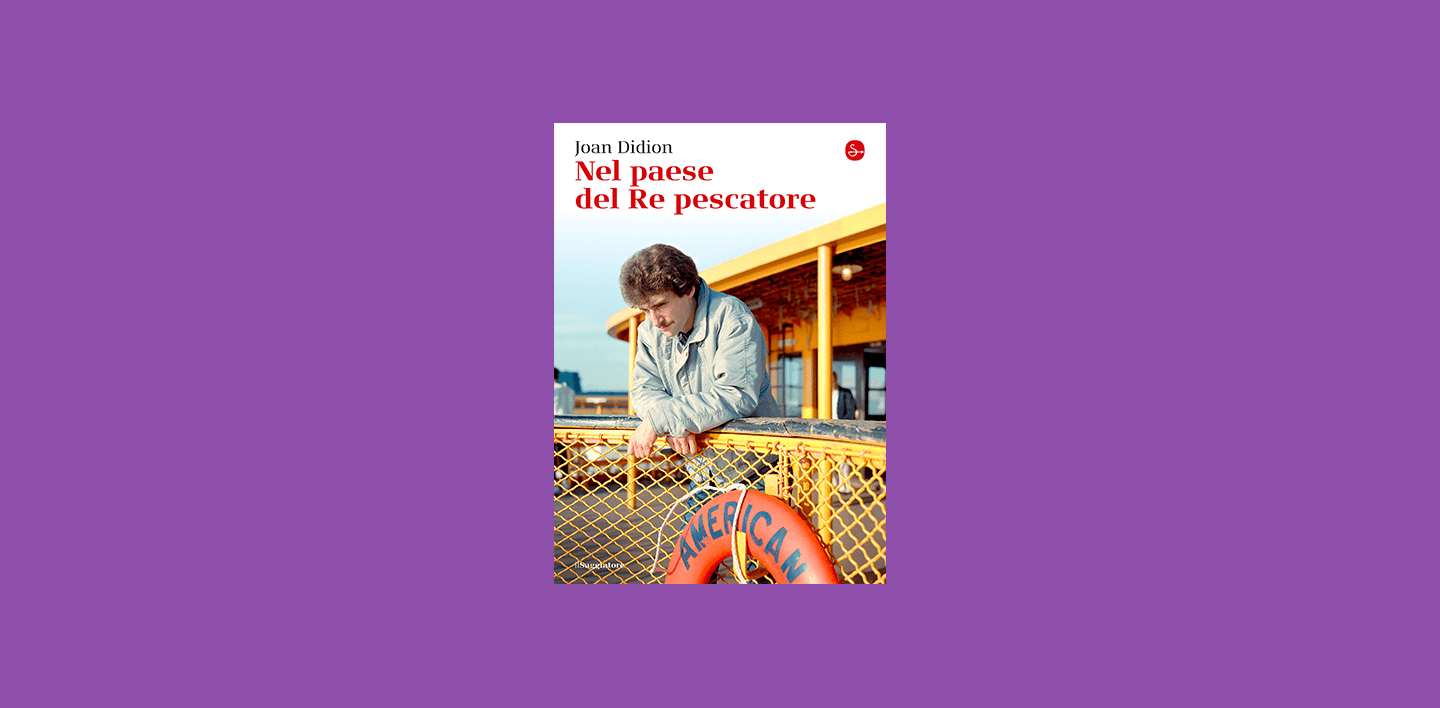
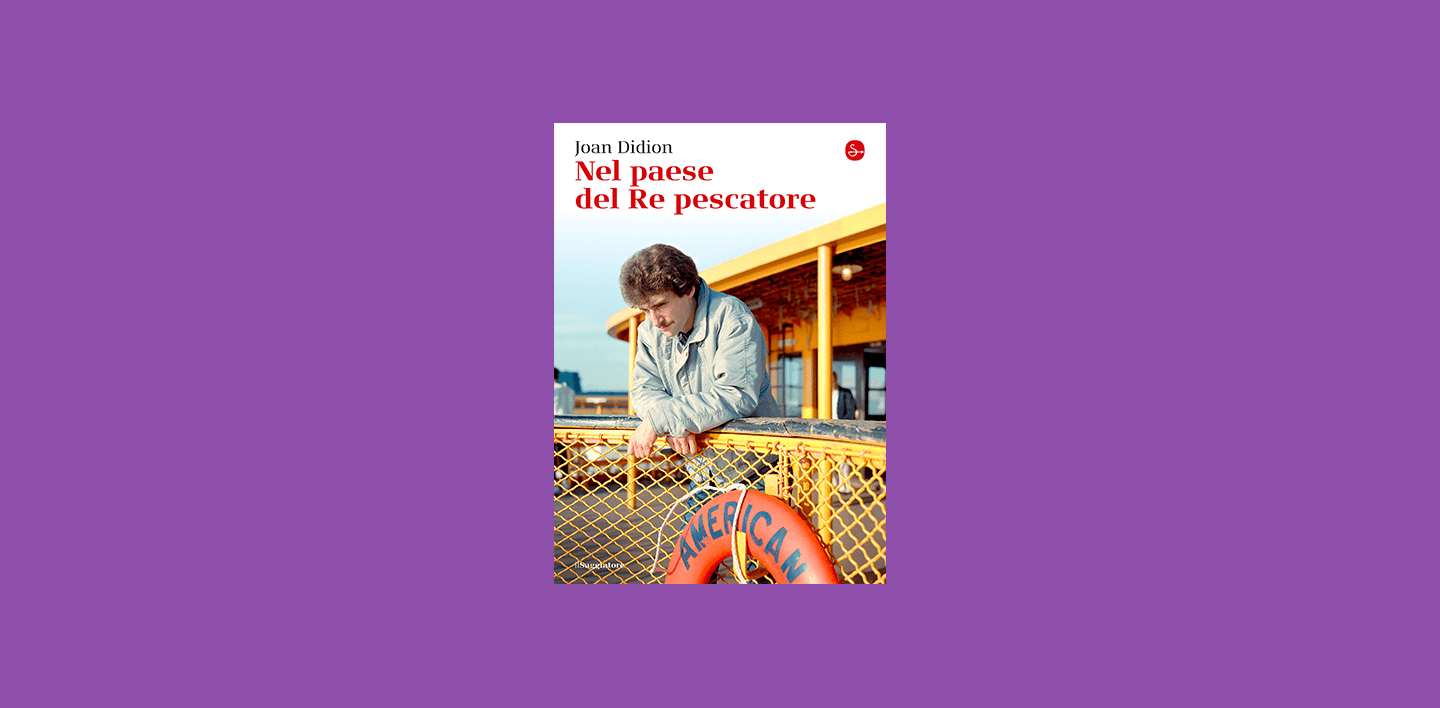
S i può etichettare Nel paese del Re pescatore un libro per completisti e comunque consigliarlo a chi non conosce Joan Didion, spesso considerata una “scrittrice per scrittrici/scrittori”, qualsiasi cosa significhi. I libri di Joan Didion vengono citati spesso da chi scrive perché sono Scritti-Bene, un requisito molto gradito anche nel pubblico non specialistico.
Dopo avere letto diversi Didion infatti, quello che mi tiene agganciato alla pagina non è più il celeberrimo “giro di frase”, rovina degli scrittori che non ne sono capaci; non è più nemmeno la sintassi ipnotica, il ritorno ossessivo dell’anafora. Non è più, e questo è chiaro e forse banale, l’interesse per l’Americana, il sapore del camp statunitense, le strade perdute slabbrate dal deserto, la sete di denaro, il gloss di Lana del Rey. All’improvviso era tutto chiaro: mi formicola il cervello quando Didion scrive di quello che oggi viene chiamato Antropocene e ieri era il mondo fuori dal portone di casa, quando scrive di Sistema – che sia politico, idrico, urbanistico, immobiliare, accademico, cinematografico. Ogni sistema presenta il proprio lessico, e il suo sottoinsieme valoriale; ogni sottoinsieme valoriale diventa elemento associativo, o divisivo, delle persone che lo popolano; ogni persona è una storia.
Ad attrarmi verso Didion non è la sua lingua di vetro insomma, o meglio, non è solo quella. Ad attrarmi è il campo di forze irradiato dai titoli. Ad attrarmi (ecco consumata un’anafora à la Didion) è la sua intelligenza, la facilità nella lettura dei fenomeni, la descrizione della struttura cristallina su cui poggia la Società (stavo per scrivere il Reale; non ne sono sicuro, ma mi sembra che in Didion l’unica cosa reale sia il dialogo tra l’uomo e la Natura – Natura che in quanto convenzione non significa niente, ma che in questa sede immagino come la forza dell’acqua che spinge sul bacino di una diga).
Tratto dominante nei saggi di Joan Didion è l’enfasi sullo storytelling, la narrazione come arma letale, oppure eco collettiva, o ninna nanna psicotica. Nascono quelle che sembrano storie da quello che sembra il nulla: il cadavere decomposto di un qualche faccendiere di professione imprecisata, la carta ormai camomilla di un giornale locale, un pomeriggio qualsiasi in ufficio. Il cadavere il giornale e l’ufficio hanno colori precisi, e la materia distribuitasi intorno ha bisogno di essere raccontata. L’anno scorso, iniziando a mettere insieme delle idee per un articolo su Mestre, una delle mie formule magiche (da giocarci in bocca finché non aveva più senso) era tessuto connettivo, Mestre come città perpetua intermediaria tra un passato da città intermediaria e un futuro da città intermediaria, motore di ricordi sospesi tra due stati, l’incanto infantile e una tonalità di anni Novanta tendente al grigio sabbia… Insomma, come si scrive di tessuto connettivo?
A Los Angeles buona parte di una qualsiasi giornata si passa al volante, da soli, in strade prive di senso per chi guida. […] Le ore di transito hanno il fascino dell’incongruenza. […] Sebbene siano per molti il vero fulcro dell’esistenza a Los Angeles, quelle ore di trance non riescono a innescare un “riconoscimento”, una qualsivoglia sequenza narrativa. […] Quando mi trasferii da New York a Los Angeles per la prima volta, nel 1964, quell’assenza di narrazioni mi sembrò una privazione.
Dopo un’introduzione che è anche ricordo sentito di Henry Robbins, amico e agente della scrittrice a cui è dedicato il libro, la raccolta si divide in tre sezioni: Washington, California, New York. Forse la prima sezione è la meno attuale, come qualsiasi cronaca politica a tenuta stagna (se è vero che la terza parte da un caso di cronaca nera ormai lontano, il pestaggio furioso e la violenza sessuale subita da una giovane jogger a Central Park, le riflessioni intorno al “Problema della Criminalità” come parafulmine di tensioni razziali ma soprattutto economiche potrebbero essere state scritte ieri). Nelle mani dell’autrice, comunque, anche su un materiale ruvido come le primarie USA del 1988 si riescono a ricamare dei principi: “le amministrazioni con scarso margine di manovra in politica interna hanno storicamente sempre cercato scenari alternativi all’estero, così da creare quelli che i sondaggisti chiamano «un evento drammatico», una crisi estera, preferibilmente abbastanza remota da rimanere astratta.”
I saggi su Los Angeles contenuti nella parte centrale del libro oscillano nel racconto di “wilderness santificata e wilderness censurata, l’esaltazione della natura e quello del sé”: contraddizioni che fondono nella storia di Patricia Campbell Hearst, studentessa di buona famiglia rapita (gli Hearst dell’omonimo gruppo editoriale) e convertita da una frangia terrorista (l’Esercito di Liberazione Simbionese), fondono nella botanica degli alberi genealogici, dove l’autrice si arrampica sempre con agilità, cura filologica e passione pura. In California tornano spesso – come nel White Album, come in Where I Was From – le storie dei Padri Pellegrini del corno occidentale d’America: sempre trentenni bianchi, incasinati, sopravvissuti al deserto e arrivati in qualche modo a Los Angeles, San Francisco o Sacramento con le tasche vuote e l’obbligo di darsi da fare, dove la profilazione di “visionari folli” sfuma in “imprenditori cinici”. L’impresa santificata e l’impresa censurata, anche loro, si fondono, santificando e censurando.
Didion trasforma i miti della fondazione, l’essenza del Frank Norris di McTeague, in fatti, distribuendo nomi, date e contratti. Nel suo racconto di Los Angeles nel particolare, e della California nel generale, la greediness, l’avidità, assume connotati mistici, oltremondani. Nascono così interrogativi intorno al rapporto problematico tra necessità e virtù, un rapporto che, senza forzare troppo, diventa chiave interpretativa di tutte le pagine scritte da Joan Didion. Si costruiscono dighe per necessità, dissetare i concittadini è virtù. Si organizzano rivoluzioni per necessità, difenderne gli ideali (per quanto vaghi, lattiginosi e – in ultima sede – contraddittori) è virtù. Capire da che parte è girato il mondo è necessità, per un/a giornalista, parlarne con chiarezza stregando il lettore, è virtù.
Quando mi trasferii da New York a Los Angeles per la prima volta, nel 1964, quell’assenza di narrazioni mi sembrò una privazione. Ma due anni dopo capii (all’improvviso, una mattina che ero da sola in macchina) che ormai le narrazioni, per me, peccavano di sentimentalismo. Questa rimane una delle differenze più grandi fra le due città, e riguarda la visione che i loro abitanti hanno gli uni degli altri.
In California un giorno Didion è seduta in ufficio, all’università, quando entra un esemplare di “ipermachismo letterario”, uno studente entrato per mostrare la sua ruota: “gli piacevano solo Céline e Djuna Barnes”. Le donne, tranne Barnes, non sapevano scrivere; riguardo alla Didion, poi, “aggiunse sedendosi sul bordo della mia scrivania, ‘i suoi giorni di gloria sono finiti, l’entusiasmo per i suoi libri si è spento’”. Poi sono passati gli anni, e questa storia non me l’ha raccontata lui.